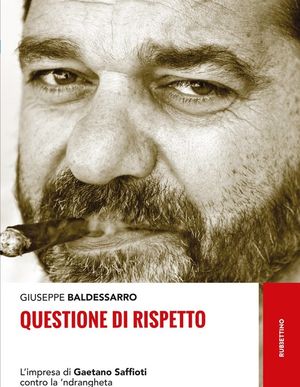«Credo che si possa e si debba cambiare, con tutto quello che ci può accadere. Si deve combattere in prima linea, in trincea a fianco di chi ne ha bisogno, e come non si abbandona un amico in difficoltà, così come non si deve abbandonare una terra e i suoi abitanti.»
“Per vincere la paura, anche di ritorsioni, non serve avere il coraggio… ma prendere coscienza e avere consapevolezza di una paura più grande; quella di non aver fatto nulla per cambiare le cose e lasciare in eredità a chi verrà dopo di noi, questo mondo malato“
(cit. Gaetano Saffioti)
VIDEO
- CONSEGUENZE DELL’ONESTÀ
- COSE NOSTRE
- DOCUMENTARIO RAI
- GAETANO SAFFIOTI – IMPRENDITORE
- INTERVISTA DI GIUSEPPE BALDESSARRO
- L’IMPRENDITORE CORAGGIO SI RACCONTA
- LA MIA VITA IN VENTI PASSI
- PREMIO BORSELLINO
- RACCONTA IL PIZZO
- STORIA DI ORDINARIA RESISTENZA
- UOMO LIBERO
Gaetano Saffioti, imprenditore e testimone di giustizia nato il 25 febbraio 1961 a Palmi in una famiglia numerosa (quattro fratelli e due sorelle), Gaetano comincia a lavorare giovanissimo (nell’impresa per la produzione d’olio d’oliva del padre, morto all’età di 50 anni per malattia); già in quei tempi comincia a scontrarsi con la ‘ndrangheta.
Tuttavia, la sua passione è il movimento terra, per questo nel 1981 dà vita alla sua impresa, a cui aggiunge nel 1992 l’impianto di calcestruzzo, vince diversi appalti pubblici e privati ma la ‘ndrangheta reclama la sua parte di potere e ricchezza, e sottopone Saffioti alle richieste estorsive che sfociano in numerose minacce, intimidazioni, danneggiamenti — come l’incendio di un camion di sua proprietà appiccato dallo stesso autista sotto le minacce delle armi delle ‘ndrine e costrizioni, visto che non era libero di utilizzare la propria cava per la sabbia, ma doveva comprarla per forza dalle imprese mafiose.
Tale situazione soffocante si è protratta per diversi anni, durante i quali Saffioti è costretto a subire e pagare, finché nel 2002 decide di dare una forte svolta e denuncia il tutto alla magistratura. Da allora la sua vita diventerà blindata, sempre sotto scorta assieme alla sua famiglia, perderà molte commesse, dipendenti, amici ma decide comunque di restare in Calabria e continuare l’attività (il suo cemento è stato usato su un tratto di pista all’aeroporto di Parigi), rifiutando gli aiuti economici statali per i testimoni di giustizia.
Con le sue dichiarazioni ha dato vita all’importante operazione di polizia Tallone d’Achille, che ha portato all’arresto e alla successiva condanna, per associazione di tipo mafioso ed estorsione, di 48 esponenti delle famiglie mafiose dei Bellocco, Mazzagatti, Romeo, Nasone, Piromalli e Gallico.
Ha contribuito in modo determinante e significativo in altre operazioni della magistratura contro la ‘ndrangheta: nel 2007 operazione Arca, nel 2010 operazione Cosa Mia[, nel 2011 operazione Scacco Matto Dal 2002 vive sotto scorta nella località di origine a Palmi.
L’imprenditore Gaetano Saffioti opera nel suo cantiere trasformato in bunker per aver fatto arrestare 48 taglieggiatori della ‘ndrangheta
L’azienda «Saffioti calcestruzzi e movimento terra», alla periferia di Palmi sulla strada che porta a Gioia Tauro, è un bunker: cancelli blindati, muri in cemento armato, decine di telecamere, filo spinato come nelle caserme , un’auto fissa della Finanza. Gaetano Saffioti, 48 anni, gli ultimi sedici anni vissuti sotto scorta per aver fatto arrestare 48 malavitosi della ‘ndrangheta che lo taglieggiavano, non ha perso il senso dell’umorismo.
Da quando ha denunciato il racket, praticamente non lavora più in Calabria, è riuscito a salvare l’azienda con le commesse all’estero. «Gaetano Saffioti, ovvero la storia di un uomo esemplare» è il capitolo della sentenza del processo nato dalle sue denunce. «
Sono nato cresciuto e pasciuto a Palmi. La mia famiglia aveva un frantoio.
La ‘ndrangheta l’ho conosciuta a 8 anni. Ero andato in una colonia estiva a Sant’Eufemia, in Aspromonte, riservata ai più bravi della classe. Ci tenevo da morire. Dopo due giorni fui richiamato a casa. Torna perché mi manchi, disse mio padre.
Anni dopo ho saputo che era stato minacciato e temeva per me.
Morto mio padre, la famiglia era diventata più debole: una donna sola con sei figli minorenni.
Arrivavano telefonate e mia madre piangeva. Noi chiedevamo: chi è ‘sta ‘ndrangheta?».
Nel 1981 Saffioti apre la ditta. «Ero appassionato di mezzi per movimento terra. Prima zappavo con il trattore, poi ho noleggiato la prima autopala, quindi un cingolato, un paio di camioncini. Fatturavo 5 milioni e mezzo di lire.
Nel 1992 aggiungo l’impianto di calcestruzzo e vinco le prime gare d’appalto pubbliche».
E le cosche? «Sempre tra i piedi. A loro non sfugge niente: persino i professori di scuola pagano il pizzo, costretti a dare voti alti ai figli dei boss.
Quando ho cominciato a lavorare, c’era il boom dell’abusivismo: tanto lavoro, i boss lasciavano le molliche e prendevano i grossi appalti. «Si presentavano a tutte le ore, io preparavo i soldi e li consegnavo a pacchi da dieci milioni.
Quando ne arrestavano uno, il giorno stesso si presentava un sostituto.
Erano cordiali, sapevano prima di me che mi era arrivato un accredito in banca e venivano a riscuotere la percentuale, dal 3 al 15 per cento.
Quando c’era un sequestro dei beni di un boss, automaticamente bisognava “risarcirlo” pagando il doppio.
Per arrivare al cantiere al porto di Gioia Tauro dovevo attraversare i territori di tre famiglie. E pagavo per tre.
Come i caselli autostradali.
Compravo una cava di inerti per fare il calcestruzzo? Non me la facevano usare, imponevano di comprare il materiale da loro.
Così per le macchine: le mie restavano ferme e noleggiavo le loro.
Pagavo anche se non mi piaceva.
Io glielo dicevo: non si può andare avanti così.
E loro mi sfidavano: denuncia. Avevo paura: di essere ucciso ma anche di essere considerato un prestanome dei boss e arrestato. Quindi registravo tutto: gli incontri, i colloqui, i pagamenti. Una specie di polizza vita».
L’azienda cresce a ritmi vertiginosi: 20-30 per cento l’anno. E così le tangenti ai boss. Ma anche la frustrazione di Gaetano, anche perché nel frattempo gli attentati intimidatori non cessano.
In uno di questi, l’incendio di un mezzo in pieno giorno, il fratello di Gaetano rischia di morire. È la svolta: Saffioti si presenta dal procuratore Roberto Pennisi e consegna tutte le registrazioni.
«All’alba del 25 gennaio 2002, all’arrivo in azienda trovo la Finanza: “Siamo qui per lei, se deve uscire l’accompagniamo noi”.
Finiva un incubo e ne cominciava un altro.
Da allora sono sempre con me e con la mia famiglia.
In pochi giorni persi tutte le commesse, 55 dei 60 operai. Il fatturato scese da 15 milioni a 500 mila euro, le banche mi chiudevano i conti attivi, i fornitori mi chiedevano fideiussioni oltre il terzo grado di parentela perché “tu sei un morto che cammina”.
Mia moglie piangeva. I clienti sparivano, nemmeno le confraternite venivano più a chiedermi i contributi per le feste patronali». Saffioti, diventato testimone di giustizia, vivrà il resto della sua vita blindato.
Quelle spaventose telefonate alla sera
«Sono brutta gente Tanino, sono gli uomini di rispetto, sono quelli della Maffia..». Era la prima volta che Gaetano sentiva pronunciare quella parola. Maffia, con due f. Dopo la morte di suo padre Vincenzo non c’era stato il tempo per piangere. Non c’era mai tempo al frantoio dell’Acqualiva dove i ritmi erano dettati dalle olive e dalla terra.
Neppure per i lutti.
Annunziata e i suoi figli avevano dovuto raccogliere in fretta il loro dolore, lo avevano stipato in un angolo dell’esistenza e avevano ricominciato a percorrere il sentiero della quotidianità. Era dura. Ci si alzava prima del sole, si lavorava per alcune ore e quando gli altri ragazzi iniziavano la loro giornata a scuola, i Saffioti si erano già buttati alle spalle diverse ore di fatica. Dopo le lezioni ce ne sarebbero state altre, identiche, dure, lunghe e, non sembri un paradosso, entusiasmanti. Aveva 15 anni quando Gaetano ha iniziato ad accorgersi che c’era qualcosa di strano, di inquieto nelle espressioni di sua madre. Arrivavano telefonate la sera. Prima occasionali, poi più frequenti.
Quasi sempre a rispondere era Giuseppe, il più grande dei fratelli. Poggiava l’apparecchio all’orecchio, annuiva, parlava a bassa voce, cambiava colore, cercava la madre con gli occhi spaventati e gli porgeva la cornetta. Annunziata sussurrava qualcosa e metteva giù piano. Quegli squilli avevano un effetto immediato inquietante, il clima cambiava rapidamente. Un venerdì sera Annunziata afferrò il telefono con energia inusuale e inizio a parlare più forte del solito. “Ma vi rendete conto? Sono una femmina sola con sei figli, dove li prendo venti milioni? Alla banca del sapone?”.
Non c’era rabbia nelle parole della madre, solo angoscia, disperazione. Tanino chiese di capire cosa stesse succedendo. E la risposta fu: “Vogliono soldi, sono brutta gente, sono quelli della Maffia”.
La parola ‘Ndrangheta non esisteva ancora. Tanino non l’aveva mai sentita pronunciare. Non sapeva cosa fosse la ‘Ndrangheta e non sapeva neppure cosa fosse la Maffia, come la chiamava sua madre. Per questo aveva continuato a cercare di scoprire la verità, tentando di mettere assieme gli elementi. “Chi sono?”…. “Mamma chi sono?”. Annunziata non sapeva come spiegare, non voleva pronunciare nomi, indicare volti.
Difendeva i suoi figli non dicendo loro oltre, non potendo dire oltre. Si trattava di gente pericolosa, sanguinari senza scrupoli che comandavano da sempre e i nomi non si potevano neppure sussurrare. Poi fatto un lungo sospiro Annunziata aveva iniziato a rovistare nella memoria cercando di trovare le parole giuste. E aveva iniziato a raccontare di quando suo padre era andato a prenderlo alla colonia estiva perché lo avevano minacciato. E gli aveva detto anche che “l’incendio del frantoio, la notte della Befana del ’71, non era stato causato da un corto circuito, ma da qualcuno che li aveva voluti male, un dispetto di vendetta”.
Così gli aveva detto. Tanino non ha mai saputo se sua madre pagò la richiesta estorsiva arrivata per telefono. O meglio, non ha mai saputo quanto pagò e in che forma. Seppe poi che rivoltasi ad alcuni parenti, erano stati loro a tentare di trovare un punto di mediazione, un compromesso.
A Palmi comandava “U lupu i notti”. Il boss Gaetano Parrello in città faceva il bello e il cattivo tempo, era la legge. A lui dovevi rivolgerti se volevi “aggiustare” le cose, con lui bisognava parlare per “sistemarle” al meglio.
Bisognava cercare “U lupu i notti”. Parrello lo hanno ammazzato come un cane, quasi dieci anni dopo, il 25 settembre del 1986.
Due giovanotti gli si affiancarono con la macchina e gli scaricarono contro le armi mentre era con la figlia Concetta e i tre nipoti. Tra l’odore della polvere da sparo, in un lago di sangue, ha smesso di determinare i destini della gente.
Sangue che avrebbe poi chiamato altro sangue, in una faida con i Gallico.
Tanino all’epoca delle telefonate non lo sapeva ancora cos’era la Maffia, né chi erano i Parrello, e non conosceva neppure i Condello e i Gallico. All’epoca non lo sapeva, ma li avrebbe incontrati tutti.
Un campo e una casa colonica «Sono cresciuto nella cultura del lavoro, mio padre mi ha insegnato che lavorando con passione e cura nulla era impossibile. Perché a “buon cavallo non manca sella”..».
La vita di imprenditore di successo di Gaetano Saffioti ha radici antiche. Radici profonde e insegnamenti. Gli insegnamenti di Vincenzo, un padre che amava dire: “Quando i miei figli cresceranno abbracceremo il mondo”.
Di figli Vincenzo ne aveva sei, Tanino era il secondo. Bocche da sfamare con il lavoro di un frantoio in contrada Acqualive. I Saffioti agli inizi degli anni ’70 avevano acquistato un piccolo podere che apparteneva a Leonida Repaci, l’intellettuale palmese fondatore del Premio Viareggio.
Un pezzo di terra e una casa colonica. Una piccola tenuta ai piedi del monte Sant’Elia. Spazi ampi per il frantoio e una struttura facilmente da raggiungere per i contadini e per i proprietari terrieri della zona. Con il vantaggio di avere anche la disponibilità di un alloggio per la famiglia che cresceva di numero. Un sogno per Vincenzo, che avrebbe potuto fare casa e bottega e controllare meglio gli affari. In quegli stessi anni, proprio in funzione della piccola azienda di lavorazione delle olive c’era stato un secondo acquisto. Vincenzo aveva comprato un trattore, un 30 cavalli Ferrari, di colore verde. Parte da quel mezzo la storia imprenditoriale di Gaetano, dall’amore per le macchine.
Quel Ferrari aveva alimentato la sua “malattia”. Nei giorni successivi all’acquisto, quando aveva poco più di dieci anni, aveva studiato quel trattore in tutti i suoi dettagli, ci aveva passato sopra ore e ore in attesa del giorno in cui l’avrebbe guidato. Sapeva che sarebbe diventato una sua protesi, parte della sua stessa anima. Aveva imparato a guidarlo rapidamente, con sorpresa di tutti. E sarebbe diventato il suo compagno di lavoro per mesi, anni, per una vita. Se tutto quello che sarebbe successo dopo ha un’origine precisa, questa va probabilmente cercata in quell’acquisto.
Il frantoio aveva iniziato ad andare bene, anzi benissimo. Il lavoro era intenso dall’inizio dell’autunno fino alla fine della primavera. C’erano cinque presse in azione praticamente per 24 ore al giorno e per sette giorni alla settimana. Dava da campare a due dozzine di operai.
Un lavoro pesante a cui Vincenzo e i suoi dipendenti non si sottraevano, e anche i ragazzi si sentivano pienamente coinvolti. C’era da rimboccarsi le maniche dal punto di vista fisico, ma bisognava anche lavorare con la testa controllando i carichi di olive. Poi tutta la parte burocratica, con le carte da compilare per accedere ai contributi comunitari per la produzione dell’olio. Bisognava selezionare il frutto e l’olio da consegnare.
Era indispensabile tener d’occhio la resa secondo regole contadine antiche. Di clan e di mafie non si parlava mai in casa, o meglio Gaetano non ne ha mai sentito parlare.
Nel ’75 Vincenzo era morto di un male incurabile. Quell’anno Tanino sarebbe diventato uomo. A capo della famiglia c’era sempre Annunziata, la madre. Ed assieme a lei Gaetano si sarebbe messo sulle spalle le responsabilità di un’azienda troppo grande, per un ragazzino ancora troppo piccolo per conoscere le cose “dei cristiani”. Cose che avrebbe imparato a conoscere praticamente fin da subito.
La prima estorsione me l’hanno fatta a 8 anni Quando Gaetano Saffioti mi raccontò questa storia eravamo a cena nei dintorni di Teramo. Era l’inverno del 2011, pioveva, e a tavola davanti ad un bicchiere di vino l’imprenditore di Palmi (in provincia di Reggio Calabria) che vive sotto scorta da oltre 16 anni per ave denunciato i boss di otto diversi clan della Piana di Gioia Tauro, mi raccontò l’episodio che mi ha poi convinto a scrive un libro sulla sua vicenda umana e giudiziaria. La storia ha inizio nel giugno del 1968. Gaetano all’epoca frequentava la scuola media San Francesco.
A fine anno era stato selezionato tra i cinquanta alunni che si erano meritati una breve vacanza premio a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Un’avventura straordinaria per quei tempi e per un bambino di quell’età.
Significava dormire fuori di casa per la prima volta.
Avrebbero trascorso sette giorni a camminare tra i boschi, a mangiare all’aperto, a dormire nelle camerate, a giocare spensierati. Tutti assieme.
Gaetano, che all’epoca tutti chiamavano Tanino, s’era impegnato durante l’anno e quella “colonia” era la sua “colonia”. L’aveva desiderato tanto, ma non tutto sarebbe andato come sperava. Il terzo giorno di gita, a Sant’Eufemia era arrivato il padre Vincenzo. Una visita inaspettata. Vincenzo gli aveva chiesto di rientrare a casa.
Gli aveva parlato con calma, gli aveva detto che la sua mamma aveva voglia di rivederlo, che le mancava, che avrebbe dovuto tornare. Tanino aveva provato a replicare, poi davanti alla fermezza del padre aveva raccolto le sue cose ed era partito con lui. Fino a casa nessuno aveva parlato.
Ma il ragazzino aveva pensato che suo padre era stato egoista.
Che se lo era portato a casa perché aveva bisogno di lui al frantoio di famiglia, che era solo per farlo lavorare. Tanino, quella colonia interrotta se l’era incisa sul cuore, l’aveva vissuta come una cattiveria gratuita, un’ingiustizia.
Non ne parlarono più. Il padre morì poi alcuni anni dopo. Gaetano aveva 15 anni e la verità su quanto accaduto quell’estate l’avrebbe saputa da sua madre quando suo padre non c’era già più. Vincenzo voleva acquistare un terreno, ma quel terreno interessava ai clan.
Lo avevano minacciato.
Avevano promesso di fargli trovare il figlio in un fosso. Per questo era corso a Sant’Eufemia a riprendersi il bambino, per questo se lo era riportato a casa. Per proteggerlo. Allora non poteva dirglielo e forse, se non glielo avesse raccontato sua madre, non avrebbe mai saputo nulla di quell’episodio. “Mi tolsero quattro dei sette giorni della colonia di fine scuola. I vigliacchi, mi fecero credere che a rubarmi quei momenti di felicità era stato mio padre.
Gli ho portato rancore, avevo pensato che era stato un egoista. Posso perdonare tutto, ma non quei giorni tolti a un bambino di 8 anni. Perché quei giorni non potranno mai più tornare. Fu un’estorsione. Mi estorsero la spensieratezza”.
Gli “amici” e i favori fra gli aranceti della Piana “Mi piace zappare la terra”, perché zappare la terra “non è un mestiere, zappare la terra è un’arte”. La terra a Gaetano era sempre piaciuta, amava il suo profumo. E non importava che terra fosse. Da bambino gli piaceva alzarsi presto e camminare in campagna sull’erba bagnata dalla brina notturna.
Gli scarponi qualche volta si inzuppavano, e le gambe fino all’altezza del ginocchio diventavano più pesanti. D’inverno dai prati saliva quel respiro ghiacciato che in inverno fa diventare la terra pastosa e nera, mentre in estate quell’alito intimo diventava morbida frescura. Andare per i campi era come immergersi nel tempo.
Fino a metà primavera la vita ruotava attorno all’odore forte e acre delle olive, poi iniziava il lavoro che più lo appassionava e che lo portava a diventare tutt’uno con gli attrezzi e la terra: “Zappare la terra non è un mestiere qualsiasi, zappare è un’arte”. Tanino lo chiamavano tutti a “fare” la campagna. Lo chiamavano perché era il più bravo, rapido e preciso con trattore.
Nonostante fosse poco più che un bambino, quando finiva di lavorare sui terreni, gli ettari su cui passava sembravano tappeti pettinati dal vento. Non importava che si trattasse di terra piana o di un costone scosceso, che fosse uliveto o zolle buone per agrumi o cereali. Le regole erano sempre le stesse. Ma anche per zappare la terra bisognava dare conto “agli amici”.
Era così da sempre e lui si era adeguato. Spesso, oltre uno sentiero, superata una strada e in alcune contrade bisognava rinunciare a qualche lavoro.
Alcuni terreni interessavano agli “amici”, certi poderi li controllavano “loro” e nessun altro poteva neanche sperare di zapparci sopra. Tanino era più bravo e faceva prezzi migliori, ma in certi posti non c’era spazio se non per gli “amici” e per gli “amici degli amici”. Per i poderi più grandi “loro” stabilivano il prezzo e anche chi doveva dissodare la terra.
A poco valeva l’opinione dei reali proprietari terrieri che, tutto sommato, preferivano stare tranquilli pagando qualcosa in più. Amavano sentirsi signori perbene, padroni generosi, in realtà erano costretti. Di fatto erano padroni solo sulla carta di terra che era della “maffia”. “Amici”, già una parola ricorrente tra gli uliveti e gli agrumeti di clementine della Piana di Gioia Tauro. In quei luoghi anche il senso delle parole era storpiato, piegato a significati inediti, meschini, falsi. Gli “amici” erano quelli che davano gli ordini, gli “amici” erano quelli che prendevano tutto. Ma amici di chi ?
I padroni della terra Gli “amici”, e quelli da loro mandati, si presentavano anche al frantoio, e nel nome di quella fantomatica amicizia pretendevano e ottenevano quel che volevano. Al frantoio, a seconda del tipo di olive, del momento della stagione, del modo in cui il frutto viene raccolto si otteneva una certa percentuale d’olio. Poi c’era la qualità che era determinata dall’acidità. Mediamente il prodotto aveva una resa del 10-11%, significava che su un quintale di olive si ottenevano dieci o undici litri di olio. In casi particolari, quando il frutto era buono, raccolto per tempo e in maniera corretta, evitando che stesse sulla terra o nelle ceste a lungo, si poteva arrivare al 14-15%. In genere il produttore contratta la percentuale con il titolare dell’impianto prima della premitura ed era difficile non trovare un accordo tra le parti. Certo ognuno prova a tirare per se il massimo possibile, ma oltre il limite dettato dall’esperienza e dal buonsenso non si andava. Quando all’azienda dei Saffioti arrivavano le ceste o i sacchi degli “amici” non c’era discussione. Gli emissari degli “amici” arrivavano al frantoio e non trattavano neppure, la resa era e doveva essere sempre massima, a prescindere dalla qualità reale del frutto. L’olio prodotto non contava nulla, contava l’olio che tornava in dietro nelle case dei mafiosi, che doveva essere della qualità migliore. Quando poi gli “amici” decidevano che di olio ne avevano abbastanza e che il resto del raccolto doveva essere venduto ai frantoi, il compenso che veniva loro corrisposto era comunque quello più alto. Gli “amici” non si lamentavano mai dell’annata, della bontà della terra, della cura con cui era stata seguita la produzione dai loro contadini. Per gli “amici” era sempre un’annata straordinaria. Era una tangente, non altro. Gaetano nel tempo ha imparato che il pizzo, la mazzetta, il contributo agli “amici” può vestire mille abiti, ne ha uno per ogni stagione, per ogni contesto, per ogni occasione. Ha l’abito elegante del “favore” chiesto alla buona società, quello ammiccante del prezzo di gonfiato o quello conciliante dettato dal quieto vivere. Poi, in ultima analisi, c’è il vestito violento dell’imposizione. Gaetano ne ha visti tanti di quegli abiti da ragazzo, molti altri ne avrebbe vissuti da imprenditore. La violenza sulle cose come gli incendi e la violenza sulle persone. La violenza persino per nascondere la vergogna di una violenza subita.
Lo Stato preso a schiaffi Lo Stato in Calabria, a Reggio e nella Piana di Gioia Tauro, è ovunque ma stenti a riconoscerlo. Gaetano Saffioti lo Stato aveva visto, ed aveva l’immagine di uno straccione. Lui stesso aveva vestito i panni dello Stato vestendo una divisa disprezzata, derisa, offesa, lacera di strappi e macchiata dai suoi stessi servitori. La sua era una divisa, quella degli agenti della Polizia penitenziaria. Piuttosto che perdere tempo facendo il militare aveva fatto i test per andare a lavorare da agente vicino casa. A Palmi c’era il super carcere per gli irriducibili della Brigate Rosse. Nei bracci speciali calabresi c’erano Renato Curcio, Prospero Gallinari, Emanuele Attimonelli e tanti altri, praticamente il vertice politico-militare dell’organizzazione. Per Gaetano però Palmi significava anche casa, e casa significava lavoro. Il primo giorno al super carcere non lo dimenticherà mai. Era la mattina del 2 agosto 1980, e mentre faceva il giuramento la tv nazionale e le radio mandavano in onda le urla disperate dei soccorritori di quello che sarebbe diventato uno dei misteri irrisolti d’Italia. A Bologna era appena esplosa la bomba alla stazione. Il primo periodo lo trascorse nel braccio riservato ai terroristi. Lunghi corridoi freddi, volti tirati, lunghi silenzi. I brigatisti con le guardie non ci parlavano quasi per niente. Erano lo Stato e con lo Stato non si discuteva, i contatti erano limitati praticamente a monosillabi, ordini o provocazioni sussurrate. Nulla di più. Gaetano ricorda ancora oggi il giorno, anzi la notte, in cui le istituzioni uscirono a pezzi da una sala colloqui del super carcere di Palmi in una sera fredda tra l’80 e l’81. Era in servizio. I notturni erano molto più faticosi, ma consentivano a Gaetano di lavorare di giorno. Dall’ufficio lo mandarono a chiamare per portare di sotto un brigatista. Ad attenderlo c’era un magistrato arrivato da Bari. In tre percorsero il lungo corridoio che portava alla cella dove l’uomo in pantaloncini e maglietta a maniche corte stava cucinando. Neppure si voltò verso di loro quando rispose alla chiamata: “Ora non posso sto facendo la maionese, se mi fermo impazzisce forse dopo”. Il tira e molla per far andare il detenuto in sala colloqui andò avanti per quasi mezz’ora, sempre la stessa risposta: “Ora non posso”. Quando finalmente decise che era tempo di seguire le guardie, il brigatista si mosse lentamente senza fare una piega. Si fece accompagnare in ciabatte, così come stava in cella, nonostante il freddo pungente. Alla richiesta di vestirsi in maniera decente la replica fu immediata: “Se volete vengo come mi pare, altrimenti ve ne andate tutti affanculo”. Il giudice se lo trovò in piedi davanti al tavolo. Ne’ un cenno di saluto ne’ nulla d’altro. Spazientito iniziò l’identificazione per notificargli un provvedimento o qualcosa del genere: “Lei è… nato a… residente in … accusato di…?”. Quando ebbe finito di leggere la scheda che aveva sul tavolo il magistrato alzò istintivamente la testa in attesa di risposta. Il terrorista ebbe uno scatto in avanti, arrivando preciso a piazzare una sberla sonora tra faccia e collo del giudice che volò via verso dietro: “Si sono io, e tu chi cazzo sei?”. Ci vollero diversi minuti per far riprendere il poveraccio e riportare in cella il brigatista che se ne tornò alla sua maionese come se nulla fosse successo: “Tranquilli non gli faccio niente”. Sbigottito il maresciallo rivolgendosi al magistrato non seppe dire altro che “dottore questo si prende un’altra condanna”. E lui con il sangue che gli colava dal naso e un dente saltato: “Mi raccomando maresciallo quello che è successo qua non deve trapelare”. Era quello lo Stato davanti agli occhi di un 18 enne. Uno stato preso a schiaffi e incapace di reagire con autorevolezza. Lo Stato non c’era, per Gaetano.
L’“assessore” ai Lavori Pubblici della ‘Ndrangheta “Il frantoio aveva dato da mangiare a tutti, prima e dopo la morte di mio padre. Era stato generoso con noi, ma sapevo che quell’attività non sarebbe bastata a far vivere me e i miei fratelli una volta che ognuno avesse avuto una famiglia propria. Bisognava fare altro, inventarsi un’attività”. Gaetano non volle firmare la ferma per restare nella polizia penitenziaria. Lo Stato lo aveva deluso ed è per questo che nel 1981 aveva deciso di tornare al lavoro del Frantoio. Andava bene anche il lavoro con il trattore. Gaetano ci faceva di tutto. Arava i campi, ripuliva gli uliveti, una volta montata una pala meccanica davanti al mezzo riusciva a sistemare stradine sterrate e sentieri, ripuliva gli alvei delle fiumare e le spiagge. Bastava chiamare, e Gaetano arrivava. Faceva qualsiasi cosa gli consentisse di portare a casa la giornata, sempre più bravo, preciso, puntuale. L’esigenza di registrare l’impresa si era presentata quando il Comune iniziò a chiamarlo per piccoli lavoretti di manutenzione ordinaria e pulizia stradate. Se hai rapporti con le istituzioni devi essere in regola gli aveva detto il geometra del Comune. Saffioti se lo ricorda ancora quando lo chiamarono a palazzo di città. Era emozionato. Strano a pensarci ora, ma all’epoca, nell’81, il giorno che andò a incontrare i tecnici dell’amministrazione si sentiva orgoglioso, fiero. Era per lui un riconoscimento importante. Avrebbe lavorato per il Comune facendo quello che sapeva fare meglio: guidare il trattore. Era gratificante sentirsi al servizio della comunità. Assieme al lavoro per aggiustare strade e scarpate iniziavano ad arrivare richieste da alcuni privati. Piccole cose, soprattutto nel movimento terra. Erano interventi di precisione, lui entrava in campo quando le grandi ruspe e gli scavatori non riuscivano a intervenire. Opere collaterali, roba che andava fatta di fino. C’era da guadagnare, ma soprattutto c’era da imparare. E Gaetano da questo punto di vista non si risparmiava. Imparava e continuava a lavorare con il suo trattore. Ogni volta nuove sfide, sempre più impegnative con un mezzo che però era inadeguata. Anche demolizioni faceva, una cosa impensabile con un trattore delle dimensioni di quello di cui disponeva. Lavora, imparava e tesseva la sua rete di relazioni. Lui scavava e per il trasporto del materiale di scarto si rivolgeva a piccoli padroncini. Era un modo per dare lavoro, ma anche per riceverne. Con gli incarichi arrivavano però anche le richieste degli “amici”, senza quasi che se ne accorgesse, c’era sempre qualcuno da accontentare. Gente a cui cedere parte delle opere, forniture da prendere da un’azienda piuttosto che da un’altra, trasporti da far fare a quelli che si presentavano a nome del ras locale, e poi il “presente” alle famiglie del paese o del quartiere. Un “regalo” per le famiglie dei detenuti, un riconoscimento per Tizio o Caio. “Un fiore” lo chiamavano, sottolineando che si trattasse di una sorta di atto dovuto. E Gaetano Saffioti faceva quel che c’era da fare. Esistono due leggi in quell’ambiente. Una legge che è quella ufficiale dello Stato e che si trova scritta sui codici e sui contratti. L’altra che è quella di una realtà parallela incisa sulla carne viva dei luoghi e degli uomini che le dinamiche di quei luoghi determinano. La regola, al netto da ogni ipocrisia, diceva che per lavorare dovevi pagare. Ed era una norma che nessuno neppure si sognava di mettere in discussione. A Palmi i boss della famiglia Gallico lasciavano agli altri solo le briciole. L’assessore ai lavori pubblici e privati, del clan si chiamava Sarò Sgrò “U Jancu”. Un uomo spietato che non nascondeva la propria arroganza e che trattava imprenditori e amministratori come fossero poco più che una nullità. Era così a metà degli anni ’80. Saffioti provava a ritagliarsi il suo spazio imprenditoriale, navigando a mezz’acqua ed evitando di pestare i piedi a chi avrebbe potuto spazzarlo via come un niente. Intanto stringeva rapporti e sognava in grande, sia pure sapendo che prima o poi con quelli come Sgrò avrebbe dovuto fare i conti.
Guerra o non guerra si pagava sempre Gaetano sapeva che nella vendetta “Il sangue si cheta solo con altro sangue, fino alla fine. Finché non c’è più sangue e ci si deve accontentare delle lacrime”. Ne aveva visti tanti di morti ammazzati. I cadaveri sfigurati riversi nella polvere aveva scandito la sua vita come quella di molti altri nella Piana di Gioia Tauro. La guerra di mafia aveva segnato Palmi per diversi anni.
Certo lui con quelle storie non c’entrava niente. Ma aveva visto morire tanta gente. Cadevano uno dopo l’altro, un funerale dietro l’altro, come un rosario senza chiusa, infinito. Di quel periodo sono restate le immagini appese nella mente, e fotografie in bianco e nero sui giornali. E sussurri: “U ‘mmazzaru”.
A Palmi i Gallico e i Condello hanno iniziato a scannarsi nel settembre del 1977 e hanno continuato a farlo per quasi vent’anni. Fin quando di Condello non ce n’erano stati più. Sterminati.
Così è cresciuto il potere dei Gallico e di tutti i loro alleati.
Le cronache dissero che era iniziata con una lite, una scazzottata tra giovani davanti ad una sala da ballo appena inaugurata dai Condello. Schiaffi e calci tra i fratelli Domenico e Alfonso Gallico e Francesco e Stefano Condello. I primi di famiglia mafiosa, i secondi eredi di un “onorato” commerciante di vino.
Tutti comunque rampolli, chi di “uomini di rispetto”. Figli di una cultura che impone di non abbassare la testa, che non ammette la parola fine. Era iniziata così, e che non sarebbe finita presto lo si era capito subito. A Palmi avevano sempre comandato i Parrello guidato dal vecchio capobastone Gaetano Parrello, “U lupu i notti”. I Gallico erano gli emergenti, un gruppo familiare numeroso e violento. Ed è per questo che i vecchi padroni della città avevano pensato di utilizzare “l’incidente” con i Condello per ridimensionare le ambizioni dei giovinastri che si stavano facendo largo a colpi di lupara. Volevano dargli una strigliata, per questo affiancarono i commercianti di vino, sostenendoli e, soprattutto, armandoli. Gaetano Parrello, “U lupu i notti” lo avevano già ammazzato il 25 settembre del 1986. Dopo di lui, altri lutti, altro sangue. Caddero a decine da una parte e dall’altra. Il 2 novembre del 1988 sarà ricordato per la strage dei fratelli Merlino, caddero infatti Valerio, Liberante e Antonio.
Pochi mesi dopo Giuseppe e Rosario Sgrò. Quest’ultimo, “U Jancu”, non era uno qualsiasi. Era l’uomo che gestiva per conto dei Gallico tutti gli appalti e i grossi lavori che si svolgevano sul territorio. Colpendo lui si colpiva il braccio imprenditoriale ed economico della cosa. Ad ammazzarlo il 4 maggio dell’89 era stato era stato Luciano Merlino, un quarto fratello, dei tre assassinati il 2 novembre precedente. Si disse che c’era anche la sera della strage dei suoi fratelli. E si disse che quella sera vide “Saro” impugnare le armi. Luciano si era dunque vendicato. Aveva lavato sangue con altro sangue, uccidendo Sgrò a Palmi, in pieno centro e in pieno giorno. Condannato per quell’omicidio a 25 anni di carcere, all’uscita si era stabilito a in provincia di Catanzaro. Una scelta imposta dal divieto di permanere nella provincia di Reggio Calabria dettato dal buon senso e dai magistrati. Non c’è un legame accertato tra quanto avvenuto il 5 settembre 2013 e i fatti dell’89. Luciano Merlino è morto con 12 colpi di Ak 47, e forse qualcuno lo ha raggiunto per saldare il conto aperto 25 anni prima. Gaetano Saffioti conosceva Saro “U Jancu”. Già negli anni ’80 quando aveva montato una piccola pala meccanica al trattore per fare lavori di movimento terra, gli aveva chiesto di fare qualche giornata per ripulire i cantieri. Roba di poco conto, portare via i detriti, sistemare il terreno per prepararlo agli scavi di fondazione, robetta. Sarò Sgrò sottolineava che non ce n’era per nessuno, arrogante, prepotente nei modi. Trattava i giovani che si affacciavano sul mercato edile con sufficienza, senza considerazione alcuna. Per loro non c’era da guadagnare, dovevano semplicemente girare alla larga. I cantieri erano tutti nelle sue mani. E anche quando Saffioti si proponeva direttamente ai committenti privati per chiedere di fare qualche lavoro le risposta erano sempre le stesse: “Questo lavoro interessa agli amici”. Saffioti ricorda ancora un committente che gli rispose con tono quasi paterno: “Questo lavoro non potrei fartelo fare, neppure se fossi tu a pagare me. Se un bravo ragazzo e conoscevo tuo padre, per questo ti do un consiglio: Se ti piace questo mestiere prova al Nord, qui non avrai futuro. Qui, questo lavoro è cosa loro”. La morte di Saro, per la verità aveva riacceso qualche illusione in tanti. I giovani che si arrangiavano con piccoli mezzi speravano che qualcosa sarebbe cambiato. Che la pressione si sarebbe alleggerito. Non era così, al primo lavoro sui cantieri si presentarono per riscuotere. Pagò Gaetano. Diede due milioni e mezzo a Ninuzzo Gallico, un moccioso mandato dal clan che si presentò da lui coperto dalla spocchia della famiglia: “Comu simu chi sordi?”. Neanche la guerra di mafia li aveva fermati.
Le voci della paura e quelle delle verità “Signor Saffioti, lei ha paura?”. Quando sei seduto davanti a un tribunale non sai mai quali domande ti saranno rivolte dai giudici o dai difensori. Gaetano, prima di testimoniare contro i suoi aguzzini, aveva immaginato spesso i quesiti che avrebbero potuto rivolgergli, lo intuiva. Da testimone, prima di andare in aula, si era confrontato con i pubblici ministeri: “Saffioti, l’importante è che lei dica la verità. Deve semplicemente raccontare quello che ha detto a noi. Deve solo stare calmo e rispondere”. In realtà non è mai facile. Le aule di tribunale sono fredde, sono ghiacciaie nelle quali l’anima si stacca dal corpo nel tentativo di cercare riparo in uno sguardo amico, in un’espressione accondiscendente, anche solo in una presenza vagamente familiare. Quello che pomposamente viene definito il “banco dei testimoni”, in realtà altro non è che una sedia di legno vecchio e consumato, è l’asta approssimativa di un microfono d’acciaio, è il vuoto che ti si crea attorno. Se qualcuno gli avesse chiesto “Saffioti lei ha paura?”. Gaetano avrebbe istintivamente risposto: “Si, ne ho. Ho paura di questo posto, di questo tempo. Si, ho paura di noi qui, più che di qualsiasi altra cosa”. Gaetano si era confrontato con la paura tante volte. Ed era sempre uguale, e sempre diversa. La paura ha un’infinità di volti. La morte, certo, fa paura. Ma quello che terrorizza di più è l’idea di essere considerato un complice. Di finire in galera trascinandosi dietro la vergogna di essere creduto come loro. Per questo, prima ancora di sapere cosa ne avrebbe fatto, negli anni prima di iniziare a collaborare aveva iniziato a registrare tutto sui nastri audio e con le telecamere. Voleva che restasse traccia della verità. Sarebbe stata la prova del fatto che era vittima e non carnefice. Qualunque cosa fosse successa, qualcuno avrebbe trovato quelle immagini e ascoltato quelle parole. Se lo avessero ammazzato, se lo avessero arrestato, se lo avessero accusato, sarebbe restata una traccia della verità, una memoria. C’è chi scrive tutto sui diari, chi appunta ogni cosa sulle agende. Ma sono parole di chi le scrive. Gaetano Saffioti aveva registrato tutto perché doveva restare una prova certa, non dovevano esserci dubbi, non voleva che ce ne fossero. Lui era la vittima.
Gli “impegni da onorare non finivano mai L’autunno del 1996 era stato particolarmente burrascoso, e il mare si era portato via un pezzo di spiaggia di fronte alla stazione del gas. Le onde si stavano avvicinando pericolosamente agli impianti della Snam tra Scilla e Bagnara, per questo l’azienda era corsa ai ripari incaricando la Demoter di Messina della realizzazione di opere di protezione sulla spiaggia davanti allo stabilimento.Un appalto da 800 milioni di lire per il trasporto e la posa in opera di massi di varie dimensioni che venivano presi in una cava di Lamezia Terme, portati a Favazzina e sistemati lungo il tratto di costa aggredito dal mare. A Saffioti era toccato un sub appalto da 400/500 milioni di lire. Lavoro per mezzi e uomini per circa una anno, appunto tra il ‘96 e il ‘97. Quando Natale Labozzetta fece ingresso nel suo ufficio Gaetano stava fumando il suo mezzo toscano, indaffarato con le carte. Quel quarantenne stempiato che si muoveva con fare incerto non lo aveva mai visto prima. Almeno così gli pareva. Portava un’ambasciata, lo avevano mandato. Quasi si scusava, sembrava imbarazzato. Saffioti se ne accorse subito, era la solita recita. Sempre la stessa. Cambiava qualche dettaglio ma il copione era quello di sempre: “Mi dicono di riferirvi che hanno piacere per il cantiere a Favazzina. E’ una buona cosa che i lavori li facciate voi. Sanno che siete una persona ragionevole, che tenete conto dei doveri. Vengo a nome dei Gramuglia, dicono di farvi sapere che non ci saranno problemi, basta che ognuno abbia quello che è giusto. Fatte il vostro dovere, basta un presente”. Labozzetta ora aveva finito di recitare la sua parte, se ne stava seduto davanti a Saffioti in silenzio. Attendeva la risposta. Che fu quella di sempre: “Non ci sono molti margini di guadagno in questo lavoro, siamo stretti, quasi ci rimettiamo. Le tasse ci ammazzano, i controlli, gli operai. E’ tutto un problema. Ma sappiamo stare al mondo, non vogliamo problemi con nessuno. Per quello che posso non mancherò…”. Labozzetta spiegò all’imprenditore che avrebbe dovuto fare qualche assunzione su indicazione del clan e che sempre attraverso la cosca avrebbe dovuto utilizzare alcune ruspe e camion “locali”. Labozzetta evidentemente era una seconda fila della cosca, forse meno. Sopra lui c’era Gramuglia e più in alto i Nasone-Gaietti. I primi giorni di cantiere sono sempre i più frenetici, c’è tanta gente che si muove rapida. In quella confusione di uomini e mezzi arrivò il boss Domenico Nasone. Camminava deciso, con fare arrogante chiese del “capo”, e senza troppi giri di parole andò dritto al punto: voleva che suo fratello Rocco fosse assunto. E così avvenne. Ufficialmente venne preso in carico dalla Demoter, di fatto lo pagava Saffioti, che così pensava di aver chiuso la partita pagando la sua tangente al clan locale. Sbagliava, le richieste dei Nasone non erano finite, il fratello doveva essere preso e con lui anche la sua ruspa che, si fa per dire, avrebbe lavorato sul cantiere. I Nasone non ne vollero sapere e l’imprenditore a fine lavori dovette sborsare un pizzo da 25 milioni di vecchie lire per “l’affitto” di quel camion che non trasportò mai neanche un metro cubo di terra. Sbagliò Gaetano quanto pensò che avendo per quei lavori assunto personale ed impiegato mezzi che non gli erano necessari, di poter assolvere a quella “obbligazione” consegnando al Gramuglia la somma di 4 milioni lire. Dopo quattro giorni Gramuglia tornò a cercare l’imprenditore. Diceva che le persone a cui aveva consegnato i soldi glieli rimandavano indietro, perché quel denaro rappresentava per loro una vera e propria “elemosina”. Chiuso il cantiere e ritirate le macchine nessuno, men che meno Gaetano, pensava che le cose sarebbero rientrate senza colpo perire. E infatti, un anno dopo, “quelli” tornarono a ricordargli “gli impegni da onorare”. Questa volta andarono a “prenderlo” a Palmi, a casa sua. Se lo ricordava bene quel giorno maledetto Saffioti. Si erano presentati in quattro. Uno si era fermato al cancello d’ingresso, un altro sulla soglia dell’ufficio. In due gli erano andati incontro spingendolo verso l’interno della stanza.
Gli avevano urlato in faccia il veleno che si portavano dietro. Dicevano che era tempo di pagare. Saffioti sorpreso dalla violenza di quei gesti se ne era restato rigido sulla spalle, con le mani nelle tasche della giacca. Gaetano era armato, non se lo ricorda più per quale ragione, ma quella sera era armato. Nella mano nascosta dalla tasca della giacca impugnava la pistola. Una piccola calibro 6 e 65. Fu quando uno dei due gli mise le mani in faccia che l’idea di difendersi gli attraversò come un lampo la mente. Mentre quello gli afferrava l’orecchio Saffioti immaginò di estrarre l’arma e far fuoco.
Mentre era immerso in quella successione di immagini, l’uomo che gli aveva vomitato contro gli ultimi insulti, aveva fatto cenno all’altro ed entrambi si allontanarono rapidi. Erano spariti così come era comparsi, portandosi dietro la loro scia di puzzo di sudore e violenza e lasciandosi alle spalle una stanza piena del vuoto che soltanto la paura sa impastare. Fu quella sera che decise che era necessario iniziare a lasciare tracce della verità. Decise che, da quel momento avrebbe registrato tutto, ogni istante della sua esistenza di imprenditore. Dovette pagare, tre rate da 5 milioni.
Come i boss mi succhiavano il sangue Signor giudice: “Non bastava pagare, a volte non era sufficiente neppure quello.
In certi casi dovevi accontentarti delle briciole, ti sentivi un estraneo in casa tua. Guardavi i mezzi fermi nei piazzali, gli operai impegnati a far nulla e ti sentivi portar via l’anima sapendo che il lavoro c’era, ma che non era per te. Perché loro avevano deciso così”. Gaetano Saffioti se li ricordava bene quei mesi. I clan si erano fatti famelici. Come iene si avventavano su ogni possibilità di guadagno facile, più che in passato. Quell’anno il Comune di Palmi aveva bandito una gara per la realizzazione di centro polisportivo. Non era un grande appalto, non almeno in termini economici e di guadagno. Era però un discreto lavoro, e sembrava tagliato su misura per le capacità imprenditoriali dell’azienda Saffioti. Poco più di 335 milioni di vecchie lire. Un’occasione buona soprattutto per alcuni subappalti. La Cooperativa Progresso e Lavoro di Polistena lo aveva già contattato per chiedergli un eventuale suo interesse nel caso la stessa si fosse aggiudicata l’appalto. Saffioti avrebbe dunque giocato di sponda, in seconda battuta. Quando la notizia che i polistenesi si erano aggiudicati la gara iniziò a circolare, Saffioti sentì quel lavoro come cosa fatta. Non c’era nulla insomma che potesse mettersi di traverso tra la sua azienda e i lavori pubblici di contrada Ponte Vecchio. Almeno così sembrava. Invece le cose andarono diversamente. Lo capì quando alla porta del suo ufficio bussò Rocco Gallico. Come sempre non usò mezze misure venendo dritto al cuore della questione. Quei cantieri interessavano, neanche a dirlo, agli “amici”. Formalmente l’esecutore sarebbe stata la ditta Saffioti che avrebbe chiuso ufficialmente il contratto con i polistenesi per i sub appalti. Poi, invece, le opere sarebbero state realizzate da un’altra azienda. Lui, Saffioti, avrebbe tenuto per se soltanto la fornitura di calcestruzzo, il resto era cosa loro attraverso il classico sistema della partita di giro. Il Comune pagava la Progresso, questa pagava il subappalto a Saffioti e lui avrebbe “girato” il denaro acquistando formalmente servizi e materiali. Gaetano aveva intuito la ragione di quei passaggi. Era una schermatura in piena regola, indispensabile superare tutta una serie di “snodi” problematici per le “famiglie”. I Gallico non avevano potuto intervenire direttamente perché la “loro” ditta non era iscritta all’albo dei costruttori, ma semplicemente alla Camera di Commercio, e questo dal punto burocrati era un dettaglio di non poca rilevanza. Avrebbe dovuto abbandonare gran parte del lavoro e pagare anche una tangente di 5 milioni per il calcestruzzo fornito e la sicurezza sul cantiere. A cantiere aperto arrivò anche la richiesta di assunzioni. Un operaio dei Gallico finì a busta paga di Saffioti che lo doveva retribuire di tasca propria benché di fatto non lavorasse per lui. Stipendi e buonuscita per 4 milioni di lire. A conti fatti quel lavoro si rivelò economicamente un disastro. Fatture alla mano, nel giro di qualche mese l’azienda a fronte di incassi pari a 118 milioni emise assegni per 152 milioni.
L’incontro con il “don” dei Piromalli Ogni volta che Gaetano Saffioti passava per lo stradone grigio del porto di Gioia Tauro ripensa a quella storia. Da Palmi ci vogliono pochi minuti di macchina. Eppure sembra di superare un confine. Palmi è Palmi, ma Gioia e Rosarno sono tutta un’altra storia.
Nel regno dei Piromalli e dei Bellocco l’aria è più pesante ancora. La mafia la senti nelle narici. Dallo stradone Saffioti guardava quei grandi piazzali e ripercorreva con la mente quegli anni. I più complicati della sua vita, i più pesanti. Ne sono passati tanti di anni, e a guardare quelle distese di container gialli e rossi a ridosso dei moli, sembrava che nulla fosse cambiato. Lo stesso odore di cemento e acciaio, di lavoro e sudore, di arance e mare. E di polvere e di ‘ndrangheta. Era il 1999 quando il commendator Francesco Persia sbarcò a Gioia Tauro.
L’imprenditore pugliese aveva appena saputo che la sua società si era aggiudicato l’appalto bandito dall’Asi (Area strategica industriale) per realizzare una via di corsa e un piazzale-deposito nel quale ospitare i container in transito da Gioia Tauro. Scatole di ferro scaricate dalle grandi navi che attraversavano l’oceano per poi essere nuovamente caricate su cargo di dimensioni più contenute in partenza per i porti del Mediterraneo. Transhipment lo chiamano quelli delle multinazionali del trasporto merci.
L’impresa Persia si era aggiudicato il terzo lotto, quello che ricadeva in un fazzoletto di terra a cavallo tra i comuni di Rosarno e San Ferdinando. Un lavoro a base d’asta di 14 miliardi di lire. Saffioti aveva letto la notizia sul giornale e come altre volte aveva sperato di entrare nell’affare. Così iniziò a proporsi come da copione. Mandò le credenziali e i preventivi di spesa. Ma dalla Persia niente, le sue proposte inizialmente restarono lettera morta. Fin quando sulla sua strada non incrociò di nuovo Pasquale D’Agostino, uomo delle famiglie, che lo rassicurò. Gli disse che se voleva “gli amici” potevano farlo entrare nell’affare, che poteva essere della partita. D’altra parte quel lavoro era loro. Poco dopo l’emissario dei clan gli aveva detto chiaro e tondo come stavano le cose: “Se lavori a 36 mila lire al metro cubo guadagni bene, noi ci prendiamo 3 mila lire e 33 restano a te. Anzi, visto che questo è un lavoro mio, facciamo che tu fatturi a Persia a 33 mila lire e siamo a posto così, nessuno di chiederà più niente».
Saffioti pensò di aver trovato l’accordo. Avrebbe dovuto pagare certo, i margini di guadagno non sarebbero stati quelli sperati, ma poteva starci dentro e non avere seccature.
Chiudere il contratto era stata una pura formalità. Era già stato tutto stabilito dall’emissario del clan Bellocco. Ad aprile del 2001, proprio il giorno della firma del contratto tra Saffioti e la ditta Persia, scattò l’operazione Conchiglia.
In manette gli uomini dei clan che si occupavano di appalti. Una scossa che di fatto, e contrariamente alle aspettative di Gaetano, e forse anche di Persia, non spostò niente rispetto alla richiesta estorsiva dei Bellocco, ma che anzi rappresentò la prima di una lunga fase di corsi e ricorsi dai tratti quasi paradossali. Dieci giorni dopo, quando la fornitura dell’imprenditore palmese al cantiere del porto era già in corso, alla porta del suo ufficio bussò un nuovo personaggio. Uno sconosciuto che gli disse che “qualcuno voleva incontrarlo”. Si trattava di Filippo Raso, secondo cui l’accordo preso in precedenza altro non era che un patto per alcune forniture. Nella sostanza gli inerti per il cantiere Persia erano cosa loro. Di conseguenza sarebbero stati loro, attraverso la loro cava, a fornire il componente base per realizzare il calcestruzzo nell’impianto di Saffiori. La cosca “per venirgli incontro” gli avrebbero fatto un buon prezzo. Ossia 11 mila lire al metro cubo tutto compreso, contro le 16 mila lire che altri fornitori facevano normalmente. Era terraccia, materiale inutilizzabile. Tanto da essere costretto a miscelare quel materiale con pietrisco buono acquistato da altri fornitori. Un accordo che tra l’altro si rivelò anche peggiore quando si scoprì che i camion di Raso dichiaravano un carico di molto superiore a quello che in realtà trasportavano. Fu in quella fase che Gaetano venne chiamato al cospetto di Gioacchino Piromalli. Latitante e al vertice della “famiglia” più potente di Gioia Tauro. Gaetano sapeva chi aveva di fronte e sapeva che la sua vita in quel momento valeva poco. Una parola sbagliata, un riferimento inopportuno, un sospetto e i suoi giorni sarebbero finiti. Piromalli lo stette ad ascoltare per alcuni minuti che a Gaetano erano sembrati infiniti, poi fu lui a parlare. E dettò le regole. Avrebbe anche potuto continuare a lavorare sul territorio di Gioia Tauro sia negli appalti pubblici che privati. Ma non avrebbe potuto fare movimento terra. Quel settore spettava agli “amici” e lui non avrebbe dovuto metterci il naso. Poteva invece fare le forniture di calcestruzzo e di misto cementato. I clan avrebbero avuto 5 mila lire per ogni metro cubo che da quel momento in poi sarebbe passato sul loro territori, il resto non era affar loro. Prendere o lasciare. Anzi, prendere e basta. Ora Gaetano era schiacciato. Doveva dare 3 mila lire al metro cubo di materiale ai Rosarnesi, altre 5 mila ai Piromalli per il passaggio delle forniture da Gioia Tauro ed in più era costretto a prendere il materiale inerti sempre dagli stessi. E non è finita. Negli stessi mesi Gaetano Saffioti aveva incontrato il commendatore Persia e suo nipote. I due imprenditori si erano lamentati dei costi del calcestruzzo. Gli avevano chiesto di abbassare il prezzo. In cambio erano disposti a fare qualche concessione. Evidentemente anche loro erano strangolati dalle continue richieste estorsive. Era chiaro. A parità di fattura, gli proposero, avrebbe potuto mettere meno cemento nell’impasto. Il misto cementato invece di avere cemento al 60 o al 45, come da contratto, ne avrebbe potuto contenere di meno, si poteva scendere anche al 30. I baresi ipotizzano di realizzare i piazzali con il classico sistema del panino. In fondo allo scavo avrebbero messo calcestruzzo di bassa qualità, in mezzo ci sarebbe finito uno strato di inerti senza cemento e in superficie si sarebbe fatto uno strato di alcuni centimetri di impasto buono. Ci sarebbe stato un risparmio nei materiali e un margine di guadagno maggiore per tutti, le fatture sarebbero state fatte comunque come da accordi precedenti. L’azienda sarebbe stata garantita e in caso di eventuali controlli le carte sarebbero state in regola. Saffioti aveva deciso a quel punto di lasciare il lavoro. Aveva detto no, questo no.
Il giorno che mi sono ripreso la mia vita Il giorno che Gaetano Saffioti decise di denunciare era arrivato. La sua storia è stata raccontata in aula davanti ai giudici che avrebbero condannato boss, tirapiedi e complici di 8 clan diversi della Piana di Giaia Tauro. I più potenti del tirreno Reggino: «Signor giudice, l’assedio di Oppido Mamertina mi ha fatto capire in maniera definitiva che non potevo più andare avanti. Che dovevo trovare il modo di riprendermi la mia vita, la mia dignità, la libertà. A Oppido ho realizzato definitivamente che non avevo via d’uscita, e che se qualche volta avevo pensato che ve ne fosse una, che prima o poi le cose sarebbero cambiate, mi ero sbagliato. Avevo il dovere di riprendermi la mia esistenza, ed ero pronto a pagarne le conseguenze». Alla fine del 1998 quelli della Demoter di Messina erano tornati a contattare la ditta Saffioti. Lo conoscevano già, e sapevano che con lui si lavorava bene. Dal loro punto di vista, il cantiere di Favazzina si era concluso senza intoppi. I guai patiti da Saffioti con il clan Nasone non avevano riguardato la loro azienda. A Oppido però le cose erano cambiate. Sono i mesi in cui Gaetano Saffioti matura la necessità di riprendersi la sua vita, ormai stanco, abbrutito dallo stress quotidiano di quei rapporti malati. Era avvilito. Non per i soldi pagati ai clan e per i mancati guadagni sottratti alla propria famiglia, quello che più gli faceva male era la certezza che su quella strada non ci sarebbe stata alcuna possibilità di crescita per l’azienda. Non riusciva più a immaginare e progettare un futuro. Amava quel lavoro, gli piaceva studiare i dettagli e ideare soluzioni operative e, tuttavia, invece di dedicarsi a ciò che più lo gratificava era costretto a correre di cantiere in cantiere a seconda dei desiderata di boss e reggi panza. Una vita impossibile che lo logorava e, giorno dopo giorno, distruggeva la sua azienda, ossia quello che di più bello era riuscito a fare mettendoci anima e testa. Anche per quelle opere Saffioti era stato “avvicinato” dagli amici che, anche in quella occasione, gli spiegarono come sarebbe andata l’operazione. L’imprenditore, per aggiudicarsi il subappalto della Demoter, avrebbe dovuto proporre un ribasso del 3% sul valore delle opere, invece che del 6%. Dal punto di vista dell’appalto si trattava di un guadagno superiore, ma c’era anche il rischio di vedersi rifiutare l’offerta. Invece la Demoter non fece una grinza, accettò di perdere 18 milioni di lire sull’unghia. E accettò di farlo perché molto probabilmente qualcuno consigliò all’azienda che quella era la cosa giusta da fare. D’altra parte, 18 milioni erano il «prezzo» da pagare per non avere problemi sul cantiere e, soprattutto, per non avere più alcun contatto con gli uomini dei clan. Saffioti, dal canto, suo avrebbe versato 40 milioni, più o meno il 6 per cento dell’appalto.Secondo le regole delle «famiglie» di Oppido, in questa maniera, una metà della tangente sarebbe stata pagata dall’azienda madre Demoter e l’altra metà dal subappaltatore Saffioti. Partita chiusa? No, Saffioti avrebbe dovuto utilizzare i mezzi delle famiglie, al prezzo da loro stabilito. E avrebbe dovuto assumere gli uomini che loro avrebbero indicato. Una mazzetta che, a conti fatti, avrebbe superato i 100 milioni di lire. Il pizzo, tra l’altro, dovevano essere invisibile. Non è facile tirar fuori, o incassare, decine di milioni di lire senza che nessuno se ne accorga. Per questo alle imprese dei boss fatturavano tutto, e quando non era sufficiente le fatture venivano gonfiate a dismisura. Le ore di lavoro delle pale meccaniche sui cantieri venivano aumentate, i costi crescevano fino all’impossibile. In caso di controlli le carte dovevano essere in ordine e ogni cosa doveva sembrare «normale». Un inferno per Saffioti, costretto a lavorare con il cappio al collo ed esclusivamente per saziare gli appetiti delle «famiglie» di Oppido e delle loro aziende satellite. Era impossibile.
Gli imprenditori “codardi” e la Calabria «Signor giudice, non sono le sbarre a togliere la dignità a un uomo, e non bastano denari e benessere per garantirgliela. La dignità non si compra, si conquista e si difende». Denunciò Saffioti, tra mille incertezze, e paure. Non si fidava dello Stato. Troppe volte lo aveva aspettato invano, tante notti lo aveva invocato pensando al giorno successivo. Non era arrivato lo Stato, nonostante avesse mandato messaggi. Non era arrivato quando aveva denunciato intimidazioni o inviato lettere anonime. Nei mesi del cantiere di Oppido ripensava a tutte le volte che aveva visto i suoi mezzi andare in fiamme, alle lettere di minaccia trovate tra la posta, alle richieste estorsive. In passato Saffioti era andato in caserma tante volte, aveva scritto, parlato con poliziotti, carabinieri e finanzieri. Aveva lasciato intendere tante cose a quegli uomini dello Stato distratti, nella speranza di ricevere un segnale di presenza, un’attenzione. Niente. Da qualche tempo però a Palmi era arrivato un giovane comandante della guardia di finanza. Si chiamava Toni Raimondi. Saffioti aveva avuto modo di scambiarci qualche parola. Una volta si erano incontrati in occasione di un controllo fiscale nel suo ufficio: «Saffioti, lei dovrebbe avere più fiducia in noi. Non siamo suoi nemici, lavoriamo per la gente e anche qui le cose possono cambiare…». E di rimando: «Comandante, qui non cambia niente. Ci diciamo sempre le stesse cose, ma non cambia niente, purtroppo…». Confidava in realtà in un comportamento diverso da quelli visti fino ad allora. La magistratura reggina in quel periodo aveva piazzato alcuni colpi importanti contro i clan della provincia. Con l’operazione «Porto», ad esempio, si era aperto uno squarcio sugli interessi dei clan sul grande approdo di Gioia Tauro. In manette erano finiti alcuni tra gli uomini di vertice dei Piromalli, dei Molè, dei Bellocco e dei Pesce. Boss e picciotti, mezze figure e teste di legno erano finiti nei guai seriamente. L’operazione aveva scalfito soprattutto l’ala imprenditoriale dell’organizzazione che aveva messo le mani su business che ruotavano intorno al porto. Ma c’era di più. Erano affiorati i rapporti con la politica. Era un’inchiesta complessa guidata da Roberto Pennisi, magistrato antimafia che già in precedenza si era occupato di indagini rognose. Saffioti osservava da tempo quel giudice dai modi sbrigativi e diretti. Gli piaceva perché era risoluto e badava al sodo. Ammirava Pennisi, e qualche volta aveva sperato di incontrarlo. Ma non era facile incrociare un magistrato di quella caratura. Difficile riuscire a ritagliarsi uno spazio “discreto” nel quale confrontarsi con lui per tastargli il polso, per sondare possibilità di dialogo vere. In televisione, durante un’intervista, Pennisi aveva detto quella frase: “Non è facile combattere la ’Ndrangheta, servirebbe più collaborazione da parte della gente, della parte sana del tessuto economico. Ma in Calabria gli imprenditori sono tutti codardi”. Quel «tutti codardi» aveva avuto l’effetto di una scarica elettrica allo stomaco di Saffioti. Uno schiaffo inaspettato in piena faccia. Forse quella di Pennisi era stata solo una provocazione. Andò a cercare Raimondi: “Comandante, ma questo Pennisi lo possiamo incontrare?”. Non fece anticamera, il giudice lo aspettava, seduto nel suo ufficio. Ed eccolo Roberto Pennisi, lo vedeva per la prima volta di persona, seduto dietro la sua scrivania, secco come un chiodo. Con la sigaretta in mano, il posacenere stracolmo e il tavolo traboccante di fascicoli. Occhi vispi sopra un paio di baffetti d’altri tempi, il tutto appiccicato su una faccia asciutta e scavata come una fiumara in agosto. Per Saffioti era tempo di prendersi una rivincita: “Dottore, volevo dirle che io sono un imprenditore, e non sono un codardo”. Si era sentito meglio dicendoglielo. Era stato come far saltare il tappo all’anima. Un pozzo dal quale sarebbe venuto fuori tutto. Aveva iniziato a parlare Gaetano Saffioti, aveva raccontato quello che forse nemmeno a se stesso aveva mai detto. Nel farlo aveva visto gli sguardi di Pennisi e Raimondi incrociarsi rapidi, increduli. Aveva raccontato tutto Saffioti e aveva messo sul tavolo le prove. Filmati, cassette audio, documenti. Li aveva inchiodati.
Il silenzio profondo di PalmiGaetano Saffioti l’aveva immaginata mille volte quella giornata, ben prima che diventasse realtà. Ne aveva vissuto i suoni, le voci, gli odori, i colori. Nella sua testa, come in un film d’altri tempi, erano passate le sirene, le irruzioni dei baschi verdi, le manette ai polsi, le urla delle donne, i pianti dei bambini. Aveva visto in anticipo le facce dei suoi aguzzini deformarsi di rabbia, le loro espressioni sfrontate, gli occhi cattivi e interrogativi puntati sulle facce di quelli che erano andati a prenderli per portarli via. Aveva già visto tutto tante volte, compreso il dubbio che, sia pure per poche ore, avrebbe lacerato quelle menti criminali. Aveva visto l’incredulità. Il crollo delle sicurezze di chi in quella terra si è sempre pensato al di sopra della legge, dello Stato e persino di Dio. Era un’alba fredda del gennaio 2002 e se la ricordava sua madre quando riceveva le telefonate della «maffia», se la ricordava piangere, in silenzio, mentre a lui, ancora bambino, si stringeva il cuore. E stava in silenzio anche lui. In attesa che il tempo passasse in fretta e portasse le risposte che non aveva ancora. Il tempo, già. Quanto ne aveva sacrificato sull’altare de “le cose cambieranno”. Aveva già visto tutto Gaetano. E aveva immaginato mille epiloghi per quella storia che aveva contribuito a scrivere, ma di cui non poteva conoscere il finale. Cosa avrebbero detto di lui i suoi fratelli e le sue sorelle? Chi di loro avrebbe capito e fino a che punto? Chi, tra Giuseppe, Domenico, Grazia, Antonio e Maria Luisa, avrebbe compreso fino in fondo quel gesto? Per non parlare poi dello scrupolo, della paura, del terrore rappresentato dal fatto che loro, e le loro famiglie, da quella notte avrebbero potuto subire la ritorsione feroce dei clan. Anche quello doveva mettere in conto, e non era facile. Attese Gaetano Saffioti, attese l’alba sapendo che niente avrebbe più potuto riportarlo indietro. L’attese nervosamente camminando su e giù tra le stanze, e da casa all’ufficio. Attraversò mille volte il piccolo piazzale che separa i due fabbricati, vigile ad ascoltare la notte in cerca di un qualche suono, di un cenno, anche solo di una voce distante. L’aria non portava nulla. Alle cinque del mattino era come se Palmi non volesse svegliarsi, come se la campagna avesse deciso di prolungare la notte. Persino l’orologio biologico dei contadini che all’alba si muovevano verso i poderi pareva essersi fermato. Nessuna macchina aveva intenzione di mettersi in moto. Silenzio, solo silenzio. Dopo pochi minuti iniziarono ad arrivare alcuni operai. Fu quello il primo segnale che aveva fatto capire a Saffioti che il futuro sarebbe stato diverso. Quella mattina i cantieri sarebbero rimasti chiusi, e anche l’azienda. Su 30 dipendenti solo in quattro avevano deciso di andare a lavorare per quell’imprenditore che era appena stato marchiato a fuoco con il simbolo dell’infame. Quattro su trenta, in una terra dove il lavoro è merce rara e dove chi ti paga regolarmente è ancora più raro del lavoro stesso. Quando c’è di mezzo la ’Ndrangheta, non c’è lavoro che tenga, non c’è bisogno, non c’è necessità, non c’è alibi. O stai da una parte o stai dall’altra. E per complicità, paura, omertà o altro in ventisei quella mattina avevano deciso di non stare dalla parte di chi per anni aveva dato loro il pane. Il muro contro Saffioti, che in mille modi si sarebbe manifestato anche in futuro, quella mattina aveva iniziato a essere innalzato, mattone dopo mattone. Da quel momento in poi, Saffioti sarebbe stato da una parte e tutti gli altri dall’altra. Lo avrebbe imparato a sue spese Gaetano. Amici, colleghi, istituzioni, politici e persino pezzi della sua stessa famiglia non sarebbero più stati al suo fianco. Era solo, e lo sarebbe stato a lungo. Dall’altra parte del muro, assieme al resto della società, c’erano anche loro: i quarantotto finiti in galera quella notte e il centinaio di indagati che facevano loro compagnia sulle carte dell’inchiesta. Oltre quel segno immaginario, c’era chi da quel momento in poi l’avrebbe odiato per tutta la vita e gli ignavi. Quelli che si nascondevano ogni volta dietro i «ma», i «però», i «forse», i «non sono convinto»; come sempre, più o meno consapevolmente, stavano seduti accanto alle famiglie Bellocco di Rosarno, Gallico di Palmi, Mazzagatti-Ruffa di Oppido Mamertina, Nasone di Scilla, Piromalli e Romeo di Gioia Tauro, Mammoliti-Rugolo di Castellace. Un esercito di mafiosi e complici, di criminali e fiancheggiatori, di boss e tirapiedi che anche in quell’occasione poteva contare sulle truppe senza soldo arruolate nella società. Nando Dalla Chiesa, ricordando il giudice Giovanni Falcone, ha scritto che «la mafia non ha bisogno di complici, gli bastano i cretini». A questi possono essere aggiunti i «pavidi». La sostanza non cambia, il silenzio, fatto di parole o atteggiamenti, è complice. In paese si era sparsa la voce degli arresti, si diceva che ne avessero presi tanti, che la guardia di finanza li avessi portati via all’alba. In tv e sulle radio locali le voci rimbalzavano incerte: “Associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni, danneggiamenti”. Forse una storia di appalti. Era stato un terremoto. Gaetano continuava a tacere, incerto rispetto alla reazione della moglie Caterina, indeciso su cosa dire e come dirlo, insicuro, impaurito, ma sempre determinato. La risposta arrivò in casa quando al tg3 regionale venne data notizia dell’operazione «Tallone d’Achille» della Dda di Reggio Calabria condotta dai pm Roberto Pennisi e Vincenzo D’Onofrio. Un’indagine partita “grazie alla collaborazione dell’imprenditore palmese, Gaetano Saffioti”. Ora era tutto chiaro a Caterina, o meglio, molti tasselli avevano iniziato a prendere il proprio posto in un mosaico ben più articolato. Un quadro che a quel punto Gaetano iniziò a spiegarle. Con calma, tentando di non spaventarla, e raccontando l’essenziale. In maniera da definire la trama generale alla quale, con il tempo, si sarebbero aggiunti altri dettagli. Le raccontò della denuncia, le traversie vissute, i rischi che si era assunto con la collaborazione, e la libertà che aveva deciso di riprendersi assieme alla dignità di uomo, marito, padre e imprenditore. Lui aveva avuto il tempo per maturare la consapevolezza che certe scelte comportano. Ora doveva costruire le condizioni perché anche chi gli stava vicino capisse fino in fondo. E ci voleva tempo. Caterina avrebbe compreso e gli sarebbe stata accanto. Doveva fare i conti con il mondo che lo circondava Gaetano Saffioti, a partire dalla propria famiglia. Fuori dalle mura domestiche sarebbe stato ancora più difficile. Gli operai, uno dopo l’altro, avevano iniziato a licenziarsi, l’attività si stava spegnendo. Nelle settimane successive (e per mesi) di nuove commesse neanche a parlarne. E poi il silenzio. Il silenzio tutto intorno. La gente aveva emesso la sua sentenza prima ancora che arrivasse quella dei giudici. E se qualche anno dopo i magistrati avrebbero deciso per la colpevolezza di quasi tutti gli imputati denunciati dall’imprenditore, la società nel giro di qualche ora aveva stabilito che in quella storia il colpevole era Gaetano. Che anche lui aveva sbagliato. Non una telefonata di solidarietà e vicinanza, non una visita, non una pacca sulle spalle, non uno sguardo amico, non una e-mail o un biglietto. Nulla. Niente di niente, a esclusione di una sola lettera. Una missiva nella quale Saffioti veniva ringraziato per il suo coraggio e per la sua determinazione. Un foglio dattiloscritto e, rigorosamente, anonimo: «capirà le circostanze», si diceva in calce. Palmi aveva di fatto spento la luce, Gaetano Saffioti andava cancellato. Annullato. Per molti, da quel momento in poi, sarebbe stato morto, semplicemente morto.
Un uomo libero oltre il confine Oggi Gaetano Saffiori è un imprenditore di successo, con commesse in diverse parti del mondo. Ha decuplicato il suo fatturato e i suoi cantieri danno lavoro a 400 persone. Non ha mai voluto un euro dallo Stato, non ha mai voluto cambiare identità. Ha mantenuto la sua azienda a Palmi. E’ un esempio, è la dimostrazione che denunciare si può e che conviene. E’ questa la sua più importante vittoria. Tra le cose più belle che ha scritto che un pensiero sul confine che divide la legalità e la libertà. Scrive Saffioti: “Quel confine non lo avevo visto, per me esisteva soltanto sulla carta. Nella vita reale non c’era. Non c’era quando alle 5 di mattina montavo sulla ruspa o sull’escavatore. Non c’era quando l’impianto di calcestruzzo si metteva in moto fragorosamente. Non c’era quando si gettavano i solai o si posavano i tubi di un nuovo acquedotto. Non c’era quando bisognava pagare gli stipendi agli operai e non c’era neppure quando gli esattori delle cosche venivano a riscuotere le tangenti. Quel confine, allora, per me non c’era. C’erano il lavoro, la voglia di far bene sui cantieri e di far crescere l’azienda. C’era la fatica e c’erano “quelli”, i mafiosi, da guardare ogni giorno negli occhi. C’erano i camion che prendevano fuoco di notte, c’erano le minacce, c’erano le lettere anonime, c’erano le mille angherie e c’erano i silenzi. Non c’era confine tra una cosa e l’altra, e non c’era neppure lo Stato. Per questo motivo quello che per pochi era un confine, per altri (me tra questi) era una linea fumosa e indefinita, che non ti rendevi conto di attraversare tutti i giorni”. E ancora: “Io un confine lo volevo, speravo che ci fosse e facevo di tutto perché quel segno diventasse un punto fermo. Invece, ogni volta che provavo a tracciare un solco tra me e loro era come arare sul bagnasciuga di una spiaggia sabbiosa. Tutto veniva cancellato in pochi istanti dall’ennesima onda. Ho scoperto che un confine esisteva quando ho deciso di non volerlo più attraversare. Non è stato facile, ma ora quel confine c’è ed è bene in evidenza. Su quella traccia ho alzato un muro. Da una parte loro, dall’altra io. Da una parte l a legalità, dall’altra la schiavitù dell’anima. Da una parte la corruzione dei pensieri e della vita, dall’altra la dignità. Non è stato semplice. Quel muro è fatto di mattoni spessi, messi in fila faticosamente uno dietro l’altro. Paura, sacrificio, incertezza, dolore, affetti negati, tradimenti, delusioni, isolamento. È stata dura. Poi quei mattoni li ho però saldati con la malta della solidarietà, della lealtà, dell’amicizia, del riconoscimento, ma soprattutto con la possibilità di tornare a guardare la mia immagine allo specchio o mio figlio e mia moglie negli occhi”. Conclude così Gaetano Saffioti: “Il confine è spesso sinonimo di immagini spiacevoli, è esclusione, è barriera, è paura dell’altro. Io, invece, ho imparato che può essere futuro. È vero che sono meno libero fisicamente, che passo giornate intere tra poche mura, ma è nella mia testa e nel mio cuore che mi sento finalmente libero. E ora guardo liberamente al mio avvenire e all’avvenire della collettività. Ho fatto una scelta creando quel confine e alzando quel muro. Ho scelto di morire da uomo libero”.
La storia di Gaetano di ATTILIO BOLZONI E’ rimasto nella sua Calabria, non se n’è voluto andare. Non ha cambiato identità, la sua azienda è ancora a Palmi, nella grande piana. E poi non ha mai chiesto un centesimo allo Stato. Mai una protesta, mai un’intervista sopra le righe, mai una “piazzata“ davanti a un Tribunale o a una Prefettura per gridare la sua solitudine o – come usano alcuni suoi colleghi che hanno capito come funziona – a battere cassa, chiedere soldi e ancora soldi e sempre soldi. Ha fatto quello che sentiva di fare. E oggi, nel bene e nel male, fa i conti con la sua scelta di libertà. Gaetano Saffioti è un esempio molto raro di calabrese e di imprenditore. Qui raccontiamo la sua storia raccolta da Giuseppe Baldessarro – che già l’anno scorso aveva scritto un bel libro (“Questione di Rispetto”, Rubbettino editore) – da quando ha conosciuto la ‘Ndrangheta da bambino sino al giorno che ha deciso di non sottostare più ai ricatti e alle umiliazioni dei boss. E’ un testimone di giustizia, dal 2002 è sotto scorta per avere denunciato i più pericolosi capibastone della Piana, terra fertile e terra maledetta, giardini di aranci e l’inferno dei Piromalli, dei Bellocco, dei Gallico, dei Nasone. Nomi che fanno sprofondare una regione intera negli abissi, uomini che sono stati sfidati da un piccolo imprenditore che per anni e anni aveva subito estorsioni fino a quando si è ripreso la sua dignità. Nel racconto di Giuseppe Baldessarro c’è tutta la vita di Gaetano. Dal giorno che per la prima volta ha sentito parlare di “maffia” (con due “f”, come si diceva una volta) alle prime richieste di denaro per poter aprire i suoi cantieri, dalla paura che ha accompagnato la sua esistenza sino al coraggio di presentarsi davanti a un ufficiale della Guardia di Finanza a un procuratore della repubblica. E’ una storia semplice quella di Gaetano Saffioti. E nella sua semplicità spaventosa. Non solo per la ferocia degli aguzzini della ‘Ndrangheta, soprattutto spaventosa per la viltà di coloro che stanno intorno a carnefici e a vittime, per la loro rassegnazione, la sottomissione. Con il suo gesto Gaetano mostra a tutti noi che si può fare. Lui l’ha fatto. LA REPUBBLICA
Gaetano Saffioti – imprenditore – video
BIBLIOTECA di COMO – 12 Giugno 2018 – ore 14 STORIA DI RESISTENZA ALLE MAFIE il testimone di giustizia sul racket in Calabria Gaetano Saffioti insieme a Giuseppe Baldassarre giornalista di Repubblica Le immagini dell’incontro in biblioteca