”Possibili gruppi di potere estranei a Cosa nostra” nella strage di via d’Amelio
PROCESSO D’APPELLO “BORSELLINO QUATER”
I magistrati non credono che Borsellino fu ucciso per la Trattativa: “Non può condividersi l’assunto difensivo secondo cui la ‘Trattativa Stato-mafià avrebbe aperto “nuovi scenari” in relazione alla “crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali” e al possibile collegamento fra “la stagione degli atti di violenza” e l’occasione di “incidere sul quadro politico italiano”
BORSELLINO QUATER, I GIUDICI: “NELLA STRAGE DI VIA D’AMELIO POSSIBILI INTERESSI CONVERGENTI DI GRUPPI DI POTERE ESTRANEI A COSA NOSTRA Con 377 pagine i giudici della corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta motivano la sentenza emessa il 15 novembre 2019: ergastolo per i boss Tutino e Madonia, 10 anni per i falsi pentiti Andriotta e Pulci. I magistrati non credono che Borsellino fu ucciso per la Trattativa: “Non può condividersi l’assunto difensivo secondo cui la ‘Trattativa Stato-mafià avrebbe aperto “nuovi scenari” in relazione alla “crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali” e al possibile collegamento fra “la stagione degli atti di violenza” e l’occasione di “incidere sul quadro politico italiano” “E’ possibile che la decisione di morte assunta dai vertici mafiosi nella corale riunione degli auguri di fine anno 1991 della Commissione provinciale e nelle precedenti riunioni della Commissione regionale, abbia intersecato convergenti interessi di altri soggetti o gruppi di potere estranei a Cosa nostra”. Lo scrivono i giudici del processo d’appello ‘Borsellino quater‘ nelle motivazioni della sentenza emessa il 15 novembre 2019 e adesso depositate in cancelleria. Si tratta dell’ultima “verità giudiziaria” sulla strage di via d’Amelio, in cui il 19 luglio del 1992 morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta. “Le numerose dichiarazioni raccolte dai testi escussi hanno rivelato numerose contraddizioni che non è apparso possibile superare, gettando al tempo stesso l’ombra del dubbio che altri soggetti possano essere intervenuti sul luogo della strage, nell’immediatezza dell’esplosione – scrivono i giudici della corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta nelle 377 pagine di motivazioni – ‘in giacca‘ nonostante la calura del mese estivo e l’ora torrida, non appartenenti alle forze dell’ordine e individuati anzi da taluni agenti intervenuti nella immediatezza come ‘appartenenti ai servizi segreti“. I magistrati sottolineano che “tale ultimo particolare appare ancora più inquietante se si considera che ‘di un uomo estraneo a Cosa nostra ha riferito anche il collaboratore Gaspare Spatuzza, indicandolo come presente nel magazzino di via Villasevaglios, il pomeriggio precedente la strage, veniva consegnata la Fiat 126 che sarebbe stata, di lì a poco, imbottita di tritolo”, aggiunge la corte presieduta dal giudice Andreina Occhipinti con consigliere estensore Gabriella Natale. L’accusa era rappresentata dal Procuratore generale Lia Sava e dai sostituti Antonino Patti, Carlo Lenzi, Lucia Brescia, Fabiola Furnari. La sentenza ha confermato le condanne all’ergastolo per i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, il primo come mandante, in qualità di reggente della famiglia di Resuttana, ed il secondo tra gli esecutori della Strage di via d’Amelio del 19 luglio 1992. Condannati a 10 anni di carcere per calunnia anche i ‘falsi pentiti‘ Francesco Andriotta e Calogero Pulci, che avevano confermato molte delle menzogne riferite da Vincenzo Scarantino (per cui il reato di calunnia è stato prescritto): è il più grande depistaggio della storia italiana ed è stato smontato solo dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza. “La strage di via D’Amelio – continua la sentenza depositata dai giudici nisseni – rappresenta indubbiamente un tragico delitto di mafia, dovuto a una ben precisa strategia del terrore adottata da Cosa nostra, in quanto stretta dalla paura e da fondati timori per la sua sopravvivenza a causa della risposta giudiziaria data dallo Stato attraverso il Maxiprocesso“. Nello specifico secondo la corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, “ogni tentativo della difesa di attribuire una diversa paternità a tale insana scelta di morte e terrore non può trovare accoglimento, potendo, al più, le emergenze probatorie indurre a ritenere che possano esservi stati anche altri soggetti o gruppi di potere interessati alla eliminazione del magistrato e degli uomini della sua scorta”. “Ma tutto ciò – dicono – non esclude la responsabilità principale degli uomini di vertice dell’organizzazione mafiosa che, attraverso il loro consenso tacito in seno agli organismi deliberativi della medesima organizzazione, hanno dato causa agli eventi di cui si discute”. Per i giudici della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta sottolineano anche che “non si hanno elementi in grado di adombrare profili di erroneità nella ricostruzione del momento deliberativo della strage e nella configurazione della ‘paternità mafiosa della stessa“. “Non è sufficiente che il proposito di rendere dichiarazioni calunniose sia stato ingenerato nell’imputato Vincenzo Scarantino – continua la sentenza – da una serie di discutibili e inquietanti e iniziative poste un essere da alcuni investigatori che hanno esercitato in modo distorto i loro poteri, con il compimento di una serie di forzature, tradottesi in indebite suggestioni e nella agevolazione di una impropria circolarità tra diversi contribuiti dichiarativi, tutti radicalmente difformi dalla realtà”. Per il depistaggio delle prime indagini sulla strage Borsellino sono attualmente a processo i poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di calunnia, aggravata dall’aver favorito Cosa nostra. Secondo la corte d’Assise d’Appello nissena, poi, non ci sarebbe un collegamento tra la Trattativa Stato-mafia e la morte di Borsellino, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’Assise di Palermo nel processo concluso nel 2018 per mafiosi, ufficiali dei carabinieri e politici. “Non può condividersi l’assunto difensivo secondo cui la ‘Trattativa Stato-mafià avrebbe aperto “nuovi scenari” in relazione alla “crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali” e al possibile collegamento fra “la stagione degli atti di violenza” e l’occasione di “incidere sul quadro politico italiano” con riferimento a coloro che “si accingevano a completare la guida del paese nella tornata di elezioni politiche del 1992. Invero, gli elementi acquisiti nel presente procedimento consentono di affermare che l’uccisione del giudice Paolo Borsellino, inserita nell’ambito di una più articolata “strategia stragista” unitaria, sia stata determinata da Cosa Nostra per finalità di vendetta e di cautela preventiva”. Per i giudici nisseni, poi, “è anche logico affermare che vi sia stata una finalità di ”destabilizzazione’ intesa ad esercitare una pressione sulla compagine politica e governativa che aveva fino a quel momento attuato una drastica politica di contrasto all’espansione del crimine organizzato mafioso”, scrivono i giudici. I magistrati considerano le indagini sulla strage avvolte ancora dai “coni” d’ombra: “Le emergenze probatorie acquisite nel procedimento costituiscono singoli pezzi di un mosaico che, nel suo complesso, continua a rimanere in ombra in alcune sue parti. Basti pensare alla ‘scomparsa misteriosà dell’agenda rossa del magistrato e alla ricomparsa della borsa stessa in circostanze non chiarite nell’ufficio di Arnaldo La Barbera”. IL FATTO QUOTIDIANO 20.1.2021
Sono state depositate le MOTIVAZIONI del processo di appello del Borsellino quater. Questi alcuni passaggi sul movente.
La cosiddetta trattativa Stato Mafia non ha nulla a che fare con la strage di Via D’Amelio. Anzi, non ha nulla a che fare con tutte le stragi mafiose, a partire da quella di Capaci fino alle bombe “continentali” del 1993. Non solo, respingendo la tesi difensiva dei boss, si apprende che «gli elementi acquisiti nel presente procedimento consentono di affermare che l’uccisione del giudice Paolo Borsellino, inserita nell’ambito di una più articolata “strategia stragista” unitaria, sia stata determinata da Cosa Nostra per finalità di vendetta e di cautela preventiva».
Parliamo delle motivazioni, appena depositate, della sentenza d’appello del Borsellino Quater. La corte d’assise d’appello di Caltanissetta scarta la tesi sulla trattativa: non è di sua competenza, c’è una sola sentenza e pure non definitiva, ma soprattutto non c’entra nulla con la casuale delle stragi.
E’ proprio la Corte che, confermando le condanne di primo grado nei confronti dei boss Vittorio Tutino e Salvo Madonia (oltre i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci), si sofferma sulle cause che hanno determinato la strage, in cui persero la vita Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Quali? L’esito del maxiprocesso e il suo interessamento al dossier mafia appalti. Queste le conclusioni che l’Assise d’Appello di Caltanissetta riversa nella sentenza, in particolare traendo le mosse dalle parole del pentito Giuffrè, sui «sondaggi» con «personaggi importanti» effettuati da Cosa Nostra prima di decidere l’eliminazione dei magistrati Falcone e Borsellino, ma anche ricordando i sospetti che lo stesso Paolo Borsellino il giorno prima dell’attentato aveva confidato alla moglie, quando le disse «che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo …ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò accadesse». Ed è proprio sulla base di tali evidenziate “anomalie”, si legge sempre nelle motivazioni, che «i Giudici di primo grado avevano disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministro per le determinazioni di competenza su eventuali condotte delittuose emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale».
Il punto non è di poco conto. Soprattutto nel momento in cui si organizzano convegni o si fanno “inchieste” televisive, invitando i soliti magistrati che puntualmente omettono i problemi che Borsellino ebbe all’interno della procura. Purtroppo accade sempre più spesso che quando nelle interviste si riporta questa oramai celebre frase che Borsellino confidò alla moglie Agnese, se ne dimentichi tuttavia la parte finale con il riferimento che il giudice fece ai suoi colleghi, i magistrati. La memoria non ha fatto gli stessi brutti scherzi alla Corte, che invece non ha dimenticato di darne rilievo, richiamandola con riferimento alle dichiarazioni testimoniali che rese la moglie di Borsellino. Non solo. Sempre nella sentenza viene citato il fatto che l’arrivo di Borsellino nel nuovo ufficio della Procura di Palermo «era stato percepito con preoccupazione da Cosa Nostra, al punto che Pino Lipari (vicino ai vertici dell’organizzazione maliosa) aveva commentato il fatto dicendo che avrebbe creato delle difficoltà a “quel santo cristiano di Giammanco”».
Ricordiamo che per i corleonesi, Lipari è stato un “consulente” che si occupava di pilotare gli appalti pubblici in modo da affidarli a imprese vicine ai boss. Il suo nome apparve anche nel famoso dossier mafia appalti scaturito dall’indagine degli ex ros Mario Mori e Giuseppe De Donno, condotta sotto la supervisione di Giovanni Falcone. Riprendendo le motivazioni della pronuncia di primo grado, la Corte ricorda anche che «non erano state poche le difficoltà iniziali incontrate dal dott. Borsellino, al quale erano state delegate solo le indagini per le province di Trapani e Agrigento, e non per quella di Palermo». A tal proposito, richiamando la sentenza di primo grado, la Corte le attribuisce il merito di aver ricostruito, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla moglie del magistrato e da alcuni suoi stretti collaboratori e colleghi, «le ragioni del contrasto fra il dottore Borsellino e l’allora procuratore capo della Procura di Palermo, dott. Giammanco, ricordando come tale delega, più volte sollecitata dal dottore Borsellino, gli fosse stata conferita solo la mattina del suo ultimo giorno di vita».
Ma su quale indagine Paolo Borsellino aveva mostrato particolare attenzione dopo la morte del collega ed amico Giovanni Falcone? Erano – si legge nelle motivazioni – «le inchieste riguardanti il coinvolgimento di “Cosa Nostra” nel settore degli appalti pubblici, avendo intuito l’interesse strategico che tale settore rivestiva per l’organizzazione criminale». Tutto qui? No, perché la Corte evoca anche quel famoso incontro tra Borsellino e la dottoressa Lilliana Ferraro, quando insieme avevano anche parlato del rapporto “mafia-appalti” ricevuto, per mano dei carabinieri del Ros, dal Procuratore Giammanco e da quest’ultimo «irritualmente inviato al Ministero della Giustizia, tanto che il dott. Falcone (nel frattempo come noto in servizio al Ministero) ne aveva disposto l’immediata restituzione». Un fatto singolare che fece infuriare Falcone. Sul tema non si manca neanche di precisare che «nel corso del dibattimento erano stati sentiti, come testi, anche i giudici Camassa e Russo i quali avevano riferito di un incontro avuto con il giudice Borsellino, intorno alla metà del mese di giugno, nel corso del quale quest’ultimo, con tono molto amareggiato e con le lacrime agli occhi, aveva detto loro che “qualcuno lo aveva tradito”».
Una sentenza che finalmente riprende in mano ciò che Falcone e Borsellino hanno sempre sostenuto. Ovvero che la caratteristica della mafia è la sua autonomia da qualsiasi potere, agisce da sola e, soprattutto, non ha bisogno di alcun aiuto esterno per compiere gli attentati. E cosi la Corte tiene anche a sottolineare ciò che aveva intuito Falcone con la nascita del pool antimafia, ovvero che «stante il carattere unitario e fortemente centralizzato dell’organizzazione criminale Cosa Nostra, ogni delitto riconducibile a detta organizzazione criminale dovesse essere considerato come l’anello di una lunga catena, e non già come un episodio a sé stante».
Ecco perché secondo la Corte non regge la linea di difesa degli imputati, portati a giudizio per la strage di Via d’Amelio, quando chiama in causa la tesi della trattativa per dire che quel presunto patto avrebbe aperto «nuovi scenari», in relazione alla «crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali» ma anche al possibile collegamento fra «la stagione degli atti di violenza» e l’occasione di «incidere sul quadro politico italiano» con riferimento a coloro che «si accingevano a completare la guida del paese nella tornata di elezioni politiche del 1992». La Corte nella sua sentenza non lascia spazio alcuno a queste argomentazioni difensive, ribadendo che «la strage di Via D’Amelio, inserita nell’ambito di una più articolata “strategia stragista” unitaria, sia stata determinata da Cosa Nostra per finalità di vendetta e di cautela preventiva».
Indubbiamente, però, c’è stata una accelerazione dell’uccisione di Borsellino. Da cosa è dipeso ce lo dicono le motivazioni quando riportano alcuni passi della sentenza della corte d’Assise di Catania: «poteva avere influito l’intervento di potentati economici disturbati nella spartizione degli appalti, la presenza di forze politiche interessate alla destabilizzazione, la necessità di umiliare lo Stato in modo definitivo e plateale». Poi la stessa Corte di Assise di Appello di Catania aveva comunque rilevato che tali ultimi motivi non hanno «creato una frattura rispetto a quelli che determinarono la decisione della strategia stragista, ma si aggiungono ad essi». Si tratta di una sentenza che potrebbe, di fatto, suggerire ulteriori piste da esplorare. A partire dalla causa della strage. Non la presunta trattativa, ma la questione “mafia appalti” che ha anche come sfondo i problemi all’interno dell’allora procura di Palermo. Il tutto è ben cristallizzato in questa sentenza. Tutto ciò potrebbe significare un ulteriore sviluppo delle indagini e la possibilità di arrivare a un Borsellino quinquies? IL RIFORMISTA 19.1.2021
PROCESSO TRATTATIVA STATO-MAFIA
LA TRATTATIVA ACCELERO’ LA MORTE DI BORSELLINO ? Secondo quanto deliberato dai Giudici di primo grado: “Può ritenersi provato oltre ogni ragionevole dubbio che fu proprio l’improvvida iniziativa dei carabinieri del Ros (la trattativa con Vito Ciancimino, nda) a indurre Riina a tentare di sfruttare ai propri fini quel segnale di debolezza delle istituzioni pervenutogli dopo la strage di Capaci” “Non vi è alcun elemento di prova che possa collegare il rapporto Mafia e Appalti all’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione di Borsellino”. Piuttosto “l’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione di Borsellino” fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo, e di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci, pervenuti a Riina attraverso Ciancimino nel periodo precedente la Strage di via d’Amelio”.
LA TRATTATIVA
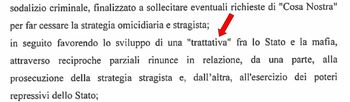
dalla Sentenza di primo grado – pag. 5
Al fine di giungere ad un accordo volto a porre fine alle stragi mafiose, da parte di ufficiali dei Carabinieri, tramite l’ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, fu avviata con Cosa nostra una sorta di trattativa. Il primo a riferirne ai magistrati fu Giovanni Brusca nel ’96 avendone sentito parlare da Totò Riina. La sentenza del processo di primo grado, che confermò la sua esistenza, venne pronunciata il 28 Aprile 2018. Secondo i giudici di Primo grado, “L’improvvisa accelerazione che ebbe l’attentato a Paolo Borsellino“ fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo – ed in sostanza, di cedimento Cosa Nostra culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Amelio“. Per i giudici del processo Trattativa Stato-mafia, “non vi è dubbio” che i contatti fra gli ufficiali dei carabinieri Mori e De Donno con Vito Ciancimino, unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l’avvicendamento di quel ministro dell’Interno che si era particolarmente speso nell’azione di contrasto alle mafie, in assenza di plausibili pubbliche spiegazioni) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Salvatore Riina già come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa nella misura in cui quegli ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato”. I giudici scrivono ancora: “Ove non si volesse prevenire alla conclusione dell’accusa che Riina abbia deciso di uccidere Borsellino temendo la sua opposizione alla trattativa, conclusione che peraltro trova una qualche convergenza nel fatto che secondo quanto riferito dalla moglie, Agnese Piraino Leto, Borsellino, poco prima di morire, le aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle istituzioni e mafiosi, in ogni caso non c’è dubbio che quell’invito al dialogo pervenuto dai carabinieri attraverso Vito Ciancimino costituisca un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino, con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato e di lucrare, quindi, nel tempo dopo quell’ulteriore manifestazione di incontenibile violenza concretizzatasi nella strage di via d’Amelio, maggiori vantaggi rispetto a quelli che sul momento avrebbero potuto determinarsi in senso negativo”.
- Quando il Generale Mori chiese a Ciancimino: “Ma non si può parlare con questa gente?”
- Claudio Martelli: quand’ero Ministro della Giustizia
- La memoria difensiva del Gen. Mario Mori
- Mario Mori e i suoi misteri
- Borsellino, Caselli: “Fu ucciso per il timore che si opponesse alla Trattativa Stato-mafia” L’ex magistrato ricorda la strage di via D’Amelio, le ragioni del suo accadimento, le sentenze Totò Riina avrebbe deciso di uccidere Paolo Borsellino perché temeva si opponesse alla Trattativa. Mentre “l’invito al dialogo pervenuto dai Carabinieri attraverso Vito Ciancimino (…) può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione (…) con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato e di lucrare, quindi (…) maggiori vantaggi”. “Questo afferma la sentenza di Palermo sul processo Trattativa Stato-mafia, emessa dai giudici della Corte d’Assise l’anno scorso. Attualmente il processo è in fase di appello”. A ricordarlo all’Adnkronos a 28 anni dai fatti di Via D’Amelio è Gian Carlo Caselli, giudice istruttore a Torino, che poi ha guidato la Procura della Repubblica di Palermo subito dopo l’uccione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nonché delle persone delle loro scorte. Oggi dirige l’Osservatorio di Coldiretti sulla criminalità nell’agricoltura e sulle ‘agromafie’. Di recente l’ex magistrato ha pubblicato anche un saggio, insieme al collega Guido Lo Forte già pm a Palermo e a Messina come procuratore capo della Repubblica. Si intitola “Lo Stato Illegale” (Editori Laterza) e traccia la storia degli stretti legami tra mafia, politica e imprenditoria nel periodo che va da Portella della Ginestra a oggi: all’eccidio di via D’Amelio del ’92 sono dedicate ampie parti del volume. “Nel capitolo dedicato alle stragi e ai relativi processi, fino a quello sulla Trattativa -sostiene Caselli- viene precisato che la storia di Borsellino ha avuto uno sviluppo tanto clamoroso quanto scellerato. A Caltanissetta sono stati celebrati vari processi sulla strage di via D’Amelio. Ma il cosiddetto ‘Borsellino quater’ ha segnato un ribaltone, perché la motivazione della sentenza di primo grado (1865 pagine, depositate il 30 giugno 2018) è totalmente sconvolgente: le dichiarazioni del pentito Vincenzo Scarantino, poste a fondamento dei precedenti processi sulla strage e di svariate condanne all’ergastolo, sono false in quanto frutto ‘di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana’, realizzato da ‘soggetti inseriti negli apparati dello Stato'”. Qui la sentenza fa riferimento specifico “al gruppo di investigatori dell’epoca guidato da Arnaldo La Barbera, appositamente istituito per le indagini sulle stragi presso la Procura di Caltanissetta: sarebbero stati loro a indirizzare l’inchiesta costruendo falsi pentiti, per scopi che sicuramente vanno ben oltre l’ansia di ottenere risultati nella ricerca dei responsabili del delitto del 19 luglio 1992”. “I giudici -conclude Caselli- e lo abbiamo scritto chiaramente con Lo Forte anche nel libro, sottolineano l’iniziativa ‘decisamente irrituale’ dell’allora procuratore di Caltanissetta, Giovanni Tinebra, di chiedere la collaborazione nelle indagini di Bruno Contrada e quella improvvida di non voler sentire ciò che Paolo Borsellino poteva rappresentare in ordine alla strage di Capaci”.18 lug.2020 (Adnkronos) di Rossella Guadagnini
CERCA
- 18.5.2012 – TRATTATIVA STATO-MAFIA, IL “FUORI ONDA” DI MANNINO ARRIVA AL PROCESSO MORI “Questa volta ci fottono, questa volta ci incastrano”. La conversazione tra Calogero Mannino e Giuseppe Gargani, raccolta dalla giornalista del Fatto Sandra Amurru, fa il suo ingresso al processo contro Mario Mori e Mauro Obinu
- Il pm Di Matteo in aula: “Sulla trattativa qualcuno nelle istituzioni mente”. L’ex ministro dell’Interno Mancino depone in aula a Palermo, ma su quello che accadde nel 1992-1993 le versioni dei politici dell’epoca non quadrano. Spunta un documento inedito della Dia che già prima delle stragi metteva in guardia dal “cedere” ai mafiosi sul 41 bis. Feb2012
- Trattativa Stato-mafia, intervista a Fiammetta Borsellino. Trattativa Stato-mafia: “Possibile movente dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino” A sostenerlo è la figlia del giudice, Fiammetta Borsellino, nel corso di un’intervista rilasciata al Fatto quotidiano: “Non sono solo io a pensarlo. C’è un intero capitolo del processo Borsellino quater dedicato alla Trattativa”
- Stato-mafia, Martelli alla commissione: “Scalfaro dominus. Amato mente”
- Trattativa, Fiammetta Borsellino: “Soggetti dello Stato hanno esposto mio padre alla mafia come bersaglio da eliminare”. Il primo pensiero di Fiammetta Borsellino, dopo aver saputo delle condanne per il generale Antonio Subranni e per gli altri, è stato per la madre Agnese Piraino, scomparsa nel 2013 dopo una lunga malattia.
- Sua madre riferì ai pm quel che suo padre le aveva detto poco prima di morire sul comandante del Ros Angelo Subranni: che era punciuto, cioè in qualche modo legato alla mafia. Allora fu attaccata duramente e poi Subranni fu prosciolto a Caltanissetta per concorso esterno in associazione mafiosa. Ora è stato condannato per la Trattativa a 12 anni. Mia madre raccontò ai magistrati solo quello che mio padre le aveva detto. Fece il suo dovere ma fu attaccata duramente. Mi fa fatica anche ricordare. Il generale Subranni, 80 anni, nel 1992 era il capo del Ros. Venerdì scorso è stato considerato colpevole di avere veicolato con il generale Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno, la minaccia della mafia allo Stato. Sua madre potrebbe essere stata ritenuta attendibile? Bisogna aspettare le motivazioni però ricordo le parole di Subranni. Disse che mia madre era malata di alzheimer e non era vero. Né lui né gli avvocati né alcuni commentatori ebbero la minima forma di rispetto verso di lei.
- Questa sentenza è importante? Certo che è importante. Attesta il coinvolgimento a un altissimo livello di soggetti dello Stato con comportamenti che hanno esposto mio padre davanti alla mafia quale bersaglio da eliminare.
- Pensa che ci possa essere stata una relazione tra la trattativa avviata dal Ros dei carabinieri dopo la strage di Capaci e la strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992? C’è un intero capitolo del processo Borsellino quater dedicato alla Trattativa come possibile movente dell’accelerazione dell’uccisione di papà. Non sono solo io a pensarlo.
- Pensa che suo padre sia stato eliminato perché era un ostacolo per il dialogo tra pezzi dello Stato e la mafia? Certamente Totò Riina era determinato a uccidere mio padre, ma penso che l’accelerazione sia stata utile anche per altri apparati non appartenenti a Cosa Nostra che avevano interesse a eliminarlo. Il depistaggio, che è ormai acclarato, delle indagini sulla strage di via D’Amelio, potrebbe essere letto come la continuazione di un modo di operare che si intravede già nella Trattativa. E poi rimane il grande dubbio sulla sparizione dell’agenda rossa. Non dimentichiamo che a prendere la borsa di mio padre, il 19 luglio in via D’Amelio, sono state sempre persone appartenenti ai carabinieri.
- La Procura di Caltanissetta sta valutando se sia il caso di riaprire le indagini sulle stragi del 1992 e sui “mandanti esterni” alla mafia. Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi sono già indagati a Firenze per le intercettazioni in carcere del boss Graviano. Secondo i pm e la Dia di Palermo, Graviano in carcere parlerebbe di qualcuno che gli ha chiesto una “cortesia” e in quel contesto nominerebbe Berlusconi. La condanna di Dell’Utri potrebbe spingere a riaprire l’inchiesta anche a Caltanissetta? La sentenza sulla Trattativa condanna Dell’Utri perché avrebbe avuto un ruolo nei riguardi del governo Berlusconi nel 1994 e anche io ho letto le intercettazioni in carcere di Giuseppe Graviano che sembra fare riferimenti a Dell’Utri e Berlusconi. Anche su questo punto penso che debbano essere fatte tutte le verifiche del caso. Penso che dopo tanto tempo è stato sistemato solo un primo tassello. È importante ma deve essere letto insieme agli altri per comprendere il quadro complessivo. Certo una cosa è sicura: lo Stato esce a pezzi da questa sentenza.
- La sentenza fotografa uno Stato che ha trattato con la mafia, però a fare la foto oggi c’è uno Stato che ha avuto il coraggio di fare un processo difficile… C’è uno Stato che ha fatto il proprio dovere. Questo processo non è una cosa strana. In uno Stato normale, fondato sul principio di legalità, questa sentenza dovrebbe essere considerata normale.
- Un grande esperto di diritto penale come il professor Fiandaca ha sostenuto che i carabinieri del Ros, anche se avessero cercato il contatto con la mafia per far cessare le stragi, potrebbero avere agito nell’ambito del lecito se non addirittura del “doveroso”. Lei che ne pensa? Non credo affatto che questo modo di porsi rispetto alla mafia sia lecito. Uomini come mio padre ritenevano di doversi opporre alla mafia fermamente. Non avrebbe mai accettato una cosa simile.
- Dopo la lettura del verdetto, il procuratore Vittorio Teresi ha dedicato questa sentenza a Paolo Borsellino e a Giovanni Falcone. Sono morti per il loro alto senso di fedeltà allo Stato, si meritavano questo e altro. Però questa sentenza è un punto di partenza, non di arrivo. Mi auguro che i magistrati continuino a lavorare per giungere a una verità non solo storica ma anche giudiziaria. Non ci voleva una sentenza per capire che questi comportamenti erano riprovevoli moralmente. Questa sentenza è il primo passo per stabilire che sono anche reati gravi. di MARCO LILLO | 22 APRILE 2018 IL FATTO QUOTIDIANO
18.1.2021 – Trattativa Stato-mafia, ”l’ectoplasma Riggio” alla ricerca di Provenzano – La testimonianza del generale Pellegrini nel processo d’appello. “Pietro Riggio? Il suo nome mi fu fatto da un personaggio che non ricordo, ma probabilmente forse ho anche trovato il nome riguardando le mie vecchie carte. Una persona, probabilmente dei servizi, che mi fu segnalato da un collega. Io ho il dubbio se mi è stato segnalata da una collega della Dia o della Territoriale. Potrei anche identificarla penso, ma non lo so dire di preciso. Mi è venuto un dubbio e lo farò presente al Procuratore Paci (reggente presso la Procura di Caltanissetta)”. A parlare è Angiolo Pellegrini, generale dei carabinieri in pensione ed ex capocentro della Dia a Reggio Calabria, Roma e Palermo, sentito oggi nel processo trattativa Stato-mafia, in corso davanti alla Corte d’assise d’Appello, presieduta da Angelo Pellino (a latere Vittorio Anania). Rispondendo alle domande dei sostituti procuratori generali, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera ha cercato di spiegare le modalità con cui venne in contatto con il collaboratore di giustizia nisseno, che al tempo avviò un rapporto confidenziale con la Dia. Una testimonianza a tratti confusa, specie quando si è trattato di individuare la genesi di quel rapporto e chiarire il ruolo di alcuni soggetti. “A Roma lo conobbi in modo particolare – ha ribadito – Mi venne segnalato che c’era una persona che lo aveva conosciuto in carcere e che Riggio era disponibile a dare indicazioni su Bernardo Provenzano. Incontrai questa persona, che si chiamava Antonio Mazzei, classe’48, a Caserta. E mi disse che Pietro Riggio conosceva cose di Provenzano. Ne parlai con il vice direttore operativo della Dia, Cesare Palazzo. Sapevo che il dottor Chelazzi svolgeva indagini in ambito del procedimento ‘Abisso’ per capire se dalle carceri fosse arrivato qualche input per le stragi. Tenuto conto che Riggio era un ex agente di custodia ne parlai con Pierluigi Vigna e con lo stesso Chelazzi. Il motivo? Io avevo un interesse particolare per Provenzano. Mi occupai di lui arrivando a scoprire le sue attività imprenditoriali, nonostante il personale limitato. Venire a sapere che qualcuno poteva dare informazioni su Provenzano stimolò molto il mio interesse”. Mazzei non era un uomo comune. Pellegrini gli diede anche un soprannome: “il Principe”. “Vestiva in modo appariscente, come fosse un nobile. Mi pare di ricordare che avesse un anello con le sue iniziali”. Un tratto distintivo, quest’ultimo, che era stato anticipato anche al pentito nisseno che lo aveva indicato come soggetto appartenente ai Servizi. Consultando alcune agende dell’epoca, acquisite al processo, Pellegrini ha confermato le date degli incontri avvenuti nell’estate 1999: “Il 2 luglio incontrai Mazzei e gli dissi che non avrei fatto colloquio investigativo con Riggio ma che sarebbe stato interrogato il 7 luglio da Chelazzi e che se avesse avuto qualcosa da dire l’avrebbe potuta dire a Chelazzi”. In quella data del 7 luglio Pellegrini ebbe modo di avere un incontro informale, precedente all’interrogatorio di Chelazzi, a cui presenziò anche Mazzei. Quell’incontro, secondo quanto detto dal teste, “fu casuale. Un’occasione per capire se effettivamente c’era qualcosa su Provenzano”. Nonostante i ripetuti tentativi di chiarimento da parte dei due magistrati e dello stesso Presidente della Corte, non si è ben compreso a che titolo potesse partecipare a quella chiacchierata. “Mazzei era un ex detenuto, non so cosa facesse di preciso – ha spiegato – Se era dei Servizi? Probabilmente, visto che chi me lo ha presentato era qualcuno dei Servizi, ma non mi disse che era collaboratore”. E poi ha aggiunto rispondendo ad una domanda del Presidente Pellino: “Lui era un trait d’union. Uno che disse che Riggio era disponibile a collaborare per dare notizie su Bernardo Provenzano”. Di quel colloquio informale il generale avrebbe parlato anche con Chelazzi il 28 luglio: “Io manifestai a Chelazzi il mio interesse per Provenzano. Venni a sapere che Riggio con Chelazzi non voleva collaborare e gli dissi che la mia impressione era che il suo intento fosse uscire dal carcere per poi tentare di infiltrarsi nell’ambiente per poter arrivare a Provenzano”. Nel corso dell’esame, però, l’ex capocentro della Dia ha riferito di non aver mai stabilito con Riggio un’infiltrazione in Cosa nostra, ma ha confermato il rapporto di collaborazione, tanto che furono anche informati i vertici della Direzione centrale ed anche l’autorità giudiziaria nelle persone dei magistrati Leopardi e Messineo a Caltanissetta e Prestipino a Palermo.
L’operazione “Crepuscolo”. Nel 2001 venne inviata anche una lettera della Dia dando un nome all’operazione, chiamandola “Crepuscolo”. Pellegrini ha anche confermato la circostanza per cui Riggio “riferì che un suo conoscente, tale Peluso, per conto della criminalità doveva venire a Palermo a fare qualcosa. Io andai a parlare con Grasso a Palermo. E chiesi la possibilità di fare intercettazioni sulle utenze di Peluso. Grasso disse che non c’erano elementi sufficienti per fare intercettazioni. Vista la risposta io chiesi al primo reparto della Dia la possibilità di fare intercettazioni preventive. Durarono 4 mesi, ma non emerse nulla. Anzi ricordo anche considerazioni pesanti, come se Peluso fosse un millantatore o un truffaldino”. Se in un primo momento Pellegrini ha detto di “non sapere quale fosse l’episodio criminale particolare a cui fece riferimento Riggio”, dopo la lettura in aula dell’informativa del gennaio 2001 in cui si fa anche riferimento ad un’ipotesi di attentato, ha ribadito: “Io non ho fatto considerazioni, ma ho riferito quello che diceva Riggio. Anche in merito alla spaccatura in Cosa nostra già emergeva che Provenzano avesse preso le distanze da Riina e che tenesse più agli interessi finanziari ed economici”. Pellegrini ha anche spiegato i motivi per cui solo a partire da maggio vennero protocollate le relazioni di servizio: “Venne il dubbio che Riggio approfittasse delle sue attività per chiedere soldi in giro. Venimmo a conoscenza che era sottoposto ad indagine dal Ros e così decidemmo di cristallizzare tutto”. Al contempo ha negato che al Riggio fu detto di infiltrarsi delinquendo: “Lui doveva solo riferire quello che sapeva. Era una fonte ed aveva parenti mafiosi. Doveva essere un ectoplasma ed allargarsi nel territorio. Cosa chiedeva in cambio? Di essere reinserito nella polizia penitenziaria. Le sue informazioni non erano false, ma riguardavano personaggi di primo piano. Veniva fuori anche riferimenti a persone con precedenti penali e quelle informazioni andavano sviluppate. Anche se poi non ci portarono a Provenzano”. Successivamente a salire sul pretorio è stato il colonnello Tersigni che se in un primo momento aveva solo accompagnato Pellegrini agli incontri con l’allora confidente nisseno, poi ha gestito in prima persona il rapporto. Questi ha raccontato che Pellegrini lo coinvolse solo in un secondo momento e che nulla gli fu detto rispetto alle dichiarazioni pregresse dei mesi che vanno dal gennaio all’aprile 2001. Ciò significa che nulla seppe rispetto al “fatto eclatante da compiersi a Palermo” a cui Riggio fece riferimento. Il pentito, quando è stato sentito nel processo, aveva dichiarato di averne parlato con entrambi gli ufficiali, ma Tersigni ha negato in maniera categorica la circostanza, come di aver offerto denaro per l’eventuale arresto di Emmanuello. Invece ha confermato il tentativo di coinvolgere Carmelo Barbieri proprio per giungere alla cattura del latitante. Il processo è stato poi rinviato al prossimo 8 febbraio con la Procura generale che ha già annunciato di voler rinunciare all’esame testimoniale della dottoressa Ferraro. In apertura di udienza, infine, è stata data notizia che il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca si trova in isolamento in quanto ha contratto il Covid-19. Brusca in primo grado è stato assolto per intervenuta prescrizione, visto il riconoscimento delle attenuanti specifiche per i pentiti. Aaron Pettinari 18 Gennaio 2021 ANTIMAFIA DUEMILA
Alfonso Giordano, classe 1928, è il magistrato siciliano che ha presieduto il maxi processo a CosaNostra. Ha accettato di presiederlo quando più di qualcuno, tra i suoi colleghi, adduceva pretesti per declinare: troppe incognite, troppo lavoro e troppi rischi di essere ucciso. E invece il più ampio processo penale della storia è stato concluso dopo un lavoro ciclopico, svolto per il I grado in ventidue mesi serrati: 460 imputati, 200 avvocati, culminato con 19 ergastoli e 4665 anni di pene detentive complessive.
È in questi giorni a Palermo l’appello Stato-mafia, come andrà a finire? Le sentenze del processo a Mannino mettono in chiaro ruoli e dinamiche: non è esistita. Che qualche elemento dello Stato possa aver parlato con qualche elemento della mafia, non lo escludo. Ma non per rispondere a un interesse generale, a un disegno complottistico come quello di cui si legge. Ho conosciuto sul campo il valore di uomini che hanno sfidato la morte centinaia di volte, pur di contrastare Cosa Nostra. E vedere i loro nomi in quel processo mi fa male, mi creda.
Il Generale Mario Mori, per esempio? Mori, per esempio, certo. Uno che colpiva con grande decisione la criminalità organizzata, a cui lo Stato dovrebbe gratitudine, piuttosto. Ha avuto interlocuzioni, ha cercato informatori, ha seguito la pista di qualche infiltrato che riferiva? Io ho potuto condannare sulla base delle operazioni che ha portato a termine Mori, se vuole la mia testimonianza è questa.Tratto da IL RIFORMISTA 9.1.2021
“Trattativa Stato-mafia mai esistita”/ Alfonso Giordano “Berlusconi e Cosa Nostra…”. Alfonso Giordano, in un’intervista sulle colonne de “Il Riformista”, rivela: “Chiunque conosca i fatti non può credervi”. La verità su Andreotti, Berlusconi e… Alfonso Giordano è il giudice che ha presieduto il maxi processo a Cosa Nostra, caratterizzato da numeri a dir poco impressionanti: 460 imputati, 200 avvocati 19 ergastoli e 4.665 anni di pene detentive complessivi. Il magistrato siciliano classe 1928 è intervenuto quest’oggi sulle colonne de “Il Riformista”, a cui ha concesso un’intervista esclusiva nella quale ha subito bocciato l’esistenza della chiacchierata trattativa Stato-mafia. “Io ho rappresentato lo Stato nel processo più duro contro Cosa Nostra – afferma –. Il nostro compito era quello di non fare sconti a nessuno e non ne abbiamo fatti. Diciannove ergastoli comminati insieme e poi confermati in appello e in Cassazione significano che lo Stato con la mafia ci andava giù duro. Alla storia della cosiddetta trattativa non credo e nessuno che conosca i fatti può credervi. Si era incaricato di smentirla Giovanni Falcone, l’aveva considerata un’ipotesi inesistente Paolo Borsellino“.
“LA MAFIA IN PARTE DIALOGAVA CON LA POLITICA”. Nel prosieguo dell’intervista concessa a “Il Riformista”, Alfonso Giordano asserisce che l’istruttoria del maxi processo fu fatta “molto bene” da Falcone e Borsellino, i quali giunsero a una fondamentale conclusione: “La mafia era gelosa delle sue cose e la Commissione, che rappresentava il vertice della Cupola, emetteva le sue sentenze senza dare ascolto né a servizi deviati, né a emissari della massoneria, né altri”. Tuttavia, una sorta di dialogo della mafia con la politica è esistita, “c’è sempre stata. I politici che prendevano parte al dialogo con Cosa Nostra sono sempre stati quelli siciliani, con incarichi amministrativi. Non c’erano, nei nostri riscontri, politici di primo piano nazionale”. Fra gli interrogati vi fu Giulio Andreotti e Giordano ricorda che il confronto con lui fu “serio, serrato. Lo andai a sentire a Roma. Andreotti mise a disposizione le informazioni che aveva, negando un suo coinvolgimento diretto. A fine interrogatorio ci fece gli auguri di buon lavoro e non interferì mai, in nessun modo, con le indagini”.
“COSA NOSTRA MINACCIÒ BERLUSCONI” Alfonso Giordano ha poi rivelato a “Il Riformista” che Silvio Berlusconi, “per quel che so, ha avuto delle minacce da parte di Cosa Nostra, sia dal punto di vista economico, sia da quello fisico. Attraverso Dell’Utri, di cui si fidava, accettò di assumere Mangano, un personaggio incaricato da Pippo Calò di tenere Berlusconi sotto protezione. Come è noto, abbiamo condannato Calò e Mangano dopo avere acquisito tantissima documentazione. Agli atti non risulta niente di più su Berlusconi, ma vedo che il suo nome continua a circolare a prescindere”. In questi giorni, a Palermo, andrà in scena l’appello Stato-mafia: come andrà a finire? Giordano pare non nutrire dubbio alcuno: “Le sentenze del processo a Mannino mettono in chiaro ruoli e dinamiche. La trattativa non è esistita. Che qualche elemento dello Stato possa avere parlato con qualche elemento della mafia, non lo escludo, ma non per rispondere a un interesse generale, a un disegno complottistico come quello di cui si legge”. Sussidiario 11.01.2021 – Alessandro Nidi
- Trattativa Stato-mafia, i 10 punti della difesa Mori. “Non vi è prova che i contatti tra carabinieri del Ros e Vito Ciancimino si sostanziarono in una ‘trattativa’ tra lo Stato e la mafia”, “anzi vi sono le prove contrarie”. E ancora. “Il giudice che ha emesso la sentenza non ha creduto a Massimo Ciancimino e al ‘papello’ consegnato dallo stesso”. E sulla sostituzione ai vertici del Dap tra Nicolò Amato e Adalberto Capriotti, avvenuta nel giugno 1993, è “emerso in modo cristallino come gli autori dell’avvicendamento siano stati Scalfaro, Conso ed i cappellani carcerari” e “non il generale Mori”. A un anno esatto dalla sentenza di primo grado del processo sulla trattativa tra Stato e mafia, prende il via domani il processo d’appello che vede ancora alla sbarra, tra gli altri, l’ex capo del Ros, il generale Mario Mori che in primo grado venne condannato a 12 anni di carcere, come il capitano Giuseppe De Donno, ad 8 anni. La difesa dei due ufficiali, in vista dell’appello, rilancia. Adnkronos è in grado di elencare tutti i punti su cui Mori e i suoi avvocati ribatteranno per dimostrare l’estraneità del generale alle accuse contestate e alla condanna subita. Al processo trattativa, in primo grado, venne condannato a 28 anni di carcere anche il boss mafioso Leoluca Bagarella – e la Procura ne aveva chiesti 16 – a 12 anni l’altro mafioso Antonino Cinà, a 12 anni l’ex senatore Marcello Dell’Utri. E poi 12 anni al generale Antonio Subranni e a Massimo Ciancimino, superteste creduto ma ‘bacchettato’ dagli stessi giudici.
- IL PRIMO PUNTO – La difesa del generale Mori punta sugli aspetti “più controversi”, del processo. Al primo punto c’è la mancata proroga dei 41 bis, cioè il carcere duro, per un gruppo di detenuti accusati di mafia. Per Mori e per i suoi difensori un dato incontrovertibile dimostra che le mancate proroghe dei 41 bis, operate da Conso nel novembre 1993, non furono dovute ad alcuna “trattativa”, tuttavia taluni documenti sono stati ignorati e Mori è stato tacciato di essere, da sempre “geneticamente deviato”, ancorché nel 1973, mentre era al Sid, sventò un attentato di matrice palestinese ad un aereo israeliano, “salvando tante vite e, per questo, ebbe un encomio solenne”. Il reato contestato al generale Mario Mori e al capitano De Donno è quello di minaccia a corpo politico dello Stato, quindi al Governo, come prevede l’articolo 338 del Codice penale. “Perché esso possa configurarsi”, per la difesa è necessario che la minaccia giunga a destinazione e venga, quindi, percepito dalla vittima, vale a dire – nel caso specifico – il governo; “viceversa non esiste alcuna minaccia nei confronti del soggetto passivo, ossia il Governo stesso”. In primo grado la difesa aveva posto a tutti i testi che all’epoca ricoprivano incarichi istituzionali e di Governo, da Giuliano Amato a Luciano Violante, da Claudio Martelli al Prefetto Gianni De Gennaro, “quindi le asserite vittime”, la stessa domanda: “Avete ricevuto minacce dal capitano De Donno o dal generale Mori?”. Le risposte di tutti i testi, fanno presente i difensori, si sono concretizzate in una serie di “No””. E quindi, la minaccia, per Mori non è sicuramente giunta a destinazione o, a tutto voler concedere, “non lo è giunta tramite gli ufficiali dei carabinieri e, quindi, si è nella impossibilità di configurare il reato e comunque di addebitarlo ai carabinieri.
- IL SECONDO PUNTO – Secondo punto della difesa, l’ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino, padre del superteste Massimo Ciancimino. Vito Ciancimino mnon avrebbe parlato “né di asserite ‘spaccature’ tra i boss Riina e Provenzano, né in occasione degli incontri con gli ufficiali del Ros, né negli interrogatori resi nel 1993 ai dottori Caselli ed Ingroia e prodotti dalla difesa dei Carabinieri”. Per gli imputati mancherebbe, quindi, la prova che il generale Mori avesse quelle conoscenze addebitategli e che le abbia portate a Di Maggio. “Anzi, esistono, come detto e ridetto, le prove contrarie”. E ancora. Secondo l’accusa, il generale Mori e De Donno avrebbero contattato Vito Ciancimino su incarico di Subranni, a sua volta “indotto dall’onorevole Calogero Mannino”, il quale, per salvarsi la vita avrebbe chiesto a Subranni di attivarsi in qualsiasi modo. Anche qui, per Mori e De Donno, manca però la prova che Mannino abbia sollecitato iniziative a Subranni.
- IL CASO BORSELLINO – Nel processo ‘appello che prenderà il via domani si ripercorrerà tutta la vicenda riguardante proprio l’uccisione di Paolo Borsellino. Il giudice fu ucciso per la “trattativa” tra Stato e mafia, come titolato da tutti i giornali il giorno dopo il deposito della sentenza?. Come apprende l’Adnkronos, i legali di Mario Mori spiegano che “le prove acquisite sono tutte contrarie alla tesi” secondo cui la strage Borsellino sarebbe stata accelerata dalla trattativa. “La conclusione secondo cui il dottor Borsellino fu ucciso per la “trattativa” è stata raggiunta grazie a rilevanti lacune probatorie” in quanto non è stata ammessa una sentenza della Corte di Assise di Catania, ormai passata in giudicato da anni che collega la strage all’interessamento di Borsellino per le indagini del Ros sugli appalti e alla possibile nomina a Procuratore Nazionale Antimafia; quella sentenza è stata, peraltro, acquisita nel processo “Borsellino Quater” che è pervenuto alle stesse conclusioni dei giudici di Catania. Ma i giudici di primo grado del processo trattativa non la pensano così. Nelle motivazioni, depositate tre mesi dopo la sentenza, proprio il 19 luglio, giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio, il Tribunale ha scritto che “l’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione del dottor Borsellino” fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo – ed in sostanza, di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Ameliio”. Per i giudici del processo Trattativa Stato-mafia, “non vi è dubbio” che i contatti fra gli ufficiali dei carabinieri Mori e De Donno con Vito Ciancimino, unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l’avvicendamento di quel ministro dell’Interno che si era particolarmente speso nell’azione di contrasto alle mafie, in assenza di plausibili pubbliche spiegazioni) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Salvatore Riina già come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa nella misura in cui quegli ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato”. Domani comincia il processo di secondo grado. Prevista la relazione introduttiva del giudice a latere del dibattimento. E poi si entra nel vivo.
- MAFIA E APPALTI – La difesa del generale Mario Mori rilancerà inoltre anche sul dossier su ‘mafia e appalti’. E’ un’indagine che fu avviata dai Carabinieri del Ros nel 1989 sotto la direzione del dottor Falcone. Essa aveva ad oggetto la illecita gestione degli appalti pubblici e, in essa, erano coinvolti politici, imprenditori e appartenenti alla mafia. Ma quale fu il problema che determinò contrasti tra il Ros e la Procura di Palermo? Secondo la Procura, i Carabinieri del Ros avrebbero operato la cosiddetta “doppia refertazione”, ossia “avrebbero consegnato, nel 1991, alla Procura di Palermo, nelle mani del dottor Falcone, un’informativa nella quale non vi erano le intercettazioni dalle quali emergevano i nomi dei politici. L’informativa completa, comprensiva anche dei riferimenti ai politici sarebbe stata consegnata, tempo dopo, e dopo l’uccisione del dottor Borsellino, alla Procura di Catania”. “La tesi della “doppia refertazione” è stata sostenuta da tutti i magistrati escussi, sebbene con alcune differenze tra loro (taluni hanno parlato di “differenze tra la informativa consegnata a Palermo e a Catania”, altri di un “Rapporto del Ros in versione completa consegnato al Procuratore di Palermo Giammanco che lo mise in cassaforte e che non lo diede ai sostituti”)” ma è smentita da due documenti provenienti da De Donno e che recano la firma di Giovanni Falcone e Guido Lo Forte. Documenti che la difesa dei Carabinieri ha chiesto di produrre ma che la Corte non ha ammesso perché ritenuti superflui.
- VICENDA BELLINI – altro punto della difesa Mori, la vicenda di Paolo Bellini, un pregiudicato, di origine romagnola, il quale, nella primavera-estate del 1992, conosce presso un antiquario il Maresciallo Tempesta, del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico. Quest’ultimo chiede al Bellini informazioni su alcune opere d’arte rubate alla Pinacoteca di Modena, al fine di recuperarle. Bellini, qualche tempo dopo, contatta il Tempesta e gli propone il recupero di altre opere d’arte, diverse da quelle trafugate a Modena, chiedendo in cambio gli arresti ospedalieri per 5 boss mafiosi (Bernardo Brusca, Pippo calò, Giuseppe Giacomo Gambino, Giuseppe Marchese e Luciano Liggio indicati nominativamente in un foglietto di carta), più l’aggiustamento di un suo processo in Cassazione e 200 milioni di lire.
- IL ‘BOOMERANG’ BRUSCA – La difesa del generale Mario Mori e del capitano Giuseppe De Donno ricorda poi le dichiarazioni del pentito Giovanni Brusca e del giudice Liliana Ferraro. “Perfino Brusca, cioè la “parte mafiosa”, ha affermato che i Carabinieri li avevano presi “in giro. Ma quelli avevano fatto solo e semplicemente il loro lavoro, gli investigatori”, come disse il pentito in un’udienza il 12.12.2013 . “Stupisce come si possa affermare l’esistenza di una “trattativa” ed, altresì, l’esistenza di un accordo”. E ancora: “Liliana Ferraro, che incontra il Capitano De Donno intorno al 20-25 giugno 1992, ha riferito che De Donno piangeva per la morte di Falcone e le disse (nel 1992), in merito a Vito Ciancimino, che “bisognava fare di tutto per cercare di scoprire gli autori di questa … strage e che lui si era ricordato di avere conosciuto in passato il figlio dell’ex sindaco di Palermo inquisito negli anni ’80 da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Caponnetto e che aveva incontrato questo figlio di Vito Ciancimino anche di recente e che forse valeva la pena di vedere attraverso il figlio se era possibile contattare il padre e vedere se il padre, visto quello che era successo, era disponibile a collaborare con i Carabinieri”. Su quei contatti con Vito Ciancimino, i giudici che hanno assolto Mori in due processi hanno scritto: “Se la cattura del Riina fosse stata il frutto dell’accordo con lo Stato, tramite il quale era stata siglata una sorta di “pax” capace di garantire alle istituzioni il ripristino della vita democratica, sconquassata dagli attentati, ed a “cosa nostra” la prosecuzione, in tutta tranquillità dei propri affari, sotto una nuova gestione “lato sensu” moderata, non si comprenderebbe perché l’associazione criminale abbia invece voluto proseguire con tali eclatanti azioni delittuose, colpendo i simboli storico-artistici, culturali e sociali dello Stato, al di fuori del territorio siciliano, in aperta e sfrontata violazione di quel patto appena stipulato”. E ancora: “Anche i progetti elaborati dal Provenzano di sequestrare od uccidere il cap. De Caprio, di cui hanno riferito in dibattimento, in termini coincidenti, i collaboratori Guglielmini, Cancemi e Ganci, appaiono in aperta contraddizione con la tesi della consegna del Riina al Ros”. “Se così fosse avvenuto, il boss non avrebbe avuto alcun interesse alla ricerca del capitano “Ultimo”, mentre, da quanto sopra, è stato accertato che effettivamente si cercò di individuarlo, tramite un amico del compagno di gioco al tennis”.
- LA FARSA DAP – Altri spunti della difesa del generale Mario Mori riguardano la sostituzione ai vertici del Dap tra Nicolò Amato e Adalberto Capriotti, avvenuta nel giugno 1993. “E’ emerso in modo cristallino come gli autori di tale avvicendamento siano stati Scalfaro, Conso ed i cappellani carcerari, Mons. Fabbri e Mons. Curioni. Mentre per quanto riguarda la nomina di Francesco Di Maggio al posto di Edoardo Fazzioli, quale vicedirettore, è emerso un interessamento del Capo della Polizia Parisi, e l’intervento di Scalfaro. “In spregio di tali evidenze, che dimostrano come Mori (che all’epoca era solo un Colonnello, per quanto importante e conosciuto ma che, proprio in quegli anni 1993 e seguenti, indagava con il suo Reparto – il Ros – anche su Scalfaro) non c’entri nulla, si è scritto in sentenza che dietro Parisi, “suggeritore” della nomina di Di Maggio, vi sarebbe il “suggeritore del suggeritore”, cioè Mori”, come dirà la difesa. Queste le parole della sentenza: “Ed appare logico, allora, pensare ad un “suggeritore” nella individuazione della persona del Di Maggio quale soggetto destinato a sostituire Nicolò Amato, tanto più che tale individuazione risale, come si è visto, già ad alcuni mesi prima della formalizzazione della nomina e, in particolare, al mese di febbraio 1993,quando, con le dimissioni del Ministro Martelli, fautore della linea di maggiore rigore per i detenuti di mafia, si aprì la prospettiva di una rivisitazione della politica carceraria instauratasi dopo le stragi dell’anno precedente. Vi sono alcuni elementi di fatto che inducono a individuare tale “suggeritore” del Capo della Polizia Parisi tra i Carabinieri, con alcuni dei quali il Di Maggio, a differenza che col Parisi, in virtù anche della sua naturale propensione derivante dal fatto di essere figlio di un sottufficiale dell’Arma ed anche per la sua predilezione soprattutto per il Ros”, come risulta dalla sentenza. Ma il vero nodo cruciale è un altro: per i legali del generale la sentenza di primo grado sostiene che Mori avrebbe portato la minaccia a Conso, tramite Francesco Di Maggio, il 27 luglio 1993, allorquando incontrò quest’ultimo. Secondo la sentenza il generale Mori, in quella occasione, avrebbe rappresentato a Di Maggio l’esistenza di una “spaccatura” tra Riina e Provenzano, il primo stragista ed il secondo assestato su una linea morbida e non di contrapposizione frontale allo Stato. Di Maggio, a sua volta, ne avrebbe riferito a Conso che, nella speranza di accontentare Provenzano, avrebbe deciso di non prorogare 334 provvedimenti 41 bis. In questo sarebbe consistita la minaccia al Governo. Mori, secondo la sentenza, avrebbe appreso la notizia riferita a Di Maggio da Salvatore Cancemi, appena 5 giorni prima. Se non chè le dichiarazioni di Cancemi, rese il 22 luglio 1993 davanti ai Procuratori Caselli, Scarpinato e Sabatino e senza che fosse presente personale del Ros, smentiscono la tesi della sentenza, perché Cancemi non parla, nè in quell’occasione, nè in altre successive, di “spaccature” tra i due boss corleonesi. Quel verbale, però, ancorchè acquisito perchè prodotto dalla difesa del generale, è stato ignorato. Un dettaglio di non poco conto, visto che la sentenza sostiene anche che Mori avrebbe appreso pure da Vito Ciancimino la notizia della “spaccatura” tra Riina e Provenzano. E se casca la tesi Conso, casca tutto… ADNKRONOS 28.4.2019 ELVIRA TERRANOVA
- Strage via D’Amelio, Fiammetta Borsellino: “Usare la parola “trattativa” è pericolosa semplificazione“ “Mai come in queste indagini sono stati compiuti errori e omissioni di così grande entità. Coinvolgere i servizi segreti nelle prime fasi di inchiesta è stato gravissimo. Imputare questa strage soltanto alla trattativa o solamente a una strage di tipo mafioso – ha detto – è molto semplificativo ma fa comodo a chi vuole impedire il raggiungimento della verità”.

- PROCESSO D’APPELLO TRATTATIVA STATO-MAFIA
- Trattativa Stato mafia
- Il Papello
- Gen. Mario Mori
- Al via l’appello per la trattativa Stato-mafia, la difesa di Mori: “Nessuna minaccia allo Stato” Si torna in aula a un anno dalla sentenza di primo grado. L’ex capo del Ros, il generale Mario Mori, era stato condannato a 12 anni di carcere mentre il capitano Giuseppe De Donno a 8 anni. Il difensore di Dell’Utri indica l’ex premier Berlusconi come teste
AUDIO UDIENZE PROCESSO D’APPELLO
- 19.01.2021
- 18.12.2020
- 14.12.2020
- 23.11.2020
- 26.10.2020
- 19.10.2020
- 05.10.2020
- 28.09.2020
- 21.09.2020
- 23.07.2020
- 13.07.2020
- 06.07.2020
- 26.06.2020
- 08.06.2020
- 26.05.2020
- 18.05.2020
- 02.03.2020
- 10.02.2020
- 16.01.2020
- 09.12.2019
- 25.11.2019
- 11.11.2019
- 04.11.2019
- 14.10.2019
- 03.10.2019
- 26.09.2019
- 19.09.2019
- 12.09.2019
- 22.07.2019
- 11.07.2019
- 08.07.2019
- 24.06.2019
- 17.06.2019
- 10.06.2019
- 31.05.2019
- 13.05.2019
- 29.04.2019
- Il 29 Aprile 2019 è iniziato l’appello del processo Stato-Mafia. Cosa era stato deciso in primo grado La trattativa c’è stata. Il patto scellerato tra pezzi dello Stato e Cosa nostra è stato siglato. Questo è emerso dal duro dispositivo della Corte d’assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, pronunciato il 20 aprile 2018 nell’aula bunker del Pagliarelli al termine di oltre quattro giorni di camera di consiglio. Con questa conclusione processuale, formulata in primo grado, si deve confrontare adesso il processo d’appello che si è aperto. Le motivazioni sono state depositate il 19 luglio dell’anno scorso, nel ventiseiesimo anniversario della strage di via D’Amelio. Dopo cinque anni di udienze, boss e politici sono stati dichiarati in primo grado colpevoli del reato di minaccia e violenza al corpo politico dello Stato. La trattativa sarebbe stata intavolata dai carabinieri fino al 1993, dall’anno successivo in poi dall’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri. Condannati a 12 anni di carcere, oltre a Dell’Utri, i generali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni e il boss Antonino Cinà; a 28 anni Leoluca Bagarella, la pena più pesante. Otto anni al colonnello Giuseppe De Donno. Stessa pena per Massimo Ciancimino accusato di calunnia nei confronti dell’allora capo della polizia Gianni De Gennaro, mentre è stato assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Prescrizione per Giovanni Brusca. Assolto l’ex ministro Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza.
- La trattativa accelerò “l’esecuzione” di Borsellino Una motivazione colossale per un processo poderoso. Tra le 5252 pagine la convinzione che “l’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione del dottore Borsellino” fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo – e in sostanza, di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Amelio“. Per cui, secondo i giudici di primo grado, “non vi è dubbio” che i contatti fra Mario Mori e Giuseppe De Donno con Vito Ciancimino, “unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l’avvicendamento di quel ministro dell’Interno che si era particolarmente speso nell’azione di contrasto alle mafie) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Riina già come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa nella misura in cui quegli ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato”. Insomma, “quell’invito al dialogo pervenuto dai carabinieri attraverso Vito Ciancimino costituisce un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino” con la finalità di approfittare “di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato”. E questo è un fatto anche laddove non si volesse convergere sulla conclusione dell’accusa secondo cui “Riina abbia deciso di uccidere Borsellinotemendo la sua opposizione alla trattativa”.
- Riina incoraggiato a mettere in ginocchio lo Stato Secondo i giudici “quei contatti che già all’indomani della strage di Capaci importanti e conosciuti ufficiali dell’Arma avevano intrapreso attraverso Vito Ciancimino, unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l’avvicendamento Scotti-Mancino al ministero dell’Interno, ndr) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Riina già come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa”. In altre parole “se effettivamente quei segnali pervennero a Riina nel periodo immediatamente antecedente alla strage di via D’Amelio (e che ciò effettivamente avvenne risulta provato) è logico e conducente ritenere che Riina, compiacendosi dell’effetto positivo per l’organizzazione mafiosa prodotto dalla strage di Capaci, possa essersi determinato a replicare, con la strage di via D’Amelio, quella straordinaria manifestazione di forza criminale per mettere definitivamente in ginocchio lo Stato ed ottenere benefici sino a pochi mesi prima (quando vi fu la sentenza definitiva del maxi processo) assolutamente per lui impensabili”.
- I Ros agevolarono il progetto di Cosa Nostra Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, i carabinieri condannati poco più di un anno fa, agirono con “il dolo specifico di colui che abbia lo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso o che comunque abbia fatto propria tale finalità”. Gli imputati, secondo la sentenza del processo stato-mafia, stimolarono “il superamento del muro contro muro e quindi l’indicazione, da parte dei vertici mafiosi, delle condizioni per tale superamento”. In questo modo, “si è inevitabilmente rappresentato il vantaggio che certamente sarebbe in ogni caso derivato per Cosa nostra nel momento in cui fosse venuta meno la contrapposizione frontale la forte azione repressiva dello Stato, già culminata nelle pesanti pene del maxiprocesso e più recentemente dopo la strage di Capaci nelle misure anche di rigore carcerario del decreto legge adottato dal governo l’8 giugno 1992”. Il ruolo di Marcello Dell’Utri “come intermediario delle minacce di Cosa nostra a Silvio Berlusconi – secondo i giudici di primo grado – non si colloca nel momento in cui quest’ultimo decise di scendere in politica, ma fu espresso dopo che fu formato e insediato il nuovo governo presieduto proprio da Berlusconi“.
- Dell’Utri intermediario, minacce a Berlusconi Il riferimento sono gli incontri che Dell’Utri, condannato a 12 anni, ebbe con l’ex stalliere di ArcoreVittorio Mangano “in almeno due occasioni, la prima tra giugno e luglio 1994, la seconda nel dicembre dello stesso anno, per sollecitare l’adempimento degli impegni presi durante la campagna elettorale, ricevendo, in entrambe le occasioni, ampie e concrete rassicurazioni”. Il collegio concordava con le argomentazioni difensive di Dell’Utri, che negano che le iniziative “fossero state effetto diretto di una minaccia”, legandole piuttosto a “libere scelte di quella consistente componente di soggetti facenti parte di Forza Italia che, per risalente asserita vocazione garantista, da tempo si battevano contro alcuni provvedimenti adottati in funzione antimafia dai precedenti governi”. “Ciò pero’ non toglie che ugualmente gli interventi di Mangano nei confronti di Dell’Utri possano avere avuto una obiettiva attitudine ad intimorire il destinatario finale, individuato dai mafiosi in Berlusconi, indipendentemente dal fatto che l’effetto intimidatorio, purché comunque percepibile, possa avere inciso concretamente sulla sua liberta’ psichica e morale di autodeterminazione”. “Le promesse o quantomeno la disponibilità manifestata da Dell’Utri per soddisfare le esigenze di Cosa nostra hanno contribuito all’entusiastico appoggio dato da quest’ultima in Sicilia alla nascente nuova forza politica”. I giudici parlavano di un ruolo di Dell’Utri “tutt’altro che neutro, perché non si sarebbe limitato ad ascoltare e a raccogliere le richieste dei mafiosi, ma avrebbe ancora manifestato disponibilità nel farsi carico delle iniziative del governo Berlusconi”. I magistrati ricordavano che “l’evento del reato contestato non è costituito dai provvedimenti legislativi poi adottati, ma esclusivamente dalla percezione da parte di Berlusconi, in qualità di capo del governo, della pressione psicologica operata da Cosa nostra col ricatto, esplicito o implicito che fosse, della reiterazione delle stragi”. In altri termini la Corte sosteneva che Dell’Utri “continuava ad informare Berlusconi di tutti i suoi contatti anche dopo l’insediamento del governo da quest’ultimo presieduto e vi è la definitiva conferma che anche il destinatario finale della pressione o dei tentativi di pressione, venne a conoscenza della minaccia in essi insita e del conseguente pericolo di reazioni stragiste che una inattività nel senso delle richieste dei mafiosi avrebbe potuto fare insorgere”. AGI 1.5.2019
- 7.1.2021 La trattativa Stato-Mafia secondo Salvatore Borsellino.Il linguaggio è importante: la trattativa Stato-Mafia non è “presunta”. La trattativa Stato-Mafia esiste ed è provata, come dice Salvatore Borsellino. Lui è il fratello di Paolo Borsellino, ucciso nella strage di via D’Amelio il 19 luglio del 1992. “Smettiamola di chiamarla così. Una sentenza di primo grado ne ha già riconosciuto l’esistenza, definirla “presunta” confonde solo le idee di chi ascolta”. Le dichiarazioni ad Adnkronos di Salvatore Borsellino seguono il servizio di Report andato in onda la sera del 4 gennaio. Nel programma di Sigfrido Ranucci si è parlato dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Salvatore Baiardo a Report: l’agenda rossa è in mano alla mafia Il servizio di Report ha per protagonista Salvatore Baiardo. Si tratta di colui che ha coperto la latitanza della famiglia dietro la strage di via D’Amelio. Ci riferiamo ai Graviano.
- I fratelli Graviano, infatti, erano dei killer al servizio di Totò Riina. Ed è nella famiglia Graviano che sarebbe finita l’agenda rossa. Al riguardo ci sarebbe stato un incontro ad Orta, in Piemonte.
- Sarebbero stati presenti anche rappresentanti di quei Servizi Segreti arrivati fin troppo in fretta sulla scena della morte di Borsellino. Riguardo la trattativa Stato-Mafia, Baiardo ha parlato di incontri con Silvio Berlusconi. Ne parla anche il collaboratore di Borsellino Giovanni Paparcuri, che ribadisce la volontà di Borsellino di indagare sul politico, su spinta di Giovanni Falcone. Baiardo parla di giri di soldi fra Marcello dell’Utri e Berlusconi, e la famiglia Graviano. Lo stesso Giuseppe Graviano aveva ribadito in passato come avesse incontrato tre volte Berlusconi, nell’aula bunker di Reggio Calabria per il processo ‘Ndrangheta stragista.
- L’opinione di Salvatore Borsellino La grande quantità di teorie, però, ha infastidito Salvatore Borsellino. Il fratello del magistrato non ha apprezzato l’unione fra verità e teorie non confermate. Chi conosce la storia non ne ha ricavato nulla di nuovo, chi non è addentro alle cose è rimasto stordito. Una serie di notizie, di ipotesi, di informazioni, affastellate una dietro l’altra che hanno generato solo una grandissima confusione. Un frullato di cose vere e altre poco attendibili. Ognuno degli argomenti affrontati ieri sera avrebbe avuto bisogno di una trasmissione dedicata, di un approfondimento. Sono cose serie, non notizie. Una delle ipotesi, per esempio, riguarda una delle copie dell’agenda rossa, forse finita nelle mani di Matteo Messina Denaro. Non è alla mafia che interessava l’agenda rossa di Paolo Borsellino ma alle parti deviate dello Stato. E se quell’agenda fosse nelle mani di Matteo Messina Denaro, avrebbe uno strumento di ricatto incredibile.
- L’agenda rossa di Borsellino e la trattativa Stato-Mafia L’agenda rossa di Borsellino, oltre ad avere un valore simbolico riguardo l’antimafia, è una delle prove chiave sulla trattativa Stato-Mafia. Secondo chi conosceva Paolo Borsellino, il magistrato aveva cominciato a prendere una serie di appunti considerati fondamentali. Non si separava mai dalla sua agenda, ma era sparita dalla scena del crimine di via d’Amelio. Salvatore Borsellino ha definito all’Adnkronos “una scellerata congiura del silenzio che è durata per 20 anni” ciò che ruota attorno all’agenda. C’era qualcuno che aspettava per fare sparire l’agenda rossa e per impadronirsene […] Quell’agenda è stata sottratta perché doveva servire per gestire i ricatti incrociati con i nomi.
- Ad oggi è uno dei più gravi depistaggi della storia italiana. Un’agenda, un oggetto apparentemente innocuo, potrebbe far luce sul torbido rapporto fra politica e mafia. Questo oggetto apparentemente innocuo diventa pericoloso, vitale ed essenza della lotta contro la criminalità organizzata. In ogni sua forma. Magari un giorno l’agenda rossa finalmente finirà nelle mani giuste: quelle della giustizia. 7 GENNAIO 2021 Ultima Voce Giulia Terralavoro
- 14.12.2020 Trattativa Stato-mafia, citati a deporre ex giudice pool antimafia di Palermo e ufficiali Carabinieri Si tratta di Leonardo Guarnotta e dei due ufficiali dei carabinieri, il generale Angiolo Pellegrini e il colonnello Alberto Tersigni La Procura Generale, che sostiene l’accusa al al processo d’appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, ha chiesto che vengano chiamati a deporre l’ex giudice del pool antimafia Leonardo Guarnotta e due ufficiali dei carabinieri, il generale Angiolo Pellegrini e il colonnello Alberto Tersigni. La corte d’assise che giudica per minaccia a Corpo politico dello Stato ex ufficiali del Ros, boss mafiosi e l’ex senatore Marcello Dell’Utri, si è riservata di decidere se ammettere l’istanza. Al centro della deposizione sollecitata dai pg le rivelazioni del confidente Pietro Riggio, ex guardia penitenziaria poi arrestata per mafia e ora collaboratore di giustizia, su un “fatto eclatante «che si sarebbe dovuto verificare nel 2001 a Palermo che avrebbe dovuto riguardare Guarnotta. Una «soffiata» mai verificata nonostante, dopo le confidenze di Riggio, che disse di aver saputo le informazioni da un poliziotto colluso, siano state effettuate intercettazioni proprio a carico dell’agente sospettato. Sulla circostanza la Procura generale ha depositato alla corte i verbali di sommarie informazioni rese da Tersigni e Guarnotta, nel 2019. «Negli anni 2000-2001 presiedevo il collegio che giudicava Marcello Dell’Utri a Palermo. Al tempo non ebbi alcuna notizia di un progetto di attentato ai miei danni», ha detto Guarnotta. “Pellegrino avvicinò Riggio con l’obiettivo di catturare Provenzano può darsi che abbia parlato anche di attentati nei confronti di magistrati ma non ne ho ricordo. In ogni caso delle sue confidenze furono redatte annotazioni di servizio», ha, invece, dichiarato Tersigni ai magistrati di Caltanissetta. La prossima udienza si terrà il 18 dicembre. LA SICILIA
- 14.12.2020 – Depistaggio via d’Amelio, Mancino e la reticenza dei ”non ricordo” L’avvocato Repici chiede la trasmissione in Procura del verbale della testimonianza dell’ex ministro. Per la prima volta sentito in aula anche il generale Borghini Quando fu chiamato a deporre nel processo Borsellino quater Nicola Mancino era un imputato di reato connesso, accusato di falsa testimonianza a Palermo nel processo per la trattativa Stato-mafia, e scelse di avvalersi della facoltà di non rispondere”.
- Ora che da quell’accusa è stato definitivamente assolto, in quanto né la Procura di Palermo né la Procura generale ha appellato per la sua posizione la sentenza pronunciata dalla Corte d’assise, lo step successivo, “complice” a suo dire il lungo lasso di tempo trascorso da certi fatti, è quello del ricorso quasi sistematico ai “non ricordo”. L’ex ministro è stato sentito come testimone al processo sul depistaggio sulla strage di via d’Amelio che vede imputati i tre poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di calunnia aggravata dall’aver favorito Cosa nostra. Una testimonianza al termine della quale Fabio Repici, legale di parte civile di Salvatore Borsellino, ha chiesto ufficialmente al Tribunale la trasmissione in Procura dei verbali della deposizione.
- E il Presidente del Tribunale Francesco D’Arrigo si è riservato di decidere sul punto.
- “Dico non ricordo”. L’ex ministro degli Interni, sentito in videoconferenza, più volte ha mostrato una certa insofferenza nel rispondere alle domande dell’avvocato, come quando ha fatto presente di aver depositato tre volumi della propria attività di ministro al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia (“Se ritiene ne può fare richiesta presso la Procura della Repubblica di Palermo. E’ pubblico e può essere letto in udienza a prescindere dall’udienza del testimone qui presente. Non mi può dire niente. Io ho fatto quella dichiarazione e mi riporto a quella dichiarazione”).
- Una visione distorta del compito che ogni cittadino, ancor di più se ha avuto un ruolo istituzionale, dovrebbe avere. Evidentemente c’è un certo fastidio nel salire sul banco dei testimoni. Fastidio ingiustificato se l’idea è quella di offrire un contributo di verità su quella terribile stagione di bombe. Uno dei temi affrontati durante l’esame, ovviamente, il famoso incontro del primo luglio con il giudice Paolo Borsellino.
- “Aveva mai visto una sua immagine in tv o sui giornali?” ha immediatamente chiesto Repici. “Io all’epoca ho detto di non ricordare. Come posso oggi dire che ricordo? Ho detto di no ed oggi non posso dire di sì” ha risposto l’ex Presidente del Senato, dimostrando la propria insofferenza.
- Quindi ha aggiunto: “Non ho mai avuto contatti con lui, non lo conoscevo e non avevamo mai avuto rapporti – ha dichiarato – Ci siamo limitati solo a una stretta di mano il giorno in cui mi insediai come ministro. Ma non ci siamo parlati”.
- In quel giorno, al Viminale, è certo, si recarono in tanti. Ma anche in questo caso i ricordi sono stati ad intermittenza. “C’erano molte persone quel giorno che volevano congratularsi con me per la mia nomina. Io non conoscevo fisicamente il dottor Borsellino. Poi ho potuto dire, solo a distanza di tempo, che lo avevo incontrato solo perché il capo della Polizia mi aveva detto che, dovendo andare al Viminale, si poteva approfittare della sua visita per salutare il Ministro dell’Interno. Borsellino era accompagnato da Vittorio Aliquò ma questo l’ho saputo dopo. Chi era presente? Non ricordo. Erano tanti che volevano congratularsi col ministro. C’era una folla notevole, parecchi amici, funzionari, persone che facevano politica, altre persone interessate a conoscere il ministro”.
- Alla richiesta di riferire qualche nome dei presenti, o a chi diede l’incarico di dirigere la propria segreteria, però, la risposta è stata sempre la stessa: “Non ricordo”.
- Però l’ex ministro ha ricordato altre cose, come l’esser stato a Palermo tra il 5 ed il 7 luglio per incontrare i Prefetti e gli appartenenti alle Forze di Polizia; l’incontro con il cognato di Falcone, Alfredo Morvillo; e lo scambio di battute con Parisi “sulla necessità di catturare Totò Riina”.
- Poi il solito mantra per ricordare le proprie attività parlamentari in favore del 41 bis.
- Durante la deposizione Mancino ha anche raccontato un dettaglio in riferimento ad un incontro avuto con l’ex Sisde Bruno Contrada. Ciò non sarebbe avvenuto il giorno dell’insediamento, ma a dicembre: “Ho incontrato Bruno Contrada solo una volta, per un saluto, alla vigilia di natale del 1992, quando ero ministro dell’Interno. Mi disse ‘Io non sono responsabile delle accuse che mi vengono mosse’ e io gli augurai che potesse venir fuori la verità. Se mi disse che l’autorità giudiziaria lo stava indagando? Non lo ricordo. Dico di no”. Quell’incontro, a detta del teste, fu promosso dal Capo della Polizia Parisi (“Mi disse che Contrada voleva parlarmi”). Certo è che Contrada fu arrestato nel Natale 1992.
- Sulla propria nomina a ministro degli Interni Mancino ha dichiarato che nessuno parlò con lui, parlamentare e membro della Prima commissione degli affari Costituzionali, della designazione. Quindi ha escluso che qualcuno gli abbia chiesto la disponibilità a ricoprire quel ruolo tanto da averlo appreso “solo nel momento in cui fui incaricato”.
- Poi ancora ha aggiunto di non aver mai conosciuto l’allora capo della squadra Mobile di Palermo Arnaldo La Barbera e di non essere mai stato coinvolto dall’allora ministro della Giustizia Giovanni Conso in materia di applicazione dei decreti del 41bis.
- Altri argomenti “caldi” il rapporto con Martelli (“Non sempre ci siamo incontrati nella trascrizione delle versioni… Certo che non ho avuto trattamenti di buona collaborazione da parte di Martelli…”) e la natura delle fonti da cui ricavò le informazioni sul dualismo tra Riina e Provenzano e sulla imminente cattura di Totò Riina, così come disse nel dicembre 1992 come riportato dal Giornale di Sicilia (“L’intento di catturare Riina non è un intento astratto ma è obiettivo concretamente perseguibile. Si deve perseguire con tenacia questo obiettivo, prefetto Parisi, attraverso l’impegno quotidiano delle energie migliori che dispongano ogni mezzo di indagine (…) La mafia sta cambiando. Forse è alla vigilia di una scissione come quella che spaccò la Camorra indebolendola”). Come aveva appreso quelle informazioni? “Io ho sempre sostenuto che bisognasse liberarsi di Riina con l’arresto. Non ricordo. Non sarei stato così imprudente da annunciarla. La spaccatura? Se ne parlava sui giornali. I quotidiani ne parlavano spesso” ha ribadito il teste.
- Quando fu sentito in Commissione antimafia, l’8 novembre 2010, disse di essere stato consapevole, già nel 1992, di una spaccatura tra l’ala stragista di Cosa nostra di Riina e quella moderata di Provenzano e disse anche che potrebbe averlo saputo dai due maggiori responsabili della Dia del tempo: De Gennaro ed Arlacchi. Tuttavia è noto che il dato, in quel momento, non era noto da quegli organi giudiziari e che l’unica fonte che aveva paventato una possibilità simile era Vito Ciancimino, l’ex sindaco mafioso di Palermo, che fu contattato dal Ros. Ma Mancino di quella vicenda non ha mai riferito nulla.
- La testimonianza di Borghini. Altro audito nell’udienza di venerdì, per la prima volta in un processo sulla strage di via d’Amelio, è stato il generale Emilio Borghini, oggi in pensione e al tempo Comandante del gruppo carabinieri Palermo uno. Una testimonianza resasi necessaria dopo che lo stesso era stato individuato in un video da Angelo Garavaglia Fragetta (agenda rossa e collaboratore di Salvatore Borsellino).
- Nelle immagini di quel 19 luglio 1992 lo si vede lasciare l’auto di servizio in via Autonomia Siciliana per dirigersi a piedi, tra idranti, fumo e macerie, verso la Croma blindata di Paolo Borsellino, saltato in aria con i cinque agenti di scorta poco tempo prima.
- L’orario del suo arrivo, calcolato misurando l’ombra del sole sul muro del palazzo di via D’Amelio, è quello delle 17.28. Un’ora contestuale a quei frame, registrati pochi minuti dopo, in cui compare l’allora capitano Giovanni Arcangioli mentre si allontana dal luogo dell’esplosione, con la borsa del giudice assassinato in mano, per dirigersi verso via Autonomia Siciliana.
- Rispondendo alle domande di Repici ha ricordato quanto vissuto il giorno dell’attentato: “Mi trovavo nella mia abitazione, vicino al Teatro Massimo. Sentii l’esplosione molto forte e da quel momento fu un susseguirsi di telefonate. Mi recai in via d’Amelio oltre mezz’ora dopo l’esplosione”.
- Una volta giunto sul luogo “c’era una devastazione totale. C’era molta confusione, sembrava un evento post bellico. In vent’anni successivi di servizio, mai visto una cosa del genere. C’era sgomento. C’era un’area a sinistra con i muri distrutti, carcasse di auto e molta acqua a terra. Una parte centrale dove c’erano uomini della polizia, carabinieri e guardia di finanza. C’erano molte persone ma non in divisa. Sulla destra persone attonite, vestite anche in maniera elegante e magistrati”.
- Rispetto alle gerarchie all’interno del reparto operativo e quelle che erano le funzioni di polizia giudiziaria Borghini ha riferito che il responsabile “era il maggiore Marco Minicucci che collaborava con il capitano Arcangioli (colui che compare in immagini e video con in mano la borsa di Borsellino, ndr), quel giorno di turno al nucleo operativo. Ricordo di aver incrociato a piedi Arcangioli. Non ricordo se avesse qualcosa in mano, ma aveva un abbigliamento estivo, poco formale”.
- Borghini, che in alcune immagini appare vicino al capitano dei carabinieri, ha riferito di non aver parlato con Arcangioli in quel giorno (“Tra me e lui c’erano tre livelli gerarchici, ma se non ricordo male era alle dipendenze di un soggetto che poi andò al Ros, credo che si chiamasse De Donno”). Non solo. Non avrebbe parlato con nessuno del personale operante nel luogo della strage. Una scelta precisa (“E’ opportuno lasciare lavorare le persone nelle loro sfere di competenza”). Così sarebbe rimasto in disparte, con il cellulare in mano, per rispondere alle continue telefonate ricevute.
- Tra le persone che riconobbe in quel giorno vi era anche Giuseppe Ayala, ex magistrato che del prelievo della valigetta in pelle dall’auto carbonizzata di Borsellino ha fornito diverse ricostruzioni contrastanti.
- Nel proseguo dell’esame Borghini ha anche ricordato quel che avvenne il giorno dopo l’attentato: “Ci fu una scelta di campo istituzionale. In queste indagini il ruolo principale spettava di diritto alla Polizia di Stato perché colpita nella strage con gli uomini della scorta. Poi la scelta cadde sul Ros e sulla Dia e sostanzialmente il mio Comando, non dico che fu estromesso, ma si dedicò alla gestione ordinaria. E Minicucci mi disse che avevano provveduto ad inviare l’attività di reperimento alla Procura della Repubblica”.
- Il processo è stato poi rinviato al prossimo 15 gennaio quando sarà sentito l’ultimo teste delle parti civili, Don Franco Neri. Successivamente, a partire dal 22, sarà la volta dei tre poliziotti imputati. Aaron Pettinari 14.12.2020 ANTIMAFIA DUEMILA
- 26.10.2020 Lo Stato-mafia secondo Riggio: la Cia, i libici, la Dia, passando per il Sappe Nel processo di Appello su Stato-mafia concluso oggi il controesame da parte di Basilio Milio e Francesco Romito, difensori degli ufficiali Ros Se si dovesse prendere alla lettera la testimonianza del collaboratore di giustizia Pietro Riggio, un ex agente penitenziario che è poi diventato un mafioso di rango, Cosa nostra non è in realtà com’è stata dipinta da Giovanni Falcone. Il controesame a Riggio da parte dell’avvocato Basilio Milio e Francesco Romito, difensori dei Ros nel processo d’Appello Stato-mafia si è concluso oggi. La mafia non solo ha ricoperto un ruolo secondario, ma addirittura è stata presa anche per i fondelli dai poliziotti e servizi segreti perfino internazionali. Il telecomando che ha azionato il tritolo a Capaci non sarebbe stato premuto da Giovanni Brusca. O meglio, quest’ultimo lo ha premuto credendo che l’esplosione sia stata merito suo, mentre invece a premere il pulsante vero sarebbero stati i poliziotti che collaboravano con i servizi. Quindi Brusca, ma addirittura Totò Riina che fino agli ultimi giorni della sua vita (pensiamo alle intercettazioni ambientali al 41 bis) ha miserabilmente osannato le sue gesta relative agli attentati di Capaci e via D’Amelio, sarebbero stati dei poveri ingenui.
- Tutto gestito da “zio Toni” Ma non c’entrano solo i carabinieri e servizi italiani. A organizzare la logistica dell’attentato di Capaci sarebbero stati addirittura i servizi segreti libici composti da una donna misteriosa, il suocero dell’ex poliziotto Giovanni Peluso facente parte del complotto e un certo Nasser, un ex pugile egiziano ma che era al servizio di Gheddafi. Attenzione, sempre secondo Pietro Riggio, tutti loro (poliziotti, carabinieri della Dia e servizi libici) sarebbero stati gestiti da un certo “zio Toni”, che di nome fa Antonio Miceli, il quale però era al servizio della Cia. Sono sempre loro, in questo caso specifico la Dia, a chiedere a Riggio di fare una sorta di agente sotto copertura all’interno della mafia. Lo scopo? Reperire notizie per catturare Bernardo Provenzano. Anzi no. Riggio – come si evince dall’interrogatorio del 2018 davanti al procuratore di Caltanissetta Gabriele Paci e a quello di Firenze – percepisce un “doppio gioco” e dice di aver capito che la Dia in realtà lo usava per non catturare Provenzano. Qualcuno gli fece anche capire che era in pericolo. Ma non si capisce bene il perché. Ed è il procuratore Paci a farglielo presente con domande serrate e precise, visto che troppe cose da lui raccontante non sembrerebbero avere un filo logico. Dopo un botta e risposta per capire la logica, a pagina 88 del verbale dell’interrogatorio Paci gli chiede testualmente: «Riggio scusi, lei mi deve spiegare il senso di questa frase perché non ha senso: “tu sei un uomo morto, io t’ho salvato perché non hai capito che i carabinieri vogliono acquisire notizie ognuno dai referenti che hanno per non farlo prendere, per non prenderlo”. Allora io veramente non ne esco fuori, noi non ne usciamo fuori. È come dire: “tu stai facendo una cosa inoffensiva, che Provenzano lo sa perché sa che si parla con i carabinieri, gli va bene che li date le notizie. Queste notizie questi non le utilizzano perché non lo vogliono prendere, però io ti ho salvato in vita”. Non fila».
- Un’incredibile memoria fotografica La narrazione prosegue, ma – almeno da quello che si evince dal verbale – si fa sempre più fatica a comprenderla. Riggio parla di tutto, dice anche di aver incontrato il poliziotto “faccia di mostro”, ovvero quello che poi lo ha riconosciuto come tale dopo aver visto le foto sui giornali. Si ricorda che lui (si faceva chiamare Filippo) era su una Bmw, accompagnato da una misteriosa donna con la mimetica. Riggio si ricorda il numero di targa a distanza di decenni. Il pm Paci gli chiede come fa a ricordarselo senza aver segnato il numero su un foglietto, e lui risponde che ha una memoria fotografica. Sempre Paci gli fa notare che tante cose che dice (apprese dal poliziotto Peluso, il presunto 007 conosciuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere) sono notizie già uscite fuori, compresa la storia della famosa telefonata dell’onorevole Rudy Maira fatta alla mafia per avvisare che Falcone sarebbe atterrato a Capaci. Da sottolineare che ci fu un processo e fu assolto, quindi innocente. Una storia, quindi, non vera. Riggio però risponde di non aver appreso della telefonata sui giornali, ma solo da Peluso. Quest’ultimo, ricordiamo, sempre secondo il pentito sarebbe il poliziotto al servizio del Sismi che avrebbe non solo azionato il telecomando per l’attentato di Capaci, ma anche organizzato un attentato – fortunatamente mai arrivato a compimento – negli anni 2000 contro il giudice Guarnotta. Il pentito ha parlato pure del caso di Antonello Montante, anche questa notizia già conosciuta.
- Riina, Brusca e co.? Degli ingenui… L’ex poliziotto penitenziario poi passato alla mafia, sembra che conosca tanti segreti. Una narrazione che però – se presa alla lettera – potrebbe far percepire che la mafia sia stata quasi ingenua, come se alla fine fosse tutto organizzato dalle altre “entità”. Riggio lo hanno voluto sentire come testimone durante il processo Capaci bis proprio gli avvocati degli imputati mafiosi. E hanno tutte le ragioni per averlo fatto: se la mafia ha ricoperto un ruolo secondario, o addirittura nemmeno ha azionato il telecomando che ha creato la terribile esplosione, la loro posizione si sarebbe dovuta affievolire. Ma fortunatamente non è stato così e il 21 luglio scorso sono stati confermati gli ergastoli per tutti e quattro i boss. Vale la pena riportare un altro racconto, questa volta delle carceri, quando Riggio faceva l’agente di custodia. Dice di aver fatto parte del Sappe, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria di cui il segretario era (ed è tuttora) Donato Capece. Il pentito, sempre nel verbale del 2018, per spiegare i presunti favori che Forza Italia avrebbe fatto alla mafia, aggiunge questo dettaglio: «La segreteria si trova, per capirci, sopra il bar Mandara a Roma, vicino piazzale Clodio, perché qui ho avuto modo di verificare dove la politica si incontrava con le richieste della mafia perché Capece in contatto con dei personaggi politici che allora facevano parte, diciamo dell’entourage di Forza Italia, cominciò a battersi per la chiusura delle carceri di Pianosa e dell’Asinara». Ora il Sappe, a parere di chi scrive, ha tanti difetti proprio perché cavalca il populismo penale. Che abbia addirittura indirettamente favorito la mafia non è lontanamente immaginabile. Un po’ tutti i sindacati, per tutelare la qualità di vita lavorativa dei loro iscritti, hanno chiesto la chiusura di questi famigerati penitenziari. Carceri delle torture fortunatamente chiuse nel 1998 tramite decreto, ma non per merito di Forza Italia che nemmeno era al governo. Così come il discorso del non rinnovo automatico del 41 bis per circa 300 soggetti, di cui solo una minima parte erano mafiosi. Lo fece Giovanni Conso, ministro della Giustizia del governo di centrosinistra e per rispettare il dettame della Consulta. All’epoca, anno 1993, Forza Italia ancora non era nata. Anche la tesi della trattativa, d’altronde, non la inserisce in quel contesto. Tanta, troppa confusione sotto il cielo. Ma ci penseranno i giudici a valutare la sua attendibilità. Pietro Riggio, ricordiamo, è sentito come testimone al processo d’appello sulla trattativa Stato mafia. In quell’occasione ha aggiunto qualcosa in più: sarebbe stato Marcello Dell’Utri a dettare alla mafia i luoghi dove compiere gli attentati. Un Totò Riina ridotto a fare lo scendiletto dei politici e servizi? Se così fosse, allora è tutta da rifare l’analisi sulla natura della mafia, a partire da ciò che si evince dal libro “Cose di Cosa Nostra” scritto a quattro mani da Marcelle Padovani e Falcone. In realtà quest’ultimo l’aveva capita molto bene la mafia e i suoi interessi affaristico-politici, per questo era stato trucidato con una quantità impressionante di tritolo tanto da squarciare l’autostrada. Stessa sorte, 57 giorni dopo, a Paolo Borsellino. Nel frattempo oggi si è concluso il controesame a Riggio da parte dell’avvocato Basilio Milio e Francesco Romito, difensori dei Ros nel processo d’Appello Stato-mafia. Damiano Aliprandi. IL DUBBIO
- 26.10.2020 – Le morti di Gioé e Ilardo nelle dichiarazioni di Riggio Alla scorsa udienza lo aveva anticipato (“Ancora ho detto poco perché Caltanissetta non è riuscita ad approfondirmi su altre cose che voi state trattando: sul telefono di Riina, sull’omicidio di Gioé e tante altre cose che ancora non ho potuto parlare”), oggi Pietro Riggio, il pentito nisseno che dal 2018 ha avviato una nuova fase della propria collaborazione con la giustizia raccontando una serie di circostanze sulla strage di Capaci, è tornato sul punto nel processo Stato-Mafia con rivelazioni roboanti. Rispondendo alle domande dei sostituti Pg, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera, ha approfondito quel suo accenno alle morti del pentito di Altofonte, Antonino Gioé (ritrovato morto, la notte tra il 28 e il 29 luglio del 1993, impiccato con i lacci delle scarpe nella cella in cui trascorreva la detenzione nel carcere di Rebibbia) – e La morte di Luigi Ilardo, omicidio di Stato E’ nei primi anni duemila che Pietro Riggio entrerà ufficialmente in Cosa nostra ed è in quel contesto che prende contatto con Angelo Ilardo, cugino del confidente-infiltrato morto nel maggio 1996. E’ con lui che parlò della morte del capomafia nisseno. “Lui mi disse espressamente che il cugino era morto perché voleva parlare di tutti quelli che erano stati gli intrecci che si erano succeduti tra il 1992 ed il 1995. Di tutte le cose più importanti che erano accadute, tra cui la strage di Falcone, di via d’Amelio, della massoneria, della nascita di Forza Italia, di Dell’Utri, di quelle cose che erano accadute in quel frangente temporale. E soprattutto mi disse che nessuno sapeva che era andato a Roma per iniziare ufficialmente quella che era la collaborazione. E pochissime persone sapevano di quella scelta: il procuratore Tinebra, il procuratore di Palermo di allora, la dottoressa Principato, e lo sapeva anche Riccio ed il colonnello Mori che si trovava lì quel giorno. Lui (Angelo Ilardo, ndr) è stato chiarissimo, è stato freddo. Se lo sono venduti lo Stato, ma non potendolo fare loro l’omicidio lo hanno fatto fare tramite appartenenti a Cosa nostra. Nel 2001 non si sapeva chi aveva ucciso Ilardo. Questo mi disse in sintesi”. Secondo Riggio, Angelo Ilardo avrebbe ospitato a Caltanissetta il cugino, raccogliendone le confidenze (“Mi raccontava che lo ospitava e che non lo vedeva sereno”). Sull’argomento è tornato con maggior precisione anche durante il controesame dell’avvocato Basilio Milio (difesa Mori) “Della morte di Luigi Ilardoparlai con il cugino, Angelo, con Carmelo Barbieri ed il boss catanese Alfio Mirabile. Seppi che l’ordine di uccidere Ilardo partì da una fonte istituzionale del tribunale di Caltanissetta che la diede ai carabinieri del Ros di Caltanissetta e che a sua volta la fecero sapere in giro. Ci fu un’azione ben precisa da parte del colonnello Mori che incaricò un suo uomo, un capitano che era in servizio in una caserma dei carabinieri di Catania e che era direttamente collegato a boss Zuccaro, della famiglia Santapaola, che da sempre era stato confidente dei carabinieri. Venne passata la notizia a lui affinché si facesse l’omicidio che non poteva essere più ritardato in nessuna maniera. Questo io lo apprendo da fonte mafiosa diretta: Alfio Mirabile. Quando venne dato l’ordine? Tra il gennaio e il maggio 1996″.
- Gioé e la lettera scomparsa Rispondendo ad una domanda specifica del sostituto Pg Barbiera, Riggio ha poi ribadito di aver saputo che la morte di Nino Gioé non è ascrivibile alla voce “suicidi”. In quel tragico anno del 1993 Riggio si sarebbe trovato molte volte a Roma in quanto membro della Commissione paritetica per i trasferimenti presso il ministero della Giustizia. Ed è in quella veste che sarebbe venuto a conoscenza di una serie di azioni effettuate all’interno delle carceri. “C’era un modus operandi a dir poco barbaro – ha detto intervenendo in video conferenza – i detenuti venivano picchiati sistematicamente con metodi quasi nazisti. Io lo so che la polizia penitenziaria aveva delle direttive ben precise e so che lo Stato copriva in quel momento la polizia penitenziaria qualsiasi cosa fosse accaduta. A Roma ho avuto modo da raccogliere le lamentele dei colleghi di Rebibbia e di quelli che avevano avuto a che fare con questo. Una sera parlando con un mio collega, Gianfranco Di Modugno, un pari corso mio, parlai anche della morte di Gioé. Tutti sapevano che non si era suicidato. Mi racconta Di Modugno che Gioé, il giorno in cui decise di voler collaborare, aveva fatto una lettera. Non la lettera che fu ritrovata, ma un’altra ben precisa in cui accusava e faceva dei nomi; dove parlava di stragi e dei contatti con servizi segreti con cui lui aveva avuto a che fare”. Alla richiesta di approfondimento da parte del Presidente Pellino sulla lettera scomparsa di Gioé ha poi aggiunto: “Da quel che mi fu riferito la seconda era falsa o comunque meno importante della prima. Era comunque scritta da Gioé”. Riggio ha spiegato che in quell’occasione sarebbe stato chiamato il colonnello Ragosa: “Lui era quello che se c’era un problema veniva investito. Lui andava e con le sue metodologie, buone o cattive, doveva risolvere un problema. E così avvenne con Gioé”. Nello specifico il pentito nisseno ha riferito l’esistenza di una vera e propria squadra di agenti “persone fidate, in mimetica, che arrivano all’interno delle sezioni, si prendono le chiavi e mandano tutti fuori. I miei ex colleghi devono avere il coraggio di dire che sono stati mandati via e sono entrate altre persone e si sono appropriate della sezione. Devono avere la dignità di parlare, perché è il momento di poter parlare. Loro sono stati esautorati e nessuno sa cosa è successo là dentro”. Rivolgendosi alla Corte ha anche raccontato l’esistenza del cosiddetto metodo ‘della scala’. “In poche parole – ha spiegato – per far parlare un detenuto o minacciarlo, loro mettevano una corda al collo del detenuto e tiravano dal basso verso l’alto e non il contrario, come si può pensare quando il detenuto si impicca e va dall’alto verso il basso. E per non legargli le mani e lasciargli dei segni, usavano dare dei pugni nel costato in modo che il detenuto, o chi si trovava in quei frangenti, non poteva tenersi per divincolarsi nella corda, perché tendeva a pararsi nel costato mentre loro tiravano con la corda. Un metodo che usavano sin dal 1980, come mi fu riferito dall’ispettore Lo Brutto Antonio, nel carcere militare. Questi erano i metodi da Gestapo usati in quel periodo”.
- Il cellulare di Riina Altro argomento approfondito ha riguardato anche il mancato trasferimento di Totò Riina dal carcere di Roma a quello di Firenze-Sollicciano e la presunta dotazione di un cellulare da parte del Capo dei capi. “Io mi trovavo in servizio a Firenze-Sollicciano e facevo parte dell’ufficio Comando – ha detto ancora – ed ero uomo di fiducia del direttore Paolo Quattrone che mi mandò a verificare lo stato del reparto M, per controllare se tutto era a posto, spiegandomi che avrebbero dovuto mandarci qualche detenuto importante. Qualche giorno dopo mi disse che volevano portare Totò Riina“. Il teste ha dunque spiegato che Quattrone non voleva avere problemi, per cui preparò una relazione riservata in cui si diceva che sotto il profilo sanitario non era in grado di gestire il detenuto. Anni dopo, in occasione di una cena, avrebbero ripreso il discorso e che in quella occasione “lui mi raccontò che a Rebibbia avevano scoperto che Riina aveva in uso un telefono cellulare”. Altro aspetto singolare riferito dal teste è lo scambio di parole che ebbe con Elio Ciolini(il depistatore noto per i suoi legami con l’estrema destra e servizi segreti, nonché per aver tentato di inquinare le indagini sulla strage alla stazione di Bologna del 1980) che nel marzo 1992 previde l’inizio “nuova strategia della tensione”che si sarebbe realizzata da lì a poco. “Ebbi modo di prelevare Ciolini, che era detenuto nella ottava sezione, la sezione protetta, e accompagnarlo all’interrogatorio con la Procura di Bologna. Ed ho avuto modo di scambiare delle parole con lui. Era frastornato al ritorno e mi raccontò di aver parlato con la Procura di Bologna e che aveva detto che da lì a poco sarebbero morti due giudici. Disse ‘Questi qua né mi ascoltano e né mi sentono. Vedremo come andrà a finire. Queste sono notizie devastanti, specie quando vedo quel che accadde a maggio e luglio”. Rispondendo ad una domanda del Presidente Pellino ha poi aggiunto che, pur non avendo mai sentito parlare del “Protocollo farfalla” era a conoscenza che “dentro le carceri entravano sempre persone particolari, senza avvisare l’autorità giudiziaria” e che di queste cose “non si lasciava traccia”.
- Di Maggio, Curioni e Fabbri davanti alla casa di Scalfaro La scorsa volta Riggio ha raccontato dell’invito ricevuto da Francesco Di Maggio, ex vice capo del Dap, di occuparsi con il sindacato delle rimostranze degli agenti della polizia penitenziaria in servizio a Pianosa e l’Asinara per giungere ad una chiusura di quelle carceri. Oggi il collaboratore ha riferito un altro episodio: “Un giorno, davanti all’abitazione del Presidente Oscar Luigi Scalfaro, ho visto Di Maggio, monsignor Fabbri e Curioni. Di questi ultimi due ero venuto a conoscenza dei problemi che avevano avuto con il vecchio capo del Dap, in quanto furono sfrattati da dove vivevano, in via Giulia”.
- Il mancato blitz a Mezzojuso Nel corso dell’esame il teste ha ribadito di aver appreso dai due marescialli Vincenzo Parrella e Pino Del Vecchio, conosciuti nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, alcuni particolari rispetto al mancato blitz per la cattura di Provenzano nelle campagne di Mezzojuso. Del Vecchio gli avrebbe riferito come loro fossero “pronti a catturarlo”, ma che in quella mattina del 31 ottobre 1995, “mancavano le minime direttive”. Unica cosa che fu permessa furono dei rilievi fotografici che “furono fatti, ma senza poi spingerci oltre”. “Lui – ha ricordato il teste – era rammaricato perché, diceva, ‘quel lavoro fatto era divenuto un boomerang’ in quanto non solo non avevano catturato Provenzano, ma nel tempo, nel momento in cui fecero delle rimostranze, subirono procedimenti per calunnia presso il tribunale di Torino. Se non erro loro avevano fatto il nome dell’allora responsabile del Ros in Sicilia, il colonnello Mori, che aveva vietato in tutte le sue forme che Bernardo Provenzano venisse catturato, e autorizzato solo un rilievo fotografico (va ricordato che Mori, nel processo per il mancato blitz, è stato assolto in via definitiva perché “il fatto non costituisce reato”, ndr)”. I due marescialli, che nelle loro propalazioni avevano rivolto delle critiche anche nei confronti del loro superiore diretto, Michele Riccio (certamente va ricordato come lo stesso colonnello dei carabinieri sia stato uno dei primi, con coraggio e non senza conseguenze, a denunciare proprio lo scandalo del mancato blitz) gli riferirono anche che altri colleghi si erano rifugiati in Sud America per non avere problemi. Tra le domande dell’avvocato Milio anche una sulla nostra testata, citata da Riggio nella scorsa udienza: “Lei ha riferito che dopo il racconto di Del Vecchio ha letto ANTIMAFIADuemila ed ha visto le foto che vennero scattate in quel giorno a Mezzojuso. ANTIMAFIADuemila in questo articolo confermava il racconto che Del Vecchio aveva fatto a lei?”. “Avvocato io ho detto che non ero sicuro se era ANTIMAFIADuemila o un altro giornale. Ho detto ‘può essere che era ANTIMAFIADuemila’. Ho detto che in una di queste foto, se non erro, si riconosceva Ferro all’impiedi fuori dalla macchina, accostato allo sportello, lui mi indicò che conosceva bene questa foto”. Di fronte alla grande rilevanza delle dichiarazioni di Riggio, ovviamente, un peso importante lo avranno gli eventuali riscontri che potranno essere, o non essere, trovati. Ed è in questa direzione che l’audizione del 23 novembre, quando sarà sentita la dirigente della Squadra mobile nissena Marzia Giustolisi, che ha compiuto gli accertamenti sulle dichiarazioni. Prima però, il prossimo 9 novembre, saranno sentiti da remoto il prefetto Rossi e l’ex direttrice degli affari Penali, Liliana Ferraro. Aaron Pettinari 26 Ottobre 2020 ANTIMAFIA Duemila
- La SENTENZA di primo grado per capitoli
- La Lunga trattativa STATO – MAFIA nel tempo
- Gli incontri con Don Vito
-
- 23.11.2020 Lettere criptiche e servizi: primi riscontri su Riggio
- 19.10.2020 Stato-mafia, pentito: “Stragi al Nord? Dell’Utri la mente”
- 17.08.2020 Ingroia: “Provenzano garante della trattativa”
- 20.07.2020 Sará chiesta l’audizione di Graviano ?
- 18.07.2020 Caselli: Borsellino ucciso per la trattativa Stato-mafia
- 13.07.2020 Ciancimino prescritto
- 09.06.2020 Avvocati degli imputati contro RAI e La7
- 19.05.2020 Palmeri parla dei Servizi segreti
- 31.03.2020 Pentito Fiume svela summit siculo-calabro
- 11.11.2019 Berlusconi non risponde ai giudici
- 04.11.2019 Mancata perquisizione covo Riina – CASELLI: mi fidai del capitano Ultimo
- 04.06.2019 Papello falso, richieste vere di Riina
- 06.05.2019 La Procura chiede 9 anni per l’ex ministro Calogero Mannino
- 29.04.2019 II Sezione della Corte di Palermo iniziato il processo d’appello
Deposizione generale Mario Mori – VIDEO
‘Ndrangheta stragista, il pentito Nucera: ”Nel ’93 il Sisde voleva far evadere Riina”
Mafia, massoneria e servizi. Virgiglio racconta il ”Potere” al processo ‘Ndrangheta stragista
‘Ndrangheta stragista, l’ispettore Provenzano e quel piano di morte per ucciderlo
‘Ndrangheta stragista, l’ispettore Zannino e i riscontri dei pentiti
- DOSSIER a cura di Attilio Bolzoni
- Salvatore Borsellino: “mio fratello fu uccisoper la Trattativa”
- Articoli
- Documentazione di Antimafia Duemila
- Trattativa Stato mafia speciale Cosa Vostra – video
FILM DOCUMENTARIO di Sabina Guzzanti
- PAOLO BORSELLINO e la verità ritrovata – Il rapporto tra Borsellino e i colleghi della procura di Palermo letto attraverso documenti inediti,che smontano parecchi teoremi sulla Trattativa stato mafia In occasione del ventisettesimo anniversario della strage di Via D’Amelio.
- Borsellino ucciso perché contrario alla trattativa
«Stato-mafia: al processo d’appello sarà sentito Pietro Riggio» L’ex agente di poliza penitenziaria Pietro Riggio. che di recente ha rilasciato una serie di dichiarazioni alle Procure di Caltanissetta e Firenze sulle stragi e le sue conoscenze con esponenti deviati dei servizi di sicurezza, sarà sentito nel processo d’appello sulla trattativa Stato-mafia. Lo ha deciso la Corte d’assise d’appello, presieduta da Angeli Pellino, che nella giornata di ieri si è espressa sulle nuove richieste istruttorie e di acquisizione di documenti presentate dalla Procura generale e dalle difese.
Così come chiesto alla scorsa udienza dai sostituti Procuratori generali, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera, il pentito sarà sentito “nello specifico in riferimento alla cattura di Bernardo Provenzano e su quel che gli sarebbe stato riferito da un tale Peluso, ovvero ‘che i carabinieri non sono di fatto interessati alla cattura di Provenzano’”, ma anche sui fatti inerenti le stragi.
Sentito in precedenti processi Riggio aveva raccontato che durante la sua detenzione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove si trovava assieme ad altri appartenenti di varie forze di polizia che avevano pendenze varie, venne coinvolto, in una prospettiva di successiva scarcerazione, per una attività parallela a quella delle forze di polizia ufficiali: un’attività di cattura latitanti.
“Lui – aveva ricordato Fici – dice che tramite le sue conoscenze in ambito mafioso nisseno avrebbe potuto fornire informazioni per la cattura di Bernardo Provenzano. Una volta uscito avrebbe iniziato ad operare a riguardo. Questi soggetti reclutati tra appartenenti di forze di polizia iniziano a collaborare per la cattura. E Riggio dà notizie che portano effettivamente ad individuare un funzionario della cancelleria di Caltanissetta. E questa squadra diventa operativa. In questo contesto succedono, dice Riggio, circostanze diverse e più significative. Dice lui che lo avrebbero voluto coinvolgere in un progetto omicidiario nei confronti del giudice Guarnotta e sostiene di aver saputo da un appartenente di questo gruppo che questi era stato coinvolto nella strage di Capaci”.
La Corte d’assise ha anche accolto la richiesta di audizione del funzionario di polizia Giustolisi, che ha collaborato ai riscontri del narrato del collaborante. Entrambi saranno sentiti il prossimo 19 ottobre.
All’udienza successiva, invece, saranno sentiti l’ex prefetto Luigi Rossi, la dottoressa Liliana Ferraro e Cinzia Calandrino, al tempo coordinatrice dei servizi presso la segreteria generale del Dap e responsabile della sezione quarta.
Saranno ascoltati a completamento del segmento di isturttoria inerente la vicenda del mancato trasferimento di Riina e dell’appunto del Sisde in cui si riferiva del possibile utilizzo di un cellulare da parte del Capo dei Capi quando questi era detenuto nel carcere Rebibbia di Roma.
La Corte d’assise ha inoltre accolto la richiesta di acquisizione della sentenza di revisione con cui il 15 marzo del 2017 la Corte d’Appello di Perugia ha assolto Domenico Papalia per l’omicidio di Antonio D’Agostino.
“La richiesta – ha letto Pellino – è accolta a completamento della documentazione già acuqisita sul tema relativo alla presunta prassi di accordi collusivi di settori deviati dei servizi di intelligence, o degli apparati di sicurezza, con esponenti di spicco di associazioni mafiose. Nello specifico per il ruolo, in tale contesto, di Domenico Papalia, personaggio menzionato nella lettera testamento Antonino Gioé proprio in riferimento all’omicidio D’Agostino”. Acquisiti anche i documenti sugli approfondimenti effettuati rispetto le dichiarazioni del pentito Armando Palmeri ed il verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore Francesco Di Carlo, recentemente deceduto.
Tra i documenti acquisiti anche le audizioni dei magistrati sentiti davanti al Csm dopo la strage di via d’Amelio “per ricostruire i contrasti all’interno della Procura di Palermo e le divergenze di valutazione su mafia-appalti e le scelte investigative effettuate su quel versante giudiziario”.
Sul fronte delle nuove prove acquisite vi è anche l’intercettazione telefonica captata il 20 luglio 2018 in cui l’avvocato Giancarlo Pittelli, ex senatore di Forza Italia arrestato nell’ambito dell’inchiesta Rinascita-Scott, commentava un articolo de Il Fatto Quotidiano in cui si parlava della sentenza trattativa Stato-mafia.
Per la Corte è una “prova sopravvenuta” e nell’ottica accusatoria “potrebbe assumere rilevanza sull’imputato Dell’Utri nel punto relativo contestato in atto d’appello sul perfezionamento del reato di minaccia a corpo politico dello Stato in pregiudizio del governo presieduto da Silvio Berlusconi”.
Nel’ordinanza sono state rigettate le acquisizioni inerenti gli approfondimenti della Procura generale sulla cosiddetta “vicenda Bianchi” tenuto conto che le “indicazioni in ordine a presunte o accertate collusioni di Marcello Dell’Utri con l’organizzazione mafiosa e Cosa nostra sono senza alcuna specifica connessione per i fatti per cui qui si procede a carico del medesimo imputato” e che lo stesso Alberto Maria Salvatore Bianchi, sentito dalla Procura generale, si avvalse della facoltà di non rispondere, dimostrando di “non avere volontà collaborativa”. Tra gli altri documenti acquisiti vi sono poi i verbali a sommarie informazioni di Vardaro, De Pascalis e Piercamillo Davigo. 6.10.2020 ANTIMAFIA 2000 di Aaron Pettinari
LE STRAGI MAFIOSE DEL 1993 E LA TRATTATIVA PER L’ALLEGGERIMENTO DEL 41-BIS La cattura del capo dei capi Totò Riina aprì ufficialmente la lotta alla successione al vertice della Commissione di Cosa Nostra. A contendersi il posto di comando dell’organizzazione criminale furono due corleonesi: Bernardo Provenzano, compagno di delitti di Riina fin dagli albori, e Leoluca Bagarella, fratello di Ninetta, la moglie del capo dei capi. A spuntarla fu proprio Bernardo Provenzano, il quale, diventato capo di Cosa Nostra, promise che prima di consultarsi con gli altri boss della Cupola si sarebbe interfacciato in via preliminare con Leoluca Bagarella. Come abbiamo raccontato, il primo era a capo di quella schiera di mafiosi che preferivano trattare con lo Stato italiano piuttosto che perseguire sulla via della strategia stragista; il secondo, invece, militava nell’ala più violenta della Cupola, che aveva sempre fatto riferimento a Totò Riina, propensa all’attacco frontale a uno Stato che, come provato dall’attivazione dei Carabinieri del Ros all’indomani della morte di Giovanni Falcone (atto che sancì l’inizio della “trattativa”), aveva già dato agli uomini d’onore l’impressione di essersi piegato di fronte al loro peso specifico.
Le due fazioni arrivarono ad un compromesso: la mafia avrebbe continuato a far esplodere le bombe, ma solo fuori dalla Sicilia. Infatti:
- Il 14 Marzo del 1993 i mafiosi fecero esplodere un’autobomba a Roma, in via Fauro, con l’obiettivo di uccidere Maurizio Costanzo, il quale stava uscendo dagli studi del Maurizio Costanzo Show. Il conduttore rimase illeso, poiché il mafioso Salvatore Benigno, aspettando Costanzo su un’automobile diversa da quella su cui viaggiava, azionò il telecomando con qualche istante di ritardo. Furono ferite ventiquattro persone.
- Il 26 Maggio del 1993 la mafia decise di colpire in via dei Georgofili, a Firenze, nei pressi della Galleria degli Uffizi. A cadere, questa volta, furono cinque persone: i coniugi Fabrizio Nencioni (39 anni) e Angela Fiume (36 anni), le loro figlie Nadia Nencioni (9 anni) e Caterina Nencioni (50 giorni di vita) e lo studente Dario Capolicchio (22 anni). Circa quaranta persone rimasero ferite per l’esplosione dell’autobomba.
- La sera del 27 Luglio del 1993 un’autobomba esplose in via Palestro (in foto), a Milano, presso la Galleria d’arte moderna e il Padiglione di arte contemporanea, uccidendo cinque persone: i Vigili del Fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l’Agente di Polizia Municipale Alessandro Ferrari e Moussafir Driss (immigrato del Marocco che stava dormendo su una panchina). Dodici i feriti.
- Poco dopo, nella notte tra il 27 e il 28 Luglio, vennero fatte esplodere due autobombe a Roma, precisamente davanti alle chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni Laterano. Ventidue persone rimasero ferite.
Il 4 Giugno del 1993, all’indomani delle bombe in Via Fauro e agli Uffizi, il Consiglio dei Ministri presieduto da Carlo Azeglio Ciampi e di cui, come Ministro della Giustizia, faceva parte Giovanni Conso, destituì Nicolò Amato (sostenitore della linea dura sul 41 bis) dalla carica di capo dell’Amministrazione penitenziaria. Al suo posto venne nominato il più “morbido” Adalberto Capriotti. Quale fu l’antefatto di questa delibera? Una lettera pervenuta nel Febbraio 1993 al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro da parte di Cosa Nostra, firmata da “un gruppo di familiari di detenuti”, che così recitava: “Siamo un gruppo di familiari di detenuti che, sdegnati e amareggiati da tante disavventure, ci rivolgiamo a Lei perché riteniamo che sia responsabile in prima persona, quale rappresentante e garante delle più elementari forme di civiltà. […] Non chiediamo indulgenze particolari o grazie ma soltanto il rispetto di dignità di persone che, nella disgrazia, stanno pagando, senza battere ciglio, i loro debiti giusti o ingiusti che siano. Per noi significa dare la possibilità ai detenuti tutti di sopportare la restrizione in maniera dignitosa, cioè avere la possibilità di incontrarsi con i familiari senza spendere un patrimonio, la possibilità di poter portare, almeno settimanalmente, la biancheria oltre al vitto ai detenuti; togliere gli squadristi al servizio del DITTATORE AMATO, dando dignità di detenuti ai detenuti. […] Al momento non crediamo che la volontà dello Stato che Lei rappresenta sia così civile nel dare una risposta adeguata. La sfidiamo a smentirci”. Insomma Cosa Nostra, per mezzo di questa missiva, si rivolse esplicitamente alla massima carica dello Stato per esigere la testa del capo dell’Amministrazione penitenziaria, i cui metodi erano per essa sconvenienti.
Nel 2003 don Fabio Fabbri, segretario particolare di Oscar Luigi Scalfaro, rivelerà ai magistrati che l’allora Presidente della Repubblica chiamò al Quirinale don Cesare Curioni, Cappellano delle carceri, dicendogli le seguenti parole: «Caro Monsignore, ho parlato ieri per telefono con il ministro Conso. La prego di dargli tutto il suo aiuto per individuare il nuovo direttore generale (dell’Amministrazione penitenziaria, ndr)». Insomma, occorreva destituire nel più breve tempo possibile Nicolò Amato. Il quale, nel suo libro “Gli amici senza volto di Corleone”, dice (senza peli sulla lingua) la sua in merito a questa vicenda: «Il 4 Giugno del 1993, il Consiglio dei Ministri, con la presenza (!), almeno formale, di Giovanni Conso, accontentò Scalfaro e mi mandò via. Era pure, ovviamente, indispensabile mettere al posto di un “dittatore” come me, persone accomodanti e sensibili all’accorato grido d’aiuto che la mafia aveva rivolto al Presidente Scalfaro, giustamente confidando nella sua carità cristiana. E la sostituzione fu perfetta. Non si sarebbero potuti accontentare di più e meglio i poveri, affranti familiari dei detenuti che avevano scritto la lettera del 17 Febbraio 1993. Così è un fatto che, in mia sostituzione, furono nominati Adalberto Capriotti, un anziano magistrato, quale formale direttore del DAP e già gratificato per questo, e Francesco Di Maggio, quale vice direttore, ma non scelto dal direttore generale, bensì a lui imposto d’autorità, nonostante, essendo solo magistrato di tribunale, non ne avesse il titolo – sicché fu necessario nominarlo, con una bizzarra prepotenza istituzionale, dirigente generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -, e messo lì perché amico del Capo della Polizia e assai vicino agli onnipresenti e onnipotenti Servizi segreti, con l’incarico di dirigere di fatto il DAP». Nel 1993, inoltre, verranno sostituiti i ministri firmatari del cosiddetto “Decreto Falcone”, ovvero Claudio Martelli (Ministro della Giustizia) e Vincenzo Scotti (Ministro della Difesa), rimpiazzati rispettivamente da Giovanni Conso e Nicola Mancino. Lo stesso anno, proprio Giovanni Conso scelse di non rinnovare il 41-bis a 334 mafiosi sottoposti al carcere duro, restituendoli al carcere ordinario. Interrogato sulle motivazioni di questa scelta, Conso sosterrà davanti alla Commissione antimafia di averlo fatto per «frenare la minaccia di altre stragi” ANTIMAFIA DUEMILA 5.10.2020 STEFANO BAUDINO
L’invito al dialogo che i carabinieri fecero arrivare al boss Totò Riina dopo la strage di Capaci indusse Cosa nostra e il suo capo dell’epoca, Totò Riina, ad accelerare i tempi dell’eliminazione di Paolo Borsellino. Lo sostengono i giudici della corte d’assise di Palermo che nel dicembre 2018 hanno depositato le motivazioni della sentenza sulla cosiddetta “trattativa Stato-mafia”. “Ove non si volesse prevenire alla conclusione dell’accusa che Riina abbia deciso di uccidere Borsellino temendo la sua opposizione alla `trattativa´ conclusione che peraltro trova una qualche convergenza nel fatto che secondo quanto riferito dalla moglie, Agnese Piraino Leto, Borsellino, poco prima di morire, le aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle istituzioni e mafiosi, in ogni caso non c’è dubbio che quell’invito al dialogo pervenuto dai carabinieri attraverso Vito Cianciminocostituisca un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino, con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato e di lucrare, quindi, nel tempo dopo quell’ulteriore manifestazione di incontenibile violenza concretizzatasi nella strage di via d’Amelio, maggiori vantaggi rispetto a quelli che sul momento avrebbero potuto determinarsi in senso negativo”. La corte ha poi negato che Borsellino sia stato ucciso per l’accelerazione dei tempi dell’indagine mafia-appalti che il magistrato stava effettuando e anche alla possibilità di una sua nomina a Procuratore Nazionale Antimafia. E ha spiegato che il ruolo di Marcello Dell’Utri sarebbe stato decisivo: “Con l’apertura alle esigenze dell’associazione mafiosa Cosa nostra, manifestata da Dell’Utri nella sua funzione di intermediario dell’imprenditore Silvio Berlusconi nel frattempo sceso in campo in vista delle politiche del 1994, si rafforza il proposito criminoso dei vertici mafiosi di proseguire con la strategia ricattatoria iniziata da Riina nel 1992″. E ancora: “Se pure non vi è prova diretta dell’inoltro della minaccia mafiosa daDell’Utri a Berlusconi, perché solo loro sanno i contenuti dei loro colloqui, ci sono ragioni logico-fattuali che inducono a non dubitare che Dell’Utri abbia riferito a Berlusconi quanto di volta in volta emergeva dai suoi rapporti con l’associazione mafiosa Cosa nostra mediati da Vittorio Mangano“.
Strage Borsellino, c’è un nuovo indagato: il dottore Cinà. Era il medico di Totò Riina, l’uomo del “papello” Il gip rigetta la richiesta di archiviazione dei pm nisseni. Il professionista palermitano è stato già condannato al processo Trattativa Stato-mafia Non si ferma l’inchiesta della procura di Caltanissetta per provare a dare un nome ai mandanti delle bombe del 1992. I magistrati hanno messo sotto inchiesta per la strage Borsellino il dottore Antonino Cinà, il medico di Totò Riina, l’uomo che avrebbe preso in consegna il “papello” scritto dal capo dei capi, con le sue condizioni per fermare la stagione delle stragi. “Papello” poi consegnato all’ex sindaco mafioso di Palermo, Vito Ciancimino, che nell’estate 1992 intratteneva un dialogo segreto con alcuni carabinieri del Ros. Cinà è stato già condannato a 12 anni nel processo “Trattativa Stato-mafia”, la stessa condanna hanno avuto gli ex ufficiali Mario Mori e Antonio Subranni, protagonisti con l’allora capitano Giuseppe De Donno (ha avuto 8 anni) degli incontri con Ciancimino. Del nuovo filone d’indagine sulle stragi, riguardante Antonino Cinà ,si apprende solo adesso, perché il gip di Caltanissetta Valentina Balboha rigettato la richiesta di archiviazione presentata dal pool nisseno coordinato dal procuratore Amedeo Bertone e dall’aggiunto Gabriele Paci. Il giudice delle indagini preliminari ha fissato un’udienza per discutere del caso, si terrà il 28 ottobre, al palazzo di giustizia di Caltanissetta. Il magistrato potrebbe disporre nuovi approfondimenti. Dice l’avvocato Fabio Repici, parte civile nei processi delle stragi al fianco di Salvatore Borsellino, il fratello del giudice Paolo: “Con il rigetto della richiesta di archiviazione formulata dalla procura di Caltanissetta, si prospetta la preziosa opportunità di un ulteriore importante approfondimento nella ricostruzione dei tempi e delle ragioni della strage di via D’Amelio e dell’accelerazione nella sua esecuzione. Sulla posizione di Cinà, infatti, possono trovare un formidabile punto di saldatura gli scenari illustrati dalla corte di assise di Caltanissetta nella sentenza del processo Borsellino quater e dalla corte di assise di Palermo nella sentenza sulla trattativa Stato-mafia”. I giudici del processo Trattativa hanno ipotizzato che Borsellino sia stato ucciso perché aveva scoperto il dialogo segreto fra un pezzo dello Stato e i vertici di Cosa nostra. Cinà, di certo, conosce il segreto della Trattativa. Ma è sempre rimasto un irriducibile, da anni ormai è detenuto al carcere duro, con una condanna all’ergastolo, in quanto ritenuto mandante dell’omicidio di un giovane capomafia palermitano non rispettoso delle regole dell’organizzazione. di SALVO PALAZZOLO La Repubblica
3.10.2019 Processo Stato-mafia, Di Pietro: “Falcone mi disse, controlla gli appalti in Sicilia”L’ex pm di Man Pulite rievoca l’inizio dell’indagine su Tangentopoli. Borsellino mi confidò: “Bisogna fare presto”. Un pezzo della tangente Enimont arrivata in Sicilia, a Salvo Lima Precisa: “Con i dottori Falcone e Borsellino ho avuto rapporti di lavoro all’epoca in cui ero sostituto procuratore a Milano, non posso dire di essere stato loro amico, ma ci incontravamo”. Antonio Di Pietro, ex pubblico ministero di “Mani Pulite”, rievoca i contatti con Giovanni Falcone all’inizio del 1992: “Dopo l’arresto di Mario Chiesa c’era bisogno di fare alcune rogatorie in Svizzera. Volevamo trovare la provvista per le tangenti. Falcone era direttore degli affari penali del ministro della Giustizia: mi fece da insegnante in una materia di cui sapevo poco, mi mise anche in contatto con la collega svizzera Carla Del Ponte“. Al processo d’appello per la “Trattativa Stato mafia”, il legale del generale Mario Mori, l’avvocato Basilio Milio, ha convocato l’ex senatore per chiedergli di parlare delle indagini sulle tangenti attorno alle opere pubbliche, di cui anche i carabinieri del Ros si erano occupati in quella stagione. “Falcone mi disse, guarda negli appalti in Sicilia – dice Di Pietro – Il giorno del funerale di Falcone, ne parlai con Borsellino. Che mi sussurrò: ‘Bisogna fare presto’. Era un riferimento a coordinare le indagini sul territorio nazionale”. Di Pietro parla anche della maxitangente Enimont, 150 miliardi delle vecchie lire: “In parte, quei soldi provenienti dall’imprenditore Raul Gardini, in Cct, arrivarono pure in Sicilia, a Salvo Lima. Sarebbero arrivati attraverso Cirino Pomicino“. “Dopo la morte di Borsellino rimasi scosso – prosegue l’ex pm – avevo capito la diffusione del sistema, mi chiusi in me e continuai a indagare. Intanto, era arrivata una segnalazione del Ros, per una minaccia di attentato nei miei confronti. E con un ufficiale del Ros, di cui non ricordo il nome, andai a parlare in carcere con l’ex capo area della Rizzani De Eccher in Sicilia, il geometra Giuseppe Li Pera“. Quell’ufficiale era l’allora capitano Giuseppe De Donno, rivela in aula il suo legale, l’avvocato Francesco Romito. Anche De Donno è stato condannato in primo grado nel processo “Stato-mafia”. “Disse che Li Pera poteva parlare di tanti appalti in Sicilia. Aggiunse che a Palermo non volevano sentirlo”. Il racconto di Antonio Di Pietro si fa appassionato quando rievoca i suoi colleghi uccisi nel 1992: “Falcone mi disse che in Sicilia bisognava fare i conti con un terzo soggetto. Accanto ai politici e agli imprenditori, i mafiosi. Ne parlai con Borsellino, che però non mi disse quello che stava facendo, non mi disse che stava lavorando sul rapporto mafia e appalti, e che stava ascoltando il pentito Mutolo. Mi disse però che dovevamo tornare a incontrarci, era convinto che in Italia ci fosse un sistema di spartizione nazionale attorno agli appalti”. Il discorso torna sulla maxi tangente Enimont: “L’avvocato di Gardini, all’epoca latitante, mi assicurò che si sarebbe consegnato. Io volevo sapere che fine avessero fatto i soldi della maxi tangente. La notte prima dell’interrogatorio, l’imprenditore tornò nella sua abitazione, che tenevamo sotto controllo. La polizia giudiziaria mi chiese se doveva scattare l’arresto. Dissi di aspettare”. La mattina seguente, Gardini si suicidò. “E’ il dramma che mi porto dentro”, dice Di Pietro. Che poi, però, sbotta: “Questo che c’azzecca con la trattativa?”. Ma dice: “Sono convinto che la morte di Paolo Borsellino sia legata alle indagini sugli appalti che voleva avviare. Io sono stato invece fermato con la delegittimazione, attraverso un’attività di dossieraggio messo in atto da uomini dei servizi segreti. Su questo bisognerebbe indagare per capire perché è finita l’inchiesta Mani Pulite”. di SALVO PALAZZOLO 03 ottobre 2019 LA REPUBBLICA
19.9.2019 – Trattativa Stato-Mafia, pentito: «Dell’Utri svelò ai Graviano il covo di Contorno» La rivelazione è del pentito catanese Francesco Squillaci che ha deposto in videoconferenza nel processo d’appello sulla presunta trattativa “Tra il 1998 e il 2000 mio padre era nel carcere di Spoleto dove ha stretto amicizia con i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. Mio padre mi ha raccontato che i Graviano gli dissero che avevano individuato il collaboratore Totuccio Contorno a Roma e che non erano riusciti ad ucciderlo per poco. Sempre i fratelli Graviano, che si vantavano di avere una amicizia stretta, intima con Dell’Utri, dissero che sarebbe stato proprio lui che attraverso servizi segreti deviati, avrebbe fatto sapere dove si trovava Contorno“. Lo ha detto il collaboratore di giustizia Francesco Squillaci, continuando la sua deposizione, in videoconferenza al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e mafia davanti alla seconda sezione della corte d’assise di appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellin. Tra gli imputati del processo, accusato di minaccia a corpo politico dello Stato, c’è anche l’ex senatore di Fi Marcello Dell’Utri che in primo grado è stato condannato a 12 anni. LA SICILIA
20.05.2019 Trattativa Stato-mafia, il PG chiede di acquisire i verbali del pentito Bisconti su Mannino La procura ha messo a disposizione della corte i verbali chiedendo, qualora fossero acquisiti, la riapertura del dibattimento e l’esame del pentito. In primo grado l’ex ministro Dc era stato assoltoTrattativa Stato-mafia, il PG chiede SEGUE
A poco più di un anno di distanza dalla storica sentenza di primo grado, che ha portato alla condanna, con l’accusa di attentato a corpo politico dello Stato, dei boss SEGUE
- ADNKRONOS 29.4.2019
- RAI NEWS 29.4.2019
- LA REPUBBLICA 29.4.2019
- IL FATTO QUOTIDIANO 29.4.2019
- MERIDIO NEWS 29.4.2019
- ADNKRONOS 28.4.19
- LIVE SICILIA 28.4.19
- STRETTO WEB 28.4.2019
La lunga trattativa Stato-mafia
Stato-mafia, chiesti approfondimenti su detenzione di Riina nel ’93
Ci fu un patto con Cosa Nostra? Le argomentazioni difensive riferite sul punto,secondo le quali si riteneva che il latitante non conservasse cose di rilievo nella propria abitazione, perché “il mafioso” non terrebbe mai cose che possono mettere in pericolo la famiglia, appaiono fondate su una massima di esperienza elaborata dagli stessi imputati ma non verificata empiricamente ed anzi contraddetta dalla risultanza offerta proprio dal materiale rinvenuto indosso al boss.
Pertanto, già il 15.1.93, sussisteva la concreta e rilevante probabilità che esistesse altra documentazione in via Bernini; probabilità che è stata confermata in dibattimento dal Brusca e dal Giuffré, secondo cui Salvatore Riina era solito prendere appunti, teneva una contabilità dei proventi criminali, annotava le riunioni e teneva una fitta corrispondenza sia con il Provenzano che con altri esponenti mafiosi, per la “messa a posto” delle imprese e la gestione degli affari.
Accertare se tali documenti effettivamente esistessero, se fossero custoditi all’interno della villa e quale sorte abbiano avuto, non può avere alcuna refluenza – ad avviso del Collegio – sulla sussistenza del reato contestato, atteso che il dato certo del ritrovamento indosso al Riina di materiale cartaceo, unito ad indizi di carattere logico, pienamente confermati dalle deposizioni testimoniali acquisite, già di per sé consente di ritenere che l’omessa perquisizione della casa e l’abbandono del sito sino ad allora sorvegliato abbiano comportato il rischio di devianza delle indagini che, difatti, nella fattispecie si è pienamente verificato, stando alle manifestazioni di sollievo e di gioia manifestate da Bernardo Provenzano e da Benedetto Spera al Giuffré (i quali ebbero a dichiarare che per fortuna le forze dell’ordine non avevano potuto trovare “nulla” con ciò intendendo riferirsi proprio a documenti) ed, ancora, alla soddisfazione espressa, durante le fasi dello svuotamento della casa, da parte del Sansone, e condivise dal La Barbera, dal Gioè, dal Brusca, dal Bagarella per il fatto che stava procedendo tutto “liscio” (cfr. in particolare le dichiarazioni di Gioacchino La Barbera).
D’altronde, appare evidente che l’ambito di un’indagine per il delitto di cui all’art. 416 bis C.P. si presenta particolarmente ampio, potendo ricomprendere una molteplicità di condotte e dispiegare i suoi effetti in relazione ad una pletora di personaggi, quali altri correi indagati in diversi filoni di inchiesta, per cui l’omessa perquisizione e la disattivazione del dispositivo di controllo di un luogo di pertinenza di un affiliato, e qui si trattava del capo di “cosa nostra”, appare condotta astrattamente idonea ad integrare non solo il favoreggiamento aggravato, ma lo stesso concorso nel reato associativo, ove si dimostri la sussistenza degli altri presupposti in punto di dolo e di efficienza causale del contributo di cui agli artt. 110 e 416 bis C.P..
Ne deriva che – ad avviso del Collegio – il punto nodale per la ricostruzione della vicenda in esame non può essere ricercato – contrariamente a quanto prospettato dalle difese – sul piano oggettivo, occorrendo invece indagare anche il “perché” siano accaduti gli avvenimenti che ci occupano.
Richiamata la narrazione degli accadimenti fattuali già esposta nella prima parte di questa sentenza, si osserva, sinteticamente, che la prospettiva accusatoria rimane ancorata ai seguenti elementi indiziari:
il giorno dell’arresto del Riina Sergio De Caprio chiese insistentemente, con l’appoggio di Mario Mori, che la perquisizione già predisposta sul complesso di via Bernini, non venisse eseguita, garantendo l’osservazione sul sito;
il pomeriggio alle ore 16.00 il furgone, con a bordo l’app.to Coldesina ed il Di Maggio, fu fatto rientrare ed il servizio non venne più predisposto;
tale decisione non fu oggetto di alcuna comunicazione;
il ROS non svolse più alcuna attività di indagine;
il 20.1.93 il De Caprio chiese che si effettuasse una perquisizione al cd. “fondo Gelsomino” come attività diversiva di depistaggio, nel presupposto che via Bernini fosse sotto osservazione;
in una riunione in data 27.1.93 Mario Mori accennò al fatto che il servizio era stato sospeso da tempo, decidendosi a rivelarlo solo il 30.1.93;
già a dicembre 1992 Mario Mori, con la consapevolezza del Di Caprio, aveva intavolato una trattativa segreta con “cosa nostra” tramite Vito Calogero Ciancimino, per ottenere una resa dei latitanti;
il ROS non poteva conoscere il sito di via Bernini, in quanto non era tra quelli indicati dal Di Maggio, dunque il Riina fu “consegnato” dalla stessa associazione criminale, ed in particolare da Bernardo Provenzano, in ossequio ad un patto di “non belligeranza” stipulato con il Mori. capitolo tratto da “Il grande mistero del covo” – stralci di sentenza . A. BOLZONI, S. BORTOLETTO, F. TROTTA – LA REPUBBLICA
Il silenzio sulla Trattativa Stato-Mafia, Roberto Scarpinato e l’urlo di Pasolini. Quando (il 1° febbraio 1975, sul Corriere della Sera) Pier Paolo Pasolini volle indicare lo stravolgimento della politica italiana, che introdusse il definitivo e radicale spartiacque con “i valori traditi” della Resistenza”, ponendo le basi, a suo dire, per un nuovo e più totale fascismo in Italia, ricorse all’immagine della “scomparsa delle lucciole”. Immagine poetica, espediente suggestivo, poco razionale, ma che aveva il merito indiscusso di sintetizzare, in maniera fulminea, ciò che era accaduto. Erano trascorsi esattamente trent’anni dalla Liberazione dal nazifascismo. E appena tre mesi da quell’altro proverbiale articolo (14 novembre 1974, ancora sul Corriere della Sera) in cui, enumerando le prime stragi di Stato dell’epoca (Milano, Brescia e Bologna), rimaste senza colpevoli – cioè senza esecutori e senza mandanti -, Pasolini aveva sintetizzato, altrettanto efficacemente: “Cos’è questo golpe? Io so”. Specificando poi, nel corpo dell’articolo: “Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi”. Dall’analisi pasoliniana sono trascorsi – adesso – altri quarantacinque anni. Verrebbe da dire che l’urlo pasoliniano è rimasto inascoltato. Le stragi di Stato – e i delitti di Stato – si sono susseguiti, con macabra cadenza. Lo stragismo sfociò persino nel delitto Moro; con Leonardo Sciascia che, volendone scrivere poliziescamente nel libro “L’affaire Moro”, come cioè avrebbe dovuto fare – ma non fece – la polizia di allora, iniziò il suo ragionamento proprio dalla scomparsa delle lucciole di pasoliniana memoria. Questo breve riepilogo (che tornerà utile fra un po’), ci porta sin dentro le parole pronunciate qualche giorno fa da Roberto Scarpinato, procuratore generale a Palermo, che ha descritto in maniera tranchant – in un dibattito pubblico – il filo d’acciaio che si è dipanato dalla strage di Portella della Ginestra (1947) sino a Capaci, via d’Amelio, Roma, Milano e Firenze. Due, per Scarpinato, i collanti comuni di questo stragismo apparentemente oscuro: il ruolo dei servizi segreti, civili e militari a seconda dei casi, nella gigantesca opera di depistaggio dell’attività della magistratura per impedirle di scoprire la verità; l’eliminazione, con delitti e finti “suicidi”, di tutti coloro i quali avevano offerto la loro compartecipazione criminale a quella strategia che, sempre per Scarpinato, è stata la caratteristica del potere politico italiano. Un potere che, quanto a ferocia – ha aggiunto – non ha mai avuto uguali in nessun paese d’Europa. Le parole di Scarpinato, sia detto per inciso, andrebbero ascoltate senza pregiudizio, come dovrebbe accadere in un Paese che fosse intenzionato per davvero, ora che il sangue di migliaia di morti si è inevitabilmente asciugato, a fare i conti con il suo passato. Se no – ma questo lo diciamo noi – non se ne esce, né se ne uscirà mai. Ma dove porta il filo d’acciaio che parte da Portella (a non volerlo retroattivamente prolungare, questo filo, sino al delitto Notarbartolo, o, più indietro ancora nel tempo, al delitto Petrosino)? A questa altra constatazione di Scarpinato: che “ci sono dei poteri, che sono ancora poteri, che hanno una capacità di intervento e di intimidazione tale da impedire che la verità venga accertata, per cui chi sa non parla”. Il Potere – verrebbe da dire – è ben più longevo di Cosa Nostra. Scarpinato non ne fa una questione di memoria negletta, o poco coltivata, di quanto è accaduto. Infatti aggiunge: “questo non è soltanto un dramma della conoscenza e della memoria, questo diventa un dramma della democrazia. Il gioco grande non è mai finito”, Parole pesanti. Solo illusi visionari potrebbero, oggi, dire che si stia tornando all’epoca d’oro delle lucciole. A ben guardare, infatti, il filo d’acciaio di cui sopra arriva intatto sino ai nostri giorni. Il potere italiano, in altre parole, non ha mai fatto una grinza. Ha scavalcato, a suon di bombe e depistaggi, il mezzo secolo che data dalla scomparsa di Pasolini. Ma che prezzi enormi ha dovuto pagare, se persino un capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha ritenuto più opportuno, per il bene della Patria, il silenzio, in luogo della parola. Ormai nove italiani su dieci “sanno”, esattamente come “sapevano” Pasolini e Sciascia. Sanno che non fu mai “sola Mafia”. Con in più – e questo non andrebbe nascosto -, le oltre 5000 pagine di sentenza del primo grado del processo di Palermo, sulla trattativa Stato-Mafia, presieduto da Alfredo Montalto, giudice a latere, Stefania Brambille, che si è concluso con condanne per uomini politici, rappresentanti dello Stato, boss mafiosi. Sono pagine che fanno rabbrividire chi tenta di capire, senza pregiudizio, cosa è stata l’Italia degli ultimi decenni. Scarpinato non poteva parlarne – né toccava a lui farlo – in considerazione del ruolo che ricopre a capo della Procura generale, e in vista proprio della imminente sentenza di appello di quel processo. Ma gli altri sì, che potrebbero parlarne. E dovrebbero parlarne tanto, e ad altissima voce. Ma non se la sentono. Certi intellettuali, certi notisti politici, certi esponenti politici, certi direttori di giornali e storici di mafia, persino certi parenti delle vittime, che restano invece in imbarazzato silenzio, certe televisioni di Stato e televisioni private, danno l’ impressione di voler nascondere la polvere sotto il tappeto. E non si accorgono che altri (i poteri ai quali si riferisce Scarpinato), nel frattempo, ne approfittano per nascondere, sotto il tappeto, la polvere da sparo (che può sempre tornare utile), con buona pace per il ritorno delle lucciole. ANTIMAFIA 2000 06 Settembre 2020. di Saverio Lodato
il PROCESSO DI PRIMO GRADO 
6.12.2018 “La trattativa accelerò via D’Amelio e attivò le altre stragi del ’93” “Padrini fondatori”- La Corte di Assise di Palermo afferma che i vertici del Ros e i loro mandanti (purtroppo occulti, ma riferibili temporalmente al primo governo di Giuliano Amato) hanno sulla coscienza gli omicidi di Borsellino… LEGGI TUTTO
PROCESSO TRATTATIVA STATO-MAFIA: arrivata la sentenza – 19 Luglio 2018 – In coincidenza con il 26° Anniversario della Strage di Via D’Amelio, sono state depositate le oltre 5 mila pagine che compogono la Sentenza dello scorso 20 Aprile 2018
- Capitolo – LA TRATTIVA STATO-MAFIA accellerò l’esecuzione di Paolo Borsellino
- Capitolo – IL PAPELLO
- Capitolo – LA MANCATA PERQUISIZIONE AL COVO DI RIINA
- Capitolo – MAFIA e APPALTI
Le tappe del processo Le motivazioni della sentenza emessa il 20 aprile scorso dalla corte d’assise di Palermo. I giudici condannarono Mori, De Donno, Subranni e Dell’Utri, assoluzione per Mancino
- Intercettazione telefonica tra Lors D’Ambrosio, Consigliere giuridico del Presidente della Repubblica Napolitano e Nicola Mancino, ex Ministro dell’Interno
- Intercettazione telefonica tra gli ufficiali dei Carabinieri Mori e De Donno
- Mori, De Donno e la Signora Borsellino
“L’improvvisa accelerazione che ebbe l’attentato a Paolo Borsellino” fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo – ed in sostanza, di cedimento Cosa Nostra culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Amelio”. Per i giudici del processo Trattativa Stato-mafia, “non vi è dubbio” che i contatti fra gli ufficiali dei carabinieri Mori e De Donno con Vito Ciancimino, unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l’avvicendamento di quel ministro dell’Interno che si era particolarmente speso nell’azione di contrasto alle mafie, in assenza di plausibili pubbliche spiegazioni) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Salvatore Riina già come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa nella misura in cui quegli ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato”. I giudici scrivono ancora: “Ove non si volesse prevenire alla conclusione dell’accusa che Riina abbia deciso di uccidere Borsellino temendo la sua opposizione alla trattativa, conclusione che peraltro trova una qualche convergenza nel fatto che secondo quanto riferito dalla moglie, Agnese Piraino Leto, Borsellino, poco prima di morire, le aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle istituzioni e mafiosi, in ogni caso non c’è dubbio che quell’invito al dialogo pervenuto dai carabinieri attraverso Vito Ciancimino costituisca un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino, con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato e di lucrare, quindi, nel tempo dopo quell’ulteriore manifestazione di incontenibile violenza concretizzatasi nella strage di via d’Amelio, maggiori vantaggi rispetto a quelli che sul momento avrebbero potuto determinarsi in senso negativo”.
Il 28 ottobre 2014 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano viene ascoltato al Quirinale dalla Corte da Assise di Palermo.
Verbale d’udienza deposizione Napolitano 28/10/2014
Intervento di Antonino Di Matteo18.10.2018
- 26 anni dopo via D’Amelio, Palermo ricorda Borsellino – askanews
- A 26 anni dall’assassinio di Paolo Borsellino. Dove si annida oggi Cosa Nostra? – Senso Comune
- Accelerazione sul processo trattativa – Il Foglio
- Accordo Stato-mafia e la fine di Borsellino – tv svizzera.it
- Berlusconi sapeva dei rapporti Dell’Utri-mafia” – L’HuffPost
- Borsellino quater e Trattativa: “Nelle sentenze parole incredibili di Dell’Utri a Berlusconi” – il Sicilia
- Borsellino quater e trattativa Stato-mafia, parla Ingroia «Il governo – Meridio News
- Borsellino, i giudici e via D’Amelio: “il dialogo tra Stato e mafia accelerò quella strage” Ristretti Orizzonti
- Borsellino, i giudici: «La trattativa Stato-Mafia accelerò la sua morte» – Corriere della Sera
- Borsellino, la Trattativa e quella «premura» di ucciderlo. Riina: «Non era studiato da mesi, studiato alla giornata» – Meridio News
- Borsellino, Mattarella: “Non smettere di cercare la verità sulla strage – Il Fatto Quotidiano
- Borsellino -Macché depistaggi, fu vittima – Il Sussidiario.net
- Borsellino: “Berlusconi sapeva ”trattativa stato-mafia accelerò la morte del giudice – Il Sussidiario.
- CORCIANO: Nel ricordo di Paolo Borsellino le Agende Rosse incontrano i Capigruppo – Umbria Notizie
- Da Berlusconi soldi a Cosa Nostra – Il Fatto Quotidiano
- I giudici di Palermo: “Trattativa Stato-mafia accelerò la morte di Borsellino” | LaPresse
- I giudici di Palermo: “Trattativa Stato-mafia accelerò la morte di Borsellino” – Yahoo Notizie
- I giudici di Palermo: la trattativa Stato-mafia accelerò la morte di Paolo – Rai News
- I giudici: la ‘trattativa’ Stato-Mafia accelerò l’attentato a Borsellino – Venti4ore
- I giudici: la ‘trattativa’ Stato-Mafia accelerò l’attentato a Borsellino – ANSA
- In Primo Piano
- La consapevolezza di Mannino e le prove di Riccio – Antimafia Duemila
- La scelta dello Stato di trattare con Riina condannò a morte Borsellino: la verità dei giudici di Palermo – Ultime Notizie
- La Stampa – «La trattativa tra lo Stato e la mafia
- La Trattativa accelerò la morte di Borsellino. Depositate le motivazioni della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia – La Voce Cosentina
- La trattativa Stato-mafia accelerò la morte del giudice Paolo Borsellino – Tp24
- La trattativa Stato-Mafia accelerò la morte di Borsellino – Mobi news
- La Trattativa Stato-mafia accelerò la morte di Borsellino. A 26 …
- La trattativa Stato-mafia accelerò l’attentato al giudice Paolo – Il Manifesto
- ‘La trattativa con Riina accelerò il delitto Borsellino’. Motivazione choc – TG La7
- L’analisi] La scelta dello Stato di trattare con Riina condannò a morte – Tiscali News
- Mafia: la trattativa accelerò la morte di Borsellino – Quotidiano di Sicilia
- Marco Travaglio, la vergogna in prima pagina: il Cav e Borsellino ucciso, dove arriva il Fatto quotidiano – Libero Quotidiano
- Mario Mori, dal Sid a Provenzano
- Mattarella: onorare memoria Borsellino significa non smettere di cercare la verità Rai News
- Nino Di Matteo commenta le motivazioni della sentenza sulla trattativa Stato-mafia: “Un pezzo di Stato piegato ai boss” – Huffington Post
- Palermo ricorda Paolo Borsellino: targa in sua memoria e “Agende – Giornale di Sicilia
- Paolo Borsellino: ISOLATO DALLA MAGISTRATURA, AMMAZZATO DALLO STATO-MAFIA.. – atuttadestra.net
- Paolo Borsellino: manifestanti con agende rosse per la verità – Blasting News
- Per i giudici la trattativa Stato-mafia accelerò l’esecuzione di Borsellino – Ultima Notizia
- Per i giudici la trattativa Stato-mafia accelerò l’esecuzione di Borsellino– AGI
- perché toto Riina decise di concentrarsi nell’uccisione di borsellino? – Dagospia
- Quello che non torna della sentenza sulla “trattativa” Stato-mafia spiegato in dieci punti – Il Foglio
- Radio Onda d’Urto TRATTATIVA STATO-MAFIA: LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.
- Rassegna stampa del 20 luglio 2018 – Prima pagina – Rai Radio 3 – RaiPlay Radio
- Salvatore Borsellino: Paolo assassinato perchè si era messo di traverso – Rai News
- Sentenza Stato-mafia, Di Matteo: Un pezzo di Stato si era piegato ai boss – TG La7
- Sentenza Stato-mafia, Di Matteo: Un pezzo di Stato si era piegato ai boss – TG La7
- Stato Mafia i Giudici la Trattativa Accelerò la Morte di Borsellino – Cerreto Laziale – Virgilio
- Stato- mafia: tsunami sui Ros ( Scenario opposto al Borsellino- – Il Dubbio
- Stato-mafia, “Berlusconi sapeva” – RSI Radiotelevisione svizzera
- Stato-mafia, “la trattativa accelerò la morte di Borsellino”. E Dell’Utri – La Repubblica
- Stato-Mafia, giudici di Palermo: trattativa accelerò morte Borsellino – Sky Tg24
- Stato-mafia, i giudici: “Dell’Utri favorì piani di Riina e la trattativa accelerò la morte di Borsellino”. Azione del Quirinale corretta | Radio24
- Stato-Mafia, i giudici: “La trattativa accelerò la morte di Borsellino” – Agenzia Dire
- Stato-mafia, i giudici: “La trattativa accelerò la morte di Borsellino” – L’Eco Vicentino
- Stato-mafia, i giudici: “La trattativa accelerò la morte di Borsellino” – News Go
- Stato-mafia, i giudici: “la trattativa accelerò la morte di Borsellino” – Affari Italiani”
- Stato-mafia, i giudici: “La trattativa accelerò la morte di Borsellino” – Polizia Penitenziaria
- Stato-Mafia, i giudici: ‘La trattativa accelerò la morte di Borsellino’ – Dire –
- Stato-Mafia, Mancino: “Del patto non so nulla, ma non lo escludo” Irpinianews.it
- STATO-MAFIA: “TRATTATIVA ACCELERÒ MORTE BORSELLINO –Il Sussidiario.net
- Stato-mafia: avevamo ragione. Motivazioni sentenza dimostrano quanto abbiamo sostenuto costituendoci parte civile | Rifondazione Comunista
- Stato-mafia: avevamo ragione. Motivazioni sentenza dimostrano quanto abbiamo sostenuto costituendoci parte civile | R.C.
- Stato-mafia: Dell’Utri intermediario e soldi di Berlusconi a Cosa Nostra – PrimaDaNoi.it
- Stato-mafia: presidente centro La Torre, si aprano archivi – Antimafia Duemila
- Strage di via D’Amelio, le immagini della fiaccolata | VIDEO – Palermo Today
- Sulla trattativa eclatanti dimenticanze di Stato. Sotto accusa Violante, Martelli, Conso, Ferraro e Contri – Repubblica Palermo
- ‘Trattativa’ accelerò morte Borsellino – Ansa
- Trattativa stato mafia, le motivazioni della sentenza – TG La7
- Trattativa Stato-Mafia accelerò la morte di Paolo Borsellino – The Today World
- Trattativa Stato-Mafia, i giudici: accelerò morte Borsellino | Video Sky
- Trattativa Stato-mafia, Salvatore Borsellino: “Depistaggio? O Dolo o incompetenza dei magistrati”. Scarpinato: “Costituire pool nazionale per trovare … Il Fatto Quotidiano
- Trattativa Stato-mafia, Salvini: ”Forze dell’ordine infedeli devono pagare doppio” – Video Corriere delle Alpi
- Trattativa Stato-Mafia. Fava: “Da chi è partito l’ordine?” – Sicilia Informazioni
- Trattativa Stato-mafia: depositate le motivazioni della Corte di Assise di Palermo – Giurisprudenza penale
- Trattativa Stato-mafia: i Ros e le strane dimenticanze di chi sapeva – Corriere della Sera
- Via D’Amelio, una strage ancora senza verità – articolo – TGR Sicilia – Rai News
Palermo, 20.4.2018 – La Corte di Assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, ha comminato oggi diverse condanne pesanti nel processo per la cosiddetta trattativa Stato-mafia, che giunge dopo quasi cinque anni di processo, circa 220 udienze e oltre 200 testimoni.
- La lettura della sentenza – video
- Il testo della sentenza
- Tutte le tappe
- Vademecum
- Video
- La trattativa e la morte di Paolo Borsellino – video
- Arrivata la sentenza
- Borsellino é stato lasciato solo
- Borsellino sacrificato sull’altare della trattativa
- Cafiero de Raho: “conferma che la mafia fu legittimata”
- Claudio Martelli: “vi racconto cosa c’é dietro”
- Condannati boss e carabinieri. Assolto Mancino
- Condannati Mori e dell’Utri. Assolto Mancino
- Condannati Mori, De Donno Dell’Utri e Bagarella. Assolto Mancino
- Dopo 5 anni di processo arriva la sentenza
- I conti che non tornano della sentenza
- I pezzi mancanti
- I punti ancora oscuri
- La trattativa ci fu
- La trattativa e la morte di Paolo Borsellino – video
- La trattativa in sette punti
- Lo Stato ha trattato per fermare le bombe
- Lo Stato scende a patti con la mafia
- Pene comprese fra gli 8 e i 28 anni
- Raffica di condanne
- Salvatore Borsellino: “felice ma manca la politica”
- Fiammetta Borsellino: “Stato coinvolto ai massimi livelli”
- Fiammetta Borsellino: “mio padre eliminato perché scomodo”
- Fiammetta Borsellino: “coinvolti soggetti dello Stato”
- Fiammetta Borsellino: ”Riina uccise mio padre ma fece un favore anche ad altri”
- Fiammetta Borsellino: “mio padre ucciso perché ostacolava la trattativa”
- Fiammetta Borsellino: ”istituzioni coinvolte“
- Fiammetta Borsellino: “trattativa Stato-mafia possibile motivazione dell’accelerazione dell’omicidio”
Agnese Borsellino: “Mio marito mi disse della trattativa Stato-Mafia…”
Scellerata trattativa…
Borsellino la ostacolava- ARLACCHI: la trattativa
- Berlusca u‘bravissimo
- Berlusconi e la mafia
- BOLZONI racconta la trattativa
- BORSELLINO: chi era Vittorio Mangano
- BORSELLINO: Paolo ucciso per nascondere la trattativa
- BORSELLINO sapeva della trattativa
- Borsellino tradito da un carabiniere
- BRUSCA: conferma la trattativa
- BRUSCA: il papello è finito a Mancino
- BRUSCA depone
- BRUSCA: Riina mi fece il nome di Mancino come destinatario del papello
- Canali di comunicazione tra Riina, Dell’Utri e Berlusconi
- CIANCIMINO: lettera della mafia a Berlusconi 1p
- CIANCIMINO: lettera della mafia a Berlusconi 2p
- CIANCIMINO: questa mattanza deve finire
- Consegnato ai magistrati
- CONTRADA
- Da Capaci e Via D’Amelio
- DELL’UTRI: trattativa giusta se per evitare guai peggiori
- Dell’Utri andò dai boss prima di fare Forza Italia
- Deposizione del Presidente della Repubblica Napolitano
- Deposizione pentito Francesco Onorato
- Deposizione pentito Francesco Onorato 2
- DE DONNO il colonnello dei misteri
- DE DONNO e MORI fra silenzi e risposte a metà
- DI MATTEO: non si vuole la verità
- DI MATTEO: “Tra i vertici dei ROS e Cosa nostra ci fu trattativa politica”
- DI MATTEO: “Scalfaro ha detto il falso”
- DI MATTEO: “Mancino ha scelto l’omertà istituzionale”
- DI MATTEO: “Il Quirinale assecondò il tentativo di Mancino di condizionare i giudici”
- Dopo 201 udienze processo in chiusura
- FERRERO: mistificazioni mediatiche sull trattativa
- GRASSO: lo stato ricattato trattó
- GRASSO: Mancino mi chiese d’intervenire
- I segreti del papello
- Il dialogo delle stragi
- Il papello
- Il papello di Massimo Ciancimino – storia di una fotocopia
- Il papello di Riina ritrovato nel 2005
- Il papello: una grossolana manipolazione di Massimo Ciancimino
- Ingroia racconta la trattativa
- INGROIA racconta la trattativa
- INGROIA racconta la trattativa 2
- Intercettazioni della DIA
- Istituzioni tradite
- La cronologia della trattativa
- La documentazione processuale
- La trattativa
- La trattativa nel testamento di Agnese Borsellino
- La trattativa- film
- La trattativa – Antonio Ingroia
- La trattativa Stato-mafia e la morte di Paolo Borsellino
- La verità fa paura
- La versione del pentito Francesco Onorato 2
- La versione del pentito Francesco Onorato
- MANCINO: ” Nessuna trattativa”
- MANCINO: Trattativa Stato-mafia insinuazioni su mio incontro con Borsellino
- MARTELLI: la trattativa ci fu
- Memoria PM rinvio a giudizio
- MORI: il papello non è mai esistito
- “MORI mi bloccò mentre stavo per arrestare Provenzano”
- Morte di Borsellino: colossale depistaggio all’ombra della trattativa
- MUTOLO: Borsellino ostacolava la trattativa
- MUTOLO: Borsellino sapeva
- Papello dopo papello
- Papello e trattativa Stato-mafia
- PISANU: tacita e parziale intesa fra le parti
- Processo-Trattativa; a Palermo è cominciato il redde rationem. Ma quale ?
- Processo Dell’Utri
- Processo Dell’Utri – Spatuzza
- Processo Dell’Utri – Graviano
- Si chiude il processo
- Stato-mafia ecco il papello
- TARTAGLIA: “Dell’Utri è l’opzione politica individuata a Roma”
- Telefonata Berlusconi-Dell’Utri
- Telefonata Ciná-Dell’Utri
- Testimonianza mar. Saverio Masi
- Trattativa Stato mafia ecco il papello
- Trattativa Stato-mafia
- Trattativa: prima udienza a Palermo
- Tutte le tappe della trattativa
- Vent’anni di trattativa Stato-mafia
- Verbali interrogatori
- 5 cose da sapere su trattativa Stato-mafia
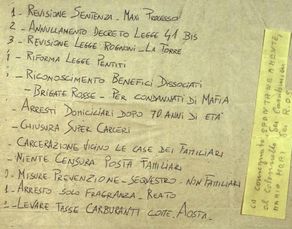
- Oltre la trattativa – documentazione
- La cosiddetta trattativa – documentazione
- Rassegna stampa
- Audio processo Bagarella – presunta trattativa Stato mafia
- 25 anni alla ricerca di una scomoda verità – video
- La trattativa – film
- Le TRATATIVE di Pietro Ingroia
Il primo a parlare di “trattativa” attraverso un “papello di richieste” è stato il pentito Giovanni Brusca, nel 1996, all’inizio della sua collaborazione con la giustizia: disse di averne sentito parlare a Totò Riina, fra le stragi Falcone e Borsellino. Da queste dichiarazioni sono ripartiti i pm di Palermo e Caltanissetta nel 2009, dopo aver raccolto le parole di Massimo Ciancimino, il figlio dell’ex sindaco di Palermo condannato per associazione mafiosa.
Le indagini di Palermo La Procura ha chiamato Massimo Ciancimino a deporre nel processo che vede imputati il generale Mario Mori e il colonnello Mauro Obinu di favoreggiamento aggravato nei confronti di Bernardo Provenzano. Nell’estate 1992, Mori incontrò più volte il padre di Massimo Ciancimino, Vito: “Per tentare di indurlo alla collaborazione e fermare le stragi mafiose”, ha sempre sostenuto Mori; “per intavolare una trattativa con Cosa nostra”, è la tesi della Procura di Palermo. Massimo Ciancimino ha accusato in particolare Mori di avere incontrato il padre già prima della strage di via d’Amelio, circostanza sempre negata da Mori. Ciancimino junior, che si attribuisce un ruolo di intermediario fra il padre e gli ufficiali dell’Arma, sostiene pure che fu consegnato a Mori un “papello” con le richieste di Riina (anche questa circostanza smentita da Mori). Nella ricostruzione di Ciancimino, la trattativa Stato-mafia condotta nell’estate 1992 tramite il padre sarebbe proseguita dopo il gennaio 1993 (ovvero dopo l’arresto di Totò Riina) attraverso il “nuovo canale” Bernardo Provenzano–Marcello Dell’Utri.
La deposizione di Massimo Ciancimino al processo Mori
Udienze:
1/2/2010
2/2/2010
8/2/2010
2/3/2010Queste sono tutte le dichiarazioni rilasciate da Massimo Ciancimino ai magistrati di Palermo tra il 2008 e il 2009, alcune intercettazioni, e le sue udienze al processo Mori:
Verbali:
- 08.04.07 PDF DOC ODT
- 08.05.15 PDF DOC ODT
- 08.06.06 PDF DOC ODT
- 08.06.18 PDF DOC ODT
- 08.06.21 PDF DOC ODT
- 08.10.02 PDF DOC ODT
- 08.12.12 PDF DOC ODT
- 09.01.23 PDF DOC ODT
- 09.04.02 PDF DOC ODT
- 09.05.21 PDF DOC ODT
- 09.06.12 PDF DOC ODT
- 09.06.30 PDF DOC ODT
- 09.07.01 PDF DOC ODT
- 09.07.16 PDF DOC ODT
- 09.07.30 PDF DOC ODT
- 09.08.04 PDF DOC ODT
- 09.09.18 PDF DOC ODT
- 09.09.29 PDF DOC ODT
- 09.10.19 PDF DOC ODT
- 09.10.29 PDF DOC ODT
- 09.11.20 PDF DOC ODT
- 09.12.22 PDF DOC ODT
- Intercettazioni:
- 23 novembre 2010 PDF
- 4 dicembre 2010 PDF
fonte ARCHIVIO ANTIMAFIA
Oggetto del processo Mori è il mancato blitz del 31 ottobre 1995, che secondo il colonnello Michele Riccio avrebbe potuto portare all’arresto di Bernardo Provenzano a Mezzojuso (centro della provincia di Palermo) grazie alle rivelazioni del boss confidente Luigi Ilardo. La vicenda è ricostruita nel provvedimento con cui il gip Maria Pino ha archiviato la denuncia per calunnia nei confronti di Riccio presentata da Mori e Obinu (i due ufficiali hanno presentato ricorso per Cassazione).
Il decreto di archiviazione del gip Maria PinoLe indagini di Caltanissetta
Una prima organica ricostruzione delle vicende legate alla trattativa Stato-mafia è contenuta nel “capitolo secondo” della richiesta di misura cautelare presentata dalla Procura nissena per la strage Borsellino. Il capitolo si intitola: “Le nuove indagini sul movente del delitto, la cosiddetta trattativa”.
L’indice del documento, e i relativi link:
1. Le indagini svolte sulla c.d. “trattativa”: una opportuna premessa. Il contributo dichiarativo di Massimo Ciancimino.
2. Le indagini precedenti. L’attivismo di Mori e De Donno nella sentenza di Firenze. Gli ulteriori incontri del dott. Borsellino nel giugno-luglio 1992: gli incontri con l’on. Mancino, con il capo della Polizia Parisi, con quello della Criminalpol Rossi, con Bruno Contrada, con gli stessi Mori e De Donno e con il R.O.S.
2.1. La Sentenza di Firenze: la trattativa Mori-Ciancimino.
2.2. Le indagini svolte negli anni ’90 da questa Procura sui contatti del dott. Borsellino nel giugno/luglio 1992 con collaboratori di giustizia e personalità istituzionali.
2.2.1. Incontro/i con Parisi (capo della Polizia) e Rossi (capo della Criminalpol)
2.2.2. Incontro col Ministro Mancino
2.2.3. Incontri con Contrada
2.2.4. Incontri del dott. Borsellino con appartenenti al R.O.S.
2.2.5. Conclusioni sugli incontri del dott. Borsellino.
3. Le nuove risultanze: le dichiarazioni di Ciancimino Massimo e Brusca Giovanni.
4. Le conferme di Giovanni Ciancimino e dell’avv. Ghiron. Le dichiarazioni di alcuni testi che rivestivano, all’epoca, importanti ruoli istituzionali: l’on. Martelli, l’on. Violante, l’avv. Contri, la dott.ssa Ferraro.
5. I “nuovi” documenti raccolti: il c.d. “papello”, e le lettere di Provenzano a Ciancimino: loro non utilizzabilità probatoria, sulla base anche della relazione tecnica in atti. Le lettere autografe di Vito Ciancimino, ed i riscontri nelle stesse contenuti alla c.d. “trattativa”. I documenti su “Franco/Carlo” e la loro inattendibilità. L’inqualificabile comportamento processuale di Massimo Ciancimino sull’identificazione dell’agente segreto, e la conseguente integrale inutilizzabilità delle sue dichiarazioni al riguardo.
6. Le “ombre” sugli apparati dello Stato: il “traditore”. Le dichiarazioni di Pino Arlacchi, Alessandra Camassa e Massimo Russo. Le ulteriori dichiarazioni di Mutolo Gaspare. Le incertezze di Di Matteo, l’intercettazione del colloquio con la moglie, e le dichiarazioni di Brusca al processo d’appello Borsellino. Le parole della vedova del dott. Borsellino.
7. Le dichiarazioni degli on.li Mancino, Scotti e Rognoni. Le dichiarazioni di Mori e De Donno. Le provocazioni di Riina, ed il suo brusco voltafaccia maturato tra il 2009 ed il 2010.
8. L’ombra della trattativa del 1992 nell’anno delle stragi di Firenze, Milano e Roma: il contrasto al D.A.P. e nei Ministeri tra due strategie ugualmente tese a disinnescare la “bomba carceri” concedendo a Cosa Nostra un drastico arretramento del 41 bis O.P. Le ricadute sui riscontri all’esistenza della trattativa nel 1992.
La richiesta di misura cautelare presentata dalla Procura di Caltanissetta (il testo integrale)
Scarica l’indice del documentoBRUNO CONTRADA
Decreto di archiviazione del gip di Caltanissetta Tona per Bruno Contrada per le stragi PDF
CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA:
Sentenza di primo grado PDF
Sentenza di secondo grado PDF
Sentenza di rigetto della Cassazione PDF
Sentenza di rinvio della Cassazione PDF
Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo PDF
Bruno Contrada, ex funzionario, agente segreto è stato dirigente generale della Polizia di Stato, numero tre del Sisde, capo della Mobile di Palermo, e capo della sezione siciliana della Criminalpol. Il suo nome è associato ai presunti rapporti tra servizi segreti italiani e criminalità, culminati nella strage di via d’Amelio dove morì in un attentato il giudice Paolo Borsellino che in quel periodo indagava sui collegamenti tra mafia e Stato, e alla cosiddetta “zona grigia” tra legalità e illegalità. Contrada si è dichiarato collaboratore e amico di Borsellino, ma i familiari del magistrato assassinato hanno smentito fermamente. Anche Giovanni Falcone pareva non si fidasse di lui da tempo. In gioventù fu amico e collaboratore di Boris Giuliano, la cui moglie ha espresso invece perplessità sulla colpevolezza di Contrada. Arrestato il 24 dicembre 1992, Contrada, che si è dichiarato estraneo al reato, è stato condannato in via definitiva nel 2007 a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Nel 2011-12 venne respinta la richiesta di revisione del processo e sempre nel 2012 finì di scontare la pena. L’11 febbraio 2014 la Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha condannato lo Stato italiano poiché ha ritenuto che la ripetuta mancata concessione degli arresti domiciliari a Contrada, sino al luglio 2008, pur se gravemente malato e malgrado la palese incompatibilità del suo stato di salute col regime carcerario, fosse una violazione dell’art. 3 Cedu (divieto di trattamenti inumani o degradanti). Il 13 aprile 2015 la stessa Corte europea dei diritti umani ha condannato lo Stato italiano stabilendo un risarcimento per danni morali da parte dello Stato italiano perché non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa dato che, all’epoca dei fatti (1979-1988), il reato non era ancora previsto dall’ordinamento giuridico italiano (principio di nulla poena sine lege), e nella sentenza viene affermato che «l’accusa di concorso esterno non era sufficientemente chiara». In seguito a ciò, nel giugno 2015 è iniziata la revisione del processo di Contrada, poi respinta il 18 novembre. Gli avvocati di Contrada hanno presentato istanza di revoca della condanna, respinta dalla corte d’appello di Palermo, e infine accolta nel 2017 dalla corte di Cassazione, che ha dichiarato “ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza di condanna”.
LA TRATTATIVA NON E’ PRESUNTA L’ESISTENZA DI UNA VERA E PROPRIA TRATTATIVA DI TIPO POLITICO CON LA MAFIA, BASATA E FINALIZZATA SUL CONCETTO DEL DO UT DES E’ COSTITUITA DALLE STESSE PAROLE PRONUNCIATE DA MORI E DA DE DONNO, SENTITI NEL PROCESSO DINANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI FIRENZE. E NON SOLO IN QUEL PROCESSO.
PM Di Matteo – dalla requisitoria 15 dicembre 2017 processo Trattativa Stato-mafia “Rispetto a quella che viene definita sempre la “fantomatica” trattativa, la messinscena della trattativa, la pseudo trattativa e quant’altro, andiamo ad esaminare tutti quegli elementi che ci inducono ad affermare che quei dialoghi, quegli incontri riservati, nella casa di Roma, costituirono il terreno privilegiato di una vera e propria trattativa politica. E non certo come vogliono far credere gli odierni imputati, di una ordinaria, se pure eventualmente temeraria e spregiudicata iniziativa investigativa. Non c’entra nulla. Su questo processo si è detto e si continua a dire tutto. Non soltanto per criticare, che sarebbe ovviamente perfettamente comprensibile, ma per delegittimare, ridicolizzare il lavoro del Pubblico Ministero e l’onestà concettuale del Pubblico Ministero. Siamo abituati non solo a sentire parlare di presunta trattativa , ma a leggere ed ascoltare quotidianamente giudizi impietosi che definiscono l’ipotesi della trattativa una messinscena, una bufala, un teorema di magistrati politicizzati privo di qualsiasi appiglio probatorio completo. Questa continua, costante, pressante attuale ricostruzione mediatica stride clamorosamente con dati di fatto di solare evidenza e di dirompente forza dimostrativa E voglio partire da ciò che tutti dimenticano o fingono di dimenticare. Al di là e ancor prima di dichiarazioni di pentiti e dichiaranti, delle ricostruzioni di Massimo Ciancimino, delle affermazioniazioni di Brusca o di Cancemi, c’è ed assume oggi una forza incredibile nella sua chiarezza indiscutibile ed inequivocabile un elemento di prova acquisito quando nessuno ancora aveva nemmeno semplicemente ipotizzato di poter aprire un’indagine sui vertici del Ros e sui loro rapporti con Vito Ciancimino. Quell’elemento di prova, quella confessione dell’esistenza di una vera e propria trattativa di tipo politico con la mafia, basata e finalizzata sull’elementare concetto del do ut des, è costituita dalle stesse parole pronunciate da Mori e da De Donno allorquando vennero sentiti nel processo Bagarella + 25 dinanzi alla Corte di Assise di Firenze. Parole molto chiare, inequivoche assolutamente antitetiche rispetto a quelle rese in questa sede con le spontanee dichiarazioni. Parole e ricostruzioni che recuperiamo attraverso il testuale riferimento nelle sentenze alla Corte di Firenze che non lasciano spazio e dubbi ad interpretazioni diverse da quelle di un’ammissione di una vera e propria trattativa con i capi di Cosa Nostra attraverso Vito Ciancimino. Andiamo a leggere alcuni passaggi di queste dichiarazioni rese all’udienza pubblica in Corte di Assise a Firenze del 27 gennaio 1998. Leggo alcuni passaggi virgolettati. Teste Mori “Andammo da Ciancimino e dicemmo “Signor Ciancimino, che cos’è questa storia qui. Ormai c’è un muro contro muro . Da una parte c’è Cosa Nostra, dall’altra parte c’è lo Stato. Ma non si può parlare con questa gente?“. Guardate, basterebbero queste parole per dire: Ma quale attività investigativa? Ma quale pseudo trattativa? Il rappresentante del Comando Operativo del reparto di eccellenza dei Carabinieri del Ros va da un soggetto che sa essere in contatto con Riina e Provenzano e e gli dice “Ma cos’è questo muro contro muro?” come se fosse strano che ci sia muro contro muro tra l’organizzazione mafiosa più pericolosa al mondo e che poco tempo prima aveva fatto saltare in aria un pezzo di autostrada a Capaci e lo Stato. Che cos’è questa Signori Giudici Popolari se non già proprio subito una proposta di metterci d’accordo per fare venire meno il muro contro muro? Altro che Scotti alle Camere che dice che non ci può essere nessuna ipotesi di mediazione, di compromesso… Ha ragione Riina quando dice “Mi hanno cercato loro”. La sentenza Tagliavia ha perfettamente ragione quando dice che il dialogo con la mafia è stato cercato …non dallo Stato, lo Stato è un concetto molto più alto, ma da alcuni esponenti deviati dello Stato. Che cos’è questo muro, non si può parlare con questa gente? Non lo dice un pentito, lo dice Mori. Poi vedremo perché in quel momento, fra virgolette, se lo lascia scappare. Il 27 gennaio 98 in una Corte di Assise che giudicava i responsabili degli eccidi di Roma, Firenze e Milano, davanti alle parti civili, davanti ai parenti dei morti. “Ciancimino mi chiedeva se io rappresentavo solo me stesso o anche altri. Gli disse lei non si preoccupi, lei vada avanti. Lui capì e RESTAMMO D’ACCORDO CHE VOLEVAMO SVILUPPARE QUESTA TRATTATIVA” La trattativa non esiste, la trattativa è il frutto avvelenato di giudici politicizzati…la presunta trattativa, la pseudo trattativa…la bufala della trattativa, la patacca della trattativa… MORI IL 27 GENNAIO 1998 (la Corte si sbaglierà -dopo leggo alcuni passi della sentenza- dicendo che di quella trattativa ha parlato solo De Donno) DI TRATTATIVA HA PARLATO MORI E NON SOLO IN QUESTO PASSAGGIO, NE LEGGERO’ ALTRI, E LEGGERO’ ANCHE SCRITTI IN CUI MORI DEFINISCE QUESTA COSA UNA TRATTATIVA. C’è un altro passaggio molto importante che Mori sottolinea che i giudici della Corte di Assise annotano: la richiesta di Ciancimino di avere un passaporto. Testuali parole del Colonnello Mori. QUANDO PARLA DEL PASSAPORTO MORI DICE “CE LO CHIESE PER SEGUIRE ALCUNE FASI DELLA TRATTATIVA ALL’ESTERO.“ CAPITANO DE DONNO, sempre lo stesso giorno, 27 gennaio 98 “GLI PROPONEMMO DI FARSI TRAMITE PER NOSTRO CONTO DI UNA PRESA DI CONTATTO CON GLI ESPONENTI DELL’ORGANIZZAZIONE MAFIOSA COSA NOSTRA AL FINE DI TROVARE UN PUNTO DI INCONTRO, UN PUNTO DI DIALOGO finalizzato -De Donno è ancora più esplicito- alla immediata cessazione di queste attività di contrasto netto e stragista nei confronti dello Stato.” Troviamo un punto di dialogo, finitela con questo contrasto netto e stragista nei confronti dello Stato, si capovolgono i termini della questione. Signori giudici popolari, questo significa acquisire informazioni? Questo significa fare un’attività investigativa? O questo significa, come qui diciamo, condurre in maniera spregiudicata una scellerata e spregevole trattativa con i vertici della mafia mentre c’era ancora il sangue dei morti in terra? Proseguo nel citare alcune delle affermazioni rese sotto giuramento da De Donno “Successivamente Ciancimino ci fece sapere che VOLEVA INCONTRARCI E CI DISSE CHE L’INTERLOCUTORE, E CIOE’ LA PERSONA CHE FACEVA DA MEDIATORE FRA LUI E SALVATORE RIINA (quindi sapevano già tutto, sapevano che Ciancimino parlava con Riina) VOLEVA UNA DIMOSTRAZIONE, UNA PROVA CONCRETA DELLA NOSTRA CAPACITA’ DI INTERVENTO. QUESTA PROVA CONSISTEVA NELLA SISTEMAZIONE DELLE VICENDE GIURIDICHE PENDENTI DEL CIANCIMINO E NELLA CONSEGUENTE CONCESSIONE DI PASSAPORTO AL CIANCIMINO.“ Quindi De Donno dice ai giudici della Corte di Assise di Firenze che, avendo parlato con Riina, per capire fino a che punto fossero affidabili interlocutori istituzionali, affidabili dal punto di vista mafioso, Riina chiese “vediamo fino a che punto si spingono: dategli un passaporto a Ciancimino”. Ciancimino a sua volta aveva detto “mi può essere utile per proseguire la trattativa all’estero, perché poi nel frattempo, aveva spiegato bene Vito Cianciminoche il suo interlocutore principale era Provenzano e che forse poteva essere utile anche qualche incontro all’estero. Io mi permetto per l’ultima volta di sottolineare che, veramente, i primi a spiegare cosa fosse la trattativa, e che quella che loro hanno fatto è stata una trattativa con i vertici della mafia, sono stati proprio Mori e De Donno il 27 gennaio 1998. Io mi permetto di leggere solo alcuni passaggi della sentenza definitiva del 6 giugno 1998, quindi non c’era ancora praticamente nulla su quello che è il quadro probatorio oggi gravante nei confronti degli imputati carabinieri Alcuni passaggi delle valutazioni della Corte di Assise di Firenze: L’esame congiunto di ciò che hanno detto testi e collaboratori dimostra in maniera indiscutibile che nella seconda metà del 1992 vi fu un contatto fra i Ros dei Carabinieri e i capi di Cosa Nostra attraverso Vito Ciancimino. Andiamo alle parti maggiormente significative. Vanno dette senz’altro alcune parole non equivoche L’iniziativa del Ros, perché di questo organismo si parla, posto che vide coinvolto un capitano, il vicecomandante e lo stesso comandante del reparto, aveva tutte le caratteristiche per apparire come una trattativa. L’effetto che ebbe sui mafiosi fu quello di convincerli definitivamente che la strage era idonea a portare vantaggi all’organizzazione. Questo è scritto in una sentenza definitiva pronunciata da una Corte di Assise in nome del popolo italiano. Sotto questi profili, proseguono i giudici, non possono esservi dubbi di sorta, non solo perché di trattativa, dialogo, ha espressamente parlato il capitano De Donno, ma soprattutto perché non merita nessuna qualificazione diversa la proposta, non importa con quali intenzioni formulate, di contattare i vertici di Cosa Nostra PER CAPIRE COSA VOLESSERO IN CAMBIO DELLA CESSAZIONE DELLE STRAGI. Qui la logica si impone con tanta evidenza che non ha bisogno di essere spiegata. Quanto agli effetti che ebbe sui capi mafiosi, soccorrono assolutamente logiche, tempestive, congruenti le dichiarazioni di Brusca, poi ci torneremo. Intanto la conclusione. IL CONVINCIMENTO DI UNO STATO CHE VA A CERCARE, VA IN GINOCCHIO A DIRE “CHE COSA VOLETE PER FINIRE LE STRAGI?” rappresenta anche il frutto più velenoso dell’iniziativa in commento che al di là delle intenzioni con cui fu avviata, ebbe sicuramente un effetto deleterio per le Istituzioni, confermando il delirio di onnipotenza dei capi mafiosi e mettendo a nudo l’impotenza dello Stato. Si deve dire quindi che alla fine del 1992 si erano verificate le tre condizioni fondamentali per l’esplosione di violenza dei mesi successivi giacché metodo ed oggetto così come le finalità erano già presenti con sufficiente precisione alla mente di coloro che muovevano le fila di Cosa Nostra. Il disinganno susseguente alla stasi della trattativa e all’arresto di Riina faranno da detonatore ad una miscela già pronta e confezionata. E allora, altro che processo fondato sulle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, altro che presunta trattativa, altro che teoremi accusatori di magistrati mossi da intenti politici. L’elemento di base, la piattaforma conoscitiva sulle quali si innesteranno le numerose successive acquisizioni per affermare che trattativa ci fu, è costituito proprio da quello che SOLO QUANDO DOPO LE PRIME DICHIARAZIONI DI GIOVANNI BRUSCA, GLI UFFICIALI VENNERO CHIAMATI AL PROCESSO DI FIRENZE, ESSI STESSI IN QUELLA SEDE AFFERMARONO , IN UN MOMENTO IN CUI CON LA TRACOTANZA CHE CON DIVERSI ASPETTI E’ CARATTERISTICA DI ENTRAMBI, ERANO CONVINTI DELLA LORO ASSOLUTA IMPUNITA’. E avevano anche in quel momento una giustificazione, avevano ragione in quel momento a sentirsi intoccabili, non a sentirsi rispettosi della legge e delle prerogative di un ufficiale giudiziario, ma SENTIRSI INTOCCABILI. Quella convinzione trovava ragione d’essere nella incredibile inerzia della magistratura fronte a quello di cui quelle persone, Mori in particolare, si era già reso protagonista con la vicenda della mancata perquisizione del covo di Riina e con l’inganno alla Procura di Palermo circa la prosecuzione del servizio di osservazione sull’abitazione del Riina, con l’incredibile vicenda della mancata cattura di Nitto Santapaola a Barcellona, con il tragico epilogo della vicenda Ilardo dopo che il confidente aveva portato con mano il Ros alla possibilità non sfruttata di catturare Bernardo Provenzano… Quando il 27 gennaio 1998 Mori e De Donno si siedono davanti alla Corte di Assise di Firenze sono forti di tutto questo. Sono forti della vicenda che non era successo niente nei loro confronti sostanzialmente, neppure all’emergere della doppia refutazione sulla questione mafia-appalti. E in quel momento, forti di quel convincimento di impunità, seppur ovviamente omettendo il particolare decisivo della ricezione della trasmissione dell’elenco delle richieste di Riina, Mori e De Donno in quel momento forti del loro convincimento avevano parlato di trattativa per porre fine alle stragi e al muro contro muro tra lo Stato e la mafia. La verità è che in quel momento con l’instaurarsi dell’interlocuzione con Ciancimino si è venuta a determinare una situazione che dal punto di vista mafioso viene plasticamente descritta da ciò che Provenzano riferisce a Nino Giuffrè: Vito Ciancimino è in missione per conto di Cosa Nostra. Dal punto di vista chiamiamolo istituzionale, Mori e De Donno con l’avvallo e la copertura decisiva del comandante del Ros generale Subranni erano a loro volta in missione segreta per conto non del Governo, non dello Stato, ma di quella parte del potere rappresentato anche da uomini che rivestivano incarichi istituzionali, che deviando dagli interessi e dai comportamenti istituzionali VOLEVA ABBANDONARE LA LINEA DELLA CONTRAPPOSIZIONE FRONTALE SENZA SE E SENZA MA CON COSA NOSTRA PER ABBRACCIARNE UNA DI SEGRETA MEDIAZIONE. Erano in missione in funzione di porre fine o comunque ammorbidire quella strategia di Cosa Nostra che proprio la parte trattatista dello Stato aveva fatto finta di non comprendere quando il ministro Scotti era andato a riferire in Parlamento.
E QUELLA SEGRETA E INDECENTE MEDIAZIONE VENNA AUSPICATA, IDEATA, ORGANIZZATA E IN CONCRETO COLTIVATA DIETRO LE QUINTE SFRUTTANDO LA SPREGIUDICATEZZA DI UN UFFICIALE, COME IL COLONNELLO MORI, DA SEMPRE ABITUATO A MUOVERSI PIU’ NELL’OTTICA DI ESPONENTE SENZA SCRUPOLI DEI SERVIZI DI SICUREZZA ED IN SOSTANZIALE DISPREZZO DI QUEI PRINCIPI DI OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI CODICI, DI SUBORDINAZIONE FUNZIONALE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IL CUI RISPETTO INCOMBE o dovrebbe incombere su ogni ufficiale di polizia giudiziaria. Mori dopo avere lasciato il servizio, da ufficiale dei Carabinieri ha continuato a muoversi in quell’ottica propria del periodo in cui era ai servizi. L’ufficiale di polizia giudiziaria è un’altra cosa. Non si comporta a prescindere dall’autorità giudiziaria, nascondendo le cose all’autorità giudiziaria, ingannando l’autorità giudiziaria. C’è un episodio emblematico. Una frase riferita dal Dottor Canali in quest’aula. Il dottor Canali dopo la sparatoria del 6 aprile 93 aveva necessità di avere un colloquio con i superiori di quegli ufficiali, Sergio De Caprio e De Donno, che avevano esploso i colpi di pistola giusto giusto il giorno dopo si era avuta la notizia della presenza di Santapaola. Canali aveva chiesto un incontro tramite il maresciallo Scibilia con il colonnello Mori per cercare di capire meglio la situazione. Dopo più rifiuti Scibilia gli riferisce che Mori gli ha risposto dicendo che non ha tempo da perdere per parlare con il magistrato. Il totale disprezzo, la totale ritenuta indifferenza, rispetto delle regole. Lì c’era stata una sparatoria, c’era un procedimento per tentato omicidio nei confronti di Imbesi Salvatore. L’INTOCCABILITA’. IL MUOVERSI AL DI SOPRA E AL DI FUORI DELLA LEGGE PER SCOPI POLITICI QUALI ERANO QUELLI DI PORRE FINE AL MURO CONTRO MURO FRA LO STATO E LA MAFIA. Una conferma indiretta ma ulteriormente significativa del fatto che il rapporto con Ciancimino non fosse finalizzato ad acquisire notizie bensì a trattare con la mafia, è costituito dalle risultanze dell’acquisizione che nel 2009 scaturì dall’ordine di esibizione che congiuntamente noi PM di Palermo e di Caltanissetta nello stesso giorno notificammo senza preavviso ai servizi. Andammo direttamente al Ros dei Carabinieri. Noi chiedevamo di consultare con quell’ordine di esibizione da una parte tutto quanto fosse contenuto negli archivi, rispettivamente dei servizi e del Ros sulla persona di Vito Ciancimino dei suoi stretti congiunti, e dall’altra parte sulla strage di Via D’Amelio. Ogni tipo di documentazione.
Un passo indietro. Della sentenza Tagliavia sulle stragi di Firenze, Roma e Milano, più recente, un’altra Corte, un altra istruzione dibattimentale, altri Pubblici Ministeri, voglio leggervi questo passaggio “Una trattativa ci fu e venne quantomeno inizialmente impostata su un do ut des -si mettano il cuore in pace coloro che continuano a parlare sempre di pseudo trattativa, potranno continuare a farlo legittimamente però avessero almeno l’onestà concettuale di dire che una sentenza definitiva afferma che una trattativa ci fu e venne inizialmente impostata su un do ut des- L’iniziativa fu presa dai rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini di mafia. l’obiettivo era trovare un terreno di intesa con Cosa Nostra per far cessare la sequenza delle stragi. Vito Ciancimino corleonese amico di gioventù di Riina e Provenzanofu ritenuta la persona più adatta a far giungere il messaggio alla cupola. La trattativa si interruppe con l’attentato di Via D’Amelio di fronte al persistere del programma stragista. Proprio per queste ragioni l’uccisione di Borsellino è nelle motivazioni e nella tempistica una variante anomala. Per tutto il resto del ’92 Cosa Nostra restò in attesa di riaprire i canali di comunicazione e sospese l’iniziativa offensiva per stimolare la riapertura dei contatti e dare prova di determinazione anche per reazione contro l’arresto di Riina. DAL ’93 SU DECISIONE DELL’ALA OLTRANZISTA RAPPRESENTATA DA BAGARELLA, GRAVIANO, MESSINA DENARO, FU AVVIATA LA STAGIONE DEGLI ATTENTATI. ESSENDOSI ORAMI ATTESO TROPPO TEMPO PER DARE ULTERIORE SMOSSA, SI PENSO’ DI DARE IL COLPO DI GRAZIA SECONDO L’IDEA DI GIUSEPPE GRAVIANO RIPORTATA NEL PROCESSO DA SPATUZZA. LA SCELTA DI COLPIRE DEI CARABINIERI ORIGINO’ ANCHE DAL RANCORE PER L’ABBANDONO DEL NEGOZIATO INTAVOLATO DAI CARABINIERI MORI E DE DONNO, INIZIATIVA ACCOLTA ENTUSIASTICAMENTE DA RIINA. TRATTATIVA, NEGOZIATO, INIZIATIVA DEI CARABINIERI E NON DI RIINA, TERMINI UTILIZZATI E CONSACRATI DA UNA SENTENZA DEFINITIVA. Per quello che qui ci interessa di più, siamo andati al Ros centrale a Roma. e ci è stato messo a disposizione tutto quanto c’era agli atti del Ros su Vito Ciancimino. E anche quello che in gergo viene definito fascicolo P, dove P sta per personale, fascicolo che non riguarda una vicenda processuale in particolare ma riguarda e raccoglie tutto quello che su un determinato soggetto è archiviato dalla struttura investigativa. Nella nostra esperienza abbiamo apprezzato la meticolosità estrema che ogni reparto dei Carabinieri mette nell’archiviare le notizie, anche quelle apparentemente più inutili. Qualsiasi cosa viene molto diligentemente, normalmente, conservata e archiviata nel fascicolo personale, soprattutto se quel fascicolo si riferisce ad una persona che, come Vito Ciancimino, nel ’92, era già una persona assolutamente nota, con una proiezione politica importante ma più volte arrestato e sotto processo per fatti di mafia. L’esame della documentazione è importante nella misura in cui consente di verificare ciò che non esiste. Ciò che era talmente segreto e fuorilegge da non potere essere nemmeno consacrato in un riservato appunto interno da contrarre agli atti quantomeno per lasciare una traccia di ciò che era stato fatto. Non c’è nulla. Una riga. Un’annotazione. Una relazione di servizio. Nulla che si riferisce ai rapporti, agli incontri fra mori, De Donno e Ciancimino nel 1992 a Roma. Vedremo che c’è un’annotazione postuma, si capisce fatta da Mori, anche se non è firmata, ma è postuma perché fa già riferimento agli interrogatori di Ciancimino resi nel ’93 all’autorità giudiziaria, che è una ricostruzione postuma, che si capisce perfettamente essere di molto successiva e probabilmente postuma rispetto alle dichiarazioni di Brusca nel ’97 al processo di Firenze. Ma nel ’92 quando per loro stessa ammissione si incontravano a casa di Vito Ciancimino dopo averlo intercettato per vedere di far venire meno il muro contro muro tra la mafia e lo Stato i carabinieri non lasciano nulla, non lasciano una traccia di quegli incontri. Di quegli incontri andavano a dire non certo ai magistrati, non certo alla DIA, non ai carabinieri. Andavano a dire a politici come Ferraro, Fernanda Contri, Luciano Violante e quant’altro. Ed è un dato che dobbiamo valutare appieno nella sua significatività volta a tutelare la segretezza di un rapporto illecito, alla luce delle prassi antitetiche normalmente seguite dal Ros. Il silenzio, il non lasciare traccia scritta, lo possiamo interpretare solo ed esclusivamente nell’ottica di una vicenda di cui non doveva restare alcuna traccia né in quel momento né per il futuro. E ciò proprio nella consapevolezza di una condotta, quella di trattare con il nemico, completamente estranea e contraria alla legge. Confrontate per cortesia il silenzio sul ’92 con la restante parte del fascicolo di Ciancimino con quello che è annotato rispetto agli anni 91, rispetto al periodo dal gennaio 93 in poi fino a quando Vito Ciancimino il 18 dicembre 92 torna in carcere. Vedrete che prima e dopo il 92 vengono conservate, archiviate anche le notizie più insignificanti. Tutto. Nel ’92 agli atti del Ros Vito Ciancimino non esiste. Veramente sembra rievocare quello che in quest’aula quel coraggioso e valoroso ufficiale, il colonnello Giraudo, ci ha detto circa il cosiddetto protocollo fantasma. C’è un appunto di Mori oggetto contatti con Vito Ciancimino fascicolo P che si capisce essere assolutamente postumo. Anche in quello che c’è, c’è qualcosa di interessante. Cosa scrive Mori riferendosi ai tempi passati. Ciancimino disse che i suoi interlocutori avevano accettato il dialogo che si sarebbe dovuto sviluppare con la sua mediazione partendo dalle seguenti irrinunciabili condizioni: trattativa da tenersi all’estero e quindi restituzione al Ciancimino che ne era stato privato, del passaporto. Mori, come dicevo, non solo ha parlato di trattativa ma lo ha anche scritto. Ci sono altri atti allegati dai quali si evince l’importanza del canale Ghiron. Con l’avvenuto arresto (Ciancimino venne arrestato per ordine della Corte di Assise di Palermo il 19 dicembre 92) ritenni che il dialogo con Ciancimino si fosse definitivamente interrotto. Invece nel gennaio 93, non ricordo se prima o dopo la cattura di Riina,ecco fui contattato dall’avvocato Giorgio Ghiron, difensore di Vito Ciancimino, il quale mi comunicò che il suo cliente desiderava incontrare me e il capitano De Donno. Abbiamo ancora degli allegati, importanti perché testimoniano che questo contatto Ciancimino Vito-Carabinieri, a prescindere dall’autorità giudiziaria di Palermo che invece nel febbraio 93 aveva iniziato gli interrogatori, si protrae nel tempo. Nel 95 Vito Ciancimino manda un telegramma al colonnello Mario Mori “urge incontrare lei insieme al capitano De Donno possibilmente in presenza procuratore Caselli oppure soli”. Con l’annotazione di Mori “informato l’avvocato Ghiron dell’intendimento dottor Caselli di incontrare il signor Ciancimino” Ancora, per dimostrare la possibilità di accedere al carcere nel quale era detenuto Vito Ciancimino da parte di Mori e De Donno al di là e al di fuori delle occasioni degli interrogatori con i magistrati vi segnalo un allegato dell’8 marzo 1994 conservato agli atti del Ros a firma Procuratore Caselli “A seguito mia nota del 25 gennaio 94 e successiva del 18 febbraio 94, mentre confermo autorizzazione a colloqui di personale del vostro ufficio con il signor Vito Ciancimino nonché la consegna al medesimo della documentazione oggetto della nota 25 gennaio 94, prego riferire allo stato degli atti con trasmissione al mio ufficio di copia del materiale da inoltrare o già inoltrato a Vito Ciancimino”. Da qui si deduce che comunque anche, non solo prima del primo interrogatorio, il colloquio investigativo che avevano fatto, ma anche nella costanza degli interrogatori fatti alla Procura di Palermo Mori e De Donno avevano perfettamente la possibilità di interloquire con Vito Ciancimino, di consegnare a lui materiale, di farsi consegnare materiale attraverso l’autorizzazione che il Procuratore Caselli gli aveva fatto. Qualche cenno ulteriore sul contenuto degli atti acquisiti al Ros nei fascicoli stavolta concernenti la strage di Via D’Amelio. Agli atti di quel fascicolo riservato spicca la presenza di annotazioni di notizie confidenziali su un attentato ritenuto imminente a Paolo Borsellino. Spicca la presenza di annotazioni relative a segnalazioni confidenziali fatte ai Carabinieri circa il coinvolgimento nella preparazione nell’esecuzione della strage di Pietro e Gaetano Scotto. Spicca la presenta di un’annotazione concernente notizie, leggo testualmente, informalmente acquisite a Palermo circa l’andamento e le prese di posizione dei singoli sostituti nel corso della prima riunione della DDA successiva alla strage, quindi c’è di tutto, pure quello che erano riusciti ad orecchiare sul contenuto di colloqui riservati e interni tra i magistrati di Palermo dopo la strage di Via D’Amelio.
Agli atti del Ros c’è tutto questo. MANCA COMPLETAMENTE OGNI, ANCHE GENERICO, RIFERIMENTO ALL’INCONTRO DEL 25 GIUGNO 1992 ALLA CASERMA CARINI DI PALERMO TRA IL DOTTOR BORSELLINO, MORI E DE DONNO. Del quale incontro l’autorità giudiziaria e in particolare per prima quella di Caltanissetta, venne a conoscenza dall’annotazione nell’agenda grigia del giudice, quella che non è scomparsa. Allora, voglio riflettere un attimo per quello che può riguardare questo processo e quello che è stato detto in questo processo, sul significato di questa assenza. Noi riteniamo che se, come gli imputati dicono, ma lo dicono dal 1997 in poi, quell’incontro avesse avuto come oggetto l’intenzione di Paolo Borsellino di approfondire il tema delle indagini di mafia-appalti dei Carabinieri, quell’assenza non si spiega. Se realmente il 25 giugno il colloquio tra Paolo Borsellino, Mori e De Donno avesse avuto ad oggetto l’interesse del giudice all’approfondimento di quell’inchiesta, Mori e De Donno avrebbero avuto non soltanto il dovere ma anche l’interesse professionale personale di rappresentare immediatamente il dato ai magistrati che si occupavano dell’indagine sulla strage e che quindi per determinarne la causale dovevano minuziosamente ricostruire le attività del Dottor Borsellino nel periodo immediatamente precedente. Se veramente Paolo Borsellino avesse detto “voglio approfondire l’indagine mafia-appalti, per favore consentitemi di farlo perché non mi fido di quello che stanno facendo i colleghi di Palermo”, il 20 luglio di mattina i Carabinieri si dovevano presentare ai magistrati di Caltanissetta per dire: attenzione giudici che Paolo Borsellino stava facendo questo. Tanto più che loro a quell’indagine attribuivano, giustamente, importanza. Niente. Silenzio. Nonostante gli ottimi rapporti con la Procura della Repubblica di Caltanissetta, perché poi ogni tanto esce fuori ma noi siamo stati zitti perché con la Procura di Palermo non c’erano buoni rapporti o per questo o per quell’altro motivo… no qui non c’è nessun tipo di dubbio. Avrebbero potuto e dovuto presentarsi per dire questo. Stanno zitti fino a quando nel 1997 dopo che si pente Siino e viene fuori nuovamente la polemica sulla famosa consegna abusiva del rapporto mafia-appalti sul possibile coinvolgimento di magistrati di Palermo, Mori e De Donno, De Donno in particolare, alla Procura di Caltanissetta chiamato per sapere cosa ne sapeva di quella cosa dice: guardate che Paolo Borsellino il 25 giugno ci ha detto di questa cosa di mafia-appalti. Come si fa a giustificare l’assenza di un’annotazione, se fosse stato questo il vero oggetto del dialogo o il vero scopo di Paolo Borsellino ammesso che abbia potuto fare riferimento al dialogo, mafia-appalti… E’ possibile che delle cose che assumono un rilievo importante non venga lasciata traccia? Voi potete mai credere -ora sta diventando quasi una moda dire io non ho detto niente allora perché nessuno mi chiamò- ma voglio dire, il vertice del Ros con il rapporto che avevano, anche di natura stretta, almeno fino ad un certo punto, almeno alcuni, con Paolo Borsellino, è possibile che se fosse stata vera quella versione dell’oggetto del colloquio del 25 giugno non lasciano una traccia scritta e soprattutto non si presenta l’indomani ai procuratori di Caltanissetta a riferire questa cosa?
Allora io ribadisco. La verità è un’altra su quell’incontro del 25 giugno 1992.
Che ci fu. Poi nelle ore pomeridiane Paolo Borsellino andò a Casa Professa e PROBABILMENTE SEGNO’ ULTERIORMENTE LA SUA CONDANNA DICENDO CHE SI SAREBBE RECATO ALLA PROCURA DI CALTANISSETTA PER RIFERIRE FATTI CHE RITENEVA GRAVI E DOVEVA RIFERIRE. SPECIFICHERA’ POI AL GIORNALISTA DAVANZO CHE LO INTERVISTAVA SU QUESTO E CHE GLI CHIEDEVA MA LEI DOTTOR BORSELLINO ANDRA’ A CALTANISSETTA PER RIFERIRE LA SUA VERSIONE, PER RIFERIRE COSA PENSA DELLA CAUSALE DELL’OMICIDIO DEL GIUDICE FALCONE, E BORSELLINO RISPONDERA’ “NO. IO SONO UN MAGISTRATO E SO CHE UNA PERSONA INFORMATA DEI FATTI DEVE RIFERIRE FATTI. IO ANDRO’ A CALTANISSETTA PER RIFERIRE FATTI DI CUI SONO VENUTO A CONOSCENZA.”
Il 25 giugno del 1992 i Carabinieri del Ros non potevano certo riferire ai PM di Caltanissetta quale era stato l’oggetto vero, l’oggetto principale dell’interlocuzione con Borsellino, perché quell’oggetto prendeva spunto dal famoso anonimo Corvo due e quindi LAMBIVA TROPPO PERICOLOSAMENTE L’ARGOMENTO DELLA TRATTATIVA CHE MORI E DE DONNO AVEVANO GIA’ INTRAPRESO CON VITO CIANCIMINO. Perché quell’anonimo in sostanza nel suo nucleo centrale PARLAVA DI UN DIALOGO E DI UNA TRATTATIVA IN CORSO TRA UN’ALA DELLA DC IN PARTICOLARE RAPPRESENTATA COME ELEMENTO DI PUNTA DA MANNINO E SALVATORE RIINA.
Io vi prego di rileggere con attenzione le dichiarazioni, utilizzabili solo parzialmente, di uno dei testi i cui verbali sono stati prodotti, e per fortuna prodotti, anche questo signore poi è venuto ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Mi riferisco a Carmelo Canale. Così come capiterà anche per Giovanni Ciancimino. Le dichiarazioni del 22 febbraio 2011, non c’è possibilità nemmeno di poter pensare che Canale sia stato suggestionato nelle sue risposte dalle domande perchè veniva chiamato come teste della difesa e rispondeva alle domande dei difensori degli imputati in quel processo. A proposito del 25 giugno Carmelo Canale dice “Un giorno eravamo al Tribunale, alla Procura. Dottor Borsellino mi chiese nella circostanza di incontrare ma molto riservatamente e all’interno non della Procura, ma della sezione anticrimine di Palermo l’allora colonnello Mori e il capitano De Donno, perché secondo quello che io ricordo e che mi riferì Dottor Borsellino, vi era una voce all’interno da parte dei colleghi suoi, -quindi dei magistrati, non mi ha detto il nome altrimenti lo avrei pure rivelato – una voce che dava il capitano De Donno come il compilatore di un anonimo, perché girava un anonimo. E allora io chiesi tramite un mio comandante della sezione di interpellare il colonnello Mori e di fissare un appuntamento con il Procuratore Borsellino. L’appuntamento ci fu poi Borsellino si guardò bene, né io gli chiesi, di dire di cosa avevano parlato. Ma il motivo per il quale il dottor Borsellino vuole incontrare riservatamente Mori e De Donno, non è certo il motivo dell’approfondimento dell’indagine mafia-appalti. Ma è il motivo relativo all’anonimo.
E’ L’ANONIMO NELLA CRUDA SOSTANZA FACEVA RIFERIMENTO AD UNA TRATTATIVA – Questi sono fatti. Questa è una versione, parziale, per carità, perché nessuno era presente all’interlocuzione tra il dottor Borsellino e gli ufficiali Mori e De Donno, ma noi sappiamo da un teste assolutamente -di cui non si può sospettare una vicinanza alla Procura, se non altro perché era stato processato dalla Procura di Palermo- il fatto è questo; borsellino chiede a Canale di attivarsi per l’incontro riservato con Mori per cercare di capire chi avesse compilato l’anonimo. E l’anonimo aveva ad oggetto sostanzialmente i contatti assolutamente impropri, fuorilegge rappresentati in questo modo, per trovare una soluzione al problema di politici -guarda caso Mannino e la mafia. Il 25 giugno 1992 si incontrano Mori e De Donno con Paolo Borsellino e si può ritenere sulla base di quello che dice Canale abbiano parlato anche dell’anonimo, mentre nello stesso momento, al di là dei teoremi fantasiosi dei Pubblici Ministeri, l’agenda di Contrada ci dice che Subranni e Contrada vanno a trovare il ministro Mannino nelle ore serali per discutere di Anonimo Corvo Due e situazione Sicilia
“L’’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino ha detto il falso”, esordisce il pubblico ministero Nino Di Matteo. La requisitoria del processo “Trattativa Stato-mafia” affronta uno dei capitoli più delicati. Il titolare del Viminale nel 1992 è accusato di falsa testimonianza. “Ha scelto la menzogna, l’omertà istituzionale”, accusa Di Matteo. “Le affermazioni di Nicola Mancino sull’incontro con il giudice Paolo Borsellino al Viminale nel giorno del suo insediamento sono state oscillanti e contraddittorie”. In un primo tempo, Mancino negò di aver visto il magistrato. Ma sono soprattutto le parole dell’allora ministro della Giustizia Claudio Martelli ad aver messo nei guai l’esponente politico. “Mi lamentai con lui del comportamento del Ros”, ha messo a verbale l’ex ministro della Giustizia. “Mi sembrava singolare che i carabinieri volessero fare affidamento su Vito Ciancimino“. Martelli ha affermato senza mezzi termini di aver chiesto conto e ragione a Mancino dei colloqui riservati fra gli ufficiali del Ros e l’ex sindaco mafioso di Palermo. Mancino ha sempre negato: ha detto di non avere mai parlato del Ros e di Ciancimino con Claudio Martelli. “Dice il falso”, accusa Di Matteo. In aula, vengono lette le intercettazioni fra Mancino e Loris D’Ambrosio, allora consigliere giuridico del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. “In quelle intercettazioni – dice Di Matteo – risulta il tentativo da parte del privato cittadino Mancino di influire e condizionare l’attività giudiziaria e addirittura le scelte di un collegio dei giudici”. Mancino non voleva essere messo a confronto con Martelli. “Quel tentativo – prosegue Di Matteo – invece di essere stoppato, venne alimentato e assecondato dal Quirinale”. Il pubblico ministero cita l’allora presidente Napolitano: “Fu irrituale il suo suggerimento, esternato da D’Ambrosio al telefono, di fare un confronto fra Mancino e Martelli, soluzione che lo stesso Mancino scartò subito”. Per Di Matteo, Mancino aveva “una vera e propria ossessione” e “fece un pressing costante nei confronti della presidenza della Repubblica, per ostacolare le indagini della procura di Palermo”. Dopo una lettera del segretario generale della presidenza della Repubblica, l’allora procuratore generale della Cassazione Esposito convocò il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso. Che dichiarò, senza mezzi termini: “Non c’è stata alcuna violazione del protocollo sul coordinamento fra le procure di Palermo e Caltanissetta (che indagavano sulla trattativa – ndr), non ci sono gli estremi per l’avocazione dell’inchiesta”. Dice oggi Di Matteo: “Il procuratore nazionale fu convocato oralmente, Grasso invece pretese di dare una risposta scritta. Il comportamento di Grasso fu intransigente e corretto”. Nella sua risposta, Grasso mise in oggetto: relazione onorevole Mancino. “Grasso riportò tutto alla cruda realtà”, dice Di Matteo. “Qualcuno avrebbe voluto aiutare il privato cittadino Mancino. Grasso, invece, respinse al mittente ogni pressione”.” Fonte : Gruppo FB FraternoSostegno ad Agnese Borsellino 14.11.2018
TRATTATIVA STATO-MAFIA – PARZIALI AMMISSIONI DI MANNINO che ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante l’udienza del 22 marzo Il 18 dicembre era stato notificato un decreto di citazione a De Mita a comparire come teste sulla trattativa Stato-mafia, il 21 (la notizia non era stata data dai giornali) Mannino si preoccupa di mandare Gargani da De Mita per dare la stessa versione. Affermazioni utili anche alla difesa di Sandra Amurri.
ORA MANNINO SI TRADISCE: “SI’, PARLAMMO DI DE MITA” –TRATTATIVA, L’EX MINISTRO AMMETTE L’INCONTRO SULLA DEPOSIZIONE DELL’EX LEADER L’incontro al bar Giolitti del 21 dicembre 2011? “Con Garganici scambiammo le informazioni che quella mattina erano sui giornali, che De Mita sarebbe stato sentito dai pm di Palermo, e gli dissi: ricorda a De Mita il congresso di Agrigento, quello in cui isolai Ciancimino”.
Lo aveva definito “il delirio di una mitomane”, ma giovedì scorso, nel processo di appello per lo stralcio della Trattativa in cui è imputato dopo l’assoluzione in primo grado, Calogero Mannino ha ammesso che l’incontro narrato in aula dalla giornalista del Fatto Sandra Amurri, nel quale, allarmato e preoccupato, avrebbe detto a Giuseppe Gargani “questa volta questi qui (i pm di Palermo, ndr) ci fottono”, c’è stato e che i due parlarono proprio della convocazione di De Mitacome teste sulla trattativa Stato-mafia. Mannino per la prima volta ammette l’incontro, continua a negare che l’oggetto fosse la sostituzione di Scotti con Mancino al Viminale nella stagione delle stragi, ma inciampa in un ricordo sbagliato: la notizia della convocazione di De Mita, che dice di avere appreso dai giornali di quella mattina, in realtà non era stata pubblicata, come ha ricordato il pm Nino Di Matteo nella requisitoria dell’11 gennaio 2018: “Il colloquio al bar Giolitti avviene il 21 dicembre – ha detto nell’aula bunker – era stato notificato un decreto di citazione a comparire a De Mita il 18 dicembre. Il 21 Mannino sa della citazione, che non era comparsa su nessun giornale, e si preoccupa di mandare l’avellinese Gargani dall’avellinese De Mita per dare la stessa versione che conviene a noi: cioè che Scotti fu sostituito per l’incompatibilità, altrimenti i pm di Palermo ci fottono’’. L’ex ministro chiede la parola negli 11 minuti finali dell’udienza, e dopo avere rivendicato “la scelta di campo” democristiana nella lotta alla mafia (e negato di avere fatto pressioni sul vice direttore del Dap Francesco Di Maggio “che neanche conoscevo” per attenuare il 41 bis), ammette che l’incontro al bar Giolitti di Roma era finalizzato a “ricordare” a De Mita, convocato tre giorni prima dai pm di Palermo, un pezzo di storia della Dc in Sicilia. Non la sostituzione di Scotti con Mancino dell’estate delle stragi, nel ’92, come sostengono i pm, ma il congresso di Agrigento di nove anni prima, quello in cui su iniziativa dello stesso Mannino la Dc isolò per la prima volta Vito Ciancimino, divenuto troppo ingombrante e imbarazzante Le ammissioni di Mannino, sia pure parziali, si interrompono qui. Il resto, per lui, è riportato in modo “farneticante” dalla Amurri, compreso l’accenno a Ciancimino(“Massimo dice un sacco di bugie, ma su di noi ha detto la verità”), che Mannino continua a negare perché il figlio di don Vito “non ha mai parlato di me nei suoi verbali”. E però Ciancimino jr è stato citato dal pm come teste (e ammesso) proprio per il ruolo centrale attribuito dall’accusa all’accertamento del “nesso di causalità” su cui si regge buona parte dell’accusa, e cioè il collegamento tra l’iniziativa del Ros di interloquire con Vito Ciancimino e il presunto accordo tra Mannino e Cosa nostra, “per salvarsi e attuare un programma politico favorevole ad una trattativa, volta a condizionare, partecipando alla volontà ricattatoria stragista della mafia, le scelte del governo”. L’inedita ammissione di Manninoservirà anche alla difesa della collega Amurri, già condannata dal tribunale a pagare 15 mila euro di spese e ora impegnata nell’appello del processo in cui aveva querelato Mannino per averla definita tra l’altro “agente volontaria della Stasi o del Kgb” e “mitomane”, espressioni che il giudice di primo grado ha ritenuto “riconducibili all’esercizio del diritto di critica… proporzionate e strettamente collegate alle accuse mossegli nell’articolo”. Ritenendo quell’ascolto casuale, seduta a un bar una fredda mattina di dicembre, un’ “indebita interferenza in una conversazione privata”. Come se denunciando un fatto processualmente rilevante, ascoltato fortuitamente, la giornalista avesse invaso la privacy di Mannino e Gargani. – di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza Il Fatto Quotidiano | 25 marzo 2018
LA COSIDDETTA TRATTATIVA Documento in cui compaiono le dichiarazioni ufficiali della signora Agnese Borsellino rese durate l’indagine sul Borsellino quater. Si tratta del capitolo secondo della richiesta di misura cautelare presentata dalla Procura nissena per la strage Borsellino. Il capitolo si intitola: “Le nuove indagini sul movente del delitto, la cosiddetta trattativa”.
“LE OMBRE” SUGLI APPARATI DELLO STATO: IL “TRADITORE”. Le dichiarazioni di Pino ARLACCHI, Alessandra CAMASSA e Massimo RUSSO. Le ulteriori dichiarazioni di MUTOLO Gaspare. Le incertezze di DI MATTEO, l’intercettazione del colloquio con la moglie, e le dichiarazioni di BRUSCA al processo d’appello Borsellino. Le parole della vedova del dott. BORSELLINO.Sempre nel campo delle indagini svolte, e per completezza, devono essere riportate tutte quelle ulteriori acquisizioni che hanno consentito di far ulteriore luce sugli ultimi giorni del dott. BORSELLINO, e di acquisire elementi circa la sua scoperta – avvenuta proprio nell’ultimo periodo – di un “tradimento”.Un tradimento, è bene chiarire sin dall’inizio, di cui il dott. BORSELLINO venne a conoscenza seguendo da vicino le indagini sulla strage di Capaci dopo che il dott. BORSELLINO venne trasferito alla Procura di Palermo nel febbraio 1992 continuò a frequentarlo perché a sua volta applicata alla DDA di Palermo per le indagini sulla mafia di Partanna (TP);in una delle occasioni in cui si trovava a Palermo per lavoro, nel corso di una discussione riguardante le indagini sulla strage di Capaci (durante la quale i due giovani magistrati lo mettevano in guardia su possibili rischi che lo riguardavano per la sua intenzione, palesata all’esterno, di indagare su quell’eccidio) il dott. BORSELLINO si era disteso sul divano e, piangendo (fatto assolutamente insolito) aveva detto loro che un amico l’aveva tradito; nel corso di un successivo incontro, di saluto alla Procura di Marsala, il mar. CANALE le aveva confidato che il dott. BORSELLINO si fidava troppo del ROS, ed in specie di MORI e SUBRANNI, che invece erano “pericolosi“; in effetti, alla teste risultavano “ottimi rapporti” esistenti tra BORSELLINO e SUBRANNI, che esulavano anche i semplici rapporti lavorativi: l’impressione che ebbe fu che il “traditore” fosse un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, persona anziana ed “autorevole“
Gli incontri con don Vito A Roma, all’indomani della strage di Capaci, il cap. Giuseppe De Donno aveva, difatti, chiesto a Massimo Ciancimino, che aveva conosciuto in occasione delle inchieste da lui stesso avviate sul padre Vito Calogero Ciancimino, di procurargli un incontro con quest’ultimo, al fine di avviare un colloquio che potesse fornire utili informazioni per le indagini in corso, nonché per la cattura dei latitanti Riina e Provenzano, e che potesse anche offrire una qualificata “chiave di lettura” sulle dinamiche interne a “cosa nostra” e sugli obiettivi che l’organizzazione intendeva perseguire con l’attacco allo Stato.
Questi tentativi di approccio furono in un primo tempo respinti dal Ciancimino, che poi invece, a fine luglio, dopo la strage di via D’Amelio, mutò opinione, acconsentendo ad incontrare il cap. De Donno.
Per ricostruire questa complessa e per molti versi, “prima facie”, anomala vicenda è necessario richiamare il contesto nell’ambito del quale essa maturò: è evidente che gli assassinii di Salvo Lima (il 12 marzo), dei giudici Falcone (il 23 maggio) e Borsellino (il 19 luglio) ponevano lo Stato italiano, nelle persone dei rappresentanti delle sue istituzioni e dei responsabili del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico, di fronte alla gravissima emergenza costituita dalla volontà stragista inequivocabilmente manifestata da “cosa nostra”, e dunque di fronte alla necessità di reperire, con ogni iniziativa utile, informazioni od elementi capaci di decifrare ed auspicabilmente neutralizzare la strategia dell’organizzazione.
Vito Ciancimino, per il ruolo di “dominus” degli appalti che aveva rivestito ed all’epoca ancora in parte rivestiva, come accertato dallo stesso cap. De Donno titolare delle investigazioni sfociate nel cd. rapporto “mafia-appalti”, costituiva senz’altro una cerniera con l’organizzazione e poteva fungere da canale privilegiato di collegamento con il gotha mafioso, sia per i sicuri contatti in suo possesso, che lo collocavano vicino al clan corleonese ma anche al Provenzano, sia perché, in attesa degli esiti definitivi di un procedimento a suo carico, versava in condizioni di particolare “fragilità psicologica” che potevano indurlo a rendersi disponibile ad una collaborazione, al fine di evitare il rischio di una nuova carcerazione (che invece di lì a pochissimo, in piena “trattativa”, sarebbe giunta) che, dal punto di vista umano e per le sue condizioni di salute, non si sentiva più in grado di sopportare, essendo già stato duramente provato dall’esperienza del carcere subita con il primo arresto del 3 novembre 1984.
Il predetto De Donno ed il col. Mori erano ben consapevoli di questa superiorità psicologica ed agirono decisi a sfruttarla (v. dichiarazioni rese dallo stesso Mori nel verbale di ud. del 16.1.03 innanzi al tribunale di Milano, acquisite al giudizio il 9.5.05 e deposizione resa all’ud. del 11.7.05 dal cap. De Donno).
I contatti – per come riferito in termini assolutamente coincidenti dal Ciancimino nel suo manoscritto “I carabinieri”, sequestrato il 17 febbraio 2005 nell’ambito di un procedimento avviato nei confronti del figlio Massimo ed acquisito in copia all’ud. del 9.5.05, e dai due ufficiali coinvolti – si articolarono nei seguenti punti: al primo incontro con il cap. De Donno, Vito Ciancimino si dichiarò disponibile a collaborare ma richiese di parlare ad un “livello superiore”; il cap. De Donno fece il nome del col. Mori e tutti e tre si incontrarono a Roma, in agosto 1992, nella casa del Ciancimino, il quale si disse pronto a cercare un contatto con l’associazione mafiosa per avviare un dialogo, chiedendo l’autorizzazione a spendere i loro nomi; una volta trovato questo interlocutore, che viene definito nel manoscritto “l’ambasciatore” (e che solo successivamente identificherà in Antonino Cinà, medico della famiglia Riina, legato anche al Provenzano), ilCiancimino gli rivelò i nomi dei due esponenti dell’Arma con cui era in contatto, ma avrebbe ottenuto una reazione di iniziale diffidenza, in quanto l’intermediario gli avrebbe risposto che i due ufficiali avrebbero dovuto prima pensare a risolvere le sue vicende giudiziarie; in un secondo momento, “l’ambasciatore” avrebbe invece superato tale diffidenza, decidendosi a ricontattarlo per rilasciargli una sorta di “delega” a trattare; il Ciancimino convocò allora il col. Mario Moried il cap. De Donno per un altro incontro nella sua casa di Roma a fine settembre 1992, nel quale finalmente precisare i termini di quell’inconsueto “negoziato”, termini che tuttavia gli si rivelarono deludenti e tali da non consentire margini di trattativa. Difatti, come testualmente annotato dal Ciancimino e confermato dai protagonisti in dibattimento, “i Carabinieri mi dissero di formulare questa proposta: consegnino alla giustizia alcuni latitanti grossi e noi garantiamo un buon trattamento alle famiglie”, proposta che venne ritenuta totalmente inadeguata dal Ciancimino stesso e come tale neppure comunicata all’ “ambasciatore”, con il quale si voleva mantenere comunque aperto un canale di dialogo. Per questo motivo, scriveva il Ciancimino nel proprio manoscritto, egli avrebbe riferito una proposta “bluff”, secondo cui un noto esponente politico si sarebbe prestato a garantire la salvezza del circuito imprenditoriale di interesse dell’organizzazione, minacciato da “tangentopoli”, che però non avrebbe avuto alcun seguito. A questo punto il Ciancimino – si legge negli appunti – avrebbe realizzato che non c’erano margini per alcuna trattativa, alla quale, tra l’altro, neppure “l’ambasciatore” aveva dimostrato vero interesse, per cui decise – come da sua annotazione testuale – di “passare il Rubicone”, ovvero intraprendere una reale collaborazione con i carabinieri, proponendo di infiltrarsi nell’organizzazione per conto dello Stato, intenzione che esplicitò ai nominati Mori e De Donno nel corso di un successivo incontro avvenuto a dicembre 1992, chiedendo in cambio che i suoi processi “tutti inventati” si concludessero con esito a lui favorevole ed il rilascio del passaporto. Nella medesima occasione, domandò – come si legge nel manoscritto e confermato dagli ufficiali – che gli fossero esibite le mappe di alcune zone della città di Palermo ed atti relativi ad utenze Amap, in quanto, essendo a suo dire a conoscenza di alcuni lavori che erano stati eseguiti anni addietro da persone vicine al Riina, avrebbe potuto fornire qualche elemento utile alla sua localizzazione. Immediatamente dopo, il 19.12.92, il Ciancimino venne nuovamente tratto in arresto.VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI DI CAMASSA ALESSANDRA DEL 14 LUGLIO 2009 Effettivamente tra me ed il dott. BORSELLINO esisteva un rapporto di fraterna amicizia e confidenza (…). Paolo Borsellino fu applicato alla DDA di Palermo verso la fine del 1991 e formalmente trasferito intorno a febbraio del 1992; io continuai a frequentarlo anche per ragioni d’ufficio, poiché ero stata a mia volta applicata ad un procedimento della DDA di Palermo relativo alla mafia del Belice; in altri termini, poiché Paolo aveva seguito quel procedimento quando era ancora a Marsala, io sovente riferivo a lui sugli sviluppi delle indagini, tanto che ricordo di aver suscitato il malcontento del Procuratore GIAMMANCO, il quale mi fece sapere, tramite Paolo, che voleva essere informato direttamente. In uno degli incontri, avvenuto in un giorno compreso tra il 22 ed il 25 giugno 1992, si verificò un episodio che mi impressionò, poiché per la prima volta in vita mia, a prescindere dal giorno della morte del dott. FALCONE – vidi Paolo piangere, cosa che non aveva mai fatto essendo un “uomo all’antica”. Preciso che ero in compagnia del dott. Massimo RUSSO, che seguiva con me il processo contro la mafia di Partanna, ed entrammo nella stanza di Paolo sita al secondo piano della Procura di Palermo una mattina in cui Paolo si trovava in Ufficio ed io avrei dovuto incontrare il Procuratore GIAMMANCO, anche perché alla fine di Giugno, se mal non ricordo, sarebbe scaduta la mia applicazione al procedimento per la mafia di Partanna (…). Ricordo che Paolo – anche questo era insolito – si distese sul divano e, mentre gli sgorgavano delle lacrime dagli occhi , disse: “non posso pensare … non posso pensare che un amico mi abbia tradito”. Non chiesi spiegazioni perchè ero molto turbata per il pianto di Paolo e perché compresi che era molto addolorato e stupito per il tradimento di un amico, del quale, però, si comprendeva non aveva intenzione di rivelare l’identità. In altri termini, si trattava di uno sfogo piuttosto che dell’esigenza di effettuare delle confidenze Lo sfogo di Paolo fu susseguente ad alcune domande che io e Massimo gli avevamo posto sui pericoli cui si esponeva tra l’altro interessandosi alle indagini relative alla strage di Capaci, per le quali era spesso in contatto con il collega VACCARA della Procura di Caltanissetta. Circostanza, questa, che avevo personalmente constatato e che era stata oggetto di confidenza da parte di Paolo in precedenti occasioni, essendo egli convinto che fosse doveroso, da parte sua, fornire ogni possibile contributo per l’utile svolgimento delle indagini Escludo categoricamente che in tale occasione il dott. BORSELLINO abbia parlato di trattative tra Stato e Cosa Nostra e ribadisco che io ed il collega RUSSO non avevamo la più pallida idea di chi fosse la persona da cui si sentiva tradito, e le ragioni di tale tradimento. Tuttavia ebbi la netta impressione che l’episodio che aveva determinato la reazione emotiva di Paolo fosse recentissimo. Non escludo, altresì, che tale incontro sia avvenuto nella tarda mattinata del giorno in cui ero andata a conferire con il Procuratore GIAMMANCO, che mi aveva ricevuta dopo qualche ora di attesa. Quella fu l’ultima volta in cui vidi Paolo in un’occasione privata ed infatti, prima della strage del 19 luglio, lo incontrai nuovamente, per l’ultima volta, in un’occasione pubblica e , segnatamente, il 4 luglio 1992, allorché organizzai una cerimonia di saluto presso la Procura di Marsala in onore di Paolo. Ricordo, in particolare, che in quest’ultima occasione incontrai il Maresciallo CANALE in quale, come del resto aveva fatto in precedenza, ebbe a confidarmi che a suo avviso il dott. BORSELLINO si fidava troppo dei vertici del ROS, facendo il nome dell’allora col. MORI e del Gen. SUBRANNI, sostenendo egli che si trattava di personaggi “pericolosi”, senza precisare altro. La cosa mi colpì perchè, parlando con Paolo in recedenti occasioni, avevo maturato la convinzione che egli avesse ottimi rapporti con il generale SUBRANNI; intendo dire rapporti che esulavano le semplici relazioni d’ufficio. Ciò naturalmente costituiva una mia impressione basata sulle parole di Paolo, poiché non ho mai conosciuto il generale SUBRANNI. Posso tuttavia confermare che Paolo nutriva sensi di stima ed affetto nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, tanto che aveva rapporti di amicizia con molti di loro, tra i quali ricordo Giovanni ADINOLFI, Raffaele – credo che questo sia il nome – DEL SOLE, un ufficiale di cognome OBINU, nonché il colonnello GENTILE. Tale era l’ammirazione di Paolo nei confronti di appartenenti dell’Arma che persino nelle indagini preferiva fare riferimento agli organismi investigativi dei carabinieri piuttosto che ad altri organismi investigativi. Altra vicenda che ricordo è la seguente. Agli interrogatori espletati insieme a Paolo presso l’Ufficio dell’Alto Commissariato era spesso presente una persona che avevo pensato fosse un poliziotto, mentre poi seppi, a distanza di anni, trattarsi di un appartenente ai Servizi Segreti, distaccato presso l’Ufficio dell’Alto Commissario: si trattava di Ninni SINESIO, persona con la quale il dott. BORSELLINO aveva rapporti confidenziali (…)il dott. BORSELLINO l’aveva segnalato ai vertici della Polizia, tra cui anche il dott. PARISI ed il dott. CONTRADA, perché fosse trasferito nella città di Catania (…) Ricordo che il 20 luglio 1992 ebbi modo di apprendere, parlando con il dott. INGROIA e con il mar. CANALE che il collaboratore di giustizia Gaspare MUTOLO aveva informalmente anticipato a Paolo BORSELLINO, con il quale aveva cominciato a collaborare,che avrebbe reso dichiarazioni accusatorie nei conrfronti del dott. Domenico SIGNORINO e del dott. Bruno CONTRADA (…) La sera stessa o il giorno successivo ricevetti una telefonata di Ninni SINESIO che, insistentemente, mi chiedeva di incontrarlo (…) SINESIO mi fece moltissime domande sulle indagini più recenti di Paolo, chiedendomi se, in particolare, si fosse interessato di un personaggio agrigentino che io ritenni potesse essere Calogero MANNINO (…) SINESIO chiese anche di SALAMONE (…) In questo contesto, fidandomi del SINESIO (…) gli riferii delle anticipazioni fatte da MUTOLO a Paolo su CONTRADA e SIGNORINO. Mi colpì il fatto che SINESIO, immediatamente dopo, si mise a tossire , lasciando intendere che era stato colto da un malore, e si allontanò ritornando dopo circa un quarto d’ora, palesemente sconvolto (…) Non ritengo che SINESIO possa identificarsi nell’amico da cui Paolo si sentiva tradito perché egli era troppo giovane; viceversa, la mia impressione fu che Paolo si fosse sentito tradito da una persona più adulta ed autorevole, con la quale vi era anche un rapporto d’affetto. Pensai che potesse trattarsi di un ufficiale dei carabinieri, ma ciò esclusivamente perché ero a conoscenza del grande rispetto e della grande riconoscenza che Paolo nutriva verso l’Arma Dunque, le parole della dott.ssa CAMASSA – pur fornendo molteplici elementi utili e preziosi – non ci consentono di identificare con certezza né il c.d.traditoredi BORSELLINO, né quale fosse stato “il contenuto” del suo tradimento. Quanto alla prima questione, comunque, le parole del dott. RUSSO, anche lui presente all’incontro con il dott. BORSELLINO descritto dalla dott.ssa CAMASSA, ci consentono di restringere il cerchio, individuando, con ragionevole probabilità in un appartenente all’Arma dei carabinieri (dal dott. BORSELLINO così tanto amata e rispettata) il c.d. “traditore”. (…)”
In particolare, il dott. RUSSO ha riferito che BORSELLINO gli disse:
- Che qualche giorno prima era stato a Roma, ove aveva avuto un incontro conviviale con alti ufficiali dei Carabinieri;
- Che qualcuno lo aveva tradito, mettendosi a quel punto a piangere, mentre si distendeva sul divanetto presente nel suo ufficio;
- che questo comportamento era assolutamente inusuale per il dott. BORSELLINO;
- che BORSELLINO era amico di molti vertici dell’Arma dei Carabinieri:
VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI DI RUSSO MASSIMO DEL 15 LUGLIO 2009 – Premetto di avere iniziato a frequentare Paolo Borsellino sin dall’ ottobre 1989 allorquando fui destinato al mio primo incarico quale giudice presso il Tribunale di Marsala; tale frequentazione divenne più assidua, allorché assunsi, nel novembre 1991, le funzione di sost. Procuratore presso la Procura di Marsala all’epoca retta da Paolo. Come è noto i rapporti tra me e Paolo ben presto travalicarono i normali rapporti di ufficio per divenire rapporti di vera e propria amicizia e stima reciproca e ciò spiega il comportamento tenuto da Paolo anche in mia presenza, di cui vi ha riferito la collega Alessandra Camassa. Ricordo perfettamente l’episodio menzionato, avvenuto nel giugno del 1992; ricordo le ragioni per cui con la collega ci trovavamo presso l’ufficio di Paolo, da poco divenuto Proc. Aggiunto a Palermo. Ho l’immagine di Paolo tristissima; ci accolse cordialmente ma era molto triste; ci fece accomodare e ci disse “chiudete la porta”.Parlammo del più e del meno e, ad un certo punto, disse che il giorno prima, o qualche giorno prima, era stato a Roma e che aveva avuto un pranzo o forse una cena, comunque un momento conviviale, con alti ufficiali dei carabinieri; sul punto il mio ricordo è sfumato; mentre era ancora seduto alla scrivania e aveva evocato questa circostanza, con le lacrime agli occhi disse: ” mi hanno tradito” o “qualcuno mi ha tradito”; quindi si alzò dalla scrivania e, si sdraiò, quasi lasciandosi andare, sul divanetto a due posti. Dopo essersi sdraiato – forse perché sollecitato da una mia domanda su come andavano le cose all’Ufficio di Palermo ovvero perché stavamo parlando delle ragioni per le quali eravamo venuti presso il Palazzo di Giustizia di Palermo – egli ebbe a pronunciare la frase: “qui è un nido di vipere“. Paolo non disse il perché dell’affermazione.Rimanemmo, io ed Alessandra, molto colpiti dallo stato di prostrazione psicologica di Paolo, proprio perché di Paolo avevamo l’immagine di una persona sempre sorridente, che infondeva sicurezza a tutti. Proprio per questa ragione non ci sentimmo neppure di domandargli da chi e perché si era sentito tradito e neppure perché, contrariamente alle sue abitudini, si fosse lasciato andare ad una così grave affermazione sulla Procura di Palermo definita: “un nido di vipere”.La conversazione poi sfumò. Escludo che in tale circostanza Paolo mi abbia parlato di una “trattativa”. In quel periodo Paolo era molto depresso per la strage di Capaci e noi, poiché ci trovavamo a Palermo per ragioni istituzionali, cogliemmo l’occasione per andarlo a trovare e per stargli vicino in un momento per lui particolarmente difficile, se non addirittura drammatico.Ribadisco di non avere elementi da fornire alle SS.LL. ai fini dell’individuazione del soggetto o della persona da cui Paolo Borsellino si era sentito tradito.
- DOMANDA: Le risulta che il dott. BORSELLINO avesse rapporti di amicizia con alti ufficiali dei carabinieri, con i quali, in particolare, si era incontrato nei giorni precedenti l’incontro di cui ci ha parlato?
- RISPOSTA: certamente aveva rapporti di amicizia con i vertici dei carabinieri e ciò posso dire per avere lavorato spesso con Paolo e perché sapevo che in quel periodo stava facendo delle indagini proprio con i carabinieri, ma non sono in grado di essere più preciso.
Dunque, prima BORSELLINO parla di un incontro conviviale a Roma con i Carabinieri, e poi riferisce ai dottori CAMASSA e RUSSO del “tradimento”. Ciò può, dunque, significare solo due cose:
- che il “traditore” fosse tra le persone incontrate, e che il dott. Borsellino avesse saputo (ad esempio, da collaboratori di giustizia) dopo quell’incontro particolari che lo avevano così tanto scosso, anche circa alcune delle persone che avevano partecipato all’incontro stesso;
- ovvero che qualcuno gli avesse riferito nel corso dell’incontro od a margine dello stesso, delle circostanze sul “tradimento”.
Non avendo mai nessuno riferito elementi che possano suffragare la seconda ipotesi, la prima appare certamente la più probabile.E’, comunque, necessario datare esattamente questo incontro tra i dottori CAMASSA e RUSSO e il dott. BORSELLINO, anche al fine di porlo in relazione con le altre risultanze agli atti sugli ultimi giorni del magistrato (si pensi, solo ad esempio, quanto sia rilevante porlo prima o dopo il 25 giugno, giorno in cui si dovrebbe essere svolto un incontro con i carabinieri del ROS; o dopo il 28 giugno, giorno in cui si svolse l’incontro con la dott.ssa FERRARO in cui la stessa gli riferì di Vito CIANCIMINO).Per questo motivo, utilizzando i pochi dati forniti dai due giovani magistrati che lo incontrarono, ed in specie facendo riferimento a quanto detto dal dott. RUSSO (sulla probabile coincidenza dell’incontro con il giorno in cui venne sentito il dott. SIGNORINO); ma anche a quanto detto dalla dott.ssa CAMASSA (sulla proroga della sua applicazione alla DDA di Palermo).
Si è accertato, così, che:
- Il 12 giugno 1992 venne svolto a Palermo l’interrogatorio del dott. SIGNORINO
- il 19 giugno 1992 venne emessa dal Procuratore Generale di Palermo proroga della applicazione della dott.ssa CAMASSA nel procedimento 1914/92 N.C., trasmesso dalla Procura di Marsala alla DDA di Palermo. Nel provvedimento si fa riferimento al fatto che il precedente provvedimento scadeva il 30 giugno 1992, e che la proroga sarebbe arrivata sino al 31 luglio 1992 nonché che era stato “acquisito il consenso” della dott.ssa CAMASSA;
- La dott.ssa CAMASSA era titolare – insieme al dott. RUSSO – del procedimento 479/91 a carico di GUNNELLA Aristide presso la Procura di Marsala.
VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI DI CAMASSA ALESSANDRA DEL 9 MARZO 2011
DOMANDA: Questo Ufficio l’ha già sentita in ordine ad un episodio avvenuto dopo la strage di Capaci, che ebbe come protagonista il dott. Paolo BORSELLINO, che in quella occasione disse a Lei ed al dott. Massimo RUSSO, piangendo, che qualcuno lo aveva tradito. E’ interesse di questo Ufficio, nell’ambito delle indagini sulla strage di via d’Amelio, ricostruire con esattezza quando questo episodio ebbe luogo. A questo fine, sono stati acquisiti alcuni dati, tra cui si ricorda:
- il fatto che il12 giugno 1992 venne svolto a Palermo l’esame del dott. SIGNORINO;
- il fatto che il 19 giugno 1992 venne emessa dal Procuratore Generale di Palermo proroga della sua applicazione (…) Nel provvedimento si fa riferimento al fatto che il precedente provvedimento scadeva il 30 giugno 1992, che la proroga sarebbe arrivata sino al 31 luglio 1992 e che era stato “acquisito il consenso” della dott.ssa CAMASSA alla proroga stessa. Queste date le consentono di ricordare quando avvenne l’episodio prima citato?
RISPOSTA: Non ho alcun ricordo che leghi l’episodio dell’incontro con il dott. BORSELLINO
alla audizione del dott. SIGNORINO. Devo dire che i miei ricordi su questo episodio non sono tardivi, ma ben consolidati, perché per tutti questi anni ho sempre parlato con mio marito di questo fatto, ritenendo potesse essere di qualche interesse. Per la verità, poiché sarei dovuta essere sentita dal Dr. Fausto Cardella, nel settembre del ’92, come dallo stesso anticipatomi per telefono, era mia intenzione riferire tale episodio al predetto magistrato; senonchè, non sono mai stata sentita dalla Procura di Caltanissetta e poiché non ritenevo che questo episodio potesse avere importanza ai fini investigativi, non ho ritenuto di presentarmi spontaneamente. Ho comunque avuto modo di sottoporre questi ricordi a plurime verifiche, e sempre ho collocato questo incontro nell’ultima settimana di Giugno. Per questo motivo il 14 luglio 2009 ho detto che l’incontro era avvenuto tra il 22 ed il 25 giugno 1992. Certo, non ricordo perché il dott. RUSSO fosse con me, ma comunque spessissimo allora eravamo insieme perché avevamo insieme una serie di indagini ed in quel periodo vi fu il problema SIGNORINO,con la revoca della sua applicazione come reggente della Procura di MarsalaIn relazione a questa vicenda abbiamo parlato almeno due volte con il Procuratore Generale Siclari, che era preoccupato non soltanto per la vicenda in se, ma anche perché vi cra stata una fuga di notizie su il “Giomale di Sicilia” in ordine all’esistenza delle indagini che coinvolgcvano il dott. Signorino. Proprio per questa ragione non posso escludere che con Massimo Russo fossimo andati da Borsellino sia per salutarlo e sia per essere consigliati su come comportarci col Procuratore Generale.Non penso che l’incontro sia avvenuto il 12 giugno perché ricordo bene che quel giorno ero molto nervosa e proicttata sul s.i.t. del dott. SIGNORINO, mentre il giorno in cui incontrammo Paolo mi ricordo tranquilla, senza ulteriori impegni lavorativi.Aggiungo che io non ho sentito direttamente il Procuratore Generalc Siclari prima del provvedimento di proroga. Io parlai con Paolo, esprimendo a lui il mio consenso. Paolo mi diceva che dovevo andare a riferire delle indagini al Procuratore GIAMMANCO. Un ulteriorc motivo per cui tendo a collocare questo episodio all’ultima settimana di giugno è legato alla circostanza che dovevo prendere accordi con Paolo Borsellino in relazione alla festa di saluto presso la Procura della Repubblica di Marsala che io stessa avevo organizzato per il 4 luglio del 1992. Ed invero, ricordo che – dopo che Paolo mi aveva fatto rimandare più volte l’organizzazione di tale evento a causa dei suoi impegni lavorativi,ero riuscita a fissarlo in coincidenza con l’ultima settimana di Giugno. Lo ricordo perché mi rimase poco tempo per l’organizzazione.
A D.R.: Non ricordo che in occasione dell’incontro con il Dr. Borsellino questi abbia fatto riferimento ad un pranzo o ad una cena che aveva avuto con alcuni Carabinieri pochi giorni prima, così come le SS.VV. mi riferiscono”.
Dunque, la testimonianza della dott.ssa CAMASSA fa virare la datazione verso l’ultima settimana di Giugno, quella stessa settimana in cui si verificò l’incontro con i carabinieri del ROS e quello con la FERRARO.
Diverso è il ricordo del dott. RUSSO, che – risentito l’8 marzo 2011 – ha riferito di non avere un ricordo preciso della data in cui si svolse l’incontro, confermando poi in esito che l’incontro avvenne presumibilmente lo stesso giorno dell’interrogatorio al dott. SIGNORINO, nella mattinata, anche se ciò ha fatto sulla base di un ricordo “logicamente ricostruito”: infatti, ritiene che – dato il fatto incontestato che lui e la dott.ssa CAMASSA fossero insieme a Palermo – ciò doveva essere accaduto per un comune impegno presso gli uffici giudiziari palermitani suo marito conosceva il gen. SUBRANNI, che aveva frequentato sporadicamente;
- sul SUBRANNI il marito le aveva riferito, il pomeriggio del 15 luglio 1992, una circostanza che lo aveva sconvolto: aveva saputo da qualcuno che SUBRANNI era mafioso;
- il 18 luglio, poi, le disse dei suoi timori sulla mano che avrebbe causato – ne era certo – la sua morte: non la sola mafia, ma anche colleghi ed altri uomini delle istituzioni;
- proprio per la sua certezza di essere ucciso, Paolo BORSELLINO aveva cominciato ad utilizzare due agende: quella grigia (ritrovata) come agenda vera e propria; quella rossa, che aveva ricevuto proprio dai Carabinieri, per segnare le sue riflessioni, che temeva di non fare a tempo di riferire alla autorità giudiziaria di Caltanissetta, e che portava sempre con sè:
VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI DI PIRAINO BORSELLINO AGNESE DEL 18 AGOSTO 2009
- A.D.R. Quando nell’agenda Paolo segnava l’annotazione “C” voleva indicare “casa” e si riferiva indifferentemente alla casa di Palermo e a quella di Carini, ma occorre tenere conto che nell’ estate del 1992 noi non ci recammo, come al solito, a villeggiare presso l’abitazione in questione e quindi l’annotazione “C” si riferiva alla casa di Palermo.
- AD.R. L’annotazione “PR” stava per “Procura” mentre il cerchio con la freccia indicava colloqui o incontri con la madre. Quando Paolo segnava sotto la lettera “C” nominativi di persone, voleva far riferimento ad incontri avvenuti presso una delle due abitazioni sopra citate.Posso escludere che annotasse le telefonate, poiché ne riceveva moltissime nell’arco di una giornata.
- AD.R. Mio marito vantava numerose amicizie tra Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, con i quali aveva anche frequenti rapporti di tipo professionale, nutrendo egli una vera e propria ammirazione verso l’Arma dei Carabinieri.
- AD.R. Circa i rapporti tra mio marito ed il Generale SUBRANNI, di cui mi chiedono le SS.LL., posso dire che Paolo ebbe modo di conoscerlo quando lo stesso era Comandante della Regione Sicilia ed ebbe occasione di frequentarlo sporadicamente. I rapporti tra i due erano, quindi, solo di tipo professionale. Prendo atto che le SS. LL. mi rappresentano che la dott.ssa Alessandra CAMASSA ed il dotto Massimo RUSSO hanno riferito di essere stati testimoni di uno sfogo di Paolo, il quale, piangendo, disse di essere stato tradito da un amico.Ignoro a chi si riferisse mio marito e, pertanto, non posso affermare che si trattasse del Generale SUBRANNI. Tuttavia ricordo un episodio che all’epoca mi colpì moltissimo e del quale finora non ho mai parlato nel timore di recare pregiudizio all’immagine dell’ Arma dei Carabinieri, alla quale mi legano rapporti di stima ed ammirazione.Mi riferisco ad una vicenda che ebbe luogo mercoledi 15 luglio 1992; ricordo la data perché, come si evince dalla copia fotostatica dell’agenda grigia che le SS. LL. mi mostrano, il giorno 16 luglio 1992 mio marito si recò a Roma per motivi di lavoro ed ho memoria del fatto che la vicenda in questione si colloca proprio il giorno prima di tale partenza.Mi trovavo a casa con mio marito, verso sera, alle ore 19.00, e, conversando con lo stesso nel balcone della nostra abitazione, notai Paolo sconvolto e, nell’occasione, mi disse testualmente “ho visto la mafia in diretta, perché mi hanno detto che il Generale SUBRANNI era “pungiutu”. Non chiesi, tuttavia, a Paolo da chi avesse ricevuto tale confidenza, anche se non potei fare a meno di rammentare che, in quei giorni, egli stava sentendo i collaboratori Gaspare MUTOLO, Leonardo MESSINA e Gioacchino SCHEMBRI.
L’Ufficio chiede alla signora Borsellino se il marito ebbe mai uno sfogo con la stessa nel periodo tra la strage di Capaci e quella di via D’Amelio.
- AD.R. Ricordo perfettamente che il sabato 18 luglio 1992 andai a fare una passeggiata con mio marito sul lungomare di Carini senza essere seguiti dalla scorta.In tale circostanza, Paolo mi disse che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, della quale non aveva paura, ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere.In quel momento era allo stesso tempo sconfortato, ma certo di quello che mi stava dicendo.Non mi fece alcun nome, malgrado io gli avessi chiesto ulteriori spiegazioni, ciò anche per non rendermi depositaria di confidenze che avrebbero potuto mettere a repentaglio la mia incolumità; infatti la confidenza su SUBRANNI costituisce un’eccezione a questa regola. Comunque non posso negare che quando Paolo si riferì ai colleghi non potei fare a meno di pensare ai contrasti che egli aveva in quel momento con l’allora Procuratore GIAMMANCO.
- A D.R. Confermo quanto ho già dichiarato in passato a proposito dell’agenda rossa su cui Paolo annotava gli spostamenti, le persone che doveva incontrare e, comunque, tutto ciò che atteneva al suo lavoro. Paolo teneva due agende, una delle quali, come è noto, si trovava a casa mia quando fu eseguito l’attentato ed era di colore grigio, mentre l’altra, di colore rosso, gli era stata regalata dai Carabinieri per le festività natalizie dell’anno precedente. In effetti, Paolo normalmente utilizzava una sola agenda, ma cominciò ad usarle entrambe subito dopo la strage di Capaci. Infatti, ritengo che Paolo in quel periodo pensasse di avere poco tempo a disposizione per approfondire le piste investigative che stava seguendo e, pertanto, annotava tutto nell’ agenda rossa per evitare, non soltanto che potessero sfuggirgli elementi utili al suo lavoro, ma anche per annotare quelle riflessioni o notizie che temeva di non poter comunicare ad altri ed in particolare alla Procura di Caltanissetta prima di essere ucciso. Ed infatti, mio marito era perfettamente consapevole, come ho già dichiarato in altre occasioni, che il suo destino era segnato, tanto da avermi riferito in più circostanze che il suo tempo stava per scadere. Prova ne sia che, pochi giorni prima di essere ucciso, si confessò e fece la comunione. L’Ufficio chiede alla signora Borsellino se il marito ebbe mai a confidarle di essere venuto a conoscenza di una trattativa tra appartenenti al ROS dei Carabinieri e Vito CIANCIMINO o altri soggetti appartenenti a cosa nostra o a servizi segreti “deviati”.
- A D.R. Non ho mai ricevuto tale tipo di confidenza da Paolo, che mai mi riferì di trattative in atto tra cosa nostra ed appartenenti al ROS dei Carabinieri o ai servizi segreti “deviati”. Non posso, tuttavia, escludere che egli fosse venuto a conoscenza di una vicenda del genere e non me l’avesse riferita, in quanto, come ho già detto, era in genere una persona estremamente riservata, soprattutto con i propri familiari che intendeva tutelare da possibili pericoli.
L’Ufficio chiede quali persone, al di là dell’ambito familiare, fossero a conoscenza del fatto che il marito facesse delle annotazioni del tipo di quelle descritte sull’agenda rossa.
- A.D.R. Sicuramente dell’esistenza dell’agenda rossa erano a conoscenza l’allora maresciallo Carmelo CANALE e Diego CAVALIERO, collega ed amico di Paolo; dato il tempo trascorso non sono in grado di fare altri nominativi, ma posso comunque dire che Paolo portava sempre con sé l’agenda anche in ufficio e, pertanto, potevano essere in molti tra i suoi collaboratori o conoscenti o, addirittura, giornalisti ad averne notato la presenza sulla sua scrivania. Mio marito non mi manifestò mai dubbi sulla fedeltà del maresciallo CANALE che continuò a frequentare fino al giorno prima della sua morte. Dopo circa un anno da queste terribili dichiarazioni, alla luce delle nuove prove raccolte, questo Ufficio ha deciso di compulsare nuovamente la signora BORSELLINO. Che ha riferito nuove circostanze, in particolare specificando – riguardo al ricordo del precedente verbale che il marito mai le aveva riferito testualmente di una “trattativa” – che suo maritole “disse testualmente che “c’era un colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato”.Ciò avvenne, a ricordo della signora BORSELLINO, intorno alla metà di giugno del 1992. Ed appare significativo che nel periodo immediatamente successivo (il 15 luglio 1992) suo marito le disse che aveva visto la “mafia in diretta”, parlandole anche in quel caso di contiguità tra la mafia e pezzi di apparati dello Stato italiano; e che sempre nello stesso periodo “chiudeva sempre le serrande della stanza da letto… temendo di essere visto da Castello Utveggio. Mi diceva:”ci possono vedere a casa”.
Inoltre, ha confermato che il 28 giugno 1992 il marito incontrò la dott.ssa FERRARO nella saletta VIP dell’aeroporto di Fiumicino; e che successivamente incontrò nello stesso luogo il Ministro ANDO’, che gli confidò che era arrivata una notizia confidenziale, da cui emergeva che sarebbe stata fatta una strage per ucciderlo, e che sarebbe stato utilizzato esplosivo.
Ancora, il marito le aveva detto che – quando aveva saputo di SUBRANNI – era stato talmente male da aver avuto conati di vomito:
VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI DI PIRAINO BORSELLINO AGNESE DEL 27 GENNAIO 2010
- A.d.r.: Confermo che il 28 giugno 1992 mio marito, il dott. Paolo Borsellino, si è incontrato sia con la dott.ssa FERRARO che con il ministro ANDÒ tornando da un convegno di Magistratura Indipendente che si era tenuto a Giovinazzo in Puglia. Il Ministro ANDÒ arrivò dopo il discorso tra Paolo e la dott.ssa FERRARO, e, se ben ricordo, i due non si incontrarono. Ricordo che eravamo insieme a mio marito in occasione di quel viaggio, e che al convegno e per tutto il viaggio siamo stati “superscortati”. Si trattò di una protezione molto stretta, che non era mai stata apprestata in questi termini per la sicurezza di Paolo. Non ricordo se vi era un appuntamento tra Paolo e la dott.ssa FERRARO. Ricordo che eravamo nella sala V.I.P. dell’aeroporto di Fiumicino. Ricordo ancora che l’aereo per Palermo partì con un’ora di ritardo proprio per la presenza di mio marito e gli accertamenti per la sua sicurezza che si resero necessari. In ogni caso, mio marito non mi fece partecipare all’incontro con la dott.ssa FERRARO. Anche successivamente, non mi riferì nulla, salvo quanto detto dal Ministro ANDÒ, che – per quello che mi venne riferito da mio marito – disse che era giunta notizia da fonte confidenziale che dovevano fare una strage per ucciderlo, e che ciò sarebbe avvenuto a mezzo di esplosivo. Mi disse che era stata inviata una nota alla Procura di Palermo al riguardo, e che ANDO’, di fronte alla sorpresa di mio marito, gli chiese: “Come mai non sa niente?”. In pratica, la nota che riguardava la sicurezza di mio marito era arrivata sul tavolo del Procuratore GIAMMANCO, ma Paolo non lo sapeva. Paolo mi disse, poi, che l’indomani incontrò GIAMMANCO nel suo ufficio, e gli chiese conto di questo fatto. GIAMMANCO si giustificò dicendo che aveva mandato la lettera alla magistratura competente, e cioè alla Procura di Caltanissetta. Mi ricordo che Paolo perse le staffe, tanto da farsi male ad una delle mani, che – mi disse – battè violentemente sul tavolo del Procuratore.
- A d.r. Mio marito, dopo l’incontro alla sala V.I.P, non mi disse nulla che riguardava CIANCIMINO. Ricordo, invece, che mio marito mi disse testualmente che “c’era un colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato”. Ciò mi disse intorno alla metà di giugno del 1992. In quello stesso periodo mi disse che aveva visto la “mafia in diretta”, parlandomi anche in quel caso di contiguità tra la mafia e pezzi di apparati dello Stato italiano. In quello stesso periodo chiudeva sempre le serrande della stanza da letto di questa casa, temendo di essere visto da Castello Utveggio. Mi diceva:”ci possono vedere a casa” .
- A d.r. Paolo mi disse dell’incontro con MORI a Roma presso il R.O.S. In quella occasione so che dopo doveva andare insieme ai carabinieri che incontrò a battezzare il bambino di un giovane magistrato da lui conosciuto, il dott. CAVALIERO. Devo specificare a questo punto che mio marito non mi diceva tutto perché non voleva mettermi in pericolo. Confermo che mi disse che il gen. SUBRANNI era “punciuto”. Mi ricordo che quando me lo disse era sbalordito, ma aggiungo che me lo disse con tono assolutamente certo. Non mi disse chi glielo aveva detto. Mi disse, comunque, che quando glielo avevano detto era stato tanto male da aver avuto conati di vomito. Per lui, infatti, l’Arma dei Carabinieri era intoccabile.
Omissis
Dunque, si aggiungono nuovi particolari a quanto sin qui a conoscenza degli investigatori: si viene a sapere che – dopo avere appreso (non si sa da chi) la notizia sul gen. SUBRANNI – il dott. Borsellino era stato malissimo, arrivando ad avere conati di vomito. Qualcosa che potrebbe in qualche modo ricondurre a quella forte crisi ed a quelle lacrime riferite dai dottori Russo e Camassa, ove si pensi che il discorso fatto ai due magistrati intervenne dopo che si era parlato di un incontro conviviale con alcuni carabinieri, e che la dott.ssa Camassa ha aggiunto che a suo avviso il tradimento proveniva da un’alta carica, probabilmente dei carabinieri.
Cio’ detto sulle dichiarazioni della signora Borsellino, deve aggiungersi che anche le già rese dichiarazioni di MUTOLO, riportate nel paragrafo 3, hanno subito – nel corso di queste nuove indagini- ulteriori aggiunte e precisazioni. Che, è importante premetterlo, a loro volta hanno ricevuto parziale riscontro.
MUTOLO e’ stato sentito la prima volta il 5 novembre 2009, al fine anche di verificare se fosse stato lui a riferire al dott. Borsellino quanto poi da questi detto alla moglie sul conto del gen. SUBRANNI. Per lo stesso motivo sono stati sentiti gli altri collaboratori interrogati in quel periodo dal dott. BORSELLINO , e cioè’ Gioacchino SCHEMBRI e Leonardo MESSINA, e tutti e tre hanno fornito risposte negative.
MUTOLO ha, comunque, riferito che, in occasione, presumibilmente, del verbale del 1° luglio 1992, nel corso di una breve interruzione, il dott. BORSELLINO aveva parlato con alcuni appartenenti alla DIA li’ presenti, ed aveva duramente stigmatizzato l’ammissibilità della “dissociazione” per gli appartenenti a Cosa Nostra, ipotesi cui era fermamente contrario
VERBALE DI INTERROGATORIO DI MUTOLO GASPARE DEL 5 NOVEMBRE 2009
- AD.R. dopo I’avvio della mia collaborazione ebbi contatti con il Col. Mori, in particolare in occasione di un confronto tra il sottoscritto ed il CANCEMI, che fu effettuato poichè il CANCEMI teneva basso il profilo della collaborazione, contrariamente alle indicazioni che io avevo fornito suI suo conto quale alter ego di Pippo CALO’ e, dunque, come persona di spessore all’interno o di cosa nostra. In tale occasione il col. MORI mi chiese un aiuto per convincere il Cancemi a collaborare seriamente. Non ricordo di aver mai affrontato con il Col. MORI argomenti inerenti l’ oggetto dei miei colloqui informali col dott. BORSELLINO
- A.D.R. ricordo che, in occasione delle pause di uno degli interrogatori che ho effettuato col dott. BORSELLINO – non ricordo esattamente quale – lo stesso affrontò con i suoi interlocutori (anche in tal caso non ricordo quali, ma si trattava sicuramente degli appartenenti alla DIA che in quel periodo seguivano la mia collaborazione) un discorso relativo alla “dissociazione” di appartenenti a cosa nostra. In particolare ricordo che si discusse del fatto che Pippo Calo, dal carcere, nella qualita’ di portavoce dei capi mandamento che erano detenuti, porto’ avanti tali argomentazioni, alle quali si aggregarono anche i camorristi. In sostanza cosa nostra cercava di portare avanti un discorso che investiva principalmente i latitanti, che avrebbero dovuto consegnarsi alla giustizia, ammettere il fatto di essere mafiosi ed in cambio ottenere benefici per loro e per gli altri mafiosi già detenuti, che del pari avrebbero dovuto ammettere di essere mafiosi. Tuttavia non so con quali personaggi delle istituzioni il Calo’ aveva contatti. Posso affermare con certezza che il dr. Borsellino, per quel che ho percepito era a conoscenza di tali fatti che, dunque, non apprese per la prima volta in quell’ occasione, ed era fortemente contrariato, direi disgustato innanzi a tale ipotesi, ripetendo che coloro che stavano anche solo pensando di accettarla erano dei “pazzi”.
- A,D.R. ai miei interrogatori, durante l’avvio della mia collaborazione, assistevano il dr. De Gennaro, il dr. Di Petrillo, il dr. Gratteri, ed altri personaggi della D.I.A
- A,D.R. non ho mai sentito parlare di Vito Ciancimino in relazione all’argomento relativo ai discorsi sulla dissociazione.
- A,D.R. non ho mai sentito parlare del Generale SUBRANNI come di una persona collusa con cosa nostra.
- Alle ore 16.20 viene sospesa la registrazione per procedere alla verbalizzazione riassuntiva.
- Alle ore 16.47 viene ripresa la fonoregistrazione.
- AD.R. non ho mai fatto riferimento ai particolari di cui sopra perche’ non mi e’ stato mai posto in modo esplicito tale quesito nel corso dei precedenti interrogatori.
- A.D.R. in relazione al contenuto del verbale di cui la S.V. mi da lettura (verbale di interrogatorio del 22.10.92), posso dire che Ie considerazioni in esse contenute – circa possibili future iniziative di matrice terroristica di cosa nostra dopo Ie stragi di Capaci e via D’ Amelio per distogliere I’attenzione -erano il frutto di quanta gia’ da me vissuto nel passato, allorche’ accompagnai Saro RICCOBONO in una riunione in cui si discusse dell’eventualità di perpetrare attentati fuori dalla Sicilia per allentare la pressione investigativa che derivava dal nuovo metodo di lavoro del dott. CHINNICI e così poter creare un clima che favorisse la possibilità di riallacciare contatti che consentissero di tornare al regime di “calma” del passato.
omissis
MUTOLO ha, poi, specificato in un successivo interrogatorio che – nell’occasione in cui venne affrontato dal dott. BORSELLINO il tema della dissociazione, si fece riferimento anche ad una persona (che, ad onor del vero, non si comprende come il collaborante identifichi in MORI) che faceva su e giù tra Roma e Palermo per una “trattativa”. A parte questa indimostrata acquisizione, questo verbale affronta integralmente tutta la questione della genesi della collaborazione di MUTOLO; viene chiesto, in particolare, se risponda al vero quanto da lui in precedenza affermato di avere reso un primo verbale di collaborazione con il solo dott. BORSELLINO, senza il dott. ALIQUO’, cui sarebbe seguito il verbale BORSELLINO-ALIQUO’. Queste precedenti dichiarazioni – che ora MUTOLO ha sconfessato – facevano ritenere possibile un incontro informale tra lui ed il dott. BORSELLINO prima della collaborazione formale, che ben avrebbe potuto essere il luogo in cui riferire di quali “colletti bianchi” aveva intenzione di parlare. Ancora, gli è stato chiesto della sua permanenza a Cinisi negli anni ’70 – risultante dai suoi primi verbali di interrogatorio – e della sua conoscenza all’inizio degli anni ’80 con Gaetano BADALAMENTI, che avrebbe ben potuto, quindi, essere la sua “fonte” per una eventuale conoscenza sui collegamenti con la criminalità organizzata del gen. SUBRANNI. Devono ricordarsi, invero, le risultanze della Commissione Parlamentare sul depistaggio effettuato nelle indagini per l’omicidio IMPASTATO, omicidio per cui poi BADALAMENTI venne condannato 20 anni dopo: la Commissione, infatti, aveva pesantemente fatto riferimento proprio al ruolo di SUBRANNI nel depistaggio. In ogni caso, MUTOLO ha riferito di non avere mai parlato con BADALAMENTI dell’omicidio IMPASTATO:
VERBALE DI INTERROGATORIO DI MUTOLO GASPARE DEL 23 MARZO 2010
- A.D.R. Confermo di avere visto il dott. FALCONE ed il dott. SINISI il 16 dicembre 1991, e che, in quella occasione, feci già il nome di CONTRADA e di SIGNORINO. Il dott.FALCONE mi mise, poi, in contatto con il dott. DE GENNARO, che – come Lei mi dice – mi venne a trovare il 29 gennaio 1992 al Centro Clinico di Pisa. Non ricordo cosa dissi in quella occasione al dott. DE GENNARO. Sicuramente ribadii la mia volontà di collaborare. Forse riferii qualcosa su di un deposito di armi, che poi venne rinvenuto a Gavarrano.
- A D.R – Mi dice, poi, la S.V. che il 15 maggio 1992 mi vidi nuovamente, a Livorno, con il dott. DE GENNARO, il col. DI PETRILLO e il dott. GRATTERI. Non ricordo neanche in questo caso cosa si disse. Mi sembra di ricordare che DE GENNARO disse agli altri due che, qualsiasi cosa avessi detto quando cominciavo a collaborare, avrebbero dovuto riferire a lui personalmente. Questo mi fece capire che DE GENNARO era sovraordinato agli altri due suoi colleghi.
- A.D.R – Dopo la morte del dott. Falcone, come ho già riferito, incontrai il dott. DE GENNARO, al quale ribadii la mia volontà di collaborare, a maggior ragione dopo l’uccisione del giudice Falcone. Al dott. DE GENNARO comunicai però che era mia ferma convinzione – scomparso il dott. FALCONE- collaborare con il dott. BORSELLINO, magistrato che già conoscevo e nei confronti del quale nutrivo stima e rispetto ritenendolo conoscitore della Mafia e dei suoi meccanismi. Siccome avevo detto di potere rendere dichiarazioni anche su Firenze, si decise di farmi sentire inizialmente dal dott. VIGNA, fare “incartare” la mia volontà di collaborare, e da lì iniziare la collaborazione formale. In effetti, venni sentito da VIGNA, gli ribadii la volontà di collaborare, ma esplicitai da subito che dovevo parlare con il dott. BORSELLINO, perché era su Palermo che avevo da fare il 99% delle mie dichiarazioni. Subito dopo l’interrogatorio di VIGNA, come Lei mi ricorda, io venni ammesso alla detenzione extracarceraria. Ricordo che venni allocato in varie sedi a Roma, sempre a disposizione della D.I.A.
- A.D.R.: Lei mi chiede se io abbia incontrato il dott. BORSELLINO prima dell’inizio della mia collaborazione “formale” con la Procura di Palermo. A questo proposito, in un primo tempo ricordavo di avere visto la prima volta il dott. BORSELLINO da solo, e poi, la seconda volta, insieme con il dott. ALIQUO’. In questo secondo caso ricordavo di avere fatto informalmente i nomi dei “colletti bianchi”. Devo avere consacrato questa ricostruzione dei miei primi incontri con BORSELLINO anche nel corso di qualche verbale. Mi venne, poi, contestato dai magistrati che procedevano alla redazione dei verbali che il primo interrogatorio con BORSELLINO avvenne, in realtà, il 1° luglio 1992, ed era presente anche il dott. ALIQUO’. Le cose, dunque, non possono essere andate che come mi venne contestato dai magistrati. In quella occasione, sicuramente, feci i nomi di appartenenti alle istituzioni collusi con la Mafia. Per quelli che sono i miei ricordi, in quella occasione non mi limitai a menzionare il dott. SIGNORINO e il dott. CONTRADA, ma menzionai anche altri, che ora non ricordo.
- A.D.R. Allorchè menzionai al dott. Borsellino i nomi di appartenenti alle istituzioni collusi con Cosa Nostra, egli rimase spiacevolmente meravigliato a sentire tutti i nomi che gli andavo facendo, non immaginando che quella fosse la realtà, anche perché si sentì “accerchiato” da tutte queste persone “colluse” all’interno delle istituzioni; non ricordo se il dott. Borsellino si meravigliò per qualcuno in particolare, ricordo che si stupì per tutti.
- A.D.R. Per quel che posso ricordare, riferendomi al periodo della mia permanenza a Cinisi dal 1968 in poi, Nino e Gaetano BADALAMENTI avevano rapporti con alcuni dei carabinieri. Ma non so nulla di specifico. In quel periodo moltissime persone avevano rapporti con persone di Cosa Nostra, perché Cosa Nostra era diversa da quella che divenne con RIINA, e non era ancora chiaro il disvalore di questi rapporti. Tra chi dirigeva le varie stazioni dei Carabinieri ed il locale capomafia, poi, era normale intrattenere rapporti, ma non sto parlando di nulla di illecito.
- A D.R – Lei mi chiede se Gaetano BADALAMENTI, quando lo vidi nel 1981-82, e mi chiese della mia attività criminale su Cinisi alle dipendenze di Nino BADALAMENTI, mi fece anche riferimento, per parte sua, all’omicidio IMPASTATO. Devo dire di no. Io certamente non potevo prendere il discorso. Ricordo, invece, di avere parlato di questo fatto omicidiario con molti altri associati, e che unanimemente si riteneva, anche da parte mia, che il fatto di un preteso attentato preparato da IMPASTATO, nell’esecuzione del quale sarebbe accidentalmente morto, appariva inverosimile, essendo chiara la matrice mafiosa di quella morte.
- A.D.R. Quando venni sentito dal dott. Borsellino, ricordo che egli sentiva anche qualche altro collaborante, ma non so dire chi.
- A D.R. Ribadisco che il dott. Borsellino affrontò, davanti a me, e con personale della D.I.A., il tema della dissociazione di alcuni mafiosi da Cosa Nostra (cfr. verbale di interrogatorio di questa Procura del 5 novembre 2009), prendendo le distanze in maniera netta da chi la riteneva un fatto positivo. Ricordo che osservai che Cosa Nostra ha fatto sempre trattative con lo Stato, semmai potevano cambiare gli interlocutori. Il dott. Borsellino, in quella occasione, era assolutamente disgustato che qualcuno delle istituzioni potesse condividere tali iniziative.
- A.D.R. Poiché mi si ricorda che in occasione dell’interrogatorio del 9 dicembre 1992, sentito dalla dott.ssa Boccassini e dal dott. Cardella, riferii ai magistrati che al dott. Borsellino avevo già fatto i nomi del dott. SIGNORINO, del dott. BARRECA e del dott. CONTRADA, mi ero effettivamente riservato di fare altri nomi; ma a tal proposito avevo notizie più generiche e conosciute indirettamente, circostanze già riferite in occasione di altri interrogatori, quindi oggi non potrei essere più preciso.
- A.D.R. Tornando al discorso della dissociazione, ricordo che BORSELLINO disse, intervenendo nella discussione in occasione della pausa durante la quale stavano trattando l’argomento in questione, che chi voleva la dissociazione era pazzo; aggiungo che BORSELLINO non era assolutamente d’accordo anche perché avevano già ucciso Giovanni FALCONE. Dai discorsi fatti capii che gli interlocutori facevano riferimento alla circostanza che l’allora Colonnello (poi divenuto Generale) MORI – che non venne espressamente indicato, ma che era facilmente individuabile dai riferimenti fatti dai funzionari della DIA di cui non ricordo però i nomi – scendeva spesso a Palermo e aveva contatti all’interno di Cosa Nostra per trattare. L’argomento ricordo che venne discusso a margine di uno dei tre interrogatori in cui era presente il dott. BORSELLINO.
- A.D.R – Lei mi chiede di esplicitare meglio questo discorso sul generale MORI. A questo proposito ricordo che i ragazzi della D.Ia che mi trasportavano erano, con mia sorpresa, più preoccupati di essere seguiti da persone dei “servizi” che da appartenenti alla criminalità organizzata.
- A.D.R – Lei mi chiede dove collochi io il gen. MORI, se al ROS o ai servizi, ed io rispondo: sia al ROS che ai servizi.
- A.D.R. Prendo atto dei nomi dei funzionari della DIA presenti in occasione dei predetti interrogatori e cioè l’ispettore Danilo Amore, il dott. Di Petrillo e il dott. Gratteri, questi ultimi presenti formalmente il primo luglio del 1992; escludo che il discorso possa essere stato affrontato dal dott. Borsellino con l’ispettore Amore, quindi potrebbe essere avvenuto con i predetti funzionari Di Petrillo e Gratteri. Non escludo che altre persone della DIA possano essere intervenute per un semplice saluto, affrontando il tema della “dissociazione”.
- A.D.R. Mi è noto che il gen. MORI è attualmente sotto processo a Palermo. I miei ricordi sono, comunque, quelli che ho detto. Non ne avevo parlato prima di oggi perché nessuno mi aveva rivolto una domanda specifica, o comunque aveva affrontato con me il tema della “dissociazione” o della “trattativa”.
MUTOLO, dunque, riferisce elementi certamente di rilievo, ma non consente, con le sue dichiarazioni di sciogliere l’enigma BORSELLINO/SUBRANNI, e cioè quale sia la fonte del dott. BORSELLINO circa i collegamenti con la criminalità organizzata del generale SUBRANNI.
Gen. SUBRANNI che, occorre ricordare, era stato certamente in rapporti con Vito CIANCIMINO, come risulto’ dalle perquisizioni effettuate dopo il suo arresto nel 1984 (cfr. verbale agli atti del 29.9.1984), e dalle dichiarazioni allora rese dal medesimo CIANCIMINO (cfr. verbali di interrogatorio del 10 e 28.11.1984 in atti).
In particolare, nel verbale del 28.11.1984 Vito CIANCIMINO testualmente dichiarava “ho conosciuto il Col. Subranni a Palermo e con lo stesso ho intrattenuto cordiali rapporti di amicizia …”.
Inoltre in esito alle perquisizioni conseguenti all’arresto del CIANCIMINO venivano rinvenute, in particolare, due lettere con biglietto da visita con aggiunta manoscritta del SUBRANNI indirizzate all’abitazione dello stesso Vito CIANCIMINO.
Rimangono, dunque, le dichiarazioni sulla “dissociazione” come principale novità contenuta nelle dichiarazioni rese da MUTOLO nel corso delle ultime indagini. Queste dichiarazioni, che in un primo momento avevano suscitato perplessità (sia per la distanza temporale dai fatti narrati, sia anche perché il tema della conoscenza, da parte del dott. BORSELLINO, della c.d. trattativa e’ stato in questi ultimi tempi dibattuto più volte dagli organi di informazione) hanno ottenuto invece riscontri inaspettati: la dichiarazione di un ex capo centro della DIA allora presente all’interrogatorio di MUTOLO (il col. DI PETRILLO), che ha confermato che la dissociazione fu uno dei temi trattati in quel periodo, facendo risalire la sua conoscenza della “dissociazione” proprio ad uno dei primi interrogatori di MUTOLO:
VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI DI DI PETRILLO DOMENICO DEL 19 APRILE 2010
- AD.R. Sono stato capo centro del C.O. DIA di Roma, dall’aprile-maggio del 1992, sino al maggio del 1995, allorché entrai al SISDE quale direttore della Divisione contro il terrorismo~ in quel momento direttore del SISDE era il Generale MARINO che fu colui che mi propose l’incarico che ho poi assunto al fine di risollevare la struttura che in quel momento aveva perso di credibilità anche a livello internazionale. Dal 31 agosto del 1996 mi sono dimesso dall’ Arma dei Carabinieri, assumendo la funzione di capo della sicurezza del gruppo ENI.
- A.D.R. La gestione della collaborazione di MUTOLO fu il primo incarico che avemmo come Centro Operativo di Roma~ da quel che ricordo il MUTOLO aveva avuto in precedenza un colloquio col dottor FALCONE, del quale era stato informato il dott. DE GENNARO. Ricordo che cercammo di trovare un modo per far fuoriuscire il MUTOLO dal carcere senza che la circostanza destasse allarme, avendo contatti anche con il criminologo dotto BRUNO, con la dotLssa FERRARO, decidendo alla fine di farlo ricoverare all’ospedale Ortopedico di Firenze sfruttando il fatto che il MUTOLO aveva problemi alla schiena. Da tale struttura dovemmo trasferire precipitosamente il MUTOLO, poiché ci accorgemmo che un palermitano era del pari ivi ricoverato lo portammo a Roma e di lì il MUTOLO iniziò la collaborazione con l’autorità giudiziaria. La mia formazione era nel campo dell’antiterrorismo e non in materia di antimafia, formazione che prevedeva un’attività di analisi prima che di polizia giudiziaria e che cercai anche di instillare allorché divenni capo centro della DIA di Roma. L’attività condotta nel covo di via Ughetti fu il culmine di questa nuova metodologia che cercai di introdurre.
- A.D.R Ho partecipato quasi sempre agli interrogatori di MUTOLO, anche perché eravamo operativi da poco e, pertanto, non vi era una mole eccessiva di incombenze cui adempiere nella mia qualità di capo centro. Allorché iniziammo ad occuparci di MUTOLO avevamo gli uffici in via Fea ed il MUTOLO venne ascoltato dal dottor BORSELLINO per la prima volta in uffici ubicati in via Libertà; in quella circostanza il dottor BORSELLINO era in compagnia del dottor ALIQUO’ e ricordo che presenziai nel momento in cui il dottor BORSELLINO incontrò il MUTOLO, ma uscii (così come gli altri funzionari della D.LA) poi dalla stanza allorché l’atto istruttorio ebbe inizio. In quel momento io ero il responsabile operativo della struttura ed era il dottor LOI il capo centro, incarico che mantenne almeno fino allorché il dottor CONTRADA venne arrestato.
- A.D.R Il mio rapporto col dottor BORSELLINO era formale perché non avevo avuto modo di conoscerlo fino a quel momento e ciò benché già conoscessi da tempo CANALE che in quel periodo era stretto collaboratore del dottor BORSELLINO; non ricordo in maniera nitida di pause effettuate nel corso degli interrogatori e non ricordo neanche di particolari commenti fatti dal dottor BORSELLINO con me sulla collaborazione di MUTOLO o su altri argomenti. Non ho nemmeno un ricordo nitido sul fatto che MUTOLO parlò con BORSELLINO di SIGNORINO e CONTRADA, circostanza che ho rammentato solo successivamente e solo dopo sollecitazioni di altri colleghi con i quali commentammo gli avvenimenti dopo che costoro erano stati assunti a verbale dall’ AG . Non ho un ricordo nemmeno sui tempi del primo atto istruttorio del MUTOLO, con particolare riguardo alla visita del dottor BORSELLINO al Ministero, ma se ben ricordo la prima fase dell’interrogatorio durò poco, circa mezz’ora-quaranta minuti, dopo di che il dottor BORSELLINO si allontanò per andare appunto al Ministero.
- A.D.R Ricordo che si parlò di dissociazione, in termini molto generici e me lo ricordo perché era un fenomeno che ho recepito poiché materia affine a quella dell’ antiterrorismo. Ne ho ricordo come un discorso fatto nel periodo della collaborazione di MUTOLO o, comunque, nel periodo iniziale del mio incarico alla DIA, ma non ricordo da chi provenne tale discorso, né ne ricordo i termini precisi. Desumo che tale discorso venne affrontato in occasione di uno degli interrogatori di MUTOLO. Le SS.LL. mi chiedono se in questo discorso della dissociazione c’entrasse Pippo CALO’ ma in merito posso dire che non ho alcuna notizia su tale circostanza. Posso solo dire di aver fatto un colloquio investigativo con Pippo CALO’ per motivazioni connesse all’omicidio PECORELLI, ma il colloquio durò pochissimo poichè il CALO’ volle interromperlo temendo che all’esterno si potesse pensare che collaborare con la giustizia.
- A.D.R il MUTOLO venne dapprima tenuto in un appartamento nella disponibilità del dott.LOI e poi in via di Priscilla, ove veniva escusso dai magistrati.
- A.D.R Ricordo che avvenne un confronto tra MUTOLO e CANCEMI nel comando del RO.S. di Roma; tale atto istruttorio, se ben ricordo, venne gestito dall’ Autorità Giudiziaria ed il motivo per cui si decise di espletarlo era per rassicurare il CANCEMI in ordine alla sua collaborazione. Escludo che vi sia stata una sollecitazione alla nostra struttura dal RO.S. per effettuare tale confronto, anche perché, essendo capo centro, ne avrei avuto sicuramente notizia. In altre parole lo scopo era indurre il CANCEMI ad una collaborazione più piena, ma, tomo a ripetere, si trattò di una situazione gestita dall’ A.G. di Palermo. Al confronto in questione era presente GRATTERI, non ricordo se vi fossero anche altri appartenenti alla DJ.A, così come ero presente anche io. Nell’occasione c’erano anche MORI ed OBINU, ma gli stessi non hanno avuto alcun colloquio col MUTOLO.
- A.D.R. Ho conosciuto MORI nel maggio del 1978, allorché venni spostato dal Comando del Nucleo Investigativo di Nuoro alla Sezione Anticrimine di Roma, che MORI comandava. Nel momento in cui entrai alla DIA continuai ad avere assidui rapporti con MORI, così come con SUBRANNI ed OBINU, anche perché andavo a pranzare alla mensa del R.O.S .. Non ho mai chiesto, comunque notizie a MORI sulle attività che il R.O.S. aveva in corso in quel periodo (faccio riferimento al periodo in cui MUTOLO iniziò la collaborazione con l’AG.), anche perché lo stesso mi considerava un “traditore” poiché avevo lasciato l’Arma per entrare alla DJ.A. Ritengo che in quel periodo MORI si recasse a Palermo per attività inerenti il suo ruolo, ma si tratta comunque di una mia deduzione fondata sui compiti che normalmente ha un funzionario quale era MORI in quel periodo, non avendo ricordi specifici sul punto.
- A.D.R. non ho mai sentito parlare, in quel periodo, di “trattativa” o, comunque, di resa dei latitanti di cosa nostra in cambio di benefici da elargire nei loro confronti. LE SS.LL. mi danno lettura di stralcio del contenuto di dichiarazioni rese da MUTOLO Gaspare il 5 novembre 2009 ed il 23.3.2010 in cui lo stesso riferisce del discorso relativo alla “dissociazione” trattato nel corso di pause di interrogatori cui presenziò il dotto BORSELLINO. Ribadisco che non ho ricordo del tema della “dissociazione” quale riferito dal MUTOLO in maniera così dettagliata alle SS.LL., ma confermo che il mio ricordo colloca il discorso della “dissociazione” nelle prime fasi della collaborazione del MUTOLO. Non mi risulta che si sia mai parlato del fatto che MORI si recasse spesso a Palermo ed aveva contatti all’interno di cosa nostra per trattare. (…) ho lasciato i carabinieri perché non mi riconoscevo più nella struttura (….) Bisogna aggiungere, comunque, che sia lo stesso dott. DE GENNARO, che l’altro allora dirigente della DIA dott. GRATTERI hanno escluso di avere mai sentito parlare in quel periodo del tema della “dissociazione” degli appartenenti a “cosa nostra”. Invece, elemento concordante con quanto sopra riportato sono, come vedremo, le dichiarazioni rese da Edoardo FAZZIOLI, allora vice direttore del DAP retto da Niccolò AMATO, che ha riferito che nella seconda metà del 1992 si discusse all’interno del Dipartimento proprio della prospettiva di creare aree separate di detenzione per mafiosi che avessero deciso di “dissociarsi”.
Altri elementi su quella stagione, ma anche sulla presenza di “servitori dello Stato” infedeli derivano dalle dichiarazioni di Gioacchino GENCHI (che ha riferito in merito al dott. Arnaldo LA BARBERA ed alla sua decisione di uscire dal pool di investigatori che si occupava delle indagini sulla strage del 19 luglio 1992), nonché dalla annosa vicenda DI MATTEO (ed al connesso sequestro del figlio, poi ucciso barbaramente dalla mafia): una vicenda i cui contorni non sono ancora del tutto chiari, ove si consideri che DI MATTEO aveva già reso importanti dichiarazioni alle Procure prima del sequestro del figlio, e che, dunque, questo sequestro doveva avere o un fine “punitivo”, ovvero, ed è più probabile, “preventivo”, teso, cioè, ad evitare che DI MATTEO potesse rivelare cose particolarmente importanti, che ancora non aveva rivelato.
Che questa possa essere la giusta chiave di lettura deriva dal primo verbale reso da DI MATTEO Mario Santo alla Procura di Caltanissetta. In specie, dopo avere riferito rilevanti elementi sulla strage di Capaci, per la cui commissione era imputato, DI MATTEO, al termine del lungo verbale, verbalizza di potere rendere dichiarazioni sulla strage di Via d’Amelio, che vengono rinviate per la stanchezza del collaboratore:
VERBALE DI INTERROGATORIO – DI MATTEO MARIO SANTO DEL 25 OTTOBRE 1993
Omissis
- Domanda: Puo’ riferire qualcosa anche in ordine alla strage di Via D’Amelio?
- Risposta: Si ma in questo momento sono particolarmente stanco e preferirei che l’interrogatorio cessasse qui dichiarandomi tuttavia pronto a fornire una totale collaborazione in un prossimo momento.
L’Ufficio da atto che non e’ concluso ne’ l’interrogatorio relativo ai fatti attinenti l’uccisione del Giudice Giovanni FALCONE ne’ tantomeno quello relativo alla morte del Giudice BORSELLINO si tiene comunque conto dell’esigenza dell’indagato e si rinvia l’interrogatorio a data da destinarsi essendo pertanto necessario verificare i primi dati forniti.
Queste dichiarazioni non vennero, poi, mai rese, limitandosi DI MATTEO a rendere generiche dichiarazioni sul telecomando e BRUSCA (che certamente, per la loro semplicità, non giustificano il rinvio della verbalizzazione del 25 ottobre 1993).
E ad illuminarci sui motivi per cui non vennero rese vi sono alcune intercettazioni che vennero effettuate ai colloqui tra gli allora coniugi DI MATTEO, nel corso delle quali la moglie pronunzia frasi assai inquietanti:
I due genitori parlano della scomparsa del figlio. La madre è disperata (A me’ figghiu mi l’hata a dari), il padre è convinto che il figlio nopn tornerà indietro. A questo punto, la CASTELLESE invita il marito a non parlare più:
- CASTELLESE: tu a tò figliu accussì l’ha fari nesciri, si fa questo discorso
- DI MATTEO: ma che discorso? Ma che fa
- CASTELLESE: parlare della mafia
- DI MATTEO: Ah, nun ha caputu un cazzu
- CASTELLESE: come non ha caputu un cazzu?
- Parlano sottovoce
- CASTELLESE: Oh, senti a mia, qualcuno è infiltrato (?) per conto della mafia
- DI MATTEO: (?)
- CASTELLESE: Aspè, fammi parlare (incomprensibile) Tu questo stai facendo, pirchì tu ha pinsari alla strage di BORSELLINO, a BORSELLINO c’è stato qualcuno infiltrato che ha preso (?)
- DI MATTEO: (?)
- CASTELLESE: Io chistu ti dicu … forse non hai capito
- DI MATTEO: tu fa finta, ora parramo cu’…
- CASTELLESE: Io haia a fare finta, io quannu cu’ papà ci dissi ca dà vota vinni ni tì capito, parlare cu to figlio
- Parlano sottovoce e velocemente: incomprensibile
- DI MATTEO: No tu dici se u’ sannu, lu sta dicinnu tu
- CASTELLESE: capire se c’è qualcuno della Polizia infiltrato pure nella mafia e ti …
- DI MATTEO: Cu?
- CASTELLESE: mi dievi aiutare da tutti I punti di vista, picchì iu mi scantu, mi scantu
- DI MATTEO: intanto pensa a to (figliu)
- CASTELLESE: cioè io pensu au picciriddu, caputu? Tu m’ha capiri! Però, Sa, u discursu è chuistu, nuatri hamma a fari (?)
- Incomprensibile, parlano a bassa voce
- DI MATTEO: Iddu mi dissi, dice, tò muglieri (?) suo marito ava a ritrattari (Inc.) Iddu, BAGARELLA e Totò (?) sanno pure che c’hanno
La conversazione continua su questo tono, sulla necessità di non rendere dichiarazioni, anche se DI MATTEO pensa che sia inutile (“il bambino non torna più, però fara più danno da morto che da vivo….” “senza motivo mi staiu innu a livare a dignità”), e che siano stati BAGARELLA e BRUSCA.
Questo Ufficio ha più volte, nel corso degli anni, provveduto a sentire DI MATTEO e la moglie su quelle gravi affermazioni, ottenendo sempre risposte insoddisfacenti.
In ultimo, DI MATTEO è stato risentito in due occasioni da questo Ufficio. Ed ha continuato a sostenere l’insostenibile, affermando nel corso del primo interrogatorio (7 maggio 2009) di non poter dire nulla sulle intercettazioni perchè quelle frasi non erano mai state pronunziate dalla moglie, che nulla sapeva delle stragi; e “sfidava” questo Ufficio a fargli ascoltare le intercettazioni, e solo in quel caso avrebbe potuto rispondere alle domande che gli venivano poste. Cosa che poi l’Ufficio ha fatto (il 20 aprile 2010), ottenenendo le solite sconfortanti risposte.
Tra l’altro, la necessità dei nuovi interrogatori derivava da alcune dichiarazioni che DI MATTEO aveva reso al “TG1” il 23 novembre 2008, in cui riferiva che avrebbe presto fatto “i nomi dei Killer della strage di Via d’Amelio”:
VERBALE DI INTERROGATORIO – DI MATTEO MARIO SANTO DEL 7 MAGGIO 2009
- A D.R.: La S.V. mi dà lettura delle dichiarazioni da me rese al giornalista del TG1 il 23 novembre 2008 e mi chiede conto delle stesse. Devo rispondere che io non volevo fare l’intervista in questione e che sono stato contattato da un mio amico che lavora in un bar della località in cui attualmente risiedo, che mi ha detto che il TG1 voleva fare un’intervista. Sono venuti loro in un posto vicino a dove abito e, in particolare, è venuto anche il Dr. Cinà, del TG1 più il giornalista che mi ha poi intervistato di cui non ricordo in questo momento il nome. L’occasione dell’intervista era l’apposizione di una lapide in S. Giuseppe Jato, in memoria di mio figlio. In realtà il giornalista, poi mi fece una domanda a trabocchetto dicendomi che avrei fatto presto i nomi dei killer della strage di via D’Amelio. In realtà io non avevo mai detto questo e tutto quanto è a mia conoscenza l’ho già riferito all’A.G. e, in particolare, alla Corte d’Assise di Caltanissetta. Confermo, dunque, quanto ho già detto, che così riassumo: è stato Riina a volere sia la strage di capaci che la strage di via D’Amelio. Per la prima ha dato l’incarico a noi (me e Brusca Giovanni) mentre per la seconda ha dato l’incarico ai Graviano, Filippo e Giuseppe. Questo mi risulta perché, come ho già detto, i Graviano vennero a chiedere a me ed a Gioè Antonino un telecomando che era residuato dalla strage di Capaci; telecomando che noi effettivamente consegnammo loro. Anche Brusca era a conoscenza di tutto perché prima il telecomando era stato chiesto a lui. Per quanto riguarda il telecomando, quello che ho consegnato, come del resto quello di Capaci, ci era stato dato da RAMPULLA Pietro ed era stato acquistato in un negozio di Palermo, sito nei pressi di via Maqueda, negozio che si occupava della vendita di giocattoli per bambini. Il Rampolla, che è un esperto, si occupava poi di inserire il meccanismo più complesso nell’involucro del giocattolo.
Viene a questo punto rappresentato dall’Ufficio che, dai processi sulla strage di via D’Amelio emerge che il telecomando utilizzato era di tipo altamente professionale.
- A D.R.: Confermo quanto precedentemente detto. Per il resto mi riporto alle dichiarazioni già rese in sede dibattimentale, relativamente alla strage di via D’Amelio. A questo punto viene richiamato il contenuto del colloquio intercorso tra il Di Matteo e la moglie Castellese Francesca il 14.12.1993, nel corso del quale la moglie fa riferimento a responsabilità di soggetti esterni a cosa nostra per la strage Borsellino, invitando il marito a non rendere dichiarazioni al riguardo, dato anche il già avvenuto sequestro del figlio.
- A D.R.: Mia moglie non sapeva nulla di questi fatti e non ha mai pronunziato quelle frasi; ciò continuo ad affermare nonostante lei mi dica che il colloquio è stato audioregistrato e che dunque quelle riportate sono state le parole dette da mia moglie.
- Spontaneamente aggiunge: Riina incaricò solo i Graviano di compiere la strage. Quando io, il 29 ottobre del 1997 ho affermato che “Aglieri, Greco e Brusca c’entrano con tutte le scarpe nella strage di via D’Amelio”, intendevo riferirmi ad una responsabilità di Aglieri e Greco come mandanti e non come esecutori. Quando dico che sono stati incaricati solo i Graviano lo dico sia per il fatto che i Graviano mi chiesero il telecomando, sia per il fatto che non aveva senso estendere troppo la conoscenza dei fatti esecutivi. In tale modo, infatti, Riina si era già comportato per quanto riguarda i fatti di Capaci. Inoltre, non conoscendo assolutamente Scarantino, pur essendo vicino ad alcuni uomini della “Guadagna”, ed avendo sicuramente questi detto il falso per quanto personalmente mi riguardava, ho sempre ritenuto che avesse detto il falso anche sulle altre cose che ha riferito. Nulla so di eventuali responsabilità di soggetti terzi rispetto all’associazione mafiosa nei fatti di via D’Amelio.
VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI DEL GIORNALISTA RAUL PASSARETTI DEL 28 LUGLIO 2009
Sono stato messo in contatto con Santo DI MATTEO da un conoscente che causalmente mi disse, in funzione del mio lavoro, che conosceva Santo DI MATTEO. Afpprofittai di quella circostanza e gli chiesi se se poteva farmi da tramite al fine di ottenere una intervista …. L’intervista durò pochi minuti e non ebbe contenuti, all’origine, particolari. Quando spensi la telecamera chiamai il mio capo redattore dott. Filippo GAUDENZI per comunicargli che il servizio era andato a buon fine ed in quella circostanza il dott. GAUDENZI mi suggerì di chiedergli qualcosa su Via d’Amelio. In funzione di ciò riaccendemmo la telecamera, e alla mia domanda se avesse Saputo qualcosa della strage rispose, in buona sostanza, che ciò che sapeva l’avrebbe raccontato ai magistrate,perchè, disse, erano altri gli autori della strage e non gli attuali condannati. Pur da me stuzzicato ed invitato ripetutamente a dire qualcosa in più non aggiunse altro e ribadì che avrebbe riferito solo ai magistrate, dandomi la concreta impression che effettivamente sapesse molto (…) Pochi giorni dopo (la messa in onda, n.d.r.) ricevetti la telefonata del figlio di DI MATTEO dalla Sicilia, il quale, in riferimento all’intervista andata in onda, manifesto seria preoccupazione per la “loro” incolumità, precisando che il papaà viveva fuori, ma “noi viviamo ancora qui in Sicilia”, e mi chiese in modo abbastanza chiaro di far seguire alle dichiarazioni del padre una rettifica (…) A distanza di circa un’ora sento al telefono Santo DI MATTEO, gli racconto della telefonata intercorsa poco prima con il figlio e lui mio chiese, in modo abbastanza incisive, di mandare quella stessa sera sul TG1 delle 20,00 una rettifica limitatamente a quanto detto su BORSELLINO (…) concordammo di far passare come una cattiva interpretazione da parte mia la possibilità che lui conoscesse circostanze inedited circa la strage di BORSELLINO (…) Dunque, appare evidente che DI MATTEO è a conoscenza di altri particolari riguardanti le stragi, che questi particolari riguardano soggetti istituzionali, ma che non intende riferirli per l’ovvia considerazione che teme per la vita dei suoi familiari. Risentito sul punto, DI MATTEO ha detto di non avere nulla da aggiungere, ma poi ha fornito – quasi a risarcimento delle mancate dichiarazioni – un inedito quadro di Nino GIOE’, che a suo dire aveva cominciato una “collaborazione” prima di “suicidarsi”. Deve richiamarsi, al riguardo, che GIOE’, ed il suo misterioso suicidio, sono stati da sempre ritenuti al centro di un eventuale “verità ulteriore” sulle stragi: si ricordano le dichiarazioni di DI CARLO Francesco (rese all’udienza del 4.10.1999 nell’ambito del processo relativo al fallito attentato dell’Addaura) che, contattato in carcere da personalità istituzionali, diede il nome proprio di GIOE’ al fine di organizzare attentati in Italia, come vanno pure richiamate le risultanze agli atti sui contatti di GIOE’ con BELLINI Paolo, soggetto al centro di una diversa e precedente – rispetto a quella sin qui esaminata – trattativa sempre con i Carabinieri del ROS:
VERBALE DI INTERROGATORIO – DI MATTEO MARIO SANTO DEL 20 APRILE 2010
- A D.R.: dopo avere ascoltato la conversazione ribadisco di non ricordare alcun riferimento a “infiltrati” quali responsabili del rapimento di mio figlio; ribadisco di non sapere altro rispetto a quello che ho già riferito in merito alla strage di via D’AMELIO. Prendo atto di quel che mi contestano le SS.LL. in merito alla trascrizione del colloquio – dalla quale emergerebbe cosa diversa da quella che dico – ma ribadisco ancora una volta che non posso essere di aiuto; se avessi saputo altri particolari li avrei già riferiti nel 1993. Prendo atto anche delle dichiarazioni, di cui ricevo parziale lettura, del giornalista Raul PASSARETTI a proposito dell’intervista e della successiva rettifica da me rassegnate al predetto giornalista in data 23 e 26 novembre 2008, nonché di parte dell’intervista in questione, dalle quali risulterebbe che io ero a conoscenza di particolari circa la strage di via D’Amelio e che poi – sempre secondo quello che mi fanno rilevare le SS.LL. – per paura abbia operato una rettifica; e ribadisco ancora una volta che il giornalista si era sbagliato nell’ interpretare alcune mie risposte.
- A D.R.: sono a conoscenza che Antonino GIOE’ era in rapporto con DI CARLO allorchè questi era ristretto in un carcere dell’Inghilterra, per averlo appreso dallo stesso GIOE’.
- A D.R.: per quanto riguarda i rapporti fra esponenti di Cosa Nostra ed appartenenti ai servizi conosco solo quelli con Bellini che io ho avuto modo di vedere insieme al GIOE’ e poi di incontrare a Paliano nell’anno 2005-2006 per quel che ricordo. In quest’ ultima occasione io cercai di stimolare il Bellini per apprender alcuni particolari dei rapporti da lui avuti con Cosa Nostra, ma il Bellini era assolutamente prevenuto e attento a non riferire nulla.
- A D.R.: In ordine al suicidio di GIOE’, posso dire di essere stata l’ultima persona appartenente a Cosa Nostra ad avere parlato con lui poco tempo prima della morte. Eravamo entrambi ristretti al carcere di Rebibbia mai io mi resi conto che egli si trovava pure in quel carcere casualmente, perché lo vidi affacciarsi dalla finestra di una cella mentre facevo l’ora d’aria. GIOE’, contrariamente a quelle che erano le sue abitudini, aveva la barba parecchio lunga e teneva un atteggiamento strano; mi precisò che poteva avere colloqui giornalieri con il fratello – credo si riferisse a Mario – e addirittura mangiare i gamberi che gli portava. Rimasi stupito da quelle parole ed intuii che aveva iniziato o stava iniziando a collaborare tanto, che gli chiesi “ma che stai facendo ?”. La sera stessa mi fu comunicato da una guardia della Polizia Penitenziaria che dovevo essere trasferito subito in altra struttura carceraria che non mi venne comunicata; infatti la sera stessa o il giorno successivo venni trasferito all’ Asinara. Dopo circa un mese dal mio arrivo all’ Asinara appresi la notizia del suicidio di GIOE’ e capii che la ragione del suicidio poteva essere legata al fatto di avere sbagliato a parlare con me facendomi capire le sue intenzioni e mettendo quindi a rischio la vita dei suoi familiari; del resto il carcere non lo aveva mai spaventato avendo sofferto in precedenza lunghe carcerazioni, durante le quali si era sempre curato del suo fisico e del suo aspetto. Ma è anche rilevante che Giovanni BRUSCA, pur affermando (nell’ambito della costante animosità esistente con DI MATTEO) che DI MATTEO era stato estromesso ad un certo punto (dopo il collocamento dell’esplosivo) dall’esecuzione della strage di Capaci, dica anche che ciò era avvenuto perché “abbiamo cominciato a sospettare che lui parlasse con la moglie”. Dunque, proprio il presupposto della difesa di DI MATTEO (“mia moglie non sa niente delle stragi”) viene contraddetto dai risultati di una “indagine interna” a “Cosa Nostra”:
DEPOSIZIONE DIBATTIMENTALE DI BRUSCA GIOVANNI –UDIENZA DEL 17 GIUGNO 1998 NEL PROCEDIMENTO C.D. “BORSELLINO BIS” Io voglio sapere questo, cioe’ a dire: tutte quelle persone che hanno partecipato alla strage, vi hanno partecipato fin dall’inizio ad eccezione di DI MATTEO., e quindi dall’inizio alla fine ad eccezione di DI MATTEO., oppure vi sono state anche altre persone nelle condizioni di DI MATTEO., cioe’ a dire che hanno partecipato fino ad un certo punto?
- BRUSCA GIOVANNI Per esempio, BAGARELLA-. ha partecipato sino al collocamento dell’esplosivo e non… e poi non c’era piu’. Il… il CANCEMI-. io non l’ho piu’ visto, tranne che il giorno in cui… il giorno in cui poi, quando e’ successo, l’ho visto assieme a RAFFAELE GANGI-. a casa di DOMENICO GUDDO-.. Quindi, il FERRA… il PIETRO RAMPULLA-. non c’era perche’ ha avuto dei problemi di carattere familiare, quindi non c’era il giorno della… della strage. Non ho altri ricordi in questo momento. Poi, bene o male, gli altri, chi per un motivo chi per un altro, hanno partecipato un po’ tutti.
- SCOZZOLA Quindi, lei dice BAGARELLA-. ed altri. Per quanto riguarda le motivazioni per cui BAGARELLA-. non partecipa piu’ e DI MATTEO-. non partecipa piu’, sono motivazioni identiche oppure sono motivazioni diverse? E se sono diverse, quali?
- BRUSCA GIOVANNI No.
- SCOZZOLA “No” in che senso?
- BRUSCA GIOVANNI BAGARELLA-. si allontana… “no” nel senso che BAGARELLA-. si allontana perche’ non c’e’ bisogno della sua presenza, e se ne va a Mazara del Vallo-., e potete chiamare a VINCENZO SINACORI-. perche’ lui gli ha dato ospitalita’, e sa dov’era e sa dove non era. Invece, il DI MATTEO-. viene allontanato perche’ abbiamo cominciato a sospettare che lui parlasse con la moglie. Quindi, abbiamo cominciato ad allontanarlo.
- SCOZZOLA E questo allontanamento di DI MATTEO-., per il motivo che lei ha detto, e’ solo per la strage di Capaci-. oppure e’ anche per altri delitti?
- BRUSCA GIOVANNI No, viene allontanato… cioe’, gia’ la strage di Capaci-. la sapeva, quindi non c’era bisogno piu’ di allontanarlo; ma per quello che doveva venire, cioe’, cominciare a chiudere un po’ il rapporto con… con il DI MATTEO-..
- SCOZZOLA Io non ho capito la risposta perche’ non mi e’ arrivata bene; c’e’ stato un attimo di confusione. Quindi, anche…
- BRUSCA GIOVANNI E allora, per la strage… per la strage di Capaci-. gia’ lui sapeva, quindi non c’era piu’ niente da potere ritornare indietro; ma per il futuro, quello che doveva venire, abbiamo cominciato a chiuderci tutti i passi, tutte le confidenze, onde evitare che lui… questo sospetto che noi avevamo, di potere continuare… Quindi, tenerlo all’oscuro di tutto, senza pero’ un grosso trauma, cioe’ nel senso di buttarlo fuori famiglia o dargli sanzioni, misure un po’ drastiche.
In conclusione, pur essendosi raccolti nuovi ed importanti elementi circa “ombre” inquietanti di apparati infedeli dello Stato sulla strage di via d’Amelio, dobbiamo con chiarezza affermare che queste, allo stato, non sostanziano alcuna responsabilità penale.
Certamente, permettono, comunque, di ribadire che – in quel momento storico – ben era possibile una trattativa con Cosa Nostra, e che molteplici erano le figure, anche istituzionali, che giocavano partite complesse e spregiudicate, con incursioni anche nel campo “avverso”.
- RISPOSTA: Non ho ricordo preciso della data in cui si svolse l’incontro con il dott. BORSELLINO. Ricordocomunque,che gli unici motivi perchè io mi recassi a Palermo potevano essere o una convocazione del Procuratore Generale (cui avevamo inviato una lettera, in cui rappresentavamo che il dott. SIGNORINO, applicato quale reggente alla Procura di Marsala, aveva subito richiesto copia degli atti del processo CULICCHIA・GUNNELLA, in cui era stato rinvenuto un bigliettino con il nome “SIGNORINO”); ovvero la data in cui io e la collega Camassa sentimmo lo stesso SIGNORINO, che come mi dite è avvenuto il 12 giugno. Posso però fornire nuovamentequali elementi dai quali risalire alla data esatta, che il dott. BORSELLINO ci riferì – nell’ occasione di cui si parla – che il giorno prima o qualche giorno prima aveva avuto un pranzo o forse una cena a Roma”, e di avere incontrato lì degli alti ufficiali dei Carabinieri. Comunque, sul punto il mio ricordo è sfumato. Penso che acquisendo i fogli di trasferta della mia scorta (allora ero seguito da personale del Commissariato di Marsala; mentre la dott.ssa CAMASSA era seguita dai CC di Trapani) dovrebbe essere possibile arrivare alla determinazione della data esatta in cui ci recammo a Palermo.
- ADR. Il fascicolo 479/91 R.G. (CULICCHIA- GUNNELLA) era di competenza della Procura di Marsala, perchè i fatti erano precedenti alla istituzione delle DDA. Non vi era dunque alcun bisogno di una mia applicazione
- DOMANDA: Nel corso delle precedenti s.i.t. ha riferito che I’incontro avvenne“ o il giornoo in cui sentimmo a s.i.t. SIGNORINO o in uno dei giorni precedenti. quando incontrammo il Procuratore Generale per par/are di tale espletando accertamento istruttorio”.
A questo punto l’Ufficio rappresenta che gli unici viaggi a Roma annotati nell’agenda grigia del dott. BORSELLINO, sono avvenuti il 9 giugno 1992 mattina, con attività alla DIA, all’ Alto Commissariato, quindi pranzo a Roma ed incontro con il dott. SINESIO, poi con ARLACCHI, e rientro la sera a Palermo; di passaggio, il 26 e 28 giugno 1992, rispettivamente per e da Bari (ritorno dal convegno di Giovinnazzo); il 30 giugno 1992, con permanenza a Roma l’ 1 luglio (in questa seconda data è inserita, di mattina, la dizione“ CC”).
- RISPOSTA: Confermo le dichiarazioni già rese, e poiché apprendo oggi che I’interrogatorio di SIGNORINO è avvenuto il 12 giugno 1992, e che il dott. BORSELLINO partecipò ad un pranzo a Roma il 9 giugno, potrebbe essere proprio la data del 12 giugno quella giusta. Chiedo di potere compulsare copia del verbale, al fine di controllare l’ orario in cui avvenne.
L’Ufficio sottopone, dunque, copia del verbale, da cui risulta che lo stesso avvenne presso la Procura di Palermo alle ore 17:05.
- RISPOSTA: Alla luce di tali dati ritengo altamente probabile che l’incontro con Borsellino avvenne nella prima parte della giornata essendoci forse portati a Palermo già nella mattinata in quanto la collega Camassa doveva interloquire con gli uffici della procura di Palermo per il rinnovo della sua applicazione in un processo DDA relativo alla mafia di Partanna che aveva seguito insieme al dott. Borsellino quando quest’ultimo era procuratore a Marsala. Non ho altro da aggiungere”.
Dalle motivazioni sentenza processo trattativa Stato-mafia – LA DEPOSIZIONE DI FERNANDA CONTRI Negli stessi mesi in cui si sviluppavano i contatti di De Donno e Mori con Vito Ciancimino, di ciò fu informata (oltre che, come si è visto, la Dott.ssa Liliana Ferraro) anche la Dott.ssa Fernanda Contri, all’epoca Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All’udienza del 15 settembre 2016 è stata esaminata la teste Fernanda Contri, la quale, dopo avere sinteticamente illustrato gli incarichi professionali ricoperti che, tra l’altro, le avevano dato occasione di conoscere il Dott. Falcone, in sintesi ha riferito riguardo al tema qui in esame dei contatti con Mori:
- – di avere conosciuto il Col. Mori per esserle stato presentato dal Dott. Falcone nel periodo nel quale ella ricopriva l’incarico di Consigliere del C.S.M. e di avere avuto con il predetto Mori uno scambio di opinioni dopo l’attentato dell’Addaura.
- – di essersi presentata spontaneamente il 18 gennaio del 2010 ai magistrati di Caltanissetta per rendere dichiarazioni e riferire, in particolare, di incontri che aveva avuto con Mori nel 1992:
“Si è maturata in me l’idea che forse potevo essere utile…” […] “Il fatto che avevo incontrato tutti questi personaggi, quelli che purtroppo non c’erano più e quelli che per fortuna ci sono ancora… In particolare io sia sulla mia agenda personale, che sull’agenda della mia segreteria, ho segnati i due incontri che ufficialmente ho avuto con Mori nel corso dell’anno 92” - – il primo dei detti incontri con Mori era avvenuto il 22 luglio 1992, tre giorni dopo l’omicidio Borsellino:
“lo ero già Segretario Generale da una ventina di giorni e avevo incontrato, nei quindici giorni precedenti, PAOLO BORSELLINO. Mi disse che stava facendo viaggi e avanti e indietro credo dall’Italia alla Germania perché aveva nove che stanno parlando.
E MI DISSE: TI PREGO, DATA LA POSIZIONE CHE TU RICOPRI ADESSO…DI’ AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AI MINISTRI CHE PER FAVORE QUELLE PROPOSTE, DISEGNI, LEGGI CHE RIGUARDANO I PENTITI VADANO AVANTI IN FRETTA, IO HO MOLTA PREMURA.
E IO PER UN ATTIMO HO AVUTO LA SENSAZIONE CHE LA SUA FOSSE QUASI UNA CONFIDENZA DI DISPERAZIONE SU QUEL MOLTA PREMURA… …LUI MI GUARDO’ CON UN’ARIA TRISTISSIMA CHE NON DIMENTICHERO’ MAI, E MI DISSE: “LA MIA E’ UNA LOTTA CONTRO TUTTI I TEMPI E TU HAI CAPITO BENISSIMO COSA VOGLIO DIRE.” - – di avere adesso il ricordo di avere ella sollecitato quella visita di Mori, ma di non essere sicura di ciò e di non escludere, quindi, che l’incontro possa essere stato richiesto, invece, da Mori come ebbe a dichiarare in un’occasione precedente
- – che in quell’incontro si parlò, innanzitutto, della contestazione al Presidente della Repubblica verificatasi in occasione dei funerali degli agenti della scorta del Dott. Borsellino
- – che, poi, in quello stesso incontro, se non in quello successivo del 28 dicembre 1992, MORI LE AVEVA DETTO CHE “STAVA AVENDO INCONTRI” CON VITO CIANCIMINO:
MORI MI DISSE “STO AVENDO DEGLI INCONTRI CON CIANCIMINO E MI SONO FATTO L’IDEA CHE E’ UNO DEI CAPI, SE NON IL CAPO DELLA MAFIA”. E QUESTA COSA MI SCONVOLSE PARECCHIO” - – che, però, poiché il 28 dicembre 1992 Ciancimino era stato già arrestato e si era parlato di Contrada, allora era accaduto certamente nell’incontro del 22 luglio 1992 che Mori le aveva fatto quella confidenza sugli incontri con Vito Ciancimino
- – di non avere detto nulla al Gen. Tavormina di quanto appreso da Mori il 22 luglio perché a quella data non lo aveva ancora conosciuto.
- P.M. Di Matteo: – … quando il Colonnello Mori le disse “sto avendo incontri con Vito Ciancimino”, lei questo contenuto lo riferì al Presidente del Consiglio Amato?
Dich. Contri: – Sicuramente sì, le riferì. Ma siccome poi non c’era stata nessuna richiesta legata, attaccata a questa, gli dissi solo: sta svolgendo questi incontri. Non ci fu commento da parte sua. - – che Mori, riferendo degli incontri con Ciancimino, aveva fatto un generico accenno ad indagini in corso:
“Me ne parlò come di una cosa che non aveva ancora fatto, come di una attività investigativa che stavano per incominciare.”
Paolo Borsellino non voleva “trattare”. A quanto sopra osservato deve aggiungersi che le anomalie nell’attività di indagine continuarono anche nel corso della “collaborazione” dello Scarantino, caratterizzata da una serie impressionante di incongruenze, oscillazioni e ritrattazioni (seguite persino dalla “ritrattazione della ritrattazione”, e da una nuova ritrattazione successiva alle dichiarazioni dello Spatuzza), che sono state puntualmente descritte nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero.Questo insieme di fattori avrebbe logicamente consigliato un atteggiamento di particolare cautela e rigore nella valutazione delle dichiarazioni dello Scarantino, con una minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, positivi o negativi che fossero, secondo le migliori esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata, incentrate su quello che veniva, giustamente, definito il “metodo Falcone”. Non a caso, già gli «appunti di lavoro per la riunione della D.D.A. del 13.10.94», predisposti dalla Dott.ssa Ilda Boccassini e dal Dott. Roberto Saieva», segnalavano che «l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo in ordine alla partecipazione alla strage di Via D’Amelio (…) di Cancemi, La Barbera e Di Matteo (ma anche di Ganci Raffaele) suggerisce di riconsiderare il tema della attendibilità generale di tale collaboratore». L’adozione di un metodo di valutazione della prova capace di unire i criteri di razionalità con la comprensione profonda dei fenomeni sociali ha condotto la Corte di Assise di Caltanissetta, nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. “Borsellino ter”), a ritenere che allo Scarantino facesse difetto «non tanto la qualifica formale di “uomo d’onore” e una combinazione rituale con santina e pungiuta, quanto un effettivo inserimento in “Cosa Nostra”»; a considerare «scarsamente attendibili le dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO in ordine alla preparazione della strage di via D’Amelio» sulla base del rilievo che «fin dal primo interrogatorio egli ha riferito almeno due circostanze assolutamente non credibili: la ricerca di una “bombola” da far esplodere per realizzare l’attentato e la riunione nella villa del CALASCIBETTA»; a riconoscere che «nel loro complesso le dichiarazioni rilasciate dallo SCARANTINO in tutto l’arco della sua tormentata “collaborazione” con l’Autorità Giudiziaria vanno incontro a una valutazione sostanzialmente negativa sotto vari profili, alla luce dei criteri di giudizio dettati dalla Corte di Cassazione tanto per l’apprezzamento sull’attendibilità delle dichiarazioni costituenti chiamata in correità, quanto per la valutazione dell’attendibilità soggettiva del chiamante»; a segnalare che «il contenuto delle dichiarazioni appare spesso poco verosimile, alla luce delle regole di comune esperienza, oltre che assolutamente incostante; le giustificazioni addotte volta per volta appaiono poco credibili ed alcune volte molto ingenue; infine, il contenuto delle dichiarazioni ha conosciuto una significativa evoluzione nel tempo, venendo accresciuta la loro compatibilità con quanto emerso per altra via dalle indagini»; a esplicitare che «inoltre, le dichiarazioni dello SCARANTINO che non appaiono ictu oculi incredibili, per altro aspetto non appaiono genuine, perché gravemente sospette di essere state attinte addirittura dalla stampa o dalle ordinanze di custodia cautelare, o comunque apprese durante le indagini, perché acquisite dagli inquirenti per altra via e poi condite con un limitato bagaglio di conoscenza diretta maturato nell’ambiente delinquenziale e mafioso della Guadagna»; e, conclusivamente, a ritenere «che delle dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO non si debba tenere alcun conto per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle responsabilità in ordine alla strage di via D’Amelio». La tendenza che invece prevalse, nell’attività giudiziaria e in quella investigativa, fu ben diversa. Si è già visto come le dichiarazioni dello Scarantino abbiamo costituito il fondamento per la condanna all’ergastolo, pronunciata con sentenze passate in giudicato, nei confronti di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe. A ciò deve aggiungersi che le indagini successive alla “collaborazione” dello Scarantino furono contrassegnate da numerosi profili del tutto singolari ed anomali. Assolutamente anomala appare, ad esempio, la circostanza che il Dott. Arnaldo La Barbera abbia richiesto dal 4 al 13 luglio 1994 altrettanti colloqui investigativi con lo Scarantino, detenuto presso il carcere di Pianosa, nonostante il fatto che egli già collaborasse con la giustizia. Una evidente anomalia è riscontrabile pure nelle condotte poste in essere da alcuni degli appartenenti al “Gruppo Falcone-Borsellino” della Polizia di Stato, i quali, mentre erano addetti alla protezione dello Scarantino nel periodo in cui egli dimorava a San Bartolomeo a Mare con la sua famiglia, dall’ottobre 1994 al maggio 1995, si prestarono ad aiutarlo nello studio dei verbali di interrogatorio, redigendo una serie di appunti che erano chiaramente finalizzati a rimuovere le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del collaborante, il quale sarebbe stato sottoposto ad esame dibattimentale nei giorni 24 e 25 maggio 1995 nel processo c.d. “Borsellino uno”. Tali appunti sono stati riconosciuti come propri dall’Ispettore Fabrizio Mattei, escusso all’udienza del 27 settembre 2013, il quale ha sostenuto di essersi basato sulle indicazioni dello Scarantino. Risulta però del tutto inverosimile che lo Scarantino, da un lato, avesse un tasso di scolarizzazione così basso da necessitare di un aiuto per la scrittura, e, dall’altro, potesse rendersi conto da solo delle contraddizioni suscettibili di inficiare la credibilità delle sue dichiarazioni in sede processuale. A ciò si aggiungono ulteriori aspetti decisamente singolari segnalati da alcune parti civili. Va quindi sottolineata la particolare pervicacia e continuità dell’attività di determinazione dello Scarantino a rendere false dichiarazioni accusatorie, con la elaborazione di una trama complessa che riuscì a trarre in inganno anche i giudici dei primi due processi sulla strage di Via D’Amelio, così producendo drammatiche conseguenze sulla libertà e sulla vita delle persone incolpate. Poiché l’attività di determinazione così accertata ha consentito di realizzare uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, è lecito interrogarsi sulle finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello Stato, che si resero protagonisti di tale disegno criminoso, con specifico riferimento:
- – alla copertura della presenza di fonti rimaste occulte, che viene evidenziata dalla trasmissione ai finti collaboratori di giustizia di informazioni estranee al loro patrimonio conoscitivo ed in seguito rivelatesi oggettivamente rispondenti alla realtà;
- – ai collegamenti con la sottrazione dell’agenda rossa che Paolo Borsellino aveva con sé al momento dell’attentato e che conteneva una serie di appunti di fondamentale rilevanza per la ricostruzione dell’attività da lui svolta nell’ultimo periodo della sua vita, dedicato ad una serie di indagini di estrema delicatezza e alla ricerca della verità sulla strage di Capaci;
- – alla eventuale finalità di occultamento della responsabilità di altri soggetti per la strage, nel quadro di una convergenza di interessi tra “Cosa Nostra” e altri centri di potere che percepivano come un pericolo l’opera del Magistrato.
In proposito, va osservato che un collegamento tra il depistaggio e l’occultamento dell’agenda rossa di Paolo Borsellino è sicuramente desumibile dalla identità di taluno dei protagonisti di entrambe le vicende: si è già sottolineato il ruolo fondamentale assunto, nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia, dal Dott. Arnaldo La Barbera, il quale è stato altresì intensamente coinvolto nella sparizione dell’agenda rossa, come è evidenziato dalla sua reazione – connotata da una inaudita aggressività – nei confronti di Lucia Borsellino, impegnata in una coraggiosa opera di ricerca della verità sulla morte del padre.
L’indagine sulle reali finalità del depistaggio non può, poi, prescindere dalla considerazione sia delle dichiarazioni di Antonino Giuffrè (il quale ha riferito che, prima di passare all’attuazione della strategia stragista, erano stati effettuati “sondaggi” con “persone importanti” appartenenti al mondo economico e politico, ha precisato che questi “sondaggi” si fondavano sulla “pericolosità” di determinati soggetti non solo per l’organizzazione mafiosa ma anche per i suoi legami con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a “fare affari” con essa, ha ricondotto a tale contesto l’isolamento – anche nell’ambito giudiziario – che portò all’uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e ha chiarito che la stessa strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione – rivelatasi poi infondata – che passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla “normalità”), sia delle circostanze confidate da Paolo Borsellino alle persone e lui più vicine nel periodo che precedette la strage di Via D’Amelio. Vanno richiamati, al riguardo, gli elementi probatori già analizzati nel capitolo VI. Un particolare rilievo assumono, in questo contesto, la convinzione, espressa da Paolo Borsellino alla moglie Agnese Piraino proprio il giorno prima della strage di Via D’Amelio, «che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, (…) ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere», e la drammatica percezione, da parte del Magistrato, dell’esistenza di un «colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato».
Occorre, altresì, tenere conto degli approfonditi rilievi formulati nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. “Borsellino ter”) secondo cui «risulta quanto meno provato che la morte di Paolo BORSELLINO non era stata voluta solo per finalità di vendetta e di cautela preventiva, bensì anche per esercitare – cumulando i suoi effetti con quelli degli altri delitti eccellenti – una forte pressione sulla compagine governativa che aveva attuato una linea politica di contrasto alla mafia più intensa che in passato ed indurre coloro che si fossero mostrati disponibili tra i possibili referenti a farsi avanti per trattare un mutamento di quella linea politica. (…) E proprio per agevolare la creazione di nuovi contatti politici occorreva eliminare chi come BORSELLINO avrebbe scoraggiato qualsiasi tentativo di approccio con COSA NOSTRA e di arretramento nell’attività di contrasto alla mafia, levandosi a denunciare anche pubblicamente, dall’alto del suo prestigio professionale e della nobiltà del suo impegno civico, ogni cedimento dello Stato o di sue componenti politiche».
Questa Corte ritiene quindi doveroso, in considerazione di quanto è stato accertato sull’attività di determinazione realizzata nei confronti dello Scarantino, del complesso contesto in cui essa viene a collocarsi, e delle ulteriori condotte delittuose emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale (tra cui proprio quella della sottrazione dell’agenda rossa), di disporre la trasmissione al Pubblico ministero, per le eventuali determinazioni di sua competenza, dei verbali di tutte le udienze dibattimentali, le quali possono contenere elementi rilevanti per la difficile ma fondamentale opera di ricerca della verità nella quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta è impegnata. ATTILIO BOLZONI La Repubblica
La storia segreta della trattativa per la resa di Cosa nostra Una straordinaria ricostruzione della trattativa tra lo Stato e Cosa nostra per la resa della mafia. Il pezzo qui pubblicato è tratto da La Stampa.it ed è stato scritto da Francesco La Licata.
C’è una parte importante di Cosa nostra siciliana che da tempo cerca un accordo con lo Stato: una sorta di «dissociazione dolce» – per dirla con l’eufemismo di chi ha portato avanti questa proposta – in cambio di qualche beneficio carcerario che attenui il rigore del «41 bis», il regime di isolamento previsto per i mafiosi e per i terroristi. Ma anche in cambio della non remota possibilità di rivedere le posizioni processuali di alcuni che ritengono di essere stati artatamente coinvolti nelle indagini sulle stragi e «ingiustamente condannati». Diversi tentativi di arrivare ad una consultazione generale del gruppo dirigente mafioso, attraverso incontri combinati nelle carceri, sono andati in fumo più d’una volta. E c’è stato persino il tentativo di consentire un intervento diretto di Bernardo Provenzano, nel frattempo arrestato (aprile 2006) e dunque giocoforza entrato a far parte del «partito dei carcerati», quello maggiormente interessato alla realizzazione dell’insolita «assemblea tra le sbarre» che potrebbe «autorizzare» l’avvio di una vera e propria trattativa fino a questo momento andata avanti a spizzichi e bocconi e senza il necessario confronto diretto tra le diverse anime di Cosa nostra.
La trattativa Su tutta questa massa di avvenimenti, che sembra più una spy-story che il racconto di una reale inchiesta giudiziaria, sta indagando la procura della Repubblica di Roma. Già, perchè c’è da verificare se nel corso dei reiterati tentativi di far incontrare i boss – attività portata avanti sostanzialmente dal Gom (l’intelligence creata dalla Direzione delle carceri che vanta, sembra, buoni agganci coi servizi di sicurezza) – sia stato violato il codice penale. E soprattutto c’è da verificare se la «trattativa» sia mai stata autorizzata da chi ne ha il potere o se è andata avanti nell’interesse di gruppi extra-istituzionali. Una inchiesta sull’attività dei servizi segreti nell’ambito delle carceri che ospitano i mafiosi al «41 bis» e sulla nascita dell’«ufficio specializzato» – che usa la tecnologia dei servizi – diretta emanazione della Dap (Direzione penitenziari), è condotta dai sostituti procuratori Erminio Amelio e Maria Monteleone. Questa, più recente, viaggia parallela all’altra ed è inevitabile che i filoni siano destinati a ricongiungersi. La storia della «trattativa in carcere» risale alla fine degli Anni Novanta, quando un gruppo di mafiosi – quasi tutti condannati in via definitiva per le stragi del ’92 e del ’93 – cominciarono a farsi sentire prima attraverso gli avvocati o con espliciti riferimenti ai legali eletti in Parlamento. Protagonisti di quel primo approccio furono Pietro Aglieri, il boss che studia teologia, e l’allora procuratore nazionale antimafia, Piero Luigi Vigna, il magistrato che ha sempre creduto possibile arrivare alla resa di Cosa nostra.
Né pentiti né dissociati I termini di quel primo contatto facevano riferimento al rifiuto, da parte di Cosa nostra, di ogni forma di pentitismo o dissociazione. In sostanza la tesi di Aglieri era (ed è ancora) che bisognava dare la possibilità, a chi accettava l’idea della sconfitta della mafia ad opera dello Stato, di arrendersi senza per questo dover accusare nessuno o confessare le proprie colpe. Come segnale di resa, la mafia si diceva disponibile a «deporre le armi», proprio in senso stretto, cioè consegnando il proprio armamento. In questa linea si riconoscevano boss importanti come Salvatore Biondino, l’uomo di fiducia di Riina arrestato in auto col capo (forse molto più importante di quanto sia finora emerso), Nitto Santapaola, boss di Catania; e poi ancora don Piddu Madonia capomafia di Vallelunga di Caltanissetta, Giuseppe Farinella delle Madonie, ed anche uno della famiglia Madonia di Palermo. Si parlò, inoltre, di un interessamento alla vicenda di Pippo Calò, ex capomandamento di Porta Nuova (Palermo), ma la notizia poi si sarebbe rivelata troppo vaga. Il fronte delle «colombe», però, si andava a scontrare con gli irriducibili di Totò Riina (soprattutto Bagarella e i Graviano di Brancaccio), convinti di poter ancora intimidire le istituzioni con lo stragismo. L’ultima che avevano pensato, come dimostrò il giudice Gabriele Chelazzi, era un «botto politico» con l’uccisione di un’alta carica dello Stato, Spadolini o Napolitano, al tempo presidenti delle Camere.
Il contatto saltò, anche perché nel giugno del 2000 finì tutto sui giornali. Ma continuò sottotraccia fino al 2002, passando per vari espedienti: prima la lettera famosa di Aglieri a Vigna e Grasso (allora procuratore a Palermo), poi la curiosità inedita di un mafioso calabrese, uno degli Imerti, che chiede la dissociazione. Fatto stranissimo che troverà spiegazione quando si saprà che il rappresentante della ’ndrangheta era stato in cella con Salvatore Biondino, numero due della trattativa, dopo Aglieri, e «delegato» da tutte le associazioni mafiose a portare avanti la strategia della dissociazione. Altra stranezza: nel novembre 2001 ancora Biondino chiede alla direzione del suo carcere di poter fare lo scopino, attività di solito ambita dai detenuti meno abbienti perché consente di guadagnare qualcosa. Ma Biondino non aveva certo bisogno di arrotondare con mestieri umili. E allora? Allora forse voleva fare lo scopino perché quell’attività gli consentiva di muoversi più liberamente e soprattutto di contattare detenuti chiusi lontano dalla sua cella. In sostanza, lo scopino poteva aggirare i rigori del «41 bis». Ma questa strategia fu intuita dall’allora capo dell’ispettorato del Dap, il magistrato Alfonso Sabella, che mette nero su bianco e scrive una nota con cui blocca la richiesta di Biondino. Era il 5 di novembre: lo stesso giorno Sabella viene destituito (direttore del Dap è da poco l’ex procuratore di Caltanissetta, Giovanni Tinebra) e prende il suo posto Salvatore Leopardi, che di Tinebra era stato sostituto.
L’ufficio di Pio Pompa Ma non era la prima volta che Alfonso Sabella (sarà per questo che il suo nome è inserito tra quelli monitorati dall’ufficio del Sismi di Pio Pompa?) mandava all’aria i preparativi per un’assemblea in carcere. La discussione sulla fattibilità della trattativa era finita persino sul tavolo di Piero Fassino, allora – giugno 2000 – ministro della Giustizia. A favore – e alla luce del sole – Piero Luigi Vigna, ma non era una novità visto che anche pubblicamente il procuratore si era dichiarato possibilista. Ci fu una riunione con Vigna, con Gian Carlo Caselli (allora direttore del Dap, prima di Tinebra) e con Sabella. Il risultato di quell’incontro sancì la «non disponibilità» del governo di intraprendere qualsiasi forma di trattativa coi mafiosi. Gli argomenti a sfavore della dissociazione, illustrati a Fassino da Sabella, descrivevano nei dettagli come un eventuale cedimento alle richieste dei boss sarebbe stato tutto a favore della mafia, senza che lo Stato ne ricevesse una contropartita adeguata. In sostanza un regalo a Cosa nostra.
Strani personaggi Il clamore mediatico poi avrebbe definitivamente affossato l’iniziativa. Ma, anche questa volta, senza che si interrompesse il filo sotterraneo, portato avanti col sistema dei colloqui investigativi affidati un po’ ad investigatori, un po’ a personaggi dei servizi con compiti sfuggenti. Un filo che resta teso almeno fino all’autunno del 2005, anno in cui ci riprovano ancora a fare l’assemblea. E’ un momento di grande iperattività pseudoinvestigativa nelle carceri: si registrano persino tentativi di orientare le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Sicuramente uno di quelli avvicinati da «strani personaggi», che in carcere avrebbero dovuto avere altri ruoli, è il collaboratore di giustizia Nino Giuffrè, invitato a cambiare le proprie dichiarazioni richieste nell’ambito di alcuni processi politici.
Ma il tentativo di forzare e fare l’assemblea è di ottobre 2005, quando alcuni mafiosi (sicuramente Aglieri e Biondino, ancora loro) vengono momentaneamente trasferiti al carcere dell’Aquila. Lì si dovranno aprire le celle e dar vita al confronto tra i boss, per definire i particolari di questa «resa». Ma qualcosa non va per il verso giusto. E’ pensabile che dalla direzione del carcere si sia richiesta l’autorizzazione necessaria a modificare il decreto ministeriale che vieta ai detenuti mafiosi di avere contatti. Finora il confronto è avvenuto registrando le rispettive posizioni dei leader e farle conoscere «a giro». I boss, però, vogliono la possibilità di parlare direttamente, anche perchè c’è da prendere decisioni per conto di chi sta fuori dalle sbarre. Provenzano, per esempio, nel 2005 ancora latitante, sa dell’iniziativa? E cosa pensa della vicenda? Bisogna, dunque, infrangere le norme del «41 bis». Ma si sta parlando di reati e allora, forse, è meglio ritentare la strada del coinvolgimento politico del governo a cui chiedere copertura. Ma il ministro, il leghista Roberto Castelli, non se la sente di fare da solo e interpella, oltre al favorevole Vigna, il procuratore di Palermo, Piero Grasso, che boccia nettamente la proposta elencando tutti gli argomenti a sfavore, preponderanti rispetto ad eventuali pro.
La posizione di Grasso – oggi particolarmente protetto perchè da quel «no» si fa scaturire una particolare avversione di Cosa nostra nei suoi confronti – è nota: la mafia, tutta, senza distinzioni tra falchi e presunte colombe, non è un’organizzazione di partigiani che può deporre le armi riconoscendo la propria sconfitta nei confronti dello Stato. Si tratta di criminali che hanno una sola via per ottenere clemenza: quella collaborazione che possa consentire di fare nuovi passi avanti sulla via della lotta alla mafia. Insomma, le garanzie proposte dai boss sembrano deboli e, soprattutto, interessate. E non può bastare la generica affermazione di «diversità» che uno come Pietro Aglieri fa passare, affermando in modo informale: «Io non ho mai ammazzato bambini, né donne né magistrati». Un modo per prendere le distanze dagli irriducibili, ma da mafioso che «non vuol farsi infame». Dicesse tutto quello che sa, è la risposta delle istituzioni.
E allora, tutto finito? Assemblea impossibile? Certo, per un po’ il filo si è ingarbugliato, anche perché i boss sono stati tutti trasferiti e c’è stato un rimescolamento, attutito da una gestione meno rigorosa del «41 bis» revocato ad un buon numero di detenuti. Ma il filo non si è spezzato. Si indaga, per esempio, sull’annosa vicenda della «collocazione» scelta per Provenzano dopo la cattura. C’era chi voleva spedirlo in un certo carcere dove, guarda caso, albergavano alcuni leader della trattativa. Solo un blitz di altri funzionari del Dap ha imposto il carcere di Terni che offriva tutte le garanzie necessarie, anche per la sopravvivenza di un detenuto così importante. E non è finita lì. Successivamente si sono verificati alcuni tentativi per creare le condizioni utili ad un trasferimento di don Binnu. Una prima volta è stata fatta girare la notizia, rivelatasi completamente falsa, di un’accoglienza ostile, a Terni, sottolineata dal commento attribuito ad uno dei figli di Riina («Provenzano sbirro»). E’ stato accertato che il giovane Riina non ha mai pronunciato quelle frasi. Poi è arrivata la storiella della crostata per il compleanno di don Binnu, presentata come una concessione benevola della direzione del carcere di Terni. Anche questa è una notizia falsa, perché il «detenuto Provenzano» ha per legge la possibilità di accedere allo stesso vitto degli agenti di custodia. Quindi nessuna benevolenza. Ma perché, allora, tutto questo can can? Forse qualcuno voleva che Provenzano cambiasse carcere. Il gioco è stato scoperto e così il trasferimento è avvenuto, ma non come volevano i fautori della «dissociazione dolce». Il boss ora sverna in un carcere del Nord, per l’assemblea bisognerà aspettare ancora. SOLE 24 ORE 13.8.2007 Nino Amadore
Il maxiprocesso e la reazione di cosa nostra Il 30 gennaio 1992 si concludeva il “Maxiprocesso”. La Corte di Cassazione confermava la condanna all’ergastolo di Totò Riina e di molti altri capi mafiosi. La reazione di Cosa nostra fu immediata e durissima. Nel giro di pochi mesi vennero assassinati il deputato andreottiano Salvo Lima (marzo 1992), considerato l’anello di congiunzione fra mafia e politica, e l’imprenditore Ignazio Salvo (17 settembre 1992). I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che del Maxiprocesso erano stati gli artefici, furono uccisi nel maggio (strage di Capaci) e nel luglio (strage di via d’Amelio) dello stesso anno. Vennero organizzate e portate a compimento la strage di Via dei Georgofili a Firenze (27 maggio 1993), di Via Palestro a Milano (27 luglio 1993) e di San Giovanni in Laterano. Secondo l’ipotesi accusatoria, tali omicidi facevano parte di un ampio programma stragista ideato da Cosa Nostra, al fine di mettere in ginocchio le Istituzioni. L’obiettivo era duplice: ottenere un “ammorbidimento” della strategia di contrasto della criminalità mafiosa e stipulare un nuovo “patto di convivenza” fra Stato e Mafia. È in questo contesto che per i pubblici ministeri, Calogero Mannino, uno dei politici finiti nel mirino dei mafiosi, si sarebbe rivolto al maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, chiedendogli di chiamare in causa il ROS (Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri), di cui era comandante Antonio Subranni, per essere protetto. Guazzelli fu assassinato subito dopo. A quel punto Mario Mori, che nel Ros dirigeva il reparto di criminalità organizzata, avrebbe avviato una serie di colloqui con l’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, chiedendogli di fungere da intermediario per una trattativa con i boss Totò Riina e Bernardo Provenzano.
Stato e mafia : un difficile compromesso Sarebbe partita così, dunque, una lunga negoziazione fra lo Stato e la mafia. La trattativa avrebbe avuto ad oggetto la cessazione della stagione stragistica in cambio di un “ammorbidimento” delle misure anti-mafia. Fra le richieste di Cosa Nostra ci sarebbe stata, in particolare, quella dell’attenuazione delle misure detentive di cui all’articolo 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario. A seguito della strage di Capaci del 1992, infatti, tale norma era stata modificata con l’aggiunta di un secondo comma che prevedeva “carcere duro” ed isolamento per i detenuti accusati di appartenere ad organizzazioni criminali ed era stata immediatamente applicata ad oltre 400 detenuti mafiosi. Il fine era quello di ostacolare le comunicazioni degli stessi con l’esterno, così da evitare il verificarsi di delitti e garantire la sicurezza e l’ordine pubblico anche fuori dalle carceri. Nel novembre del 1993 a 334 mafiosi ,detenuti secondo il regime dell’art. 41 bis c.p., la normativa non venne più applicata, fatto che viene interpretato dall’accusa come una prova del cedimento da parte dello Stato alle intimidazioni di Cosa Nostra. A detta dell’accusa, la trattativa prosegue anche oltre l’arresto di Totò Riina nel ’93, e vive uno dei suoi momenti più drammatici col fallito attentato dello stadio Olimpico nel novembre dello stesso anno (per cui verranno arrestati i fratelli Graviano). Il processo sulla presunta ‘trattativa Stato-mafia’ diviene di competenza della Corte di Palermo e la prima udienza si tiene il 27 maggio 2013. Gli imputati sono dieci. Quattro capi mafia: Totò Riina, Bernardo Provenzano, Antonino Cinà e Leoluca Bagarella. Un pentito, Giovanni Brusca. Tre ufficiali del Ros: il generale Antonio Subranni, il capitano Giuseppe De Donno, il colonnello Mario Mori. Due politici, l’ex ministro Calogero Mannino e l’ex senatore Marcello Dell’Utri. Il capo di accusa è il concorso nel reato di «violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato» (combinato disposto degli artt. 338 e 110 c.p.). Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste il reato di “trattativa”. Imputati sono anche Massimo Ciancimino, uno dei testi principali dell’accusa, e Nicola Mancino, ministro dell’Interno all’epoca dei fatti e accusato di falsa testimonianza. L’impianto accusatorio si basa sulle testimonianze di Massimo Ciancimino (figlio di Vito Ciancimino) e Giovanni Brusca. Ciancimino ricostruisce tutti gli incontri fra i carabinieri e il padre: secondo i militari solo per ottenere collaborazione nella cattura dei latitanti, secondo l’accusa per mettere in piedi una trattativa a 360 gradi. Brusca, invece, è il primo a parlare del c.d. «Papello», il documento che conterrebbe le dodici richieste avanzate da Cosa Nostra allo Stato in cambio della cessazione delle stragi e ad indicare il Ministro Mancino quale termine ultimo degli accordi. È dubbia, però, l’attendibilità di tali testimonianze. Massimo Ciancimino, infatti, nell’ambito dello stesso processo, risponde dell’imputazione di calunnia per aver falsificato un documento sull’ex capo della polizia Gianni De Gennaro ed i ricordi di Brusca sono “progressivi”, in quanto la sua versione si è man mano evoluta nel corso degli anni e degli interrogatori. Da di Cecilia Colletta 21 maggio 2020 diritto.it
PROCESSO TRATTATIVA STATO-MAFIA: QUELL’ALLARME CHE ARRIVO’ A TEMPO SCADUTO di Lorenzo Baldo ed Aaron Pettinari
Estate 1992. Dopo l’autostrada sventrata a Capaci e la morte di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, e gli agenti di scorta c’è un nuovo allarme attentati. Nel mirino i due magistrati più in vista in quel momento: Paolo Borsellino e Antonio Di Pietro. Lo scrive il Ros in un’informativa riservata redatta il 16 luglio 1992 e trasmessa all’ufficio centrale di Roma, alla Procura di Milano, ed anche a quella di Palermo, per posta ordinaria. Arrivò al palazzo di giustizia soltanto il 22 luglio 1992, tre giorni dopo la strage di via d’Amelio. Il 23 la stessa venne trasmessa agli organi competenti per la sicurezza del magistrato. Una vera beffa di fronte a tutto quello che ormai era avvenuto il 19 luglio. A seguito di quell’informativa a Di Pietro e alla sua famiglia venne rafforzata la scorta, tanto che all’ex pm di Milano in quel periodo non venne consentito nemmeno di dormire nella propria abitazione e nel mese di agosto di quello stesso anno venne persino fatto partire per una trasferta in Costa Rica, con tanto di nome di copertura: Marco Canale.
Come aveva fatto il Ros ad avere notizia su una imminente strage? E’ quello che la Procura di Palermo ha cercato di capire chiamando sul pretorio il teste Vinceno Alonzi, dal ‘92 al ‘96 comandante della sezione Anticrimine del Ros di Milano (oggi generale dei carabinieri in pensione), che all’epoca firmò proprio quella nota trasmessa a Palermo. La figura di una “fonte confidenziale” dei Carabinieri che aveva anticipato – seppur rimanendo inascoltata – l’eccidio di via D’Amelio, resta sullo sfondo. Quello che predomina è l’assoluta mancanza di memoria da parte di un ex ufficiale dell’Arma. Una (ennesima) oscenità in spregio ai fatti di cui si discute a processo. Una testimonianza costellata di “non so”, “non ricordo” e “può essere” che diventa un macabro inno alla burocrazia di fronte al dato di fatto che Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta furono assassinati e che, nonostante le informazioni ricevute, nessuno allertò immediatamente i responsabili della sicurezza del giudice, né informò successivamente la Procura di Caltanissetta che su quell’attentato aveva iniziato ad indagare.
Nel documento di quattro pagine si parla chiaramente di elementi appresi dalla “fonte”, che in aula il teste ha detto di ricordare essere una prostituta, il giorno 15 luglio. Dall’allarme attentato nei confronti di Di Pietro e Borsellino, all’arrivo dal Sudamerica di Gaetano Fidanzati, ai contatti dei Fidanzati con ambienti della politica. Si fa anche riferimento ad altri due soggetti, un certo Pino Reina ed un certo Roberto, che verrebbero indicati con tanto di numeri di telefono. “Non ricordavo tutti questi dettagli – spiega in aula il teste – ricordo che il primo rapporto era di un brigadiere di Cernusco sul Naviglio di Milano era con meno informazioni. Evidentemente integrammo. Però da quello che ricordo fummo convocati in Procura e Di Pietro disse questa cosa del rischio di attentato e sicuramente facemmo gli accertamenti soprattutto sulla situazione di Di Pietro”. Alonzi non ricorda ugualmente di avere parlato telefonicamente con gli allora ufficiali del Ros Mario Mori e Mauro Obinu: “Sicuramente con uno dei due, ma non mi ricordo… Non credo di aver parlato dell’informazione, non era un problema… non ricordo il contenuto della telefonata…”. “Lei ha inoltrato l’informativa alla procura di Milano e di Palermo – insiste il pm Di Matteo – ma qualcuno si è posto il problema di allertare i dispositivi di sicurezza del dott. Borsellino, la sua scorta, la Prefettura?”. “Di questo non so nulla”, risponde laconicamente il teste. Fatto sta che l’informativa viene comunque inviata a Palermo il 16 luglio, ma non arriva in tempo e Borsellino salta in aria. Anche dopo la strage le indagini proseguono ma l’esito finale di tutti gli accertamenti (“Quel Reina non aveva legami con nessun mafioso mentre su Roberto non ricordo”) non viene comunicato a nessuno. Le omissioni investigative del Ros in merito alle indagini su quella “fonte”, prima e dopo la strage di via D’Amelio, denotano la volontà di porre in essere una particolare metodologia. Che, per quanto riguarda lo stesso Borsellino, non ha alcun senso logico. Certo è che un mese prima dell’eccidio del 19 luglio ’92 il giudice Borsellino era stato informato dai Carabinieri di un attentato in preparazione contro di lui da parte di Cosa Nostra.
Nel 2012 era stato il colonnello dei Carabinieri Umberto Sinico a riferirlo in aula durante il processo Mori-Obinu. Sinico aveva raccontato delle confidenze ricevute dal mafioso di Terrasini Girolamo D’Anna, che all’epoca era un loro informatore. “Andammo subito dal magistrato a riferire quanto appreso da D’Anna – aveva dichiarato Sinico – e lui replicò: ‘Lo so, lo so: devo lasciare qualche spiraglio, altrimenti se la prendono con la mia famiglia’. Il Procuratore non voleva coinvolgere in alcun modo la sua famiglia”. “Girolamo D’Anna – aveva quindi specificato Sinico – era in confidenza con il maresciallo che comandava la stazione del paese, Antonino Lombardo”, poi suicidatosi nel marzo del ’95. “A sentire D’Anna, nel carcere di Fossombrone, andammo io – aveva sottolineato l’ufficiale dei Carabinieri – Lombardo e il comandante della compagnia di Carini, Giovanni Baudo, ma Lombardo fu il solo a parlare con D’Anna, che disse dell’esplosivo e dell’idea di attentato. Subito ripartimmo e andammo dal procuratore a riferirglielo e lui ci rispose in quel modo, di saperlo e di dover lasciare qualche spiraglio. ‘Procuratore, risposi io, allora cambiamo mestiere’”. Le parole di Sinico si contrappongono inevitabilmente a quanto riferito oggi in aula da Alonzi. Alla domanda del pm Di Matteo se dopo il 19 luglio il Ros gli avesse chiesto di approfondire le indagini sulla “fonte” che aveva anticipato la realizzazione di quella strage, lo stesso Alonzi arriva a definire l’eccidio “una questione collaterale” per poi concludere: “non ricordo… posso pensare di no perché non era usuale approfondire l’indagine…”. Quindi per il teste “non era usuale”. Nemmeno dopo una strage annunciata? Fonte: Antimafia 2000
TRATTATIVA, GRAVIANO INTERCETTATO IN CARCERE: “BERLUSCA MI HA CHIESTO QUESTA CORTESIA. STRAGI ’93? NON ERA LA MAFIA” La procura di Palermo migliaia di pagine di registrazioni captate nel carcere di Ascoli, durante l’ora di socialità del boss di Brancaccio, ora indagato per la Trattativa. Secondo gli inquirenti le parole del padrino rappresentano un elemento di prova nel procedimento attualmente in corso davanti alla corte d’assise di Palermo. Durante la sua ora di socialità, infatti, il boss parla delle stragi del 1993, del 41 bis, dei dialoghi con le istituzioni. Ma soprattutto parla dell’ex premier Il boss di Brancaccio sembra volere attribuire all’ex premier il ruolo di mandante delle stragi del 1993 di F. Q. | 9 GIUGNO 2017
“Berlusca mi ha chiesto questa cortesia. Per questo è stata l’urgenza” e poi: “Lui voleva scendere, però in quel periodo c’erano i vecchi e lui mi ha detto ci vorrebbe una bella cosa“. E ancora: “Nel ’93 ci sono state altre stragi ma no che era la mafia, loro dicono che era la mafia”. La voce del boss Giuseppe Graviano irrompe nel processo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Ore e ore di intercettazioni in cui il padrino di Brancaccio parla della Trattativa per alleggerire le condizioni carcerarie dei detenuti mafiosi, tirando in ballo direttamente Silvio Berlusconi, al quale sembra sembra voler attribuire il ruolo di mandante delle stragi del 1993. “Lui voleva scendere, però in quel periodo c’erano i vecchi, lui mi ha detto: ci vorrebbe una bella cosa”, dice intercettato nel carcere di Ascoli il 10 aprile del 2016, mentre parla col compagno di ora d’aria, Umberto Adinolfi, camorrista di San Marzano sul Sarno.
Anche Graviano indagato – Trentadue conversazioni, registrate durante le ore di socialità condivise dai due detenuti nel carcere marchigiano tra il marzo 2016 e l’aprile del 2017 che adesso sono finite agli atti del processo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. A depositarle il procuratore aggiunto Vittorio Teresi e i sostituti Nino Di Matteo, Roberto Del Bene e Roberto Tartaglia, che hanno iscritto il nome del boss di Brancaccio nel registro degli indagati con le accuse di minaccia a corpo politico dello Stato in concorso con altri boss. È lo stesso reato contestato ai dieci imputati del processo sulla Trattativa. Secondo gli inquirenti le parole di Graviano rappresentano un elemento di prova nel procedimento attualmente in corso davanti alla corte d’assise di Palermo. Durante la sua ora di socialità, infatti, il boss di Brancaccio parla delle stragi del 1993, del 41 bis, dei dialoghi con le istituzioni. Ma soprattutto parla di una persona, parla di Silvio Berlusconi.
“La cortesia al Berlusca” – “Berlusca mi ha chiesto questa cortesia: per questo c’è stata l’urgenza. Lui voleva scendere… però in quel periodo c’erano i vecchi e lui mi ha detto ci vorrebbe una bella cosa“, dice Graviano: per i pm allude all’intenzione di Berlusconi di entrare in politica già nel 1992. Una frase che sempre gli investigatori interpretano come la necessità di un gesto forte in grado di sovvertire l’ordine del Paese. Come una strage appunto. Impossibile infatti non ricollegare quella “cortesia” fatta con “urgenza” al “colpetto” che secondo il pentito Gaspare Spatuzza si doveva dare per ordine dello stesso Graviano. Il collaboratore ha raccontato di aver incontrato il suo capomafia a Roma il 21 gennaio 1994. “Incontrai Giuseppe Graviano all’interno del bar Doney in via Veneto, a Roma. Graviano era molto felice, come se avesse vinto al Superenalotto, una Lotteria. Poi mi fece il nome di Berlusconi. Io gli chiesi se fosse quello di Canale 5 e lui rispose in maniera affermativa. Aggiunse che in mezzo c’era anche il nostro compaesano Dell’Utri e che che grazie a loro c’eravamo messi il Paese nelle mani. E per Paese intendo l’Italia. Quindi mi spiega che grazie a queste persone di fiducia che avevano portato a buon fine questa situazione, che non erano come quei quattro crasti dei socialisti”.
Il colpetto in via Veneto – A quel punto arriva la richiesta: “Graviano mi dice che l’attentato ai carabinieri si deve fare lo stesso perché gli dobbiamo dare il colpo di grazia“. Il riferimento è all’attentato allo stadio Olimpico contro il pullman dei carabinieri che gestiscono il servizio d’ordine pubblico durante le partite di calcio. Sarebbe stata l’ennesima strage di quel biennio ma fortunatamente alla fine era saltata a causa di un guasto al telecomando collegato all’autobomba. È quella la “cortesia” che Graviano sostiene di avere fatto a Berlusconi? Impossibile dirlo. È un fatto però che nello stesso periodo in cui Graviano incontra Spatuzza a Roma, Marcello Dell’Utri si trova nella capitale a pochi metri dal bar Doney di via Veneto: il 22 gennaio 1994, infatti, era in programma una convention di Forza Italia all’hotel Majestic, sempre in via Veneto e secondo gli accertamenti della Dia l’arrivo di Dell’Utri in albergo è registrato il 18 gennaio. È possibile che Graviano abbia incontrato Dell’Utri negli stessi giorni in cui dava quegli ordini a Spatuzza?
“Silvio traditore: gli faccio fare una mala vecchiaia” – Di sicuro c’è solo che pochi giorni dopo – il 27 gennaio del 1994 – il boss di Brancaccio viene arrestato a Milano. Intercettato in carcere Graviano oggi prova sentimenti di vendetta nei confronti dell’ex cavaliere. “Berlusconi – dice – quando ha iniziato negli anni ’70 ha iniziato con i piedi giusti, mettiamoci la fortuna che si è ritrovato ad essere quello che è. Quando lui si è ritrovato un partito così nel ’94 si è ubriacato e ha detto: Non posso dividere quello che ho con chi mi ha aiutato. Pigliò le distanze e ha fatto il traditore“. Un concetto – quello del tradimento – sul quale Graviano torna più volte. “Venticinque anni mi sono seduto con te, giusto? – dice in un altro passaggio delle intercettazioni – Ti ho portato benessere, 24 anni fa mi è successa una disgrazia, mi arrestano, tu cominci a pugnalarmi, per che cosa? Per i soldi, perché tu ti rimangono i soldi. Dice: non lo faccio uscire più, perché sa che io non parlo, perché sa il mio carattere. Perché tu lo sai che io mi sto facendo, mi sono fatto 24 anni, ho la famiglia distrutta e senza soldi: alle buttane glieli dà i soldi ogni mese. Io ti ho aspettato fino adesso perché ho 54 anni, i giorni passano, gli anni passano, io sto invecchiando e tu mi stai facendo morire in galera“. Quindi il mafioso stragista continua: “Al Signor Crasto (cornuto, ndr) gli faccio fare la mala vecchiaia. Pezzo di crasto che non sei altro, ma vagli a dire com’è che sei al governo, che hai fatto cose vergognose, ingiuste“.
Stragi ’93 non erano mafiose” – Già le cose vergognose. Graviano parla anche di quelle. “Poi nel ’93 ci sono state altre stragi ma no che era la mafia, loro dicono che era la mafia. Allora il governo ha deciso di allentare il 41 bis, poi è la situazione che hanno levato pure i 450″, dice il boss intercettato. Per i pm è un passaggio che dimostra come tra gli oggetti della cosiddetta Trattativa ci fosse l’allentamento del carcere duro: in cambio Cosa nostra avrebbe fatto cessare le stragi. E a questo proposito il boss ricorda il suo soggiorno nel supercarcere di Pianosa. “Pure che stavi morendo dovevi uscire e c’era un cordone, tu dovevi passare nel mezzo e correre. Loro buttavano acqua e sapone”. Una condizione che in passato era stata alleggerita. “Andavano alleggerendo del tutto il 41 bis – dice il boss – Se non succedeva più niente, non ti toccavano, nel ’93 le cose migliorarono tutto di un colpo”.
Non avrebbero resistito a colpo di Stato” –“Graviano commenta anche quanto accaduto la notte del 27 luglio 1993, cioè la notte degli attentati contemporanei al Padiglione di arte contemporanea di Milano e alle basiliche di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro, a Roma. Si temette un golpe anche perché i telefoni di Palazzo Chigi rimasero del tutto isolati per alcune ore. “Quella notte si sono spaventati, un colpo di Stato, il colpo di Stato e Ciampi è andato subito a Palazzo Chigi assieme ai suoi vertici, fanno il colpo di Stato. Loro, loro hanno voluto nemmeno la resistenza, non volevano nemmeno resistere. Avevano deciso già… In quel periodo il 41 bis è stato modificato e 300 di loro…”. Nel novembre del ’93, in effetti, l’allora ministro della Giustizia Giovanni Conso decise di non prorogare il ‘carcere durò per oltre 300 detenuti, quelli indicati dal boss Graviano nella intercettazione con Adinolfi
Ho messo incinta mia moglie al 41 bis” – Ma in carcere il boss parla anche di altro. Si lascia andare a confidenze e persino a vanterie. Come quando sostiene di avere messo incinta la moglie durante la detenzione al carcere duro. Alla donna sarebbe stato permesso di entrare nell’istituto di pena e stare col marito. È lo stesso Graviano a raccontarlo a un compagno di detenzione.”Dormivamo nella cella assieme“, dice Graviano.”Mio figlio è nato nel ’97 – racconta Graviano – ed io nel ’96 ero in mano loro, i Gom (gli agenti di polizia penitenziaria ndr)”. “Ti debbo fare una confidenza – prosegue il boss – prima di nascere il bambino, prima di incontrarmi con mia moglie, siccome una cosa del genere mi era successa in altre occasioni pure, io ho detto: no ci devo provare. Io sapevo che doveva venire la situazione, io tremavo…nascosta poi ad un certo punto … nascosta ni robbi (nascosta nella biancheria ndr) e dormivamo nella cella assieme. Cose da pazzi, tremavo. Quando è uscita incinta mi è finito quel tremolizzo, l’ansia che avevo”. Ufficialmente per la verità il figlio di Graviano sarebbe nato in provetta. Nel 1996 Giuseppe e Filippo Graviano – detenuti al 41 bis già dal 1994 – sarebbero riusciti a fare uscire dal carcere le provette con il proprio liquido seminale, senza alcuna autorizzazione. Le loro mogli, Rosalia e Francesca, partorirono due bambini nati a distanza di un mese l’uno dall’altro. Una versione – quello del figlio in provetta – che viene adesso messa in dubbio da Graviano.
Graviano ai pm: “Non rispondo però vi verrò a cercare”- Il 28 marzo scorso, i pm della procura di Palermo sono andati a interrogare Graviano in carcere per contestargli le parole intercettate durante le due ore di socialità. “Quando sarò in condizioni sarò io stesso a cercarci e a chiarire alcune cose che mi avete detto”, ha detto il boss che si è avvalso della facoltà di non rispondere a causa delle sue “condizioni di salute che oggi non mi consentono di potere sostenere un interrogatorio così importante ed anche a causa del mio stato psicologico derivante dalle condizioni carcerarie che mi trovo costretto a vivere”. “Io – ha detto Gravian o ai pm – sono distrutto psicologicamente e fisicamente con tutte le malattie che ho, perché da 24 anni subisco vessazioni denunciate alle procure e le procure niente. Da quando mi è arrivato questo avviso di garanzia, entrano in stanza, mi mettono tutto sottosopra. I documenti processuali sono strappati. Mi hanno fatto la risonanza magnetica perché mentre cammino perdo l’equilibrio e hanno trovato una patologia che mi porterà a perdere la memoria, sarà tra cinque o dieci anni. Io assumo ogni giorno cinque capsule di antidepressivi, solo di antidepressivi e subisco vessazioni dalla mattina alla sera. Entrano in stanza e mi fanno tre perquisizioni a settimana”.
Ghedini: “Parole destituite di fondamento” – Alle intercettazioni di Graviano replica l’avvocato Niccolò Ghedini, legale dell’ex cavaliere. “Dalle intercettazioni ambientali di Giuseppe Graviano – dice l’avvocato – depositate dalla Procura di Palermo, composte da migliaia di pagine, corrispondenti a centinaia di ore di captazioni, vengono enucleate poche parole decontestualizzate che si riferirebbero asseritamente a Berlusconi. Tale interpretazione è destituita di ogni fondamento non avendo mai avuto alcun contatto il Presidente Berlusconi né diretto né indiretto con il signor Graviano”.
- Trattativa, “Berlusca” o “bravissimo”: ecco l’audio dell’intercettazione del boss Graviano in carcere. Esclusiva Sekret
- Trattativa, al via requisitoria: “Le Istituzioni hanno cercato il dialogo con Cosa nostra. Risultato? Devastante”
- Trattativa, scontro tra consulenti sull’intercettazione di Graviano: “Non ha detto Berlusca ma bravissimo”
IL PATTO SPORCO- PRIMA PARTE, Il Patto Sporco: la sentenza dimenticata
- SECONDA PARTE, Stato-mafia: la sentenza
- TERZA PARTE, Le tappe della Sentenza dimenticata
- QUARTA PARTE,La Sentenza: i Corleonesi
- QUINTA PARTE, La Sentenza: i Collaboratori/1
- SESTA PARTE, La Sentenza: i Collaboratori/2
- SETTIMA PARTE, La Sentenza: i Collaboratori/3
- OTTAVA PARTE, La Sentenza: i Collaboratori/4
- NONA PARTE, La Sentenza: i Collaboratori/5
- DECIMA PARTE, La Sentenza: i Collaboratori/6
- UNDICESIMA PARTE, La Sentenza: i Collaboratori/7
- DODICESIMA PARTE, La Sentenza: i Collaboratori/8
- TREDICESIMA PARTE, La Sentenza: i Collaboratori/9
- QUATTORDICESIMA PARTE, La Sentenza: i Collaboratori/10
- QUINDICESIMA PARTE, La Sentenza: i Collaboratori/11
WORDRD NEWS
- Lettura della SENTENZA – Video
- DOSSIER a cura di Attilio Bolzoni
- Stato-mafia, ecco il papello. Ecco il primo documento sulla trattativa tra le istituzioni e Cosa nostra nell’estate delle stragi. Fogli consegnati ai magistrati dal figlio di Vito Ciancimino di Lirio Abbate
- Portale sulla trattativa Stato-Mafia, su statomafia.it.
- Archivio Wikiwand Patto Stato/mafia
A CURA DI CLAUDIO RAMACCINI -DIRETTORE CENTRO STUDI SOCIALI CONTRO LE MAFIE – PSF