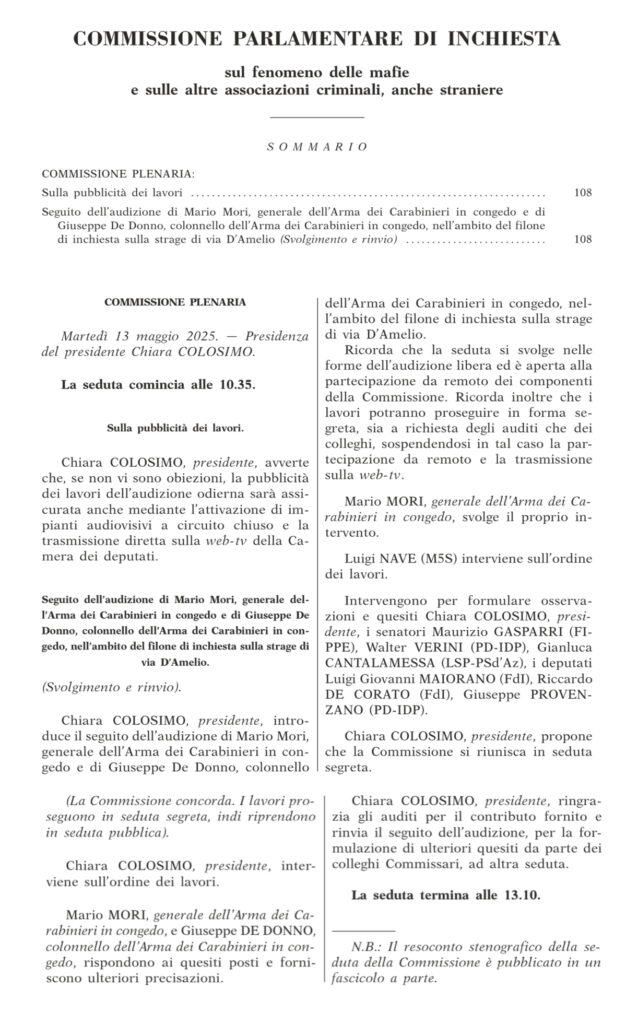VIDEO AUDIZIONE 13 maggio 2025
VIDEO AUDIZIONE 16 aprile 2025
RESOCONTO STENOGRAFICO Seduta n. 80 di Martedì 13 maggio 2025
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHIARA COLOSIMO
La seduta comincia alle 10.35.
Seguito dell’audizione di Mario Mori, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo e di Giuseppe De Donno, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo, nell’ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D’Amelio.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione di Mario Mori, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo e di Giuseppe De Donno, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo, nell’ambito del filone di inchiesta sulla strage di via d’Amelio. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell’audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell’audito o dei colleghi e in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web-tv.
Do la parola al generale Mori per il finale della sua relazione e poi passiamo direttamente alle domande. Prego, generale.
MARIO MORI, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo. Buongiorno a tutti. Mi riallaccio alle dichiarazioni rilasciate dal dottor Giuseppe De Donno nell’audizione del 16 aprile scorso. Pag. 4L’indagine mafia-appalti con i suoi contenuti sostenuti in maniera convinta prima da Giovanni Falcone, poi da Paolo Borsellino, ridefiniva l’approccio investigativo alle indagini sulla gestione degli appalti pubblici, individuando in molti tra politici e imprenditori non già le vittime dell’organizzazione mafiosa bensì dei concorrenti nel loro illecito condizionamento. Già nel giugno del 1990 davanti alla Commissione parlamentare dell’epoca, il dottor Falcone aveva fatto comprendere l’ampia dimensione del fenomeno che interessava l’intera Sicilia e presentava potenziali connessioni a livello nazionale. La partecipazione di personalità politiche emersa durante l’indagine, delineata ma non ancora compiutamente definita nelle dimensioni, apriva nell’inchiesta prospettive delicate, ma ineludibili. La determinata presenza della componente mafiosa manifestatasi in più procedimenti giudiziari connessi alla problematica degli appalti, sviluppati anche fuori dalla Sicilia, consentiva e avrebbe logicamente imposto di tenere unite le varie vicende che emergevano progressivamente nelle indagini. In pratica, per la prima volta in un’inchiesta di questo tipo, avrebbe potuto essere ipotizzato nei confronti di tutti i responsabili accertati il reato di concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso, rendendo quindi più incisiva l’azione di contrasto delle istituzioni. Le annotazioni del ROS fornivano le prime indicazioni su attività e protagonisti di uno spaccato significativo della borghesia siciliana non solo imprenditoriale, ma anche politica, amministrativa e delle professioni. In quel contesto emergevano anche una serie di rapporti, per noi preoccupanti, tra più di un magistrato ed esponenti collegati a personalità e ambienti discutibili, se non proprio criminali. Valgano al riguardo la notoria frequentazione dei due capi delle Procure più importanti della Sicilia, Pietro Giammanco e Gabriele Alicata, con i discussi esponenti politici Mario d’Acquisto e Salvo Lima; la Pag. 5difficile situazione personale del magistrato agrigentino Fabio Salamone a fronte dell’inchiesta che riguardava direttamente il fratello Filippo, uno dei maggiori protagonisti del condizionamento illecito degli appalti pubblici in Sicilia; la parentela del magistrato Francesco Messineo con Sergio Maria Sacco, fratello della moglie – Sacco, più volte indagato per reati di mafia e sempre scagionato, compreso un arresto nell’ambito delle indagini per l’omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, nel 2009, e quindi nel periodo in cui Messineo dirigeva la procura di Palermo, verrà condannato per associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, per aver operato, d’intesa con un gruppo criminale legato al noto esponente mafioso di Partinico, Vito Vitale; la posizione dell’aggiunto della Procura della Repubblica di Palermo, Vittorio Aliquò, la cui cognata, Giulia Gemmato Aliquò, era la più diretta collaboratrice del commercialista palermitano Piero Di Miceli, il professionista che all’epoca tutelava gli interessi mafiosi in tutti i più importanti procedimenti fallimentari tenuti a Palermo; lo stretto e non del tutto lineare rapporto tra il Di Miceli e il dottor Pietro Giammanco, Procuratore della Repubblica di Palermo; l’acquisto nell’anno 1980 a Palermo da parte del dottor Guido Lo Forte, sostituto procuratore cointestatario dell’indagine mafia-appalti di un alloggio dell’Immobiliare Raffaello, gestita da imprenditori notoriamente legati ad ambienti mafiosi; altri appartamenti nello stesso periodo, sempre da parte dell’Immobiliare Raffaello, erano stati venduti ai familiari del dottor Giuseppe Pignatone, anch’egli cointestatario dell’indagine del ROS sugli appalti; il conflitto di interessi prospettatosi al dottor Giuseppe Pignatone, coassegnatario dell’altra indagine del ROS sulla società SIRAP, che coinvolgeva anche l’attività del padre Francesco; le accuse, successivamente giudicate infondate, rivolte dai collaboratori di giustizia Giovanni Drago e Gaspare Pag. 6Mutolo ai magistrati Giuseppe Prinzivalli, all’epoca Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, Pasquale Barreca, Francesco d’Antoni e Domenico Mollica presidenti di Corte d’assise d’appello palermitani e Carlo Aiello, consigliere di Corte di cassazione, indicati come responsabili di aver aggiustato una serie di processi di mafia; il suicidio del dottor Domenico Signorino, pubblico ministero del maxiprocesso a Cosa nostra, avvenuto in coincidenza con le accuse di collusione con ambienti mafiosi, a lui rivolte dai pentiti Drago e Mutolo.
Le archiviazioni proposte e ottenute dalla Procura di Palermo in merito alla nostra inchiesta che seguivano mancate deleghe di indagine, a cominciare da quelle delle annotazioni dell’agosto del 1990, coinvolgenti alcune personalità politiche, dimostravano che l’iniziativa non aveva ottenuto la considerazione che, anche per le sue potenziali prospettive, noi carabinieri ritenevamo meritasse e che il chiaro interesse mostrato da Giovanni Falcone e poi da Paolo Borsellino avrebbero almeno consigliato. Questo non fu solo il nostro giudizio, ma anche quello di Giovanni Falcone, appunto, che in più occasioni e, in particolare, dopo i pochi arresti del luglio 1991, aveva commentato con grande delusione gli sviluppi dell’inchiesta confidando alla giornalista Liana Milella che riteneva riduttiva la scelta di arrestare solo certe persone e che non si volevano sviluppi di alcun genere nei confronti dei politici. Le iniziative assunte da parte dei requirenti incaricati della trattazione delle indagini sugli appalti, sono state quindi un prodotto di un approccio parziale che, oltre a indebolirne l’intrinseca potenzialità, ne ha danneggiato lo sviluppo. Valgano al riguardo la consegna senza omissis già nel luglio del 1991 alle difese degli indagati dell’annotazione base dell’indagine mafia-appalti, a cui ha fatto seguito il 14 agosto 1992 la parziale archiviazione relativa a molti soggetti indicati nella annotazione del 16 Pag. 7febbraio 1991. Tutto ciò, mentre, sempre nel luglio 1991, il procuratore Giammanco, dopo aver suddiviso l’indagine attivando altri uffici giudiziari siciliani, realizzandone così una scontata dequalificazione sotto l’aspetto del reato associativo, con un atto illecito volto a svalutarla completamente, aveva inviato l’annotazione base del ROS al Ministro della giustizia, tentando di farla passare come un’informativa di natura politica, senza poi tenere conto, come si seppe poi in tempi successivi, che già dopo pochi giorni dalla sua consegna, grazie sempre al Procuratore Giammanco, l’annotazione del ROS era in mano a Cosa nostra.
L’insieme delle attività che poi prenderà la denominazione giornalistica di dossier mafia-appalti, ha rappresentato obiettivamente per me e per Giuseppe De Donno una serie di brucianti sconfitte. Infatti, più volte, nel corso dell’attività sviluppata in Sicilia, ci è stata chiusa «la porta in faccia», come si dice, costringendoci ogni volta a ricominciare da capo, fino a obbligarci a desistere. Mi riferisco precisamente: all’estromissione dell’attività d’indagine del dottor Alberto Di Pisa che, trascinato in uno scandalo da cui solo dopo parecchi mesi sarà giudicato del tutto estraneo, fu costretto ad abbandonare l’inchiesta condotta da noi carabinieri su di un comitato d’affari, riconducibile a Vito Ciancimino, che avrebbe dovuto interessare anche l’allora sindaco di Palermo, Leoluca Orlando; al voltafaccia del professor Giuseppe Giaccone, sindaco di Baucina, che, dopo aver rivelato a Giovanni Falcone come veniva alterato il sistema degli appalti in Sicilia, affidato per legge alla protezione dell’Alto commissario antimafia, si pentì di essersi pentito; alla mancata possibilità di sviluppare a livello regionale e nazionale i contenuti delle nostre informative preliminari del luglio-agosto 1990, riguardanti le attività di personalità politiche, non essendoci mai state concesse deleghe di indagine al Pag. 8riguardo; alla tragica morte del dottor Paolo Borsellino che, oltre alla sua vita e a quella della scorta, stroncò anche le possibilità di collegare la nostra inchiesta a quella milanese «Mani pulite», possibilità che avrebbe potuto segnare, all’esito, non solo un fondamentale momento di contrasto a un sistema illecito che drenava rilevanti risorse pubbliche, ma anche una rigenerazione dell’intero sistema economico nazionale; all’archiviazione di una parte significativa della nostra indagine, a 25 giorni dalla morte di Paolo Borsellino, che la stava sostenendo, decisa dal GIP Sergio La Commare, dando anche l’impressione di essere stata non casualmente depositata il 14 agosto 1992, in un periodo cioè di scontato disinteresse per qualsiasi attività che non fosse quella dello svago e del riposo, così da farla passare, come avvenne, sotto un pressoché tombale silenzio; alla decisione tranciante, assunta dal dottor Gabriele Alicata, Procuratore della Repubblica di Catania, a cui si deve la disarticolazione dell’inchiesta che il dottor Felice Lima e il capitano De Donno avevano impostato sulle dichiarazioni del geometra Li Pera, depotenziando e alla fine rendendola carente sotto l’aspetto del reato associativo con il suo smembramento tra le procure di Caltanissetta, Catania e Palermo; all’omesso collegamento di tale inchiesta di Massa Carrara con la nostra su mafia-appalti che avrebbe imposto di dare comunque una dimensione nazionale all’azione di contrasto al fenomeno dell’illecito nella concessione degli appalti pubblici; all’impedita possibilità per i carabinieri del ROS di potere partecipare alle indagini connesse alla formale collaborazione di Angelo Siino, malgrado le iniziali e lunghe indagini svolte dal Reparto sull’imprenditore; al rifiuto opposto a Vito Calogero Ciancimino di esporre la sua versione sul condizionamento degli appalti pubblici, fornito cioè da chi quel sistema, che coinvolgeva anche Pag. 9politica e imprenditoria, aveva gestito in prima persona e per lungo tempo.
In questo contesto poi si è verificato addirittura l’impensabile, cioè che l’annotazione del ROS, depositata nel febbraio 1991, quasi nell’immediatezza, e prima ancora delle conclusioni delle attività proprie della polizia giudiziaria, secondo le dichiarazioni di alcuni pentiti mai smentite, era stata consegnata a Cosa nostra dal titolare dell’indagine, cioè il Procuratore della Repubblica di Palermo in carica, tramite due personalità politiche, gli onorevoli Mario d’Acquisto, già vicepresidente della Camera dei deputati e presidente della Regione Siciliana, e Salvo Lima, parlamentare nazionale poi europeo. In tal modo, già nella primavera del 1991, Cosa nostra poteva definire le sue contromisure: valgano soprattutto, ma non solo, le stragi di Capaci e di via d’Amelio. Gli atti attribuiti in particolare a Pietro Giammanco, se posti in essere da un qualsiasi cittadino italiano, appena conosciuti, avrebbero comportato l’immediata emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per concorso aggravato in associazione per delinquere di tipo mafioso. Invece, nessun ufficio requirente o singolo magistrato ha sentito all’epoca obbligo morale, prima che professionale, di denunciare pubblicamente i fatti, così da chiarire in particolare gli aspetti che investivano il mondo politico e giudiziario e che, se adeguatamente sviluppati, avrebbero forse potuto dare una più ampia portata alle indagini sulle vicende connesse alle stragi del 1992-1993 che ancora oggi presentano vuoti conoscitivi.
Respinti in Sicilia, riproponemmo la stessa tecnica di indagine sul condizionamento degli appalti, in Campania e in Calabria, ottenendo qui significativi risultati, frutto della piena collaborazione con i magistrati delle due procure della Repubblica interessate e malgrado che, anche in queste vicende, oltre che esponenti della criminalità organizzata e dell’imprenditoria,Pag. 10fossero protagonisti personalità politiche. Gli esiti di queste inchieste hanno dimostrato quindi che anche in Sicilia potevano ottenersi risultati migliori se vi fosse stata collaborazione tra magistrati requirenti e investigatori. Si ha un bel dire, come sostengono anche alcuni componenti di questa Commissione, che, successivamente, le vicende a base dell’inchiesta mafia-appalti vennero riprese e trattate. Questo è vero, ma ciò è avvenuto in una fase successiva a quella connotata dalla presenza e dall’attività di Paolo Borsellino e dell’azione investigativa del ROS, che non fu più sollecitata una volta ripresa l’inchiesta. I detrattori della nostra attività omettono infatti di precisare che, con il deposito dell’informativa SIRAP del settembre 1992, cessò praticamente il rapporto di collaborazione tra la Procura di Palermo e il ROS, e non per volontà dei carabinieri. In tal modo, si evita di dover spiegare le diverse inadeguatezze da noi lamentate che hanno caratterizzato le attività di alcuni magistrati siciliani nel periodo in cui il ROS era realmente operativo nell’isola. Peraltro, i requirenti palermitani, anche in successione di tempo, hanno agito sempre in modo settoriale e con un approccio angusto rispetto all’indagine, perdendo di vista quella strategia complessiva che l’indirizzo prefigurato da Giovanni Falcone e le iniziative di Paolo Borsellino – volte a rivitalizzare mafia-appalti e a stabilire intese con Antonio Di Pietro, che conduceva «Mani pulite» – uniti ai primi esiti di altre inchieste, consentivano. Si sarebbe dovuto considerare infatti nello stesso contesto investigativo la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara e quella sugli appalti nel comune di Pantelleria, inviata proprio dal procuratore Borsellino, che avrebbero dato una dimensione più ampia all’azione di contrasto, ma ciò non è avvenuto. L’impatto sul problema del condizionamento criminale degli appalti è stato inferiore a quanto potenzialmente Pag. 11ottenibile e comunque insufficiente per stroncare il fenomeno. Sempre in merito all’assunto che le vicende alla base dell’inchiesta mafia-appalti vengono riprese e trattate dopo la morte del dottor Borsellino, faccio osservare la circostanza che fu la Procura di Catania a trasmettere a Palermo nell’estate del 1992 una parte della propria indagine sulle dichiarazioni del geometra Li Pera e, come accennato, vi fu l’accordo per la ripartizione sulle competenze tra la procura di Milano e quella di Palermo. Un fatto è archiviare un’indagine scaturita da un’indagine di polizia giudiziaria, altro è assumere la stessa decisione quando l’indagine è in materia di collegamento con altre autorità giudiziarie.
Sul finire del secolo scorso le personalità migliori della magistratura requirente nazionale avevano compreso che il fenomeno della criminalità organizzata, per le dimensioni raggiunte e per le sue dirette implicazioni sul sistema economico nazionale, non poteva essere più combattuto con le normali, ma ormai inadeguate prassi giudiziarie applicate sino ad allora, bensì con un salto di qualità che ne considerasse la più ampia dimensione raggiunta. Si può ritenere che le decisioni assunte nel periodo 1989-1992 in Sicilia, siano state il frutto di un approccio che prescindeva dalla volontà di favorire l’organizzazione mafiosa, ma le azioni del Procuratore Giammanco e di qualche altro magistrato diede allora a noi carabinieri l’impressione che dietro la loro decisione ci fosse un disegno preciso, almeno quello cioè di tutelare ambiente e persone collocati in posizione di alto prestigio politico e sociale, perché, in quell’ambito, le indagini non vengono certamente condotte con la dovuta determinazione. Al riguardo faccio due nomi a puro titolo esemplificativo. Filippo Salamone, parente di un magistrato in servizio in Sicilia, e Pietro Catti De Gasperi, parente di un uomo politico che ha connotato un periodo della Pag. 12nostra storia. In quella fase, era proprio l’estensione dell’indagine che si voleva evitare. Così la pensava peraltro, come già ricordato, anche Giovanni Falcone. Si vedano al proposito i suoi appunti, i cosiddetti diari, e contro questa soluzione si stava adoperando con tutte le sue forze, Paolo Borsellino. L’incomprensibile e ingiustificabile dimenticanza, malgrado l’ampio margine di tempo disponibile, di interrogare sui fatti connessi alla morte di Paolo Borsellino il dottor Pietro Giammanco, l’uomo che aveva consegnato l’annotazione di base del ROS a Cosa nostra, pesa poi su queste vicende come un macigno che nessuno dei vari magistrati, coinvolti in quel complesso di indagini, a tutt’oggi ha voluto affrontare e spiegare in maniera adeguata. E non si venga a dire che il documento degli otto magistrati che, dopo la strage di via d’Amelio a minacciare le dimissioni, fu una prestigiosa denuncia contro l’operato del Procuratore, perché, in quella circostanza, costoro trattarono quasi esclusivamente problemi di sicurezza, limitandosi a chiedere l’invio in Procura di una personalità più forte, senza mettere però mai in dubbio la correttezza professionale o evidenziare gli ostacoli posti all’attività di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, ma anche di noi carabinieri, da parte di Pietro Giammanco. I malintesi e gli attriti sorti in quella circostanza per un lungo lasso di tempo hanno reso poi difficile, se non del tutto improduttivo, il rapporto tra le Procure siciliane più importanti e il ROS che, al di là dell’essere il Reparto a cui l’Arma affidava la competenza investigativa nazionale nel settore della criminalità organizzata, aveva svolto le indagini e redatto le prime informative sul condizionamento degli appalti pubblici, rappresentando già all’epoca, per i risultati conseguiti sul terreno, se non la migliore, certo una delle più efficaci espressione operative dello Stato nell’azione di contrasto alle forme criminali più evolute. Il danno alla complessiva azione Pag. 13repressiva portata avanti dalle istituzioni veniva accentuato anche, nella fase più grave dell’attacco mafioso allo Stato, dalle prese di posizione di alcuni magistrati, esplicitata con atteggiamenti emotivamente ben sopra le righe, se è vero che, nell’immediatezza della strage di via d’Amelio, dalla scalinata del tribunale di Palermo, uno dei più noti tra loro, il sostituto procuratore Vittorio Teresi, a nome dei colleghi e ripreso dalla stampa nazionale e dalle televisioni, aveva addirittura proposto pubblicamente di chiudere il tribunale per cinque anni – affermazione che oggettivamente costitutiva una chiara resa a Cosa nostra. Un magistrato, se consapevole delle sue attribuzioni e del ruolo ricoperto, non poteva dare un esempio così platealmente negativo non solo a chi nelle istituzioni continuava a operare con impegno e senza tentennamenti, ma soprattutto alla pubblica opinione, già di per sé intimorita e preoccupata, com’era in quei giorni quella dell’intera Nazione e della Sicilia in particolare. Anche il dottor Caponnetto, uscendo dalla camera ardente di Paolo Borsellino, esclamò «È finita!», volendo significare che, con quella morte, il contrasto a Cosa nostra subiva a suo parere un colpo decisivo, ma successivamente, con parole umanissime, se ne scusò, definendo quell’espressione un cedimento momentaneo, frutto del fortissimo dolore provato dalla circostanza. Altri invece non hanno ritenuto di dover fornire qualche spiegazione alle loro esternazioni.
Con la nostra assistenza professionale abbiamo suscitato la disapprovazione di alcuni magistrati di Palermo che hanno ritenuto, testuale, «ipertrofica» la nostra attività di polizia giudiziaria. Anche la Corte d’assise d’appello di Palermo, pur assolvendoci, ha giudicato improvvida per alcuni aspetti la nostra azione investigativa. Qualche altro magistrato palermitano, infine, con un’espressione che ne denota solo la personale meschinità, considerando la mia complessiva vicenda professionale,Pag. 14mi ha attribuito una matrice genetica «strana» – beato lui! Quindi, secondo questa valutazione, a fronte di una Procura della Repubblica che si mostrava decisamente attendista, se non addirittura remissiva verso Cosa nostra e comunque contraria anche alle iniziative dei suoi uomini migliori – vedasi il contrasto all’azione prima di Giovanni Falcone e poi di Paolo Borsellino – avremmo dovuto operare con maggiore prudenza, adeguandoci cioè a quei rituali investigativi legati a tanti lutti e a tanti insuccessi. Noi, invece, come il dovere ci imponeva, tentammo di fare qualcosa che migliorasse l’efficienza della nostra azione, avvertendo peraltro, delle attività messe in atto, ben individuate personalità istituzionali e cioè: Liliana Ferraro, direttore dell’Ufficio affari penali del ministero della Giustizia, Fernanda Contri, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e Luciano Violante, presidente della Commissione parlamentare antimafia, oltre ovviamente ai nostri superiori gerarchici. Tutti costoro se avessero ritenuto che fossimo stati partecipi di chissà quale progetto illecito ovvero portatori di un messaggio indebito, avrebbero avuto la possibilità, anzi il dovere, di fermarci e di denunciarci, ma ciò non è avvenuto e tuttavia nessuno li ha chiamati a rispondere insieme a noi. Invece, nella mia competenza di responsabile di un Reparto di polizia giudiziaria, mi astenni di proposito dall’informare la Procura di Palermo sino a quando, nel gennaio 1993, non venne cambiata la direzione dell’ufficio e questo perché diffidavo del Procuratore Giammanco e di qualche altro magistrato.
In conseguenza della mia azione di comando, sono stato sottoposto a tre procedimenti penali. Imputato, in separati giudizi, con il mio superiore gerarchico e con tre diversi ufficiali dipendenti, chiamati in causa per vicende giudiziarie tra loro artificiosamente divise, fatti cioè oggetto di accuse formalmente distinte, ma sostanzialmente tutte riconducibili allo stesso contestoPag. 15operativo, se è vero che, oltre ai nostri difensori, anche illustri giuristi, quali Giovanni Fiandaca e Tullio Padovani, hanno sostenuto la tesi che, nella successione dei processi, fosse stato violato il principio rappresentato dal ne bis in idem, a significare cioè che i procedimenti erano legati non solo da un filo investigativo unico, ma anche da una precisa correlazione giuridica. Appare comprensibile che indagini di grande impegno, sia pure condotte da investigatori e magistrati professionalmente preparati, possano presentare aspetti che a una disamina accurata, fatta però con conoscenza ottenuta a posteriori, evidenziano qualche lacuna o superficialità. A noi, dagli esponenti della Procura della Repubblica di Palermo dell’epoca e da qualche giudice di quel tribunale, non ne è stata perdonata nemmeno una. Ad altri, loro colleghi compresi, molte. Il più emblematico dei processi subiti è il procedimento giornalisticamente denominato «Trattativa Stato-mafia», quello cioè che Antonio Subranni, Giuseppe De Donno e io abbiamo affrontato con l’accusa di avere minacciato il Governo della Nazione, noi che, come ufficiali dell’Arma dei carabinieri, avevamo il preciso dovere di tutelare e, a favore di non si sa chi, lo avremmo fatto d’intesa con Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella, contro i quali abbiamo condotto una parte significativa della nostra vita professionale. Il procedimento, iniziato il 7 marzo 2013, con rinvio a giudizio per violenza aggravata a corpo politico, amministrativo e giudiziario, cioè, nella fattispecie, al Governo nazionale, è terminato dieci anni dopo, il 27 aprile 2023, con la nostra assoluzione per non aver commesso il fatto. L’esito dei processi, però, non ha ancora convinto in tutti i nostri instancabili critici, a cominciare dal dottor Antonino Di Matteo che, malgrado sia in atto componente della Procura nazionale antimafia e già rappresentante dell’accusa nel processo sulla cosiddetta «Trattativa Stato-mafia», ha scritto un libro, intitolato «Il colpo di spugna», per criticare, a mio avviso ben al di là del limite consentito alla deontologia di un magistrato in servizio, non tanto le nostre azioni, quanto e soprattutto, la decisione presa dalla Corte di cassazione. Il supremo organismo giudiziario viene accusato in pratica di aver obbedito all’ordine di assolverci perché il Paese non era ancora in grado di conoscere l’effettiva verità. In base alla tesi sostenuta dal dottor Di Matteo, vi sarebbe l’esigenza di procedere contro gli esecutori di questa serie di gravi reati da lui individuati. Tuttavia il magistrato non ha ancora indicato agli organi competenti né di quali elementi eventualmente disponga, né i nomi dei responsabili del condizionamento dei giudici della Corte di cassazione ai quali comunque sarebbe già attribuibile, allo stato, il grave illecito di essersi fatti condizionare indebitamente. Il tutto, almeno a mia conoscenza, senza che il Consiglio superiore della magistratura abbia sin qui ritenuto di prendere decisioni in merito.
La conferma di una critica incondizionata, costantemente espressa in certi ambienti, rivolta più che alle nostre persone, a un indirizzo professionale che prescinde da costruzioni o ricostruzioni imposte da una linea di condotta predefinita, è costituita da molti esempi. Per brevità, qui tratterò solo, fra le tante accuse ricevute, le opinioni sostenute dall’avvocato Fabio Repici, perché espresse anche in sede di questa Commissione. Il legale dell’ingegner Salvatore Borsellino, quindi un professionista qualificato, ha esposto le sue tesi che, per quanto attiene ai fatti che hanno riguardato me e il dottor Giuseppe De Donno, alla luce degli esiti già processualmente definiti, sono del tutto prive di fondamento. Egli sostiene che la morte di Paolo Borsellino non derivi dal suo interesse per mafia-appalti, giudicato un falso scopo inventato da noi per coprire le nostre responsabilità. Infatti, citando il tenente colonnello Carmelo Pag. 17Canale, Repici afferma che, nel colloquio del 25 giugno 1992 tra noi e Paolo Borsellino, non si parlò dell’indagine del ROS bensì di un anonimo di cui il magistrato sospettava che il capitano De Donno fosse l’autore. Premesso che la sentenza del Borsellino quater, quindi non noi carabinieri, ha attribuito la causa più attendibile della morte del magistrato al suo manifesto interesse per l’inchiesta del ROS, osserva che Carmelo Canale ha sempre sostenuto che il tema dell’incontro alla caserma Carini era relativo al dossier mafia-appalti. L’ufficiale, davanti a questa Commissione, ha riferito che il dottor Borsellino era a conoscenza di voci, pervenutegli da alcuni colleghi, che indicavano il capitale De Donno, quale possibile autore dell’anonimo inviato al sostituto procuratore di Catania, Felice Lima, per togliere la competenza dell’indagine mafia-appalti alla procura di Palermo. Infatti quel pomeriggio, appena il magistrato Borsellino vide l’ufficiale, esclamò, testuale: «Ho sentito parlare molto male di lei, ma se si fidava Falcone, mi posso fidare anch’io». Subito dopo, ottenuta la nostra disponibilità a proseguire l’indagine mafia-appalti, ne concordò con noi i tempi e le modalità di sviluppo. D’altro canto, non si capirebbe perché, avendo dei sospetti, il dottor Borsellino – quindi non uno sprovveduto uditore giudiziario – invece di convocare formalmente il capitano De Donno nel suo ufficio, decise di recarsi in tutta riservatezza in una caserma dei carabinieri, senza redigere un atto formale che facesse poi fede della sua iniziativa. L’avvocato Repici riprende poi precise e ripetute accuse che alcuni magistrati ci rivolgono per l’addebito nei nostri confronti di un atteggiamento omertoso per l’ingiustificabile e sospetto ritardo con cui avremmo parlato dell’incontro con il dottor Paolo Borsellino. In tutte le vicende che hanno riguardato i censori del nostro operato, nelle ricostruzioni dei fatti, quando non conviene, costoro tralasciano quei singoli aspetti contrastantiPag. 18con le versioni da loro sostenute che, senza qualche omissione o qualche invenzione, non starebbero in piedi. Nella fattispecie, l’avvocato Repici, che pure ha partecipato con incarichi professionali alla serie dei processi relativi alla strage di via d’Amelio, dimostra di ignorare il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese nel dicembre del 1992 dall’allora capitano Giuseppe De Donno nel quadro delle indagini svolte in merito dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. L’ufficiale, in quella circostanza, riferì ai magistrati requirenti sui contenuti dell’incontro che il precedente il 25 giugno 1992, insieme a me, aveva avuto con il dottor Paolo Borsellino. Anche e soprattutto quei magistrati che si sono distinti per le accuse rivolteci sul nostro ingiustificabile ritardo nel riferire, non hanno mai citato questo episodio che pure, stante il loro andirivieni professionale tra gli uffici giudiziari di Palermo e di Caltanissetta che ne ha contraddistinto le loro splendide carriere, non sarebbe dovuto sfuggire loro. Altri invece sono coloro che hanno parlato a distanza di troppo tempo dei loro contatti con Paolo Borsellino: i magistrati Alessandra Camassa e Massimo Russo erano sostituti procuratori della Repubblica in servizio alla Procura della Repubblica di Marsala quando il dottor Borsellino riferì loro – siamo nella metà di giugno del 1992 – che un amico lo aveva tradito e che la Procura di Palermo era un nido di vipere. E questa sì, a tutti gli effetti, dopo la tragica e quasi immediata morte di chi aveva pronunciato quelle parole, era una vera e propria notitia criminis che doveva essere portata subito a conoscenza degli inquirenti. Ebbene, i due magistrati, cioè non due persone giuridicamente digiune, almeno per quanto mi consta, tardarono sino al 14 e 15 luglio 2009, cioè 17 anni, a riferire formalmente ai pubblici ministeri di Caltanissetta e solo nell’anno 2012 lo fecero in sede di testimonianza processuale. Nessuno, in questo lungo periodo Pag. 19di tempo, a cominciare dall’avvocato Repici e dai loro celebrati colleghi, li ha mai accusati, a mia conoscenza, di ritardi ingiustificati o addirittura omertosi, forse perché, in questo caso, indagare sul nido di vipere insediato nella Procura di Palermo sarebbe risultato oltremodo scomodo per molti.
Di questi giorni è la sentenza della Cassazione che manda assolto il noto mafioso Antonino Madonia dall’accusa di essere l’autore dell’omicidio dell’appartenente alla polizia di Stato Antonino Agostino e della sua moglie. Il Madonia, malgrado il parere contrario della stessa procura di Palermo, che non aveva ravvisato nei fatti acquisiti elementi sufficienti per sostenere l’accusa, era stato rinviato a giudizio su iniziativa del Procuratore generale, Roberto Scarpinato, che aveva riaperto il caso sulla base di un esposto presentato proprio dall’avvocato Repici. In merito, la motivazione della sentenza di archiviazione da parte della Cassazione appare emblematica, sostenendo che la tenuta logica di una decisione non dipende dalla capacità di costruire una narrazione suggestiva, ma dalla corretta applicazione delle regole processuali.
In definitiva, in tutta la complessa vicenda che ci ha riguardato, se una critica istituzionalmente è stata fatta, questa è stata rivolta ai pubblici ministeri e ai giudici di primo e secondo grado nel nostro processo a cui la sentenza della VI sezione penale della Corte di cassazione ha attribuito un modello di ricostruzione del fatto penalmente rilevante condotto secondo un approccio metodologico di stampo storiografico. Il processo penale non è un laboratorio per l’esposizione di ardita ricostruzione di storicistiche o personali visioni del mondo, mentre le argomentazioni accusatorie che avevano condannato in primo grado me e i miei colleghi nel procedimento della cosiddetta trattativa non prospettavano nulla che si riferisse a un puntuale accertamento processuale, ma erano state assunte e sviluppate
da alcuni magistrati essenzialmente sulla base di esclusive interpretazioni di natura non giuridica, bensì ideologica. Una posizione questa che, nell’elaborazione del recente anno, giudiziario, il dottor Luigi Salvato, Procuratore generale della Cassazione, ha riassunto nella definizione di populismo giudiziario.
A questo punto, seguendo una diffusa tendenza nazionale, dovrei lamentarmi per la lunga azione persecutoria rivolta contro di me, ma io rifiuto questa rappresentazione vittimistica. In questi anni, con il sostegno della mia difesa e l’appoggio di alcuni colleghi, ho inteso replicare in tutte le sedi consentite e con tutti i mezzi leciti di cui potevo disporre alle accuse rivoltemi dai depositari di un modo di fare politica, giustizia e informazione che ritengo arrogante e iniquo perché arbitrario e in più circostanze ho espresso loro apertamente la mia totale disistima che anche oggi, in questa sede, ribadisco. L’ho inteso fare anche per i tanti che non avevano il vissuto professionale, le possibilità economiche, la documentazione, il tempo e l’ampio sostegno di cui invece io ho goduto e che quindi hanno dovuto subire, senza potere replicare, come minimo una forte e immeritata esposizione mediatica, se non, ed è peggio, gravi danni morali e materiali, uniti anche a un ingiusto discredito pubblico esteso anche ai propri familiari. Proprio da appartenente alle istituzioni dello Stato, se ritengo doveroso che verso ogni cittadino, anzi, a maggior ragione, per gli operatori in campo giudiziario, siano eseguiti i più ampi accertamenti per fatti conseguenti alla loro attività professionale, a questo punto chiedo che, per le vicende qui descritte, questo tipo di approccio sia riservato veramente a tutti coloro che hanno avuto parte. Nell’istituzione a cui ho appartenuto, per ogni dipendente oggetto di un procedimento giudiziario, al di là del relativo esito, fa seguito invariabilmente una valutazione di tipo disciplinarePag. 21volta a stabilire se, oltre a eventuali illeciti penali nell’attività svolta, emergano mancanze di natura etica o di condotta. Come è avvenuto da parte dell’Arma dei carabinieri, per tutti gli ufficiali coinvolti in queste vicende, ritengo che analogamente il Consiglio superiore della magistratura e l’Ordine nazionale dei giornalisti per queste vicende dovrebbero considerare il comportamento di alcuni dei loro appartenenti o ex appartenenti. Il mondo politico, se non altro, questo esame lo affronta periodicamente attraverso l’andamento del consenso popolare e infatti il suo ricambio si è realizzato nel tempo non solo per ragioni di età.
Questa valutazione sarebbe auspicabile in particolare per alcuni tra politici, magistrati, personalità della cultura e giornalisti, protagonisti ovvero testimoni delle tragiche vicende connesse ai fatti di Sicilia qui esaminati che oggi vanno sostenendo la loro piena conoscenza dei rapporti malati fra politica e Istituzioni di quell’epoca, analizzando criticamente insufficienze, errori e conseguenti colpe. Si veda per ultima la serie RAI, intitolata «La linea della palma» che ne ha rappresentato una significativa selezione. Bene, in buona parte si può concordare con le censure espresse, ma questi severi critici, nelle analisi di quel contesto, si ricordano solo ora di indicare alcune situazioni negative e determinati personaggi da condannare. Dico allora che costoro oggi sono del tutto fuori tempo e mi permetto di sostenere che alcuni di loro sono in malafede perché, in quei momenti, ufficialmente non hanno mosso un dito o alzato una parola o una voce per contrastare e denunciare efficacemente quelle azioni criminali di cui adesso trattano con distacco e presunzione, fino a stabilire condanne e a elaborare teorie buttate lì, senza prove, e che in alcuni casi appaiono addirittura prospettazioni farsesche. Forse in quel modo alcuni cercano di scalzare qualche responsabilità personale,Pag. 22altri invece tentano di conseguire nuovi utili professionali. Così agendo, potranno convincere qualche ascoltatore distratto o compiacente, ma non eviteranno la disistima di chi in quei giorni era presente e quindi conosce i fatti nei loro rispettivi sviluppi.
In conclusione, se il progressivo allontanarsi degli avvenimenti rende per queste vicende sempre più difficile l’accertamento della verità sul piano giudiziario, auspico almeno che questa ricerca venga condotta sotto l’aspetto di una coerente ricostruzione dei fatti, con una serena e distaccata disamina delle responsabilità. Questo lo si deve al concetto di Stato di diritto, a coloro che hanno pagato con la vita il proprio impegno nelle Istituzioni, ai loro familiari che pretendono giustamente una spiegazione accettabile dei fatti, ma anche chi, sopravvissuto, merita che si giunga a una verità almeno logica su una pagina tragica della nostra storia nazionale. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie mille, generale Mori. La parola al senatore Nave.
LUIGI NAVE. La ringrazio presidente. Ho chiesto di intervenire perché in realtà noi come gruppo del Movimento 5 Stelle, avendo letto la relazione rilasciata dal generale Mori e dal colonnello De Donno, abbiamo riscontrato delle inesattezze e falsità e quindi con atti alla mano e documenti alla mano abbiamo deciso…la prego, presidente, mi faccia completare poi ognuno farà le sue affermazioni.
PRESIDENTE. Fate concludere il collega.
LUIGI NAVE. Per questione di tempo questa mattina abbiamo consegnato una relazione che punto per punto, con documenti alla mano, certifica la falsità e addirittura la mistificazione di alcune affermazioni. Ritengo presidente – la prego Pag. 23di farmi completare – che queste affermazioni sono gravi perché non fanno altro che aumentare la densità, quella coltre di fumo che già di per sé avvolge le stragi di via d’Amelio e quelle del 1993-1994. Mi ritengo oggi oltremodo indignato per quanto è stato detto. Ritengo che i colleghi possano prendere atto e formulare domande sulla base di una formulazione più corretta e sana, ma questo ritengo sia a beneficio di tutti, nessuno ha detto che si tratti di verità infusa, si può leggere e confutare così come abbiamo fatto noi. Chiedo, presidente, che la seduta venga sospesa prima delle domande e rimandarla anche a questa sera o a domani, così come chiedo che il generale Mori e il colonnello De Donno vengano auditi successivamente perché devono rispondere delle affermazioni fatte, proprio in virtù della documentazione che è stata presentata. Grazie, presidente.
PRESIDENTE. Senatore Nave, rispondo molto volentieri sia nel merito sia nel metodo. O meglio, nel merito mi sarebbe piaciuto rispondere potendo leggere quello che voi avete prodotto alle 10,05 di questa mattina e quindi non permettendo a nessuno di averne accesso. Mi faccia finire, senatore Nave, mi pare di non averla interrotta, anzi le ho permesso di parlare, quindi mi fa finire. Nel merito quindi non posso sapere che cosa avete prodotto anche se le posso dire che ho visto l’elenco degli allegati e sono tutti ampiamente presenti nell’archivio della Commissione antimafia, quindi non c’era bisogno di riprodurli. Per quanto riguarda lo scritto di ben 86 pagine che avete presentato questa mattina alle 10,05, primo: non è previsto da nessun regolamento della Commissione, vi invito a studiarli, che si presenti una relazione su cui ci si esprima come gruppo parlamentare perché le relazioni in un organo democratico si presentano e si votano, e questo non è avvenuto. Fermo restando che l’avete potuta depositare in archivio. È depositata i archivio come documento libero quindi chiunque vuole la può andare a leggere. Non intendo invece per nessun motivo, nel metodo, assecondare alla sua richiesta perché l’audizione e la consegna della relazione degli auditi è avvenuta il 16 aprile. Non devo ricordare a nessuno che giorno è oggi e non devo ricordare a nessuno che c’è stato un Ufficio di presidenza la settimana scorsa dove in effetti, se avevate una documentazione così importante la potevate presentare in quella sede e quindi permettere a tutti di avere il tempo di leggerla. Evidentemente, avete preferito farlo in questo modo e in questo tempo. Le segnalo però che, se ha delle questioni da porre, questa è la sede dove porle, sempre che ci si riesca, ovviamente, perché qui si fanno le domande e si chiede agli auditi di rispondere a eventuali dubbi.
Questa è la modalità in cui lavora una Commissione d’inchiesta e questo è il modo in cui io intendo far lavorare la Commissione d’inchiesta. Iniziamo con gli iscritti a parlare, non intendo aprire la discussione su questo punto. Senatore, non è la prima volta che vediamo queste scene. Passiamo alle domande, ho già risposto sia nel merito sia nel metodo e non ci sono appigli per continuare questa discussione. La relazione è in archivio, chi vuole può accedervi.
WALTER VERINI. Non è la padrona della Commissione, è la garante delle regole.
PRESIDENTE. Nemmeno lei è il padrone della Commissione. Ho risposto e appunto sono garante delle regole, che valgono per tutti, senatore Verini. Prego, senatore Gasparri.
MAURIZIO GASPARRI. Vado direttamente alle domande perché il momento è importante. Sono un pragmatico. Nonostante questo tentativo di impedire questa attività della Commissione,Pag. 25essa però procederà. Molte cose sono state già dette e quindi voglio che ci focalizziamo su alcuni aspetti perché il documento è ampio, la materia, ahimè, è storica e da decenni caratterizza il dibattito. L’archiviazione di una parte del dossier mafia-appalti avviene nel luglio del 1992. Secondo voi poteva essere evitata o era un atto necessario in quel momento? Seconda domanda e concludo. Secondo le motivazioni del processo cosiddetto Borsellino quater e anche secondo quanto avete esposto lei e il colonnello De Donno, la causa principale della morte del dottor Borsellino va ricercata nell’interesse del magistrato per l’inchiesta mafia-appalti. Come mai in Sicilia è necessario uccidere due magistrati – quei magistrati – con le loro scorte e sviluppare un attacco frontale alle istituzioni statali, mentre nel resto d’Italia le indagini del filone «Mani pulite» – anche oggi lei ha ricordato Carrara e altre vicende relative al cemento – si sono potute sviluppare con conseguenze eclatanti e lì invece questa situazione non potrà avere lo sviluppo? Molte risposte ce le ha ricordate anche oggi, ma vorrei cominciare dal focalizzare l’archiviazione e l’impedimento a questa attività investigativa, di cui chiaramente si parlò anche nella caserma di via Carini perché Borsellino voleva andare lui dai carabinieri perché non si fidava della Procura. Questo è un fatto ormai storicamente assodato.
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. Se il presidente permette, potrei rispondere io alla prima domanda del senatore Gasparri.
PRESIDENTE. Prego, colonnello.
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. Ritengo, ma è un mio parere, che l’archiviazione del luglio 1992 poteva essere tranquillamente evitata per vari Pag. 26motivi. Innanzitutto occorre ricordare una cosa fondamentale. L’informativa che presentiamo nel febbraio del 1991 non era esaustiva delle indagini svolte: il dottor Falcone ci chiese di averla a tutti i costi prima della sua partenza verso il Ministero della giustizia. Ci fu anche una discussione perché io non volevo consegnare l’informativa, sapendo che avevamo raccolto un materiale enorme che andava ancora in alcune parti sviluppato, però lo facemmo perché questa fu l’intesa con il dottor Falcone. L’informativa, oltre ad avere già chiare una serie di tante responsabilità, alla fine si concludeva con la redazione di circa 44 schede su quelli che ritenevamo i personaggi sui quali erano già stati raccolti elementi molto significativi. In più, l’archiviazione secondo me non andava fatta per un motivo molto semplice, perché l’informativa conteneva una serie di spunti investigativi che andavano sviluppati. È vero che alcune parti che furono archiviate non erano sufficienti per andare, diciamo così, in dibattimento o per ottenere delle misure, ma è anche vero che su queste parti, che erano comunque inserite in un contesto conoscitivo enorme, non ci è stata concessa nessuna delega. Quello che ho sempre lamentato – chiaramente l’archiviazione è una decisione dei magistrati della Procura, ci mancherebbe altro – è che però in quel contesto, in quel momento, sapendo ampiamente quello che avevamo fatto e quello che era successo, con la strage di via d’Amelio, sapendo l’interesse del dottor Borsellino per questa indagine, nulla vietava che ci fosse, come ne avevamo fatte tante in precedenza, una riunione in Procura per concordare come procedere. Si potevano delegare altre attività, potevamo fare altre intercettazioni telefoniche, potevamo sviluppare tutti quegli elementi che nell’informativa si diceva sarebbero stati sviluppati. A ragione di questo faccio un solo esempio. Questo diverso approccio rispetto al non prendere in considerazione quello che Pag. 27può portare a ulteriori conseguenze, chi invece lo prende in considerazione è il dottor Borsellino con l’attività che svolse a Marsala. Partendo da alcune nostre indicazioni sugli appalti di Pantelleria, la Procura di Marsala del dottor Borsellino sviluppò adeguatamente ancora le indagini che avevamo fatto e arrestò, credo, una ventina di persone solamente per alcuni appalti a Pantelleria. Allora questo metodo poteva essere usato anche con questa archiviazione, ma le dirò di più. Molto spesso siamo stati accusati del fatto che l’archiviazione fosse conseguente al fatto che la Procura non conoscesse alcuni nostri atti e che non conoscesse soprattutto l’esistenza di una serie di attività che riguardavano uomini politici o altro. Questo è stato più volte detto ed è smentito non solo dall’ordinanza della dottoressa Lo Forte a Caltanissetta, ma, siccome avevamo già eseguito le intercettazioni sulla SIRAP, il famoso consorzio della Regione Siciliana che gestiva i mille miliardi per le venti aree attrezzate nella Sicilia, è smentita anche dal fatto che, alla luce delle risultanze delle indagini, avevamo chiesto alla Procura l’autorizzazione al riascolto di quei nastri. Ascolto che facemmo e ci portò a realizzare ulteriori attività, ulteriori emergenze, tanto è vero che il 30 giugno 1992 inviammo, ben prima della richiesta di archiviazione – l’autorizzazione era stata ottenuta alcuni mesi prima – in cui notificavamo alla procura di Palermo il fatto che avevamo trascritto ulteriori telefonate, che avevamo raccolto ulteriori elementi di indagine utili. Nella nostra nota dicevamo testualmente che: «Abbiamo trascritto intercettazioni telefoniche i cui relativi verbali, salvo diverso avviso della S.V., saranno inviati successivamente e contestualmente alla nota informativa concernente le illecite attività nel campo degli appalti pubblici». La nota è del 30 giugno 1992, con protocollo n. 5434/59. Per cui noi notiziammo la procura di Palermo che c’erano altre attività e altre emergenze processuali e dicemmo Pag. 28tra l’altro: «salvo diverso avviso» e quindi se avessero ritenuto diversamente le avremmo depositate venendo a discutere. La Procura non ci ha chiesto niente e ha archiviato comunque. Ritengo che, in risposta alla sua domanda, tranquillamente si poteva evitare l’archiviazione. Tra l’altro, non c’era nessuna fretta di archiviare e potevamo tranquillamente continuare a lavorare e sviluppare queste attività, cosa che in realtà non avvenne.
PRESIDENTE. Prego generale.
MARIO MORI, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo. Per quanto riguarda l’altra domanda, inizialmente le inchieste «Mani pulite» e «mafia-appalti» procedettero in maniera separata, anzi ci fu prima mafia-appalti e successivamente Mani pulite, condotte ovviamente dalle due procure. Dopo la strage di Capaci, Borsellino ritenne che la causa dell’attentato a Giovanni Falcone poteva essere individuato nella sua attività di contrasto all’illecito negli appalti e quindi riprese in mano l’indagine mafia-appalti che praticamente era stata, non dico archiviata, ma messa da parte dalla Procura. Qual è la differenza tra le due indagini? Nelle indagini milanesi c’erano due protagonisti negativi, cioè l’imprenditoria e la politica. Nelle indagini in Sicilia, oltre a imprenditori e politici, c’era la terza componente, che era la mafia. Quando Borsellino si rese conto dell’attività che stava sviluppando a Milano, prese ripetutamente contatti con Di Pietro e gli chiese di unire le due indagini sulla base del fatto che c’erano alcune personalità vicine ad ambienti mafiosi che erano presenti nelle due indagini, sia in quella di Milano sia in quella di Palermo. L’intesa poi non ebbe seguito per la morte di Paolo Borsellino. Perché si è stati costretti a uccidere due magistrati in Sicilia? Perché proprio la presenza mafiosa con il condizionamento rappresentato dall’intimidazionePag. 29costante, che in quegli anni era veramente opprimente a Palermo, aveva imposto un’altra delle nostre indagini, attraverso l’illecita diffusione della nostra indagine di base, la frammentazione della inchiesta, divisa tra più uffici giudiziari, e gli ostacoli posti ai magistrati, in particolare a Paolo Borsellino e a Giovanni Falcone, ma, oltre a loro, anche a Felice Lima e ad Augusto Lama di Massa Carrara. Questi ultimi due, Lima e Lama, furono bloccati con artifici procedurali, gli altri due Falcone e Borsellino sono stati abbattuti dalla mafia. Questa è la differenza.
PRESIDENTE. Grazie mille. È iscritto a parlare l’onorevole Maiorano.
GIOVANNI MAIORANO. Sì, grazie, presidente. Ho una domanda per il colonnello De Donno. Alla pagina 14 del libro «L’altra verità», dopo la strage di Capaci, riflettendo sulle menti raffinatissime richiamate da Falcone dopo l’attentato all’Addaura del 1989, lei dice di avere un’idea su chi potrebbero essere le menti acute, i doppiogiochisti, quelli che sventolano la bandiera antimafia mentre flirtano con un sistema infetto. La semplice domanda è: chi sono?
PRESIDENTE. Prego, colonnello.
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. Il libro fa essenzialmente riferimento al nostro rapporto con Vito Calogero Ciancimino e il collegamento che facciamo – mi permetta questa piccola digressione – è esattamente tra le parole che Falcone pronunciò in un’intervista a Saverio Lodato pochi giorni dopo il fallito attentato all’Addaura e alcune affermazioni che faceva Vito Calogero Ciancimino. Entrambi, chiaramente in maniera diversa e tenuto conto dell’abisso che intercorreva tra i due personaggi, sostenevano, Pag. 30probabilmente con forme, con idee, con prove diverse, che, oltre alla mafia, esistessero collegamenti, delle menti, delle persone che, per altri fini, condizionassero le attività di Cosa nostra. Questa tesi, per carità poi tutta da dimostrare e da verificare, stranamente però trovò una coincidenza tra il pensiero di Giovanni Falcone e il pensiero di Vito Calogero Ciancimino che, ricordo, proprio con il dottor Falcone, arrestammo due volte. Nel libro, ripercorrendo quel passaggio, quelle affermazioni e quella storia, qualche idea posso averla avuta, posso averla, però chiaramente, essendo indicazioni completamente prive di un riscontro probatorio, di un riscontro documentale, di un riscontro investigativo che tra l’altro all’epoca non furono fatti e che adesso non posso più fare. È chiaro che non mi sono addentrato in indicazioni di nomi e cognomi perché lei sa bene che questo, a parte che sarebbe totalmente arbitrario e illecito, mi esporrebbe a una serie di attività giudiziarie non potendo dimostrare le mie idee. Quello che posso dirle, se mi consente, è che in realtà dall’esperienza che abbiamo maturato, sono assolutamente convinto di quello che diceva il dottor Falcone, cioè che non esisteva e probabilmente non esiste un terzo livello, intendendo un livello politico o di altro genere sovraordinato gerarchicamente a Cosa nostra. Questo non lo credo e non credo che esista perché sono mondi completamente diversi e distanti. Esistono però una serie di convergenze di interessi ed esistono sicuramente una serie di situazioni, tra cui gli appalti pubblici, in cui, difendendo le attività di uno, automaticamente si difendono gli interessi degli altri perché il sistema è interconnesso – come dicevamo – tra Cosa nostra, imprenditoria e politica. Tra l’altro in varie affermazioni, Ciancimino sosteneva esattamente questo e lo fece in molti verbali alla Procura di Palermo, cioè che secondo lui, dietro alcuni omicidi eccellenti – dove probabilmente dietro qualcuno c’era Pag. 31anche lui stesso – esistevano decisioni prese altrove dalla Sicilia e che per una serie di convenienze venivano fatti eseguire poi a Palermo e quindi diventavano delitti di mafia. Tutto questo è quello che poi in realtà in parte nel libro un po’ lamentiamo, cioè il fatto che questa ipotesi investigativa, chiamiamola così, non fu adeguatamente sviluppata e approfondita e rimane quindi a tutt’oggi qualcosa di non dimostrato.
PRESIDENTE. Grazie mille. Prego, senatore Verini.
WALTER VERINI. Grazie, presidente. Se avessi avuto la parola, avrei richiesto semplicemente un’ora di tempo per poter leggere perché bisogna andare avanti. Non c’era nessuna volontà ostruzionistica. Chiusa questa parentesi, credo – e prego di essere creduto – di avere qui davanti due persone che hanno servito lo Stato e che per il loro servizio sono stati anche accusati politicamente, ma anche sul piano giudiziario, di aver commesso errori. Sul piano penale, il vostro percorso, e il suo in particolare, generale, è uscito indenne. Ciò non toglie che ci sono state negli anni molte questioni che – io dico purtroppo, dal mio modestissimo punto di vista – hanno diviso un mondo fatto da autorità giudiziaria, fatto da magistratura che entrambe dovevano stare, debbono stare in generale, dalla stessa parte, quella della lotta contro la criminalità organizzata, per la legalità. Quindi io ho queste persone davanti. Ciò non toglie che, avendo queste persone davanti, e lei in particolare, vorrei farle brevemente qualche domanda, anche di contesto. Lo dico sinceramente e anche con una certa umiltà: non ho tutti gli elementi che possono avere – e credo anche diversi altri membri della Commissione – tutti gli elementi che hanno persone che per tutta la vita si sono esclusivamente occupate di queste indagini, di questo contrasto, di tutte queste attività. Alcune domande mi sono venute, perché ho letto anch’io libri, Pag. 32interviste e altre cose. Dopo le stragi e dopo gli omicidi, quando arrivò a Palermo il magistrato Giancarlo Caselli, lei, come del resto ha fatto anche il magistrato Di Pietro in audizione, ebbe a dire che quello fu un fatto positivo. Del resto Giancarlo Caselli veniva da un’esperienza di lotta al terrorismo per la quale tutti dobbiamo semplicemente metterci sull’attenti. Della rilevanza che attribuivate al tema mafia-appalti, come elemento, come motore acceleratore dell’assassinio di Borsellino e della strage di via d’Amelio, avete subito informato il magistrato Caselli? Se questo non è avvenuto, ma se foste tornati, come risulta, a parlare di mafia-appalti soltanto nel 1997, raccontando solo qualche anno dopo del famoso incontro alla caserma Carini, questo perché, se è così, è avvenuto così? Seconda domanda. Avete lavorato e avete anche arrestato, lo ha ricordato prima il dottor De Donno, Ciancimino. Tuttavia, avevate informato Paolo Borsellino delle vostre «interlocuzioni» con Vito Ciancimino? Perché mentre, a soli due giorni dall’incontro alla caserma Carini, non risulta abbiate informato il magistrato, però il colonnello De Donno parlò con la dottoressa Ferraro, persona che ho conosciuto personalmente e che stimo. Ho anche lavorato con lei, in altri ruoli naturalmente, è stata assessore alla sicurezza al comune di Roma. Perché avete avvertito il livello politico e non avete ritenuto invece di interloquire con il livello giudiziario? Un’altra domanda, questa sì, generale, «politica» nei suoi confronti. Nella sua carriera ha svolto due ruoli fondamentali, uno quello di ufficiale dei servizi e l’altro quello di ufficiale dei carabinieri. Siccome è noto che la lotta alla mafia, secondo scuole di pensiero e di azione, può avvenire sia su un piano immediatamente di contrasto e quindi con sole interlocuzioni con la magistratura requirente, come dovrebbe fare un ufficiale dei carabinieri in generale, il fatto che voi informavate, a volte, più il livello politico, vuol dire che prevaleva,Pag. 33in certe occasioni, e in certi casi ha prevalso in voi, essere stato ufficiale dei servizi, quindi direttamente interlocutore del Governo, del ruolo politico? Gestire politicamente il tramonto della mafia – e lei sa a chi alludo con questa frase – oppure perché non immediatamente, e contestualmente almeno, informare l’autorità giudiziaria?
Finisco con un’ultima questione, anche questa per me molto importante e di contesto. Lei è stato direttore del SISDE, è stato capo del ROS. Davvero ha avuto non solo un ruolo fondamentale nel contrasto alle mafie, ma punti di osservazione assolutamente privilegiati, e meritoriamente privilegiati. La domanda è questa: il tema mafia-appalti certamente è stato tra le cause che hanno prodotto quegli anni, ma in quei momenti, mentre si svolgevano le questioni legate a mafia-appalti, generale, accadevano in Sicilia e nel Paese dei fatti. Lei che opinione si fece, se se ne è fatta qualcuna, in quegli anni, di alcuni omicidi importanti che ci sono stati in quegli anni in Sicilia, omicidi politici, da Salvo Lima in poi? Che impressione si è fatto del ruolo svolto a cavallo tra Mani pulite e la fine della cosiddetta Prima Repubblica, che poi non è mai finita per la verità, ma in ogni caso che idea si è fatta di quello che accadde sul piano politico in quegli anni, per esempio del ruolo svolto da Marcello dell’Utri in Sicilia e nel Paese se lei è a conoscenza di qualche ruolo? Che idea si è fatto delle stragi di via dei Georgofili, dell’attentato al Velabro, dei fatti di Milano? Pensa davvero che non ci sia connessione tra quella stagione di attentati, omicidi, dell’assassinio di Falcone e Borsellino con un contesto che aveva anche queste cose? Davvero non è una domanda polemica, ma da uno come lei mi aspetterei, se possibile, qualche valutazione. Davvero l’ultima domanda: parlo di storia, non parlo di polemica politica. In un certo periodo capitò che c’era un signore – ribadisco il ruolo di Marcello dell’Utri – un Pag. 34signore che si chiamava D’Alì, che faceva il sottosegretario all’interno, mentre lei era ai servizi, c’era Tinebra, insomma protagonisti – non parlo di lei – non particolarmente brillanti del contrasto alle mafie. Lei, avendo vissuto quella stagione da protagonista in ruoli di grande osservazione, non ha avuto sentore che nel nostro Paese, quindi anche in Sicilia e quindi anche legati alle stragi Falcone e Borsellino, si muovessero interessi non soltanto legati a mafia-appalti, ma anche legati alla volontà di cambiare il sistema politico e di cambiare dopo la fine della Prima Repubblica qualche esito? Le elezioni del 1987 in Sicilia furono un primo segnale. Grazie, generale.
PRESIDENTE. Prego, generale.
MARIO MORI, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo. Giancarlo Caselli a Palermo arrivò il giorno dell’arresto Totò Riina e lo conoscevo dal periodo del terrorismo, avendo lavorato con lui. Lo avevo anzitempo contattato su sua richiesta e, mi sembra l’8 o il 9 gennaio, andai da lui a Torino per fare un inquadramento sulla situazione palermitana visto che dopo pochi giorni doveva assumere la direzione della Procura. Gli fu fatto un quadro dove cercai di spiegare la nostra attività. Immediatamente, se lei noterà le date, il 15 gennaio viene arrestato Salvatore Riina, dopo pochi giorni che era stato arrestato, Ciancimino ci chiede di parlare in carcere, andiamo noi due con l’autorizzazione di Caselli, preavvertito. Convinciamo Ciancimino che non era più il caso di fare un rapporto tra polizia giudiziaria e lui, ma tra lui e la Procura di Palermo e lui accettò di parlare con Caselli. Siamo quindi a gennaio del 1993. Noi ci aspettavamo, quando iniziarono gli interrogatori di Ciancimino da parte della Procura, che a sentire il Ciancimino, che era l’autore del sacco di Palermo, quindi un personaggio che nel campo del condizionamento degli appalti era veramente Pag. 35il numero 1 in negativo, fossero chiamati quei magistrati che negli anni precedenti e tuttora, svolgevano indagini sugli appalti, quindi Pignatone, Lo Forte, Sciacchitano e, se non loro, Aliquò, Scarpinato, De Francisci e Teresi. Invece, si presentarono a interrogare per un anno circa Vito Ciancimino, Giancarlo Caselli, che conoscevo e stimavo moltissimo come magistrato, ma che non sapeva nulla di attività antimafia – me lo consentirà – e due ragazzi, Ingroia e Patronaggio, i quali, rispetto a quegli altri che prima ho citato, non sapevano nulla. Questo mi fece capire che ancora una volta c’era da parte della Procura di Palermo l’idea di non approfondire il problema degli appalti. Recentemente in una presentazione di un nostro libro c’era presente anche Antonio Ingroia, al quale chiesi: «Ma perché lei e Patronaggio e non Lo Forte e Pignatone?» e quello sa cosa mi rispose all’aula Koch del Senato, quindi un luogo pubblico? «Sì, ma loro non volevano e siamo venuti noi». Caselli fu informato quando è iniziata la nostra attività. Anche noi abbiamo cercato di ricostruire, ma loro hanno proceduto e non hanno rilevato. Sono problemi di loro valutazione. Non entro nella valutazione di Caselli, Ingroia e Patronaggio sul merito di quello che poteva dire e non dire Ciancimino. Faccio solo un’osservazione: è stata consentita la possibilità di parlare e sono stati concessi forti sconti di pena a personaggi come Pasquale Galasso, presenti noi, che non si ricordava il numero di omicidi che aveva fatto, come Giovanni Brusca che, oltre ad aver fatto una strage e una serie di omicidi, aveva dato l’ordine di mettere nell’acido un bambino, Santino Di Matteo, reo solo di essere il figlio di un pentito. A loro è stata data la parola e sono stati dati ampi sconti di pena. Perché non abbiamo voluto sentire Vito Ciancimino? Come ha detto giustamente Giuseppe De Donno, Ciancimino era un criminale, che aveva commesso una serie infinita di reati e altri più gravi li aveva commissionati Pag. 36ai suoi compaesani – Provenzano e Riina – ma questo non cambiava la situazione. Se si voleva affrontare il problema degli appalti lo si doveva far parlare. Al termine, fatta una valutazione su quanto aveva detto, pro e contro, si dava eventualmente qualche vantaggio. Questo non l’hanno fatto e hanno lasciato quindi il dubbio che non si volesse approfondire l’argomento.
Sono stato un ufficiale dei Carabinieri che ha svolto varie attività, ma sempre ben distinte e separate. Sono stato da giovane ufficiale operativo del servizio, ma non operativo da burletta, come nei film, ho fatto l’operativo all’estero, quindi so il mestiere. Poi sono diventato un ufficiale di polizia giudiziaria, ho fatto l’attività col Nucleo speciale di polizia giudiziaria del generale Dalla Chiesa, quindi penso che del settore della criminalità organizzata mi intendo. Successivamente sono stato nominato direttore del Servizio, sa quando? Qualche giorno dopo l’attacco alle Torri gemelle perché in quei giorni lì eravamo solo tre o quattro che potevano fare quel mestiere: hanno scelto me, potevano sciogliere altri. Nel fare questo mestiere ho sempre capito la differenza che c’era tra l’ufficiale di polizia giudiziaria Mori e l’operativo del servizio Mori: sono due mondi che, come diceva un certo politico, sono due linee parallele che non si incontrano mai e io l’ho avuto sempre presente. Circa il rapporto con i magistrati, ho avuto sempre un grande rispetto per la loro funzione, ma non ho mai consentito che mi si dicesse cosa dovevo fare una volta che mi era stata data la delega, perché una volta che mi dai la delega da quel momento lavoro io, poi ti riferisco e tu mi dici se ho fatto bene o male, questo deve essere chiaro. L’ho sempre fatto e questo mi ha portato anche qualche problema con alcuni magistrati, ma era lo stesso stile di Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ci ha insegnato questo sistema e che, viva Dio, ha funzionato. ChiedevaPag. 37come ho potuto valutare queste situazioni che avvenivano mentre ero a Palermo nella veste di responsabile del ROS. Guardi è facile parlare, anche per me è facile parlare nel 2025. Una volta con espressione direi volgare, in un Comitato nazionale, attaccai il Procuratore della Repubblica di Palermo Paino, dicendo che lui giudicava stando con il «sedere al caldo», mentre noi eravamo fuori a lavorare. Quindi so bene come si lavorava e come si cercava di fare qualche cosa. Pensavamo di essere sostenuti in maniera totale, come era avvenuto per il terrorismo e Caselli ne era un esempio. Ho lavorato con Vigna, ho lavorato con Spataro, ho lavorato con Boccassini: erano sempre dalla parte nostra, nei limiti rispettivi della procedura ovviamente. A Palermo, ma non solo a Palermo, anche a Catania, ci siamo trovati con un approccio da parte della magistratura che era di distacco, eravamo anche noi sotto inchiesta e questo io non lo tolleravo, l’ho sempre detto a tutti. Se tu mi dai una delega è segno che mi stimi, quindi mi deve far lavorare e non sospettare su tutto. Questo approccio di sospetto fu tipico di tale procura in quel contesto di pochi anni.
WALTER VERINI. Perché generale?
MARIO MORI, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo. Questo non glielo so dire. Qualcuno parlava del Palazzo dei veleni. È difficile poterlo dire e valutare adesso i fatti dell’epoca, forse la situazione la conosce il dottor Cafiero De Raho, però quella napoletana era un’altra realtà, era tutta diversa da Palermo, mancava quella sintonia che nel terrorismo abbiamo avuto, forse per cultura diversa, per impostazioni diverse, per sospetti che c’erano, diversi. All’epoca avevamo tanto da fare, non pensavamo alle sottigliezze, riscontravano questa situazione e ne prendevamo atto, fino a un certo punto, ma nel frattempo si sommavano una serie di vicende che ci facevano Pag. 38sempre più tenere il distacco da questa gente. Non ho capito perché Giammanco ha fatto tutto quello che ha fatto, personalmente. Le posso dire che Giammanco non era un criminale, era una persona inserita in quel contesto sociale, aveva le sue relazioni con il mondo imprenditoriale e delle professioni, e con il mondo della politica. Soprattutto, c’era un gruppo di persone che riteneva in quel momento, e anche successivamente, di poter fare quello che voleva, entro certi limiti, perché la legge per loro non era la stessa, la legge per il cittadino Mario Mori a Palermo, non era la stessa del dottor Pietro Giammanco, questo è pacifico, da qui tutto il resto. Mi ha parlato di Dell’Utri e di D’Alì, certo che li ho conosciuti. Come ha detto lei, ho affrontato parecchi momenti della vita in cui ho dovuto parlare con il mondo politico. Mi sono formato dal punto di vista professionale nell’attività investigativa in cui bisogna fare come faceva san Tommaso: tocco, quindi credo, non tocco, non credo. Ci siamo sempre comportati così perché così era anche il concetto di azione del Nucleo speciale di polizia giudiziaria di Dalla Chiesa: constati i fatti e riferisci. Non avevamo il tempo allora di fare valutazioni. Lei mi chiede se le posso fare adesso. Adesso le posso fare, ma non contano, le mie valutazioni in questo momento non contano, contano quelle che facevo all’epoca. Sono stato un operativo, ho fatto dei fatti, questi fatti li ho notificati, ho pagato per qualche fatto perché qualcuno li ha giudicati non corretti, la magistratura mi ha dato ragione, quindi non mi esprimo su vicende politiche che sono fuori dal mio contesto, quindi non posso rispondere.
Le posso dire una cosa. Mi ha chiesto perché non abbiamo informato Borsellino dei contatti con Ciancimino: molto semplice. Incontro Borsellino il 25 giugno del 1992. I contatti con Ciancimino erano appena iniziati e li teneva solo Giuseppe De Donno. Ciancimino per noi, allora, e successivamente, è sempre Pag. 39stato una fonte informativa regolata dall’articolo 203 del codice di procedura penale per cui quello che diceva andava valutato e poi si riferiva al magistrato. All’epoca, il 25 di giugno, Borsellino non aveva ancora detto che voleva collaborare con noi, per cui non avevo motivo di parlare con lui perché se a Borsellino avessi dovuto raccontare tutto quello che facevamo in quei giorni non 25 minuti – quant’è stato grosso modo il nostro incontro – ma sarebbero servite delle ore. Non parlammo quindi di Ciancimino, ci ripromettemmo di farlo successivamente. Quando? Quando ci rendemmo conto che c’erano delle ostilità da parte della Procura nei nostri confronti, mettemmo le mani avanti, come si dice. Ha chiesto del perché solo al potere politico. Liliana Ferraro non era il potere politico, era l’amica e la collega più vicina a Giovanni Falcone. Parlare adesso di queste cose è difficile. Il rapporto tra me, la Ferraro, l’avvocato Contri, Luciano Violante, Caselli, non era il rapporto con il signor ministro o il dottor Violante, era un rapporto di gente che combatteva dalla stessa parte nella stessa battaglia. Andai da Contri a questo titolo e addirittura mi chiese se volevo parlare con Giuliano Amato. Le ho risposto di averlo detto a lei e che ci pensasse lei a parlargli. Erano rapporti del tutto diversi in quel momento. Giuseppe De Donno, che frequentava continuamente Giovanni Falcone, anche a Roma, incontrandosi con la Ferraro, parlò del tentativo, su mia autorizzazione, sia chiaro, perché io comandavo, io non dirigevo, io comandavo, e quindi prima di fare qualsiasi atto i miei ufficiali chiedevano la mia autorizzazione. Autorizzai io De Donno, che aveva arrestato due volte Vito Ciancimino, di fare il tentativo di portarlo dalla nostra parte. Non so come ha vissuto quel periodo, ma in quei giorni lo Stato era in ginocchio, se se lo ricorda. Caponnetto diceva che era finita. Qualcuno si nascondeva da qualche parte o comunque non faceva dichiarazioni. Qualche mio Pag. 40collega a Palermo non usciva più, preferiva il lavoro d’ufficio. Questa è la realtà che forse molti di voi non sanno neanche che cosa sia. In questo contesto ce ne siamo altamente fregati del potere politico. Facevamo delle indagini, volevamo dei risultati e in parte li abbiamo ottenuti. Tutti i discorsi di altra natura non mi competono, non li voglio fare perché non li so nemmeno fare.
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. Presidente, posso aggiungere un paio di cose?
PRESIDENTE. Prego, colonnello.
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. Solo per chiarire alcune situazioni. Riguardo al discorso del Procuratore Caselli. Per tutta la vicenda Ciancimino, appena Caselli diventa Procuratore a Palermo, siamo noi che avvisiamo la Procura di Palermo dei rapporti che avevamo instaurato con Ciancimino. Questa è un’altra cosa che nel tempo è stata un po’ confusa: non è la Procura che scopre questa teorica, come è stato soprannominata, «trattativa», ma siamo noi che avvisiamo Caselli perché con Caselli possiamo parlare, tanto è vero che, come diceva il signor generale, andiamo in carcere a convincerlo, su autorizzazione della Procura di Caselli. Gli abbiamo parlato di mafia-appalti? Certo che ne abbiamo parlato, ma poi i rapporti anche lì sono cambiati perché, a parte la circostanza che in Procura, come accennavo prima, quando il dottor Caselli disse che il ROS era disponibile e aveva convinto Vito Calogero Ciancimino, alcuni magistrati dissero che non bisognava neanche andarlo a sentire e Ingroia nella conferenza ha fatto i nomi, erano il dottor Pignatone e il dottor Lo Forte. Nel maggio 1993 la Procura di Palermo ci concede 33 ordinanze di custodia cautelare – Riina Pag. 41Salvatore più 32 – perché era arrivato il fascicolo che la Procura di Catania aveva instaurato con il dottor Lima e aveva trasmesso a Palermo per competenza. Si trattava di tutta la parte SIRAP. Con il dottor Caselli facciamo questa attività, ma anche lì succede poi qualcosa di inspiegabile. È la prima volta in cui mettiamo le mani sui Buscemi, riusciamo ad arrestare alcune persone, anche se tutta la parte sviluppata a Catania viene stravolta. Anche lì succede il fatto che non riceviamo deleghe, non viene ampliata l’indagine, ma soprattutto il dottor Caselli fa addirittura una relazione in cui mi accusa, insieme con altri magistrati della Procura di Palermo, della teorica idea della doppia informativa. Vengo sottoposto a un procedimento disciplinare dal Procuratore generale della Cassazione qui a Roma dal quale vengo assolto perché non ho commesso nessun illecito perché non esisteva nessuna doppia informativa, vicenda questa acclarata anche dal procedimento a Caltanissetta quando faccio le dichiarazioni sulle rivelazioni di Angelo Siino e quindi sull’indagine a carico di alcuni magistrati. Il clima, già a maggio 1993, dopo alcuni mesi, diventa praticamente irrespirabile. Dopo quegli arresti, che furono obbligati a essere eseguiti perché da Catania arrivò l’indagine, non potemmo più parlare, la Procura non ci diede più nessuna delega e praticamente non ci autorizzò a fare più nulla.
Su Catania le racconto solo un episodio che è agli atti perché siamo stati citati addirittura al CSM. Chiariamo subito il dubbio sulla teoria dell’anonimo che avrei scritto per spostare la competenza da Palermo a Catania. Anche questo è un falso storico, già acclarato in sede giudiziaria. Falso storico perché a un certo punto arriva un esposto anonimo in cui si dice che a Catania stanno facendo dei lavori SIRAP. Il dottor Lima fa delle indagini, bisogna ascoltare Li Pera che sa un sacco di cose. Questo anonimo diede inizio all’indagine di Catania e all’epoca Pag. 42qualcuno disse che l’avesse scritto il ROS e il capitano De Donno per spostare l’indagine da Palermo a Catania. Questo è falso per un motivo molto semplice: se avessi scritto questo anonimo per portare Li Pera a Catania, l’avrei portato e avremmo iniziato. Prima di andare a Catania, chiesi l’autorizzazione per iscritto – c’è il foglio documentato con firma – ai dottori Pignatone e Lo Forte e questo mi assolve. Questa accusa me l’hanno rifatta anche quando il dottor Lo Forte mi fece la querela per diffamazione a Caltanissetta e io mi salvai da questa accusa perché non portai arbitrariamente Li Pera a Catania, chiesi il permesso della Procura di Palermo di portarlo a a Catania a farlo sentire da quei magistrati e la Procura di Palermo mi autorizzò per iscritto. Se avessi scritto l’anonimo non avrei chiesto l’autorizzazione, scrivo un anonimo per sottrarre l’indagine, non chiedevo l’autorizzazione alla procura di Palermo per andarci. Quando andiamo lì e facciamo l’indagine, il dottor Lima redige una misura cautelare nei confronti di una quarantina di persone, il dottor Alicata, al momento della firma, si inalbera gli toglie la competenza, dice che il fascicolo non è competenza di Catania – era tutto Catania, non c’era neanche l’associazione mafiosa – stralcia una serie di parti mandandole a varie procure e manda tutto alla Procura di Palermo. Trattiene a Catania un episodio relativo all’ospedale Cannizzaro, se non sbaglio, dove era coinvolta la famiglia Costanzo. Noi seguiamo questo spezzone che resta a Catania, la procura ci delega l’intercettazione telefonica, perché era stata richiesta una misura dell’ordinanza cautelare nei confronti dei Costanzo più altri funzionari pubblici e imprenditori, una mattina vado in Procura e la segreteria del Procuratore Alicata mi chiama dicendo che il procuratore mi vuole parlare. Vado dal procuratore che mi disse: «Capitano, mi dicono che lei è venuto a chiedere notizie sulla emissione di alcune ordinanze di Pag. 43custodia cautelare». Rispondo affermativamente. Con fare severo mi chiese: «A che titolo lei viene a chiedere queste informazioni?». Pensavo si fosse confuso. Rispondo: «Procuratore, sto facendo intercettazioni telefoniche, li stiamo seguendo, li pediniamo per evitare che scappino. Ci sono le intercettazioni telefoniche, è normale che vengo a chiedere quando saranno emesse le misure per prepararci per l’attività». Lui mi disse: «Ma chi ha detto che io delego voi per gli arresti?». A quel punto non le ripeto per decenza tutta la frase che dissi. «Procuratore, lei sta scherzando o sta parlando seriamente?». «Sto parlando molto seriamente». Allora gli dissi: «Per quanto mi riguarda, lei può delegare anche la forestale – all’epoca la forestale non era ancora nei carabinieri – in questo momento rientro in caserma, rimetto la delega, stacco i telefoni e non mi interesso più. Se vuole parlare con me, da questo momento in poi è lei che viene in caserma». Chiudemmo i rapporti con Catania, non ci delegò le indagini, non ci delegò gli arresti e non ci diede nessun’altra delega. Questi erano i rapporti che avevamo con alcuni magistrati. Ultime due annotazioni. Viene ripetuto ancora una volta – forse è un suo lapsus: io non ho riferito dell’incontro del 25 luglio nel 1997, lo abbiamo riferito nel 1992 quando la procura di Caltanissetta ci ha chiamato e ci ha chiesto queste cose, ci sono gli atti processuali, quindi anche questa teoria che abbiamo raccontato dell’incontro del 25 luglio anni dopo la strage, è falsa. Circa la dottoressa Ferraro, la conoscevo perché me l’aveva presentata il dottor Falcone dato che, come lei sa, si occupò della costruzione dell’aula bunker a Palermo per il maxiprocesso. Era una persona con cui avevamo creato un certo rapporto e quindi c’era una certa sintonia ed era una delle persone a cui Falcone era più legato, quindi è normale che dopo la strage ci fossero questi contatti. Andai da lei al Ministero, dove aveva preso il Pag. 44posto del dottor Falcone, e le parlai di questa cosa. Lei mi disse che ne avrebbe anche riferito al dottor Borsellino tant’è vero che – anche su questo c’è documentazione processuale – lei ne parlò a Borsellino in un incontro all’aeroporto credo di Roma Ciampino, non so dove si incontrarono, e la dottoressa riferisce che Borsellino non dimostrò molto interesse per questa cosa e anzi, in quella circostanza, si mise a parlare di mafia-appalti. Tra l’altro, e chiudo, il 25 giugno l’incontro fu molto stringato. Borsellino mi disse di preparare tutto quello che serviva e di fare un piano per riprendere le indagini e poi quando sarebbe tornato dalla rogatoria in Germania ne avremmo riparlato. Non abbiamo più fatto un altro incontro. Tutto qui.
PRESIDENTE. Propongo che la Commissione prosegua i lavori in seduta segreta per poter esaminare un documento riservato.
(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).
PRESIDENTE. La parola al senatore Cantalamessa.
GIANLUCA CANTALAMESSA. Grazie presidente. Generale, per me e per il nostro gruppo della Lega è un onore averla conosciuta. La sua presenza ha un peso, una storia e una dignità che meritano attenzione e rispetto. Lei merita per lo meno attenzione e riconoscimenti, se non anche risarcimenti, non solo presso l’opinione pubblica attraverso i media, ma anche da parte dei partiti politici e da parte dello Stato italiano. Come «ringraziamento» per il suo coraggio, la sua lealtà e i suoi eccellenti risultati investigativi, ha dovuto subire da parte di una parte dello Stato tre processi per ipotesi di reato che la Corte d’appello ha giudicato infondati. Non da ultimo nel maggio del 2024 – credo fosse il giorno del suo ottantacinquesimoPag. 45compleanno – ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Firenze in relazione alle stragi del 1993-1994 per reati di strage, associazione mafiosa, associazione con finalità di terrorismo internazionale e di eversione dell’ordine democratico. Credo che questo tutti i presenti lo sappiano, ma credo che sia necessario ripeterlo. Condivido l’auspicio e il pensiero del collega Verini, ma trovo che sia paradossale che è stato oggi indagato per non aver fatto nulla per impedire le stragi dopo essere stato processato per aver trattato per fermarle: è un evidente paradosso.
Passo alle domande. Se è possibile volevo avere qualche informazione in più sull’informativa cui prima si è fatto riferimento, quella del 16 febbraio del 1991 – lei vi ha fatto cenno. Di fatto, voi commettete un errore non riconoscendo in un’intercettazione telefonica in cui si discuteva di un personaggio a capo dell’organizzazione di gestione illecita degli appalti l’imprenditore Filippo Salamone, indicando invece che ci si stesse riferendo ad Angelo Siino. Questa circostanza è l’unica in cui si faceva riferimento all’imprenditore Salomone o ce ne sono state altre? Nella sua relazione ha fatto riferimento all’indagine svolta con la Procura della Repubblica di Napoli sempre sul sistema illecito di gestione di appalti pubblici, indagine che, se non erro, è stata anche oggetto di studio da parte dell’Università Federico II. Potrebbe riassumere brevemente il contesto di quell’indagine, illustrarci che tipo di rapporto instaurasse con quella magistratura e spiegarci perché quell’indagine poi è risultata così importante per la comprensione del sistema illecito di gestione degli appalti pubblici in Italia?
MARIO MORI, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo. Penso che debba rispondere De Donno che ha svolto materialmente le indagini.
PRESIDENTE. Prego colonnello.
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. Per quanto riguarda la vicenda Salamone – è già stato detto l’altra volta – fu un mio errore. Avevamo posto sotto controllo il consorzio CEMPES di Palermo, composto da una serie di aziende nazionali, tra cui la Tor di Valle, e si creò un problema perché la Tor di Valle non aveva vinto un appalto e si era diffusa la notizia che stesse preparando ricorso. I responsabili locali, se non ricordo male c’era l’ingegner Zito, vennero contattati affinché la Tor di Valle recedesse da questo intento. Lui fece fortunatamente una serie di telefonate con Roma e parlò con il dottor Catti De Gasperi, spiegando questa situazione e in quella telefonata gli spiegò quello che era successo dicendo che se non avessero dato fastidio, non avessero rotto il meccanismo senza fare ricorso, sarebbero stati ricompensati perché c’era una torta da mille miliardi da suddividere, che erano i mille miliardi del consorzio SIRAP. Il dottor Catti anziché dire, come si sarebbe dovuto aspettare, di andare dai carabinieri e sporgere denuncia, disse che gli stava bene, ma che con la garanzia di quello che conta, quello che inizia con la «S», facendo una serie di riferimenti. In quella circostanza, sbagliai – perché gli errori si fanno – l’individuazione e ritenni, poiché noi eravamo concentrati su Angelo Siino che ci appariva in quel momento il personaggio dominus dell’indagine, individuai nell’informativa, e lo scrissi, che il personaggio che contava, quello che inizia con la «S», era Angelo Siino. Invece in quella circostanza il riferimento era a Filippo Salamone, cosa che noi avremmo capito dopo nelle indagini successive. Questo poteva essere un accertamento molto importante perché probabilmente ci avrebbe consentito di fare delle valutazioni diverse. Sta di fatto che comunque Salamone era abbastanza noto nell’informativa, l’avevamo già indicato. Adesso non le cito tutte le telefonate e tutte le Pag. 47questioni, di cui ho gli appunti, ma già nel nostro dossier lui viene citato abbondantemente a pagina 201. A pagina 280 ci sono delle intercettazioni telefoniche. Tra l’altro l’avevamo indicato in rapporto con Spezia, che era un imprenditore che risulta poi interessato a tutta la vicenda degli appalti di Pantelleria e a tutte le altre questioni. Questa storia, siccome è stata riportata ed è stata strumentalmente usata anche per attaccarmi più volte, entra anche nelle indagini di Caltanissetta. Anche la dottoressa Loforti cita nella sua informativa il fatto che, sebbene avessimo commesso questo errore, però la figura di Salamone della ditta Impresem di Agrigento fosse ampiamente nota, ampiamente riconducibile ed era ampiamente dimostrato quale fosse il suo ruolo. Per esempio la dottoressa Loforti disse: «Senza dire che il ruolo del Salamone era emerso nella sua pienezza nell’ambito della manipolazione di appalti pubblici indetti da SIRAP e che su tale gara, alla pagina 203 della informativa, si affermava che si tornerà in un altro elaborato, così come a pagina 225 della medesima informativa si dava atto che erano stati sottoposti a intercettazioni telefoniche altre utenze riconducibili alla questione». Poi c’è tutta un’altra serie di attività e di questioni. Per cui, sì, effettivamente l’errore l’ho fatto, ma questo incise in una valutazione iniziale, ma Salamone era già noto e conosciuto e poi ritorna ampiamente, tanto è vero che viene arrestato successivamente.
Per quanto riguarda l’inchiesta di Napoli, l’onorevole Cafiero la conosce benissimo. Provo a riassumerla, ma per quanto cercherò di essere sintetico, si tratta di una cosa abbastanza complessa. Con la Procura della Repubblica di Napoli credo che abbiamo forse condotto l’unica indagine di questo tipo che mai sia stata fatta in Italia, un prototipo e un laboratorio di attività che non erano state mai tentate prima e mai sono state ripetute dopo. Siamo nel 1996 e iniziavano i cantieri per la costruzione Pag. 48dell’Alta velocità Roma-Napoli. In alcuni cantieri gestiti dalla Calcestruzzi S.p.A., erede dell’impero Gardini, si presentarono alcuni malavitosi chiedendo il pagamento della tangente. L’amministratore delegato dell’epoca, che era una persona assolutamente perbene e coraggiosa, il dottor Parrello, si presentò in Procura dal dottor Paolo Mancuso e sporse denuncia. Il dottor Mancuso mi chiamò e mi affidò le indagini. Era una classica estorsione, di quelle che avvenivano nei cantieri. Dissi che ci avremmo lavorato. Tornando in ufficio mi chiesi perché ci avremmo dovuto lavorare come in una classica estorsione dove alla fine avremmo preso tre persone senza comprendere quale fosse il quadro complessivo. Per cui tornai in Procura ed esposi una tesi abbastanza ardita che il dottor Mancuso, persona di assoluta intelligenza e di grande acume, accolse immediatamente nonostante sul momento sembrasse folle. Sostanzialmente, proposi alla Procura di Napoli di accettare l’estorsione, sostituendo i funzionari dell’azienda Calcestruzzi con un nostro ufficiale di polizia giudiziaria, di dichiararci disponibili a pagare l’estorsione per cercare di risalire a monte il canale di gestione delle attività e quindi cercare di arrivare veramente a chi gestiva tutta la cosa. Il Procuratore della Repubblica, il dottor Agostino Cordova, accettò questa impostazione. Scegliemmo un ufficiale del ROS – all’epoca era il tenente colonnello Paticchio che comandava la sezione anticrimine di Bologna – che trasformammo nell’ingegner Varricchio. Il colonnello Paticchio ha sbagliato mestiere, non doveva fare l’ufficiale dei carabinieri, in un’altra vita deve fare o il truffatore o l’attore. A Hollywood – lo dico sempre – avrebbe vinto il premio Oscar. Entrò immediatamente nella parte con tutta una serie molto complessa di azioni, che l’onorevole Cafiero conosce benissimo perché abbiamo lavorato a lungo anche con lui. La Procura di Napoli predispose una serie di provvedimenti non semplici, Pag. 49perché si autorizzò un documento di copertura e altre attività molto complesse. Nel frattempo avevamo arruolato un geometra di Acerra, che aveva presentato una denuncia contro il comune. Casualmente la Procura ci passò questo atto – ecco quando c’è il colloquio immediato tra Procura e investigatori – ci parlò di questa indagine, ci passò questa denuncia che sembrava irrisoria, noi capimmo il personaggio, lo contattammo e lo convincemmo a lavorare per noi per cui divenne il tramite con la famiglia di Acerra, perché l’estorsione era stata fatta ad Acerra. Chiedemmo un incontro al responsabile della famiglia camorristica di Acerra dove facemmo andare l’ingegner Varricchio il quale espose questa tesi: «I lavori dell’Alta velocità sono lavori complessi, si allargano per centinaia di chilometri, sono molto lunghi. Non è una cosa che possiamo risolvere con un pagamento, ci sono tante ditte coinvolte. Io sono il responsabile del consorzio, parlate con me, noi siamo disposti a pagare, l’importante è che non succeda nulla». Quando il nostro interlocutore sentì questo discorso, disse che occorreva fermarsi perché la cosa era complicata e bisognasse andare dai Casalesi, da Michele Zagaria. Quindi passammo ai Casalesi. Riuscimmo a interloquire con i Casalesi più volte e proponemmo alla camorra questo schema di lavoro. «Siamo disposti a lavorare, vogliamo fare l’opera, l’opera è importante, non diamoci fastidio, troviamo un modo per risolvere la questione». Ci chiesero il 3 per cento dell’importo degli appalti, parliamo di migliaia di miliardi. Gli feci questa proposta. Io dirigevo tutto il lavoro. Il colonnello Paticchio stava fuori sede, ogni tanto veniva, io lo istruivo su quello che facevamo perché nel frattempo avevamo microfonato mezza Campania, avevamo preso il controllo del parcheggio dell’hotel vicino alla Procura, portavamo tutti lì a cena e mentre cenavano microfonavamo le macchine per cui ascoltavamo praticamente tutti. Sapevo quello Pag. 50che succedeva e preparavo Paticchio alle interlocuzioni del giorno successivo. Ci chiesero il 3 per cento degli importi, rispondemmo che il 3 per cento non era possibile perché si parlava di cifre enormi e fare tutto questo «nero» non era possibile. Il successivo passaggio fu un meccanismo al contrario. «Dateci le ditte, noi suddividiamo i lavori tra le vostre ditte, affidiamo loro i lavori e ogni ditta vi storna il suo 3 per cento, così lo diluiamo». Durante questa interlocuzione c’era tutto un altro gruppo di persone che ci giravano intorno. Ci fecero presente che c’era anche un problema politico, perché non si trattava solamente di camorra, dovevamo parlare con i politici. «Siamo qua, non c’è problema» e ci portarono alla regione Campania dal vicepresidente della giunta che ci ricevette. Tutto quello che vi sto dicendo per la prima volta è stato foto-video documentato. Avevamo videocamere – la tecnologia era diversa – dovunque, nelle macchine, anche una valigetta è entrata nella regione Campania a documentare l’incontro. Il vicepresidente della giunta ci disse che era tutto perfetto, solo che c’erano i partiti perché il tracciato passava per tanti comuni e bastava che un sindaco si opponesse e si bloccavano i lavori. Che dobbiamo fare? 3 per cento, tutto documentato. Era sempre Paticchio che parlava per il tramite del lavoro che facevamo. Ci garantì che tutti i partiti avrebbero preso il 3 per cento tranne Rifondazione Comunista e la Lega perché allora non erano nella regione Campania. «Nessun problema» si rispose «però perché non facciamo un incontro con ognuno dei vari responsabili giusto per essere sicuri che siamo d’accordo?». Chiaramente il nostro intento era avere la certezza che non fossero millanterie. «Si può fare». Mentre trattavamo con la camorra, quindi, iniziammo a trattare con tutti i partiti e incontrammo tutti i responsabili dei vari partiti chi a Roma chi a Napoli, tutto video-audio documentato. A loro facemmo lo stesso discorso e Pag. 51gli dicemmo: «Guardate, non vi possiamo pagare questa cifra enorme di denaro in nero. Dateci le vostre ditte, noi diamo loro i subappalti e ognuno vi storna il 3 per cento». «Perfetto, nessun problema» e cominciano ad arrivare gli elenchi. La parte politica fu molto più facile da convincere. I Casalesi invece si fecero delle domande perché tra di loro c’era il braccio destro di Michele Zagaria che aveva il dubbio che questa cosa filasse troppo liscia, fosse troppo tranquilla. Una sera fecero una riunione in un appartamento a Caserta – all’epoca c’era Tele+ ed eravamo riusciti a inserire una telecamera con microfono dentro il decoder di Tele+ per poter riprendere in diretta. Stavano sul divano e fecero tutta una discussione, perché soprattutto quello che si chiamava lo sceriffo – l’onorevole lo ricorderà – diceva che nel caso fossero stati carabinieri, se avessero dato i nomi delle ditte sarebbero stati completamente «fottuti». Allora uno sul divano tra quelli più propensi – tant’è vero che estrapolai questo spezzone e lo portai al signor generale – disse di aver conosciuto qualche generale dei carabinieri, ma che non gli sembravano capaci di fare una cosa simile. Al che chiamarono un avvocato e gli chiesero consiglio. Questo avvocato disse: «Chiedetegli dei soldi perché loro possono procurarsi il denaro ma non possono consegnarvelo. Quando lo consegnano e vi arrestano, al massimo si tratta di estorsione, ne arrestano due, però salvate tutto l’impianto». All’epoca ci chiesero 200 milioni di lire in contanti, richiesta che trasmisi al mio comandante. A me sono arrivati 200 milioni di lire in contanti – faccio riferimento all’onorevole Cafiero perché l’abbiamo vissuta insieme. La Procura di Napoli per la prima volta fece un provvedimento molto articolato perché, grazie, devo dire la verità, al dottor Parrella della Calcestruzzi, quest’ultima, senza andare in consiglio di amministrazione perché altrimenti avremmo disvelato tutto, accettò Pag. 52di versare 200 milioni su un conto corrente della Procura della Repubblica. La Procura sequestrò quei 200 milioni e autorizzò la interposizione di altra somma. Usammo il denaro e organizzammo un incontro a Caserta dove loro si presentarono – noi ascoltavamo tutto per fortuna – con sei macchine e due moto, perché sicuri che eravamo carabinieri. Riuscimmo a pedinarli nonostante fossero con otto mezzi fino a che a mezzanotte non entrarono a Caserta vecchia e cominciarono a correre per le strade. A quel punto chiaramente non potevamo più seguirli. Paticchio era con loro, mi ricordo che quella sera via radio dissi di sospendere il servizio e un mio sottufficiale quando mi chiese: «E Moro?» – era il suo nome di battaglia – risposi: «Al massimo lo vendichiamo domani mattina». Vanno in un appartamento, si guardano, Paticchio tira fuori 200 milioni in contanti, tutti pronti per l’irruzione dei carabinieri. Dopo dieci minuti Paticchio propone di andare a dormire. Questi prendono i soldi e se ne vanno. La mattina dopo Zagaria chiama e dice: «Ingegnere, siete una persona seria, a mezzogiorno al Nuovo Hotel di Caserta Sud vi diamo l’elenco delle ditte» e ci spara tutto l’elenco delle ditte della camorra. Ancora 2-3 minuti prima di concludere per arrivare al perché fu importante. Non contenti di questo proposi un altro meccanismo – questa cosa la facemmo anche con i politici – cioè di chiedere l’autorizzazione a incontrare le singole ditte perché – mi ponevo il problema processuale – un domani la ditta avrebbe potuto dire di stare in un elenco senza sapere niente. Nessun problema. Prendemmo una bellissima suite all’Hotel Terminus a Napoli che riempimmo di microspie e telecamere e convocammo tutti gli imprenditori, quelli segnalati dai politici e quelli segnalati dalla camorra. Nel frattempo facemmo entrare un secondo agente sotto copertura, che era un maresciallo bravissimo, perché bisognava entrare nel tecnicismo degli appalti,Pag. 53al secolo geometra Del Vecchio che a mano a mano che arrivavano chiedeva a ognuno chi lo mandava – Zagaria o un politico. «Che deve fare?» «Mi hanno detto che devo fare il nero», «Come lo fa?» «Così e così». Uno dei più grandi costruttori napoletani, settantenne, uscendo dalla stanza si rivolse al mio maresciallo e gli disse che ci doveva dare la mano perché finalmente avevano fatto una cosa come Cristo comanda con un meccanismo perfetto! Incontriamo tutti, tutto questo nell’arco di sei mesi, non di più.
PRESIDENTE. Colonnello, che anno era?
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. 1996. A un certo punto succede un imprevisto perché, dall’altra parte, il mondo politico che ci aveva segnalato le aziende aveva saputo che avevamo pagato qualcosa e volevano qualcosa, in particolare un personaggio che ci portava in giro. La storia sarebbe lunga. Il problema era che i Casalesi, visto che la cosa funzionava, perché gli avevamo dato 200 milioni a fondo perduto e chiaramente li avevamo persi, ce ne chiesero altri 200. Non ebbi il coraggio di rifare la richiesta al generale. Rispondemmo che glieli avremmo consegnati il giorno dopo al casello di Cassino sud. Loro vennero e chiaramente l’ingegner Varricchio non si presentò e facemmo telefonare loro dicendo che l’ingegner Varricchio aveva avuto un incidente, che era ricoverato in ospedale e quindi non sarebbe potuto venire. Per fortuna la Golf Gti in cui si trovavano l’avevamo microfonata perché alcuni di loro, gente «seria» del settore, dubitarono di questa cosa e dissero che sarebbero andati a trovarlo in ospedale. Quindi si misero in macchina e partirono per Bologna. Chiamarono la segretaria per sapere in quale clinica fosse ricoverato e noi nel frattempo ricoverammo l’ingegner Varricchio. Abbiamo ricoverato il colonnello Paticchio, gli abbiamo Pag. 54anche fatto una dose di anestetico per evitare che potesse essere colto da qualche crisi di riso, lo fasciammo e ingessammo – ci sono le foto, è tutto documentato – e questi arrivarono in ospedale trovando Varrichio, e quindi era «vero». In questo frangente arrivò un maresciallo dei carabinieri in divisa chiedendo loro se fossero stati parenti. Spiegò loro che era una cosa strana in quanto l’ingegnere viaggiava su una macchina molto potente, un’Audi A 6 – che loro conoscevano perché l’avevamo mostrata loro più volte – in cui c’era una valigetta piena di soldi. «Siamo noi, noi siamo i collaboratori». «Andiamo in caserma». Loro si aspettavano che consegnassimo loro i soldi che non avevamo e facemmo un verbale dicendo che però non potevamo consegnare i soldi perché erano stati sequestrati all’autorità giudiziaria a seguito dell’incidente. Questa storia finisce che, non potendo portarla avanti oltre, a un certo punto con la Procura si decise di intervenire, quindi arrestammo un sacco di persone, questa cosa venne rivelata. Finisce che tutta la parte camorristica venne condannata, tutta la parte politica no, perché, nonostante la Procura abbia fatto vari ricorsi, la Cassazione ritenne che mentre l’associazione camorristica preesistesse al nostro arrivo – considerò la presenza più che di un infiltrato di un agente provocatore, se non ricordo male. La Cassazione ritenne che invece la parte politica si fosse organizzata nel momento in cui noi eravamo arrivati, e che su questo presupposto non fossero punibili. Inoltre ritenne che, essendo noi carabinieri e non potendo pagare tangenti, il reato fosse impossibile per cui ci fu tutta una complessa discussione giuridica per cui la parte politica fu assolta. Tutto il resto è stato documentato. La Facoltà di Economia dell’Università Federico II ha inserito questa indagine nel percorso di studio per vari anni. Recentemente è stato più volte citato sia dall’Autorità anticorruzione sia da alcuni magistrati come uno strumento – Pag. 55quello dell’agente infiltrato non provocatore – che la magistratura dovrebbe avere quindi per scoprire questo tipo di reati. È importante perché è stata l’unica indagine di questo tipo che è stata fatta in Italia a mia memoria, ed è stata un’indagine che, al di là degli esiti giudiziari, ha documentato dal vivo – sono depositate agli atti centinaia di ore di video-registrazione – come si comportano la camorra, e la famiglia dei Casalesi ne era la parte più importante, e la politica cattiva nella gestione degli appalti pubblici. Credo che da questo punto di vista sia stato un esempio unico di questa attività.
PRESIDENTE. Indagini molto accurate e geniali sotto un certo punto di vista. È iscritto l’onorevole De Corato.
RICCARDO DE CORATO. Volevo intanto ringraziare sia il generale Mori sia il colonnello De Donno per quello che ci hanno raccontato qui in Commissione, ma soprattutto per aver svolto un ruolo importante nella vicenda di mafia-appalti. Quindi grazie generale e grazie colonnello. Voglio anche ringraziare il generale, avendo seguito «Mani pulite» nel consiglio comunale di Milano in quegli anni, ricordo che il generale Mori, almeno da parte mia, era uno dei più ascoltati perché che ci fosse qualche connessione tra le due vicende ci appariva già chiaro allora. Siccome il generale ha fatto riferimento ad alcune interconnessioni che ci sono state tra l’indagine che faceva il dottor Di Pietro a Milano e quella che veniva fatta a Palermo e in Sicilia da Falcone e Borsellino, volevo chiedere innanzitutto se questi nomi li ricorda e ci può essere da parte sua un riferimento circa questa connessione? A parte Gardini che ovviamente nelle due vicende era abbastanza coinvolto, credo che ci fosse qualcun altro. Siccome ne ha fatto riferimento in un passaggio veloce, ma che io ho colto, non so se lei ne abbia conoscenza, magari anche in seduta segreta, a discrezione del presidente.Pag. 56
Volevo fare altre due domande al generale Mori che riguardano il libro, che è stato citato da un mio collega prima, «L’altra verità», dove, a pagina 252, viene posta una questione che ritengo cruciale da parte degli autori. Dicono gli autori: «Cosa c’è stato dietro il tentativo di squalificare e criminalizzare Mori, De Donno e Subranni con il processo Trattativa?». La domanda è questa generale. Adesso che la vicenda processuale si è conclusa con la sentenza della Cassazione, pensa che ci sia una connessione con l’indagine che vi vedeva impegnati in mafia-appalti? Altra domanda, generale, sempre facendo riferimento al libro «L’altra verità», a pagina 253, alla fine del capitolo 20, ponete forse quella che ritengo la questione più importante di questo libro, e cioè la trattativa Stato-mafia non è quella oggetto del famoso processo annullato in Cassazione. Forse c’è stata un’altra trattativa interna, tutta interna, alle dinamiche politiche nel passaggio alla seconda Repubblica, per garantire la continuità del potere con uno o più architetti, che sarebbe emerso se l’indagine mafia-appalti non fosse stata depotenziata. Sempre a pagina 269 del libro, poi dite: «Abbiamo maturato una precisa idea della vera identità dell’architetto». Domanda: ci può dire almeno a quale mondo questo architetto appartiene o fa riferimento? Preciso che non avete prove per la sua personale individuazione, ma potremmo magari capire dalle sue parole qualcosa di più. Grazie generale.
MARIO MORI, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo. La connessione tra l’indagine milanese «Mani pulite» e quella di mafia-appalti nascono dal fatto che le due inchieste presentavano dei personaggi in comune. Chi erano? Erano personaggi che secondo noi venivano dal Nord. Personaggio-chiave era chiaramente Gardini. Con lui c’era Panzavolta che era l’amministratore delegato di Calcestruzzi e poi c’era quel mondo mafioso che si era inserito nella Calcestruzzi e quindi stabilire Pag. 57il legame preciso tra imprenditoria del Nord e mafia appalti e quindi Cosa nostra. Di Pietro lo ha ammesso anche di recente: non capì inizialmente questo legame. Glielo descrisse per la prima volta Paolo Borsellino durante il funerale di Giovanni Falcone e decisero quindi di proseguire insieme. Chiaramente la morte di Paolo Borsellino ha fatto sì che ciò non avvenisse. Successivamente Di Pietro, sollecitato da Giuseppe De Donno, andò a sentire sia Vito Ciancimino sia soprattutto il geometra Li Pera, il quale gli spiegò come si sviluppava il condizionamento degli appalti. L’intendimento di Di Pietro è noto – lei ha seguito questa indagine – era quello di costringere Raul Gardini ad ammettere che in pratica la provvista della tangente Enimont, che lui aveva creato, provenisse in parte, se non tutta, dalle rimesse mafiose e probabilmente secondo Di Pietro avrebbe ammesso qualcosa. Quella mattina in cui lo doveva sentire, si suicidò. A questo punto si possono fare tutte le ipotesi, ma ripeto quello che ho detto prima al senatore Verini, a me non piacciono le ipotesi perché ho fatto un altro mestiere. Sono veramente come San Tommaso: intanto dico qualche cosa perché l’ho documentato. Anche Di Pietro si fermò di fronte al fatto che Gardini quel giorno non parlò. Dare giudizi ulteriori soprattutto dal punto di vista politico, non mi compete.
Per quanto riguarda le affermazioni che abbiamo illustrato ed espresso nel libro «L’altra verità», anche lì quello che abbiamo dichiarato è scritto e documentato, nessuno ci può contestare quanto abbiamo scritto in questo libro, ma nulla di più di quello che è scritto vogliamo dire perché sarebbe delazione e non sarebbe corretto. Mi limito a questo, non so se De Donno vuole aggiungere qualche cosa.
Circa l’architetto, secondo Vito Ciancimino non è di cosa Nostra, secondo Vito Ciancimino era un politico. Se vuole il mio parere, io mi sono fatto l’idea, ma non gliela dico perché non Pag. 58ho documenti per fare un nome. Ciancimino questo nome ce l’ha fatto, ma siccome non ci sono prove e siccome Ciancimino era un criminale, non possiamo dirlo.
PRESIDENTE. Colleghi, sull’ordine dei lavori. L’Assemblea della Camera vota alle 14 ma ci sono ancora 8 iscritti a parlare. O ammetto un ultimo intervento oppure aggiorniamo immediatamente i lavori, si tratta di mezz’ora di differenza.
Sarete costretti a tornare perché ci sono ancora molte domande.
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. Nessun problema.
PRESIDENTE. Va bene. Consento un ultimo intervento. La parola all’onorevole Provenzano.
GIUSEPPE PROVENZANO. Grazie presidente. Condivido anche le premesse dell’intervento che ha fatto prima il senatore Verini e mi scuso se torno su alcuni aspetti, generale. Aggiungo una premessa, presidente. Credo che chiunque di noi non abbia vissuto da protagonista quella stagione debba avere un profondo rispetto per tutti i protagonisti. Tra le manifestazioni di questo rispetto credo che non rientrino, presidente, le tifoserie da stadio a cui abbiamo assistito in questa Commissione perché rischiano di produrre una strumentalizzazione politica che non sono convinto possa portare particolari benefici non solo ai lavori di questa Commissione, ma anche agli autori stessi di questa strumentalizzazione.
Generale, se non sbaglio, sia lei sia il dottor De Donno avete in qualche modo giustificato il silenzio tra il 1993 e il 1997 sull’indagine mafia-appalti, con, se capisco bene, un deterioramento delle relazioni politiche ambientali con le Procure di Palermo e di Catania. Se però era forte in voi, scusate se ci Pag. 59torno, il convincimento che questa fosse la causale che spiegava la strage, come mai in quegli anni – sono stati quattro anni tra il gennaio del 1993 quando sono iniziati gli interrogatori di Ciancimino, che voi stessi avete sollecitato con la Procura, e il pentimento di Siino – non vi siete attivati, non dal punto di vista della polizia giudiziaria, su cui posso capire che vi fossero quei problemi ambientali che avete ricostruito, ma con altri canali, come avevate fatto per esempio nel caso della Ferraro, cioè con gli uomini con cui avevate combattuto dalla stessa parte o addirittura in maniera formale con esposti, eccetera? Questa è la prima domanda sulla quale vorrei tornasse.
Non penso che in questa Commissione dobbiamo rifare i processi che vi hanno visto imputati e che hanno visto un esito molto chiaro e non penso nemmeno che però in questa Commissione occorra fare la storia investigativa o la storia giudiziaria di una singola Procura, anche perché è difficile non inserire la strage di via d’Amelio in una sequenza di avvenimenti tragici che hanno segnato la storia d’Italia e la storia della nostra democrazia. Il compito di questa Commissione, io credo, dovrebbe essere quella di ricostruire il contesto storico-politico in cui maturano le scelte o le mancate scelte delle istituzioni nel contrasto alla criminalità mafiosa e che possono illuminare ancora oggi la nostra strategia di contrasto alla mafia. Alla luce degli elementi di continuità profondi che lo specifico fenomeno criminale mafioso porta dalle sue origini a oggi, tra questi c’è una indefettibile connessione tra la mafia e la politica. Come diceva Pio La Torre, la mafia è un fenomeno di classi dirigenti e quindi bisogna discutere di classi dirigenti. Come diceva Paolo Borsellino, che abbiamo ripetutamente richiamato qui oggi, mafia e politica sono due poteri che insistono sullo stesso territorio: o si fanno la guerra o si mettono d’accordo. E allora, generale, io le chiedo di tornare, insisto, su alcune domande che Pag. 60le ha posto il senatore Verini alle quali lei si è sottratto dicendo che dal suo punto di vista non è rilevante quello che pensa lei, ma lo lasci dire a questa Commissione se è rilevante o no. Innanzitutto, mi lasci dire, non siamo dei magistrati e la regola di san Tommaso qui non vale, ma, anche a far valere la regola di san Tommaso, è difficile immaginare che dal suo osservatorio lei non vedesse cosa è accaduto nelle elezioni del 1987, che giudizio ha dato su quella stagione a Palermo, che significato ha avuto in una transizione politica profonda nel nostro Paese l’omicidio di Salvo Lima, quali erano gli interlocutori e i riferimenti che in quella fase si stavano attivando a Palermo. Lei era lì, non si può dire che non vedesse dall’osservatorio in cui è stato, a meno che, ma farei un torto alla sua intelligenza e alla sua conoscenza del fenomeno mafioso, lei non pensasse che il ruolo che la politica ha nel rapporto con la mafia sia esclusivamente quello di erogatrice di appalti, ma credo che così non sia. Da questo punto di vista, allora, le chiedo, soprattutto, quale legame a suo avviso rimarrebbe tra la strage di Capaci e quella di via d’Amelio, tra la strategia terroristico-mafiosa e le stragi di via dei Georgofili, via Palestro, gli attentati a Roma. Anche qui – non se la prenda se anticipo la sua risposta – difficilmente può essere mafia-appalti. L’ultimissima cosa, a proposito delle stragi, le chiedo se anche in altre funzioni, non quelle di polizia giudiziaria, non quelle del ROS, ma per esempio al SISDE, lei ha avuto modo di entrare in contatto con i fratelli Graviano direttamente o indirettamente.
PRESIDENTE. Onorevole Provenzano, fermo restando che tutte le domande sono legittime, lei non può dire al generale come deve rispondere, se lui non vuole dare un suo punto di vista.
GIUSEPPE PROVENZANO. Non ho detto come deve rispondere, ha chiesto di rispondere e di valutare noi.
PRESIDENTE. Onorevole, lei ha questo vizio che quando io parlo, mi parla sopra. Deve imparare che chi presiede non interrompe e non vuole essere interrotto. Quando ha imparato questo, poi mi risponde se mi vuole rispondere. Siccome questa audizione fin qui è sempre stata corretta, le dico intanto che i qui presenti non sono sottoposti a nessun interrogatorio, quindi è loro libertà decidere se rispondere o meno; secondo, che non è carino imboccare gli auditi con delle risposte, fermo restando che loro sono qui per indicare quale fosse il motivo per cui Borsellino indicò la Procura di Palermo come «nido di vipere» e non per fare suggestioni sull’allora situazione politica. Quindi, ferma restando la liceità di tutte le domande, la prego di avere rispetto delle risposte che vogliono o non vogliono dare. Ciò vuol dire che è mio dovere, come ho fatto in altre occasioni, mantenere il motivo dell’audizione. Prego, generale Mori.
GIUSEPPE PROVENZANO. Mi lasci dire.
PRESIDENTE. Sempre io la do la parola però, onorevole Provenzano, lei me la chiede e io gliela do, non se la prende da sé, perché funziona così.
GIUSEPPE PROVENZANO. Presidente, credo o di essermi spiegato male o lei non ha ascoltato perché io ho precisato non il modo in cui doveva rispondere il generale. Mi sono limitato a chiedere di non sottrarsi a una valutazione che ritengo possa essere rilevante per questa Commissione, così come ho specificato che noi non siamo magistrati.
PRESIDENTE. Facciamo che ho capito male io, preferisco aver capito male io, fermo restando che loro sono liberi di rispondere come credono.
GIUSEPPE PROVENZANO. Mi atterrò a ciò che lei ritiene carino nell’andamento dei lavori di questa Commissione. Non credo che lo siano il tifo e gli applausi.
PRESIDENTE. Ancora? Mi sono pentita di aver voluto prolungare questa audizione perché dimostrate ancora una volta di non voler un clima teso a raggiungere la verità. Non mi fa ridere senatore Verini! Prego generale. Rispondete come credete ovviamente. Ora basta, grazie. La parola al generale Mori.
MARIO MORI, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo. Delle due domande, rispondo a quella di carattere politico perché sulla parte tecnica potrà rispondere meglio e più di me Giuseppe De Donno. Lei ha detto che, rispondendo al senatore Verini, non ho risposto. In effetti è vero e le dico anche perché. Perché su queste vicende siamo ancora molto indietro rispetto alla verità, tant’è vero che c’è ancora la Commissione antimafia. Ma perché devo fare io una valutazione politica a lei che è un politico su problemi che non mi riguardano? Io faccio l’operativo e il mio l’ho fatto, e l’ho fatto bene, molto bene, quindi mi faccia tutte le domande sulle attività che ho svolto, le risponderò. Sulla parte politica non le rispondo perché non mi compete e la domanda è provocatoria.
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. Onorevole, brevissimamente. Lei chiedeva che cosa abbiamo fatto dal 1993 al 1997. Intanto a Catania il Procuratore della Repubblica ci ha tolto le deleghe e quindi le indagini non le potevamo più fare. Anche in una recente intervista del senatore Scarpinato, fatta in un programma che citava prima il generale, il parlamentare diceva che la polizia giudiziaria fa le intercettazioni, il PM non legge i brogliacci e si limita a leggere quello che gli manda la polizia giudiziaria e quindi se non gli manda le cose, è colpa della polizia giudiziaria. Non mi pare che il codice di procedura penale dica questo. È sempre facile scaricare sulla polizia giudiziaria. Ci dimentichiamo di una Pag. 63cosa: che il dominus delle indagini dalla riforma del 1989 è il pubblico ministero. Se il Procuratore della Repubblica di Catania mi toglie la delega io che devo fare? Quando a Palermo dopo gli arresti del 1993 abbiamo fatto delle altre attività e la procura di Palermo non mi delegò le indagini, io che cosa dovevo fare? Cosa ho fatto? Io l’ho fatto: ho avuto il coraggio di andare alla Procura della Repubblica di Caltanissetta e scrivere 50 pagine di verbale. Ho denunciato i magistrati di Palermo, l’ho messo per iscritto assumendo le mie responsabilità. Penso che nessun ufficiale di polizia giudiziaria in Italia abbia fatto quello che ho fatto io. Sono andato in Procura a Caltanissetta e ho messo a verbale quello che pensavo. L’ho fatto. C’è stato un processo: giustamente il GIP di Caltanissetta ha assolto tutti quanti, perché tra l’altro alcuni magistrati della Procura di Palermo mi hanno querelato per diffamazione. Più che denunciarlo a un’autorità giudiziaria, che dovevo fare? Quando abbiamo capito che non c’era possibilità di fare nient’altro, perché oltre questo non vedo che cosa potevamo fare, ci siamo trasferiti, ma non è che ce ne siamo andati in vacanza, siamo andati a Napoli, dove la procura di Napoli ci ha accolto. Quello che ho raccontato poco fa è stata una delle attività che abbiamo fatto, tra l’altro con l’onorevole presente qui in aula. Non è che noi ce ne siamo andati, non mi hanno messo in condizione di lavorare.
1997. Si pente Siino, la Procura di Palermo non mi chiama, delega le indagini alla Guardia di finanza, è un suo diritto. L’onorevole Cafiero penso che possa confermare che, quando si prende un arrestato in un’operazione, in genere viene dato alla forza di polizia che ha proceduto, ma non per un piacere, ma perché si presume che la forza di polizia che lo ha indagato e lo ha arrestato ne sappia molto più di tutti quanti gli altri, e Siino non ce l’hanno fatto toccare. Una regola non scritta, per Pag. 64carità, la Procura può delegare chi vuole, ci mancherebbe altro, ma quando il generale chiama il Procuratore Caselli e gli dice che De Donno aveva parlato con Siino e che c’erano le relazioni di servizio. «Le vuoi?». Caselli dice no. Ci convoca a Torino e ci prende a verbale in due stanze separate con quattro magistrati, ma che dovevamo fare più di questo? Tutte le altre deleghe, le stragi: lo chieda ai magistrati di Caltanissetta. Perché nel gruppo di indagine sulle stragi il ROS è stato delegato solamente in parte? Non ci hanno chiamato, non ci hanno fatto indagare, hanno delegato il gruppo di indagine Falcone-Borsellino. Benissimo, è stata una scelta loro. Penso che da parte nostra più di questo non potevamo fare.
PRESIDENTE. Grazie mille. Il seguito dell’audizione è rinviato a una prossima seduta.
La seduta termina alle 13.
16.4.2025 RESOCONTO STENOGRAFICO Seduta n. 79 di Mercoledì
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso nonché via streaming sulla web-tv della Camera dei deputati.
Audizione di Mario Mori, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo, e di Giuseppe De Donno, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo, nell’ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D’Amelio.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di Mario Mori, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo, e di Giuseppe De Donno, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo, nell’ambito del filone di inchiesta sulla strage di via d’Amelio.
Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell’audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione, e che i lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell’audito o dei colleghi. In tal caso, non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web-tv.
Prima di dare la parola agli auditi, comunico a tutti che, come da intesa raggiunta nell’ufficio di presidenza, nella seduta di oggi procederemo alla sola audizione degli auditi, anche perché consegneranno della documentazione e quindi le domande saranno rivolte in un’altra seduta.
Nel dare direttamente la parola al generale Mori, voglio prima ringraziarlo per la sua cortesia e per la sua disponibilità ad essere qui.
MARIO MORI, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo. Saluto tutti e ringrazio per l’opportunità che ci viene concessa.
La relazione verterà sulla nostra attività svolta in Sicilia nei confronti dell’organizzazione criminale di cosa nostra. Questo intervento, con l’autorizzazione della Commissione, si articolerà come segue: farò una breve premessa, poi cederei la parola a Giuseppe De Donno, che è colui che materialmente ha fatto le indagini, e poi vorrei concludere io con delle considerazioni su quanto avrà detto il dottor De Donno.
PRESIDENTE. Va bene.
MARIO MORI, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo. Dati i tempi molto ristretti, noi abbiamo preparato un documento completo che, se la Commissione vuole, possiamo consegnare.
PRESIDENTE. Il regime è libero?
MARIO MORI, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo. Libero.
PRESIDENTE. Prego, generale.
MARIO MORI, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo. Ho assunto il comando del gruppo di Palermo il 22 settembre 1986. Non avevo mai svolto servizio in Sicilia. Provenivo da un incarico nello Stato maggiore dell’Arma, mi ero formato sul piano operativo e avevo anche fatto parte del Nucleo speciale di polizia giudiziaria del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. In quel tipo di reparto si era capito che per il contrasto alla criminalità organizzata doveva essere fatta una strategia generale, con linee ben precise di intervento, e quindi nulla veniva lasciato al caso.
Arrivato a Palermo, mi trovai di fronte a una situazione dove, invece, tutti gli organi di polizia giudiziaria vivevano alla giornata, senza avere delle linee strategiche e operative ben definite. Si puntava al risultato immediato, certamente più facile da ottenere, ma senza alcuna prospettiva in seguito. Ebbi la conferma di questo difetto di impostazione quando dopo pochi mesi – chi è stato a Palermo lo sa – realizzammo un’ottima operazione dei servizi e arrestammo i Madonia, Francesco Madonia con i suoi figli Giuseppe e Nino. Tutti e tre latitanti, tutti e tre poi colpiti da una serie di ergastoli perché responsabili di una serie di omicidi, tra cui quelli cosiddetti «eccellenti», dal consigliere Rocco Chinnici al capitano Basile, al generale dalla Chiesa, al dottor Ninni Cassarà.
Dopo quattro mesi da questa operazione, facendo i conti, eravamo al punto di partenza. Non eravamo riusciti cioè a entrare nel sistema e dovevamo ricominciare da capo. Ci rendemmo conto che il metodo era sbagliato e bisognava colpire nell’essenza cosa nostra.
Individuai quest’essenza non tanto nel pizzo, che provocava introiti molto modesti, tutto sommato, ma nel condizionamento degli appalti lo strumento con cui si poteva attaccare cosa nostra, la quale temeva non tanto la cattura anche di un Madonia, che era comunque vicinissimo a Totò Riina, ma che fossero scoperti i collegamenti esterni tra cosa nostra e il mondo, la società, e soprattutto che venisse attaccato il sistema economico di cosa nostra.
Questo tipo di attacco, tra l’altro, per noi era più agevole, perché normalmente cosa nostra opera in maniera indipendente e senza relazioni con l’esterno, ma nel condizionamento degli appalti per forza di cose doveva rapportarsi con una serie di persone che erano fuori dal suo mondo, quindi era più facile per noi intervenire. Su queste basi decisi di costituire un reparto che non era previsto nell’ordinamento del mio comando, ma lo creai con lo scopo preciso di realizzare questo attacco alle strutture economiche di cosa nostra. Individuai poi non nei vecchi ufficiali, delusi e poco reattivi, ma nei giovani la possibilità di sviluppare questo tipo di reparto. Individuai così in Giuseppe De Donno chi doveva fare questo tipo di indagine.
Lascio quindi la parola a Giuseppe De Donno per quanto riguarda lo sviluppo dell’indagine che poi giornalisticamente prenderà il nome di «Mafia e appalti».
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. Signor presidente, grazie e grazie a tutti i commissari.
Io arrivo a Palermo nel settembre del 1986, dopo il transito dalla Scuola ufficiali carabinieri.
Nel 1987 l’allora colonnello Mori mi chiese di transitare al gruppo Palermo 1, e venni trasferito al Nucleo operativo della compagnia di Bagheria, e l’anno successivo al Nucleo operativo del Reparto operativo del comando carabinieri Palermo 1, alla Sezione omicidi. In questo frangente iniziai la collaborazione col dottor Falcone, perché con lui eravamo già stati una volta in Spagna a seguito dell’arresto di un latitante mafioso, tale Ribaudo Gioacchino, che era considerata una delle persone di fiducia di Michele Greco detto «il Papa».
Con il dottor Falcone poi ho svolto una serie di missioni all’estero. Sono stato con lui in Argentina, in Australia, in Germania, in Messico e in altri Paesi. Il 3 dicembre 1990, quando venne costituito il ROS, io sono transitato al ROS fino al 2001, poi, con un intermezzo di una permanenza in Cile, sono andato al SISDE, l’attuale AISI, quale capo ufficio segreteria del generale Mori.
Nel marzo 1989 il sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, Alberto Di Pisa, aveva in corso un’inchiesta relativa a un comitato di affari volto alla gestione di appalti diretto da politici della Democrazia cristiana, Vito Calogero Ciancimino e Salvo Lima, d’intesa con l’imprenditore tale Francesco Vassallo. Sulla base di queste indagini che io svolsi il magistrato dispose la perquisizione degli uffici del comune di Palermo.
Ero stato destinato al Nucleo operativo di Palermo per mettere in pratica il progetto mirato voluto dal generale Mori di contrastare l’illecito negli appalti pubblici. Perquisizione durante, nella cassaforte del dottor Leoluca Orlando, all’epoca sindaco di Palermo, venne rinvenuta, da lui vistata, una lettera dell’Alto commissario antimafia, il prefetto Riccardo Boccia, regolarmente protocollata, nella quale lo si informava del fatto che dietro alle imprese COSI e SICO – erano due aziende romane, la Cozzani e Silvestri e Silvestri e Cozzani, due raggruppamenti temporanei di impresa – che risultavano aggiudicatarie di appalti per la manutenzione delle strade e degli edifici pubblici della città di Palermo vi era il sospetto della presenza di Vito Calogero Ciancimino.
Interrogato su queste concessioni da lui rilasciate, il sindaco Orlando non fornì alcuna giustificazione e venne in quella sede indagato. Incidentalmente rilevo come l’inchiesta del dottor Di Pisa fosse ampiamente nota a Palermo.
In merito, il dottor Falcone ne tratterà al Consiglio superiore della magistratura il 15 ottobre 1991, quando venne chiamato a difendersi proprio dalle accuse di tenere nei cassetti le carte degli appalti, accuse che gli mosse il sindaco Orlando. In quel contesto, il dottor Falcone così si espresse: «Nonostante la presenza di un sindaco come Orlando, la situazione degli appalti continuava ad essere la stessa e Ciancimino continuava ad imperare sottobanco in queste vicende. Difatti, sono stati arrestati non solo Ciancimino, Pag. 7ma anche Romolo Vaselli e Domenico Vaselli. Vaselli è il factotum a Palermo di Vito Ciancimino per quanto attiene alle attività imprenditoriali. Devo dire che probabilmente Orlando e i suoi amici hanno preso come un inammissibile affronto alla gestione dell’attività amministrativa del comune un mandato di cattura che in realtà si riferiva ad una vicenda che riguardava episodi di corruzione molto seri, molto gravi, riguardanti la gestione del comune di Palermo». Il provvedimento a cui faceva riferimento il dottor Falcone era quello da lui emesso nei confronti di Vito Ciancimino.
Noi arrestiamo due volte Vito Ciancimino e una serie di funzionari, insieme col dottor Falcone. Il 26 maggio 1989, in San Nicola l’Arena, personale della Polizia di Stato arresta due esponenti mafiosi, Salvatore Contorno e Gaetano Grado. All’epoca ai due, facenti parte della fazione perdente nella seconda guerra di mafia, verranno successivamente attribuiti una serie di omicidi verificatisi in quei mesi in danno di appartenenti al gruppo vincente dei corleonesi.
Subito sorsero delle polemiche perché il Contorno, nella sua veste riconosciuta di collaboratore di giustizia, si sarebbe dovuto trovare sotto protezione negli Stati Uniti.
Nei primi giorni del successivo mese di giugno, giunsero a varie autorità palermitane una serie di lettere anonime, giornalisticamente definite le «lettere del Corvo», nelle quali si accusavano i magistrati Giovanni Falcone e Giuseppe Ayala, oltre al dirigente della Polizia di Stato Gianni De Gennaro, di avere organizzato il rientro del Contorno in Sicilia, consentendogli di compiere le sue vendette in cambio di notizie sui latitanti di spicco di cosa nostra.
Le indagini svolte dalla procura della Repubblica di Caltanissetta, sulla base di un prelievo di impronte digitali acquisite senza le previste garanzie procedurali da personale del SISMI, all’epoca servizio segreto militare, attivato dall’Alto commissario antimafia pro tempore prefetto Domenico Sica, attribuirono la responsabilità degli anonimi al dottor Di Pisa, che venne indagato.
La notizia creò un caso di rilevanza nazionale e conseguentemente al magistrato vennero sottratte tutte le indagini che stava svolgendo a Palermo, compresa quella connessa con gli appalti del comune di Palermo. Condannato in primo grado nel 1992, il dottor Di Pisa venne poi assolto per non aver commesso il fatto nel 1993.
In sostanza, però, il caso delle lettere del Corvo determinò la mancata prosecuzione delle indagini sul sindaco Orlando, posto che, per quanto mi è ancora noto a tutt’oggi, da allora l’inchiesta che lo riguardava non ha avuto nessuno sviluppo. Noi non ottenemmo nessun’altra delega né siamo stati capaci di capire quel fascicolo, dopo l’uscita di scena del dottor Di Pisa, dove andò a finire.
Il 13 giugno 1989 venne ucciso a Ventimiglia di Sicilia un indiziato mafioso, La Barbera Barbaro. Le indagini che io condussi dal Nucleo operativo di Bagheria indirizzavano l’inchiesta nell’area di Baucina, altro comune della provincia di Palermo. Emergeva che La Barbera, in contrasto con Giuseppe Pinello, capomafia del luogo, in quanto entrambi interessati dall’illecita gestione degli appalti, erano tutti e due indirizzati alla gestione dei comuni di quella zona.
Apparve chiaro, quindi, che quella famiglia mafiosa, in relazione all’assegnazione degli appalti, condizionava l’attività del professor Giuseppe Giaccone, un docente di biologia marina dell’Università di Catania divenuto sindaco del comune di Baucina.
Il 28 giugno 1989 il dottor Falcone venne nominato procuratore aggiunto della Repubblica a Palermo, dopo una serie di attriti con il dottor Meli sulla modalità di azione del pool antimafia.
Nel successivo mese di agosto 1989 il magistrato incriminò il mafioso catanese Giuseppe Pellegriti e l’estremista di destra Angelo Izzo per le accuse allora rivolte al senatore Giulio Andreotti e a Salvo Lima.
La decisione, tecnicamente obbligata, provocò però le critiche di esponenti politici e giornalistici quali Leoluca Orlando, Carmine Mancuso, Alfredo Galasso e Nando dalla Chiesa. In particolar modo, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando attribuiva al magistrato la volontà di insabbiare queste indagini e il coinvolgimento dei politici nei delitti eccellenti dell’epoca. Per queste accuse, formulate attraverso un esposto, il 15 ottobre 1991 il dottor Falcone sarà costretto, come abbiamo detto, a difendersi davanti al CSM. Nel frattempo, i contrasti sorti col dottor Giammanco dopo la nomina di quest’ultimo nel giugno 1990 a procuratore della Repubblica di Palermo, indussero il dottor Falcone ad accettare, nel febbraio 1991, la nomina a direttore dell’Ufficio Affari penali al Ministero di giustizia propostagli all’epoca dal Ministro Claudio Martelli.
L’11 luglio 1989 noi consegnammo al sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Giuseppe Ayala, il rapporto di denuncia per Giuseppe Pinello + 49, con le accuse di associazione a delinquere di tipo mafioso, turbativa d’asta, estorsioni ed altro. Nello sviluppo delle indagini, emersero i contatti della mafia di Baucina con quella palermitana e nella fattispecie con Cataldo Farinella, imprenditore legato a cosa nostra in diretti rapporti con il senatore Salvo Lima.
Contestualmente, dalle prime intercettazioni telefoniche effettuate, emerse la figura di Angelo Siino, che si connotava immediatamente come uno degli elementi di raccordo tra mafia e imprenditoria, in contatto con ambienti politici ed imprese nazionali e locali.Pag. 10
Il 15 settembre viene ucciso a Baucina l’imprenditore Giuseppe Taibbi.
Il successivo 19 settembre 1989 il sindaco di Baucina Giuseppe Giaccone, temendo per la sua vita, inizia la collaborazione con noi carabinieri, venendo successivamente inteso dal dottor Falcone, a cui spiega i motivi dell’omicidio Taibbi, da lui collegato alla illecita gestione degli appalti pubblici, spiegandone le modalità di gestione a livello regionale.
Risultava la singolare associazione, per lavori di scarsa rilevanza tecnica ed economica, tra la modesta impresa del Taibbi e un colosso nazionale nel settore delle costruzioni, la società romana Tor di Valle di Piero Catti De Gasperi, genero di Alcide De Gasperi.
Giuseppe Giaccone, che, come previsto dalle disposizioni normative dell’epoca, era stato affidato alla protezione dell’Ufficio dell’Alto Commissario per la lotta alla mafia, appena giunto a Roma ritrattò tutte le dichiarazioni fatte agli investigatori palermitani e al dottor Falcone e denunciò, per essere stato costretto a mentire, oltre che me anche il dottor Falcone e il suo avvocato, il senatore Pietro Milio.
Per le accuse formulate noi chiaramente fummo assolti e il dottor Giaccone riceverà una condanna a un anno e sei mesi per calunnia.
Il 6 ottobre 1989 il giudice istruttore di Palermo, dottor Leonardo Guarnotta, nel prosieguo delle indagini autorizza l’intercettazione dell’utenza telefonica intestata al Consorzio CEMPES, acronimo che stava per Collettore emissario della città di Palermo zona est, e del quale facevano parte, oltre alla Tor di Valle, la Fortunato-Federici di Roma e la CISA di Udine. Fra i soci di quest’ultima vi erano gli imprenditori Antonino Buscemi, che troveremo poi dopo, e Cataldo Farinella.
Con questo atto inizia formalmente quella che viene chiamata indagine «Mafia e appalti».
Il 5 giugno 1990, a conclusione di altre indagini da me condotte, coordinate dal dottor Falcone, vennero tratti in arresto Vito Ciancimino, suo genero Loris Ercoli, il costruttore romano Romolo Vaselli, socio occulto del sindaco, ed altri funzionari accusati di associazione a delinquere, abuso d’ufficio, turbativa d’asta per alcuni appalti dell’azienda municipalizzata del comune di Palermo.
Il 19 giugno 1990 il dottor Giammanco diviene procuratore capo della Repubblica di Palermo.
Il 22 maggio 1990, nel corso di un’audizione in Commissione parlamentare antimafia, mentre tutti gli altri magistrati del distretto palermitano rivolgono la loro attenzione alla descrizione delle indagini in corso su cosa nostra, illustrando gli sforzi nella ricerca dei latitanti, il dottor Falcone indirizza specificatamente la sua relazione sulla problematica degli appalti pubblici affermando: «Sono vicende che stanno venendo a maturazione adesso per effetto di indagini che sta conducendo l’Arma dei carabinieri; indagini complesse che richiedono una serie di esami della documentazione contabile estremamente ardui. Abbiamo la conferma di un sistema mafioso che, per quanto concerne i grandi appalti anche nei piccoli centri per tutti gli appalti, ne gestisce in pieno l’esecuzione». Disse ancora: «Possiamo ritenere abbastanza fondato che c’è, almeno nella Sicilia occidentale, una centrale unica di natura sicuramente mafiosa che dirige l’assegnazione degli appalti e soprattutto l’esecuzione degli appalti medesimi con l’inevitabile coinvolgimento delle amministrazioni locali sia a livello burocratico che a livello di alcuni amministratori».
Il 3 dicembre 1990 nasce il Raggruppamento operativo speciale e il generale Antonio Subranni diventa comandante.
Il 20 febbraio 1991 io consegno al dottor Falcone, quale procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, un’annotazione a firma del colonnello Mario Mori datata 16 febbraio 1991, conosciuta poi come «Mafia e appalti», composta da 877 pagine, 483 allegati e 44 schede relative a persone coinvolte nelle indagini. Il documento costituiva il compendio di tutta l’attività investigativa eseguita su questo settore fino a quel momento. Il magistrato che ne aveva sollecitato il deposito prima del suo incarico al Ministero di grazia e giustizia rimetteva personalmente l’annotazione al procuratore Giammanco.
In precedenza, poiché siamo stati più volte accusati di aver omesso nell’informativa del febbraio 1991 tutta la parte politica che era venuta fuori, parecchie persone che ancora sostengono questo dimenticano che nel quadro di queste indagini io avevo consegnato al dottor Falcone e ai dottori Guido Lo Forte e Giuseppe Pignatone, co-assegnatari dell’indagine Mafia e appalti, una serie di annotazioni preliminari, in due delle quali, quelle del 2 luglio e del 5 agosto 1990, si delineavano i rapporti relativi a responsabilità di personalità politiche nazionali e regionali in merito alle quali noi richiedevamo la necessità di svolgere più approfonditi accertamenti. È il motivo per cui nell’informativa del 16 febbraio non sono citate le parti politiche.
Tengo a dire che su questo aspetto specifico, che noi ritenevamo fosse il centro di questa indagine, non riceveremo mai una delega di indagine da parte della procura della Repubblica di Palermo. L’11 marzo il colonnello Mori e io incontriamo il dottor Falcone in preparazione di un intervento a un convegno organizzato dall’Alto Commissario per la lotta alla mafia che si doveva svolgere a Palermo. Il magistrato in questa circostanza chiese al colonnello Mori di andare a incontrare il senatore Gerardo Chiaromonte, presidente della Commissione parlamentare antimafia, a cui aveva accennato le finalità delle nostre Pag. 13indagini per spiegargli genesi, sviluppo e prospettiva dell’inchiesta.
Il 14 marzo, a circa un mese dalla consegna dell’informativa al dottor Giovanni Falcone, questi, intervenuto a un convegno a Castello Utveggio a Palermo sul tema «Infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici», afferma che il condizionamento mafioso negli appalti si realizzava sia al momento della scelta delle imprese che nella fase esecutiva, con caratteristiche totalizzanti, cioè senza escludere nessuna impresa, neanche quelle del continente.
Il magistrato, in una successiva circostanza pubblica, pronuncerà la frase «la mafia è entrata in Borsa», volendo significare che l’organizzazione mafiosa in campo economico era passata da una funzione esclusivamente parassitaria all’assunzione di iniziative anche dirette rapportandosi con il mondo politico e gli ambienti imprenditoriali.
A tale riguardo il dottor Falcone aggiungeva che, viste le dimensioni, le indagini andavano svolte a livello nazionale. Non va dimenticato un dato fondamentale, che nell’informativa del 16 febbraio 1991 noi rassegniamo alla procura di Palermo la prova che la famiglia Buscemi di Passo di Rigano era diventata socia della Calcestruzzi Spa.
La Calcestruzzi Spa era praticamente l’impero Ferruzzi di Raul Gardini. Noi, quindi, troviamo la prova che la mafia corleonese era entrata nel gruppo Ferruzzi. Questo è il motivo per cui il dottor Falcone indica l’entrata in borsa di cosa nostra. Questa affermazione troverà successiva conferma poi nelle dichiarazioni di Angelo Siino, quando l’11 luglio 1997, dopo aver deciso di collaborare, di fronte alla corte d’assise di Caltanissetta, sosterrà che negli anni Ottanta la mafia diventa imprenditrice perché comincia a gestire direttamente l’aggiudicazione degli appalti ad imprese a lei vicine e poi a tappeto Pag. 14comincia a gestire lavori conto terzi, subappalti e praticamente mette il pizzo sul pizzo: lo 0,80 per cento a discapito della tangente politica.
Il 22 marzo il colonnello Mori incontra a Roma il senatore Chiaromonte e nelle linee generali gli descrive l’indagine gestita dal dottor Falcone.
Il 4 aprile 1991 il generale Subranni e il colonnello Mori svolgono un incontro con il procuratore della Repubblica Pietro Giammanco e con i sostituti Lo Forte, Pignatone, Giusto Sciacchitano, assegnatari dell’inchiesta Mafia e Appalti.
Nella circostanza gli ufficiali del ROS sollecitarono iniziative in merito a quell’indagine per la quale, a più di quaranta giorni dal deposito dell’annotazione, non erano state ancora concesse deleghe, mentre alcuni giornali inopinatamente già parlavano del contenuto dell’operazione svolta, ipotizzando divergenze tra la procura e i carabinieri del ROS.
Il 13 aprile nasce il settimo Governo Andreotti con Vincenzo Scotti Ministro dell’interno, Claudio Martelli Ministro della giustizia e Calogero Mannino destinatario per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Il 2 luglio 1991 io consegno alla procura di Palermo una prima annotazione sulle attività della società SIRAP, acronimo che stava per Siciliana incentivazioni reali per attività produttive, ente costituito dalla Regione Siciliana per lo sviluppo economico e industriale dell’isola. Ad iniziare dal successivo 26 luglio la procura di Palermo mi conferirà alcune deleghe di indagine su questa attività. Gli accertamenti produrranno una ulteriore informativa, su cui torneremo tra poco, che noi consegneremo il 5 settembre 1992.
Il 9 luglio 1991 la procura di Palermo, senza preavviso, come sarebbe stata prassi costante, senza quindi preavvisare l’organo di polizia giudiziaria precedente, cioè il ROS, che nella sua Pag. 15annotazione del 16 febbraio aveva evidenziato, come già ricordato, quarantaquattro posizioni ritenute penalmente rilevanti, chiede ed ottiene dal GIP cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettante persone coinvolte nell’indagine Mafia e appalti.
Gli arrestati sono Angelo Siino, indicato come uomo di collegamento e successivamente soprannominato «il Ministro dei lavori pubblici di cosa nostra», gli imprenditori siciliani Alfredo Falletta, Cataldo Farinella e Serafino Morici, oltre al geometra Giuseppe Li Pera, capoarea della Sicilia per l’impresa di costruzione Rizzani De Eccher di Udine. Il successivo maggio 1992 verrà disposto per loro il rinvio a giudizio per 416-bis ed altro. Nella stessa giornata del 9 luglio si svolge un’ulteriore riunione tra gli ufficiali del ROS e i magistrati. Al termine di questa riunione la procura della Repubblica emette addirittura un comunicato stampa nel quale si afferma che nell’incontro sono stati esaminati gli importanti risultati già acquisiti nelle indagini in corso, specie in ordine all’infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti, anche al fine di ulteriori iniziative da assumere. Tuttavia, in realtà, i contrasti evidenziati nella precedente riunione del 4 aprile risultavano maggiormente cresciuti.
Noi investigatori dell’Arma, infatti, ritenevamo che sulla base dei dati ottenuti altri soggetti, in particolare alcuni dirigenti delle grandi imprese nazionali, fossero da ritenere coinvolti a pieno titolo nelle vicende connesse al condizionamento illecito degli appalti in Sicilia e quindi, come quelli siciliani, meritevoli di analoghi provvedimenti restrittivi.
Dopo gli arresti del 9 luglio e alla scontata illecita richiesta della difesa degli arrestati, invece di depositare, come è prassi, il testo dell’annotazione del ROS con i relativi omissis per i numerosi aspetti che avrebbero dovuto o potuto avere successivi Pag. 16sviluppi investigativi, la procura di Palermo consegna ai difensori l’intero documento. Quindi, dopo solo cinque giorni tutta Palermo, cosa nostra compresa, sapeva dove eravamo giunti, da dove eravamo partiti, ma soprattutto dove potevamo andare.
Il 12 luglio 1991 la procura di Palermo assume un’altra decisione che noi contrastiamo, ma sulla quale chiaramente non abbiamo nessun potere, perché a firma del dottor Giammanco si smembra l’indagine Mafia e appalti e invia alle procure di Agrigento, Caltanissetta, Marsala e Trapani stralci dell’annotazione del 16 febbraio 1991.
L’iniziativa, oltre a frammentare l’inchiesta suddividendola tra vari uffici giudiziari diversi, ne rifiuta l’impostazione unitaria e quindi sottende già l’evidente intenzione di chiudere il procedimento.
Il 15 gennaio 2021 nel processo intestato a Mario Bo + 2, noto come il famoso depistaggio delle indagini di via d’Amelio relative alle attività compiute dal gruppo Falcone e Borsellino, il teste Antonino Ingroia ha riferito che Paolo Borsellino, a proposito del frazionamento nella annotazione del ROS, riteneva che l’iniziativa della procura di Palermo fosse propedeutica al suo insabbiamento.
Il 18 e il 26 luglio, contestualmente ad alcune notizie giornalistiche che descrivono i contrasti tra noi del ROS e la procura di Palermo, il procuratore Giammanco ci concede alcune deleghe di indagine connesse all’informativa del 16 febbraio. A queste prime indagini, che peraltro non coinvolgono gli aspetti e i personaggi chiave delle indagini, non ne seguiranno altre. Non conosco l’esito dei procedimenti a cui giunsero sulle vicende segnalate le altre procure che furono interessate dalla procura di Palermo.
In quel contesto, tra l’altro, il dottor Giovanni Falcone nel corso di un colloquio con la giornalista Liana Milella, che ne Pag. 17riferirà successivamente in sede processuale, le consegna alcuni appunti relativi alle vicende palermitane. In uno di questi, pubblicato il 24 giugno 1992 sul quotidiano Il Sole 24 Ore, conosciuto come i «Diari di Falcone», il magistrato giudica la decisione della procura di Palermo relativa alla annotazione Mafia e appalti del ROS testualmente dicendo: «È una scelta riduttiva per evitare il coinvolgimento di personaggi politici». Dopo la morte, nel computer del magistrato verrà trovata la seguente nota riferita al procuratore Giammanco: «Ha sollecitato la definizione delle indagini riguardanti la Regione Siciliana al capitano De Donno, assumendo che altrimenti avrebbe perso alcuni finanziamenti. Ovviamente, qualche uomo politico gli ha fatto questa sollecitazione ed è altrettanto ovvio che egli prevede un’archiviazione e solleciti l’ufficiale De Donno in tale previsione».
L’appunto è del 10 novembre 1990. Il fatto è vero perché il dottor Giammarco me lo chiese personalmente.
A questo punto, per una migliore comprensione, va fatta una piccola digressione relativa ad Angelo Siino. Angelo Siino era titolare di un’impresa, Litomix, a Palermo di cui erano soci occulti Bernardo Brusca, capo del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato, e il figlio, l’altro esponente di cosa nostra, Giovanni Brusca. Iscritto a una loggia massonica di Santa Margherita Ligure, già consigliere comunale della Democrazia Cristiana a San Giuseppe Jato, titolare a Palermo di un avviato autosalone e corridore automobilistico a livello nazionale noto con lo pseudonimo «Bronson», Siino era un’espressione emblematica di una parte della borghesia siciliana di quell’epoca. Siino è stato oggetto di un’indagine da me condotta, iniziata nel 1989 e conclusasi in una prima fase con il suo arresto il 9 luglio 1991.
Dopo l’arresto iniziai, formalmente autorizzato, una serie di prese di contatti con il Siino. Accertata la volontà di realizzare Pag. 18un’interlocuzione con noi, il detenuto venne incontrato nel carcere di Carinola dal colonnello Mori e da me il 25 giugno, il 24 agosto e il 18 ottobre 1993, ma pur dichiarandosi pronto a collaborare sul piano confidenziale non si dimostrava disposto a passare a un rapporto di tipo formale, asseritamente per timore di essere ucciso per i danni di natura economica che una simile decisione avrebbe causato all’attività della moglie, titolare di una nota distilleria a Palermo.
Di conseguenza gli incontri ebbero un’interruzione.
Il 10 gennaio 1995 al Policlinico Umberto I di Roma, dove era temporaneamente ricoverato, Siino, su iniziativa del suo difensore, l’avvocato Nicolò Amato, già magistrato e già responsabile del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, svolge un ulteriore colloquio investigativo con me e con il colonnello Mori, senza però determinarsi, anche questa volta, a una collaborazione.
In quella sede, lui, pur senza determinarsi a questa scelta, aggiunse che aveva conosciuto subito, attraverso l’onorevole Lima, il contenuto dell’annotazione, mettendone immediatamente al corrente il geometra Giuseppe Li Pera, capoarea della Rizzani De Eccher in Sicilia. Nei giorni immediatamente successivi al deposito dell’annotazione Mafia e appalti il documento era stato consegnato dal procuratore Giammanco, tramite l’onorevole Mario D’Acquisto, all’onorevole Salvo Lima e da questi a Giuseppe Lipari, commercialista palermitano legato a Salvatore Riina e a Bernardo Provenzano.
Il 24 gennaio 1995, in un successivo colloquio svolto unicamente da me, Siino, che già in precedenza aveva espresso generici dubbi negativi sul comportamento di alcuni magistrati alla procura di Palermo, formulò critiche dirette di corruzione nei confronti del dottor Pietro Giammanco e dei sostitutiPag. 19procuratori Guido Lo Forte, Giuseppe Pignatone e Ignazio De Francisci.
A fronte della ribadita volontà del Siino di non voler passare a una formale collaborazione, i dati da lui forniti a titolo confidenziale – tutti, peraltro, da valutare alla luce della personalità del soggetto e dei suoi ammessi legami con ambienti e uomini di cosa nostra – non presentavano una adeguata possibilità di sviluppo.
Il 9 luglio 1997 Angelo Siino viene nuovamente arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura della Repubblica di Palermo, aprendosi – questa volta sì – alla piena collaborazione con i magistrati di quell’ufficio, che delegavano per le indagini personale della Guardia di finanza. Sorpreso per non essere stato in qualche modo coinvolto negli accertamenti su di un soggetto per il quale era solo arrestato e avevamo a lungo investigato con il nostro reparto, per telefono il colonnello Mori segnalò al procuratore della Repubblica di Palermo pro tempore, dottor Gian Carlo Caselli, che poteva mettere a disposizione del suo ufficio un’ampia documentazione al riguardo, oltre che per le attività già svolte, anche alla luce dei contatti confidenziali che erano intercorsi tra il Siino e gli ufficiali del ROS. Il procuratore declinò l’offerta, non volle.
Il 13 ottobre 1997 stranamente il tenente colonnello Mori e io venimmo convocati a Torino dai magistrati della procura della Repubblica di Palermo, dottor Gian Carlo Caselli, Maurizio De Lucia e Michele Prestipino, che ci interrogarono sui rapporti avuti con Angelo Siino, ritenuto dagli inquirenti un collaboratore affidabile. In particolare, vennero a me rivolte formali contestazioni in merito a difformità tra le dichiarazioni del Siino e quanto lui in quel momento aveva affermato circa i nostri contatti.
A fronte del rifiuto espresso dal dottor Caselli di consentirmi una complessiva ricostruzione dei fatti relativi al rapporto con il Siino perché – testualmente, è riportato nel verbale di assunzione di informazioni testimoniali – l’argomento esulava dai temi dell’atto istruttorio, ritenendo di dover tutelare la mia posizione sotto l’aspetto penale, nei giorni successivi rilasciavo sommarie informazioni testimoniali ai magistrati della procura della Repubblica di Caltanissetta competenti, per quanto attivati su aspetti che potevano coinvolgere le responsabilità dei magistrati palermitani. In quella sede, infatti, ricapitolavo tutte le vicende direttamente e indirettamente connesse alle indagini da me svolte sul Siino, comprensive anche di quelle confidenze e delle specifiche accuse verso i magistrati palermitani a suo tempo fattemi da lui, consegnando le bobine di quei colloqui – non tutti – che avevo potuto registrare.
Gli aspetti della vicenda vennero alla luce in breve tempo, creando una fortissima polemica stampa. In conseguenza delle querele proposte dai magistrati interessati, la procura di Caltanissetta apriva due fascicoli: per calunnia nei miei confronti e di Angelo Siino e per corruzione nei confronti di alcuni magistrati palermitani.
Il 15 marzo 2000 il GIP del tribunale di Caltanissetta, dottoressa Gilda Loforti, con l’ordinanza 210897, archiviò entrambi i procedimenti.
Il 24 luglio 1991 il colonnello Mori incontra nuovamente il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Gerardo Chiaromonte, al quale spiega tutto il disagio creatosi nei confronti della procura della Repubblica di Palermo e le determinazioni assunte dal precedente luglio 1991 riguardo al dossier Mafia e appalti. In quello stesso mese di luglio il dottor Giammanco, con un atto illecito, trasmetteva al Ministro di grazia e giustizia una copia dell’informativa Mafia e appalti, sostenendo che i suoi contenuti, che in quel momento erano coperti da segreto istruttorio, avevano soprattutto una valenza politica piuttosto che una valenza investigativa.
Il 7 agosto 1991 il Ministro Martelli, su consiglio di Giovanni Falcone, senza prenderne visione, restituì gli atti alla procura di Palermo, sottolineando l’esclusiva rilevanza giuridica, che escludeva, quindi, l’esame da parte di un organo non competente come un Ministero. Dell’iniziativa del dottor Giammanco, il Guardasigilli informò, per le valutazioni, il CSM. Non so il CSM che determinazioni assunse nei confronti del procuratore di Palermo.
Il 26 agosto 1991, invece, il dottor Lama, sostituto procuratore della Repubblica di Massa-Carrara, trasmise per competenza a quella di Palermo una parte della sua inchiesta sulle ditte I.M.E.G. e S.A.M., concessionarie dello sfruttamento del 50 per cento dei terreni marmiferi dell’area delle Alpi Apuane. Le due società vengono indicate come riconducibili all’imprenditore siciliano Antonino Buscemi, che le stava gestendo tramite un proprio cognato, il geometra Cimino.
Buscemi, con il fratello Salvatore e un altro imprenditore, Francesco Bonura, tutti noti per connessioni con ambienti mafiosi, era tra i soci di una società operante nel settore edilizio estrattivo posseduta al 50 per cento dalla Calcestruzzi Spa, società che a sua volta aveva Lorenzo Panzavolta come amministratore delegato, inserita nel gruppo Ferruzzi diretto da Raul Gardini.
Il 20 febbraio 1991 viene istituita la Direzione nazionale antimafia (DNA). La creazione del nuovo ufficio, proposta sostenuta dal dottor Falcone, fu molto contrastata, provocando anche uno sciopero dell’Associazione nazionale magistrati, in larga parte contraria a questo progetto. A conclusione di questa attività emergerà una formulazione di quell’ufficio estremamente diversa dal progetto originale del dottor Falcone, il quale alcuni giorni prima di essere ucciso aveva convocato al Ministero sia me che il colonnello Mori per chiederci di poter partecipare, quale polizia giudiziaria, nella struttura della Procura nazionale antimafia.
Ricordo che il colonnello gli disse: «Forse ti siamo più utili se restiamo al ROS». Il dottor Falcone disse: «Voi non avete capito nulla, perché nella Procura nazionale che io dirigerò il Procuratore avrà compiti di indagine, ma soprattutto avrà la possibilità di acquisire i fascicoli delle procure che lui riterrà non essere stati adeguatamente sviluppati». Quindi, sarebbe cambiata completamente la storia investigativa di questo Paese.
Il 30 gennaio 1991 si conclude in Cassazione il maxi maxiprocesso per cosa nostra. In quella circostanza, Salvatore Riina riceve il primo ergastolo. L’11 febbraio 1992 il quotidiano toscano Il Tirrenopubblica un’intervista del dottor Lama, nella quale vengono rivelati i contenuti nella sua inchiesta. Il magistrato, oggetto di un esposto presentato dai legali della società Ferruzzi, è costretto ad astenersi dall’indagine, a cui seguirà un’inchiesta disciplinare proposta dal Ministro Martelli.
Il 26 novembre 1993 il Consiglio superiore della magistratura valuta corretta la condotta del dottor Lama. L’indagine del dottor Lama, trasferita al tribunale di Lucca, quindi a Roma, non avrà più sviluppi pubblicamente noti e ritengo sia stata archiviata. Della documentazione inviata a Palermo dal dottor Lama nel 1991, cioè quando l’indagine Mafia e appalti era in corso e pienamente nota ai magistrati di quella procura, non venne mai data notizia a noi del ROS che, se informati, avremmo facilmente collegato le indagini sulla vicenda delle pregresse connessioni con Antonino Buscemi.
La trattazione di questa documentazione ricevuta da Massa-Carrara fu assegnata a personale della Guardia di finanza e si concluse con una rapida archiviazione.
In una recente intervista, in una inchiesta televisiva della Rai, il dottor Lama ha dichiarato che la procura della Repubblica di Palermo non lo informò dell’esistenza delle indagini del ROS sul condizionamento mafioso negli appalti. La trasmissione di quegli atti dalla procura di Massa-Carrara a quella di Palermo è stata resa nota pubblicamente grazie all’attività del difensore del colonnello Mori, Basilio Milio, il quale dopo numerosi tentativi per trovare supporto alle nostre tesi difensive solamente nel settembre 2020 ha ottenuto l’accesso al fascicolo inviato dal dottor Lama, fino ad allora archiviato alla procura di Palermo.
Il 17 febbraio 1992 a Milano viene arrestato in flagranza Mario Chiesa e comincia formalmente l’indagine «Mani pulite». Il 1° marzo 1992 il dottor Borsellino, capo della procura della Repubblica di Marsala, assume le funzioni di procuratore aggiunto di Palermo. Tra le perplessità generali, il dottor Giammanco non gli attribuisce la delega alle indagini sulla mafia relative alla provincia di Palermo, bensì di Agrigento e Trapani, ciò malgrado il magistrato fosse il naturale erede delle attività del dottor Giovanni Falcone.
Il 12 marzo 1992 viene ucciso l’onorevole Salvo Lima. Giovanni Brusca nella sua successiva collaborazione afferma che Lima era stato ucciso da cosa nostra perché «ci ha preso in giro, promettendoci nei suoi rapporti con l’organizzazione cose che poi non aveva mantenuto».
Nei giorni immediatamente successivi all’omicidio, Giovanni Falcone in più dichiarazioni pubbliche sostenne che l’episodio segnava un significativo mutamento della strategia mafiosa e affermava testualmente «abbiamo tanti segnali che ci fanno temere che possano accadere cose spiacevoli nel prossimo futuro».
Il 4 aprile 1992 ad Agrigento viene ucciso il maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, investigatore interessato alle indagini sugli appalti pubblici e già dipendente del comandante del ROS, generale Subranni.
Gli accertamenti successivi proveranno dirette, ma vane pressioni esercitata da Angelo Siino sul Guazzelli, da lui precedentemente conosciuto, perché intervenisse presso il generale Subranni al fine di alleggerire la posizione dell’inchiesta degli appalti condotta dal ROS.
Anche qui devo riferire – ed è processualmente acquisito – che alcuni giorni prima di morire il maresciallo Guazzelli venne a Palermo a cercarmi. Io quel giorno non ero a Palermo. Lui parlò con un mio sottufficiale e gli disse testualmente: «Avvisa il capitano di stare attento alle indagini, perché lo ammazzano. Appena torna fammi parlare». Io tornai un paio di giorni dopo da Roma, mi fu riferita questa circostanza, ma non ebbi il tempo di incontrare il maresciallo Guazzelli.
Il 25 aprile 1992 si dimette il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.
Il 23 maggio 1992 nell’attentato di Capaci muoiono il dottor Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.
Il 25 maggio 1992, nel corso dei funerali di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino si intrattiene con il collega Alberto Di Pisa, definendo quella strage una strage «stabilizzante» in quanto più volta a mantenere in piedi un sistema criminale consolidato, aggiunge: «Intendo riaprire le indagini su mafia e appalti». Si veda, a questo proposito, l’audizione del 4 maggio 2021 del dottor Di Pisa nella commissione antimafia regionale siciliana.
I processi conseguenti alla strage di Capaci del 19 maggio 1995 si sono conclusi il 20 maggio 2020, con l’ultima condanna all’ergastolo di Matteo Messina Denaro.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sostenute da un imponente complesso investigativo, hanno consentito ai giudici della corte d’assise di Caltanissetta di affermare nella sentenza del 7 aprile 2000 che la causale dell’omicidio del dottor Falcone aveva una finalità preventiva volta a impedire al magistrato di promuovere l’approfondimento delle investigazioni dallo stesso promosse e dirette a individuare l’intreccio esistente tra cosa nostra, alcune frange del Partito Socialista Italiano e il gruppo finanziario Gardini, che aveva come punto di riferimento in Sicilia imprenditori mafiosi, come Antonino Buscemi e suo fratello Salvatore.
Il 25 maggio viene eletto Presidente della Repubblica l’onorevole Scalfaro.
Il 29 maggio, nel corso di una manifestazione pubblica, il Ministro degli interni Vincenzo Scotti afferma che è intenzione sua e del Ministro Claudio Martelli proporre Paolo Borsellino come Procuratore nazionale antimafia. Questa dichiarazione creerà una forte contrarietà nel magistrato, anche per l’ulteriore esposizione ai fini della sicurezza che questa notizia procura.
In quegli stessi giorni del giugno 1992 venne fatto circolare un documento anonimo a Palermo indirizzato, però, a 39 personalità, tra cui il Presidente della Repubblica, i Presidenti di Senato e Camera, il Vicepresidente del CSM, il procuratore della Repubblica di Palermo Pietro Giammanco, il dottor Borsellino e diversi rappresentanti politici delle istituzioni, nonché i direttori di alcune delle più importanti testate giornalistiche. L’anonimo inquadrava gli omicidi del senatore Salvo Lima e del dottor Giovanni Falcone nell’ambito di lotte di potere interne alla Democrazia Cristiana siciliana, facendo riferimento esplicito all’attività dell’onorevole Calogero Mannino, a cui veniva attribuito l’intento volto a scalzare il potentato politico-elettorale vantato in Sicilia dall’onorevole Giulio Andreotti attraverso Salvo Lima.
In tale contesto veniva messa a fuoco la figura di un commercialista palermitano, tale Pietro Di Miceli, professionista che aveva tutelato gli interessi mafiosi di tutti i più importanti procedimenti fallimentari svoltisi innanzi al tribunale di Palermo, anche grazie agli stessi rapporti intessuti con i magistrati di quella sezione fallimentare. Soprattutto, il Di Miceli venne indicato come l’organizzatore di alcuni incontri tra l’allora Ministro Calogero Mannino e Salvatore Riina, finalizzati a realizzare un nuovo patto politico con cosa nostra che sostituisse gli accordi andreottiani.
Secondo questo anonimo, nel corso di questi incontri sarebbero stati raggiunti accordi che facevano determinare l’assassinio dell’onorevole Lima in successione a quello del dottor Falcone.
Il documento conteneva, tra l’altro, un invito a riconsiderare i contenuti dell’annotazione Mafia e appalti del ROS indicata quale strumento per comprendere gli interessi che legavano gli ambienti economici, politici e mafiosi siciliani.
Sul conto del Di Miceli il ROS svolse articolate indagini da luglio 1993 a ottobre 1994, co-delegata dalla procura di Palermo, dottor Croce e dottor Napoli, e da quella di Caltanissetta, dottoressa Boccassini, dottor Petralia e dottor Saieva, che consentirono di accertare la collocazione del commercialista al centro di un complesso circuito relazionale che comprendeva esponenti della magistratura, il procuratore della Repubblica di Palermo Giammanco, il dottor Giuseppe Ayala, uno dei titolari dell’accusa nel maxiprocesso a cosa nostra e il dottor Vittorio Aliquò, procuratore aggiunto di Palermo. Tutto questo fu refertato alla procura di Palermo in numerose informative.
Tra le persone frequentate da Di Miceli e sospettate di rapporti con ambienti prossimi a cosa nostra, veniva evidenziata la figura di un imprenditore, detto Benedetto «Benny» D’Agostino, rappresentante della SAILEM Spa, società palermitanaPag. 27operante nel settore dei lavori pubblici. D’Agostino sarà indicato dal collaboratore di giustizia Marino Mannoia come vicino all’imprenditore Antonino Buscemi e in contatto con Angelo Siino, fatto salvo che tutto questo emergeva già nell’indagine Mafia e appalti.
L’inchiesta, nonostante tutti questi elementi, venne archiviata, anche in relazione ai rapporti tra il Di Miceli e Raffaele Ganci, capo della famiglia mafiosa del quartiere palermitano della Noce, su cui riferiranno diversi collaboratori di giustizia e che risulterà il gestore per conto di cosa nostra della latitanza di Salvatore Riina.
Il 19 giugno 1992 il GIP del tribunale di Palermo, dottor Renato Grillo, su richiesta formulata il 1° giugno dal dottor Gioacchino Natoli, archivia la parte dell’inchiesta del dottor Lamadella procura di Massa-Carrara relativa ai rapporti tra Antonino Buscemi e il gruppo Ferruzzi. Nella circostanza viene ordinata anche la smagnetizzazione delle bobine delle intercettazioni telefoniche e la distruzione dei brogliacci delle conversazioni relative all’indagine. Su questo aspetto sono in corso indagini della procura della Repubblica di Caltanissetta.
La procura della Repubblica di Caltanissetta, però, nella sua richiesta di archiviazione del 9 giugno 2003, cosiddetta «Mandanti occulti-bis», a commento di questa decisione del dottor Grillo, afferma testualmente: «La magistratura di Palermo, probabilmente per il limitato bagaglio di conoscenze, non attribuì soverchia importanza alle connessioni tra il Buscemi e il gruppo Ferruzzi». È assolutamente inconcepibile immaginare e scrivere che a giugno 1992 la magistratura palermitana non conoscesse la dimensione imprenditoriale del gruppo Ferruzzi e sottovalutasse la pericolosità criminale dell’indiziato mafioso Antonino Buscemi, che aveva in corso un procedimento per il sequestro dei beni e la cui famiglia d’origine è notoriamente legata a Salvatore Riina.
All’epoca, infatti, a Palermo non si poteva ignorare che Antonino Buscemi, cointeressato alla Calcestruzzi Spa, appartenente al gruppo Ferruzzi, era anche il fratello di Salvatore Buscemi, quest’ultimo, alleato dei corleonesi, già indicato da Tommaso Buscetta come capo della famiglia di Passo di Rigano. Salvatore Buscemi, coinvolto nel maxi processo a cosa nostra, riceverà una condanna definitiva a otto anni di reclusione.
L’attività dei Buscemi era stata ampiamente indicata nella nostra informativa del febbraio 1991. Sulle attività e le relazioni di Buscemi ha riferito anche Giovanni Brusca, altro collaboratore, che nella seconda fase della sua collaborazione, quella sviluppata a partire dal 1998, le più grandi direzioni distrettuali antimafia d’Italia hanno ritenuto assolutamente attendibile.
L’8 settembre 1998, davanti ai sostituti procuratori della Repubblica di Caltanissetta Antonino Di Matteo e Luca Tescaroli, Brusca, in una dichiarazione fonoregistrata, trascritta in 70 pagine, la maggior parte delle quali coperte da omissis, sosteneva: «Salvatore Riina si accorge che i Buscemi hanno un canale privilegiato, ad esempio, ve l’ho già detto, il giudice Pignatone.
Ho dichiarato che era vicino ai Buscemi e questo canale se lo tenevano chiuso. Salvatore Riina, quando ha scoperto di questo canale, è diventato pazzo. Cioè, dice: come, voi tenete questo canale e non lo dite a noi?». Continua ancora Brusca: «Tanto è vero che più di una volta io vi ho detto che quando spunta… spunta il malloppo mafia e appalti, a un dato punto abbiamo la sensazione che le indagini vengono deviate, buttate su Siino. Uno poteva essere Salamone, cioè il giudice Salamone in quanto, per difendere il fratello, ma l’altro riferimento per coprire Gardini, per coprire il suo gruppo politico, cioè il suo gruppo di amici, era Pignatone».
Alla domanda del dottor Tescaroli: «cioè il canale di fuoriuscita alle notizie concernenti quest’indagine mafia e appalti sarebbe stato veicolato dal dottor Pignatone per il tramite di Buscemi?» Brusca risponde: «e per chi, per me? Questo era il canale e che Salvatore Riina si era incazzato in maniera molto forte».
Il verbale sopracitato è stato reso pubblico solo nel 2020, a seguito delle indagini che abbiamo svolto nel nostro processo, in cui eravamo coinvolti, il processo cosiddetto «trattativa Stato-mafia».
PRESIDENTE. Mi perdoni, la data?
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. 2020.
È agli atti del nostro processo. Se vuole ne abbiamo copia, presidente.
PRESIDENTE. No, non si era capita la data. Prego.
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. I Buscemi, in particolare Antonino Buscemi, sono emersi nell’indagine Mafia e appalti anche perché in stretti rapporti economici con il geometra Giuseppe Lipari, considerato l’economo e il consigliere di Bernardo Provenzano. Presso l’ufficio del Lipari, a Palermo, nel corso dei servizi attuati, era stato più volte fotografato e notato Angelo Siino. Quest’ultimo, dal canto suo, risultava in frequenti contatti telefonici con l’ingegner Giovanni Bini, di cui ho detto prima, rappresentante per la Sicilia della Calcestruzzi Spa, società, questa, come già ricordato, che possedeva metà del capitale sociale della FINSAVI, di cui era fondatore e azionista Antonino Buscemi.
Nella successiva richiesta di archiviazione del 13 luglio 1992 relativa all’indagine Mafia e appalti del ROS, a firma dei magistrati Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato, con riferimento in particolare ad Antonino Buscemi, si afferma testualmente che il predetto «fratello di Buscemi Salvatore, ritenuto capo mandamento di Passo di Rigano, non è risultato coinvolto in alcuno degli episodi costituenti espressione dell’attività dell’associazione mafiosa sottoposta a indagini né in altri specifici fatti illeciti».
Sempre in merito alla posizione di Buscemi, Angelo Siino, nell’interrogatorio del 5 maggio 1999, ai magistrati di Caltanissetta sottolineò il trattamento, da lui ritenuto mite, che i requirenti della procura di Palermo avevano riservato al Buscemi, il quale nel luglio 1991 non era stato arrestato, benché fosse direttamente coinvolto nella gestione degli appalti pubblici.
Quando, poi, venne arrestato da noi, nel 1993, era stato da poco rimesso in libertà e gli erano stati addirittura restituiti gli immobili in precedenza posti sotto sequestro.
Per completezza espositiva va detto che anche il pentito Salvatore Cancemi, nel 1994, riferirà che in cosa nostra era notorio come il dottor Pignatone fosse nelle mani dell’imprenditore Vincenzo Piazza, uomo d’onore del mandamento di Boccadifalco, Passo di Rigano, di cui Salvatore Buscemi era il capo. Cancemi sosteneva che il Piazza aveva persino donato un appartamento al magistrato.
Gli accertamenti svolti in merito appurarono che l’appartamento era stato venduto nel 1980 alla moglie del dottor Pignatone dalla società immobiliare Raffaello, della quale erano soci gli indiziati mafiosi Vincenzo Piazza, Francesco Bonura, Salvatore Buscemi e il fratello Antonino. La transazione tra la signora Pignatone e l’immobiliarista Raffaello risultò regolare.
Un’altra affermazione di Giovanni Brusca circa l’attenzione che cosa nostra delegava alle indagini sul ROS appare al riguardo molto significativa, cioè quella secondo cui l’organizzazione, una volta acquisita tra febbraio e marzo 1991 la relativa annotazione, si rese conto che non erano stati individuati, secondo Brusca volutamente, i suoi referenti principali nel mondo politico e imprenditoriale, cioè Filippo Salamone e Giuseppe Pignatone, perché tutta l’attenzione degli investigatori era stata dirottata sul Siino.
Ignoro se presso il tribunale di Caltanissetta esista o meno un fascicolo che avrebbe dovuto essere stato aperto nei confronti del dottor Pignatone sulle dichiarazioni di Brusca e di Cancemi.
Resta da sottolineare che, così come nel caso delle indagini della procura di Palermo su Angelo Siino, sviluppate dal 1997, anche la parte dell’inchiesta trasmessa dal dottor Lama corroborava inequivocabilmente le risultanze della nostra informativa del 1991. Anche in questa ulteriore circostanza, invece di attivare il ROS, che aveva condotto le indagini in ambito siciliano, la procura della Repubblica di Palermo preferì interessare un reparto della Guardia di finanza non in possesso del complesso dei dati e dei riferimenti già in precedenza acquisiti e sviluppati da noi carabinieri, che non fummo neppure informati, mai, della documentazione trasmessa dalla procura di Massa-Carrara.
Il 19 giugno 1992 gli ufficiali del ROS, il capitano Del Sole e il capitano Umberto Sinico, informarono per le vie brevi il dottor Borsellino che una fonte, ritenuta molto attendibile, aveva riferito di un prossimo attentato contro la sua persona. Contestualmente il comando del ROS comunicò formalmente la notizia agli organi superiori.
Il 23 giugno 1992 incontro la dottoressa Liliana Ferraro, che aveva assunto la carica di Direttore degli affari penali del Ministro della giustizia dopo la morte del dottor Falcone, e le riferisco del tentativo di contattare Vito Ciancimino per sollecitarne la collaborazione. Il magistrato ne parlerà diffusamente in una serie di interrogatori fatti dalla procura di Palermo.
Il 25 giugno 1992 nella caserma Carini dei carabinieri di Palermo il colonello Mori e io incontriamo il dottor Paolo Borsellino, che ci aveva chiesto un colloquio riservato fuori dal tribunale di Palermo. L’argomento era Mafia e appalti, di cui il magistrato aveva già ottenuto da noi copia, su sua richiesta, mentre era procuratore di Marsala. Il dottor Borsellino, che ne aveva parlato diffusamente con Giovanni Falcone, individuava nel lavoro del ROS, oltre che una possibile causale alla morte del collega, anche un nuovo e più efficace strumento investigativo nei confronti di cosa nostra. Si decideva, quindi, di riprendere le indagini sotto la sua specifica ed esclusiva direzione. Il rilevante interesse del dottor Borsellino nell’indagine Mafia e appalti è dimostrato anche dal fatto che lo stesso 25 giugno 1992 nel tardo pomeriggio, quando lui si recò alla biblioteca comunale di Palermo di Casa Professa, riparlò di questo argomento.
Come già ricordato, il giorno precedente, il 24 giugno 1992, il quotidiano ilSole24Ore, a firma della giornalista Liana Milella, pubblicò una serie di appunti del giudice Falcone, scritti al computer, relativi alle sue valutazioni sulle difficoltà incontrate nell’ultimo periodo di lavoro alla procura di Palermo diretta da Pietro Giammanco, in cui attribuiva anche la precisa intenzione di ostacolare Mafia e appalti.
Nella recente audizione svolta in questa sede del tenente colonnello Carmelo Canale, l’ufficiale ha riferito che, nella circostanza del convegno di Casa Professa, Leoluca Orlando fece pervenire al dottor Borsellino un biglietto nel quale lo pregava di evitare, nell’intervento, riferimenti ai pregressi, anche quelli ricordati, relativi ai contrasti avuti da lui con il dottor Falcone.
Aggiungo una considerazione a commento dell’ultimo intervento del dottor Borsellino. Il magistrato, nell’evidenziare la sua attività volta ad assemblare le circostanze utili a individuare le cause della strage di Capaci, sostenendo con forza di essere il testimone dell’autenticità degli appunti redatti dall’amico Falcone, formulò indirettamente ma esplicitamente un atto di accusa contro le persone che riteneva corresponsabili di quella morte. Quelle dichiarazioni, a nostro avviso, probabilmente segnarono definitivamente la fine di Paolo Borsellino, perché chi stava seguendo e contrastando la sua attività si sentì inequivocabilmente indicato.
Il 28 giugno 1991, a seguito delle dimissioni del Governo Andreotti, entra in carica quello formato dall’onorevole Giuliano Amato.
Il 28 giugno Paolo Borsellino incontra all’aeroporto di Roma Fiumicino la dottoressa Ferraro, che gli riferisce del contatto da me avuto e del mio tentativo di avvicinare Vito Ciancimino. Il procuratore Borsellino ne prende atto, ma, a detta del magistrato, ne tratterà nelle sue deposizioni senza darne eccessivo peso, mentre chiede una serie di dettagli sull’indagine Mafia e appalti.
Il 29 giugno, in un teso confronto riferito successivamente dalla moglie la signora Agnese Piraino Leto, Paolo Borsellino chiede al procuratore Giammanco perché non lo aveva informato sulle minacce di morteche lo riguardavano e a lui riferite informalmente anche dal Ministro della difesa, onorevole Salvo Andò. In quello stesso giorno, il 29 giugno 1992, come testimoniato dalla moglie, ma anche dal dottor Ingroia, nella sua abitazione Paolo Borsellino incontra il dottor Fabio Salamone, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, e gli consiglia di chiedere il trasferimento ad altra sede fuori dalla Sicilia. L’attività illecita nella gestione degli appalti condotta da Filippo Salamone, fratello del magistrato, era stata segnalata dal ROS nella sua annotazione del 16 febbraio 1991. Filippo Salamone, con Antonino Buscemi e l’ingegner Bini, tecnico della Calcestruzzi, dallo sviluppo delle indagini risulterà coordinare un comitato d’affari, indicato anche come «sistema Salamone-Nicolosi» dove per «Nicolosi» si intende l’onorevole Rosario Rino Nicolosi, presidente della Regione Siciliana, che insieme ad altri analoghi comitati presiedeva all’aggiudicazione e alla spartizione degli appalti tra le tre componenti interessate, il cosiddetto «tavolino», dove sedevano per accordarsi imprenditori, amministratori pubblici e mafiosi.
In tale ambito, ad Angelo Siino residuava il compito di gestire gli appalti di dimensioni medio-piccole. In particolare, Filippo Salamone, oltre che garantire gli accordi, era il materiale portatore delle tangenti ai referenti politici tramite il pentito Siino, secondo cui nel periodo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta ricevette mensilmente da Salamone 200 milioni di lire da distribuire a politici di riferimento.
La posizione di rilievo dell’imprenditore Salamone nel sistema del «tavolino» viene anche evidenziata dall’amministratore delegato della Tor di Valle, Pietro Catti De Gasperi, in una conversazione telefonica con un dipendente, l’ingegner Giuseppe Zito, intercettata da noi il 19 dicembre 1989 e riportata nell’informativa del 16 febbraio 1991.
In quella circostanza Filippo Salamone, indicato con la sola lettera «S», viene descritto come «quello che conta di più» e in particolare la persona che poteva fornire garanzie di futuri vantaggi se fosse stato ritirato un ricorso contro l’aggiudicazione di un appalto da 26 miliardi di lire, per il quale la società romana si riteneva illecitamente esclusa. Inizialmente noi – io in particolar modo – individuammo il personaggio importante indicato da Catti De Gasperi con la lettera «S» in Angelo Siino e solo successivamente,Pag. 35alla luce delle indagini svolte sulla società SIRAP, capimmo correttamente che, invece, trattavasi di Filippo Salamone.
Questa conversazione evidenziava, però, che anche il dottor Catti De Gasperi, uno degli imprenditori continentali coinvolto nelle indagini del ROS, non solo era del tutto consapevole del sistema in atto per il condizionamento degli appalti pubblici in Sicilia, ma vi aderiva scientemente per conseguire maggiori utili possibili. Piero Catti De Gasperi sarà uno di quegli indagati per i quali il 13 luglio 1991 i sostituti procuratori della Repubblica Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato chiesero l’archiviazione.
Nel periodo che va da maggio a luglio 1992 nei contatti tra Paolo Borsellino e il dottor Di Pietro, che conduceva le prime fasi dell’indagine «Mani pulite», emergeva come anche nelle indagini della procura della Repubblica di Milano risultassero fatti e persone già messe a fuoco a Palermo. I due magistrati decidevano, quindi, di procedere in maniera coordinata.
La successiva, tragica morte del dottor Borsellino e le successive dimissioni dalla magistratura del dottor Di Pietro impediranno la pratica realizzazione di questo progetto, che, a detta del dottor Di Pietro, si fondava sul presupposto di far parlare gli imprenditori. In merito, con diverse dichiarazioni processuali e anche recentemente, nel corso di interventi pubblici, l’ex magistrato dottor Di Pietro ha confermato questa sua intesa con Paolo Borsellino. Nella sua testimonianza del 3 ottobre 2019, resa nel processo d’appello sulla cosiddetta «trattativa Stato-mafia», Antonio Di Pietro, riepilogando i rapporti di quel periodo tra le procure della Repubblica di Milano e Palermo, spiegò l’intesa sulle modalità di coordinamento tra i due uffici, raggiunta non senza contrasti nel corso del mese di giugno 1993, sulla base di una intuizione del dottor Piercamillo Davigo fondata sulle connessioni tra le rispettive inchieste, che potevano essere definite deboli o forti, a seconda dell’eventuale presenza di aspetti di criminalità mafiosa.
In pratica, Milano avrebbe operato a tutto campo sugli imprenditori, quindi a livello nazionale, interessando di volta in volta i requirenti palermitani per gli spunti che fossero eventualmente messi in relazione a problematiche mafiose. L’accordo raggiunto si fondava sulla constatazione, ricavata tra l’altro dall’amministrazione del manager della Calcestruzzi, Panzavolta, il quale aveva dichiarato al dottor Di Pietro che sino al Rubicone, per salvarsi, ammetteva tutto e sotto il Rubicone preferiva la galera, evidenziando il timore diffuso, nell’imprenditoria nazionale, per la variabile della presenza della criminalità mafiosa.
Nella sua deposizione Antonio Di Pietro ricordò anche le ripetute sollecitazioni ricevute da parte mia perché si interessasse all’inchiesta Mafia e appalti. Infatti, proprio in base a questa mia iniziativa, il 12 novembre 1992 il magistrato poté interrogare il geometra Giuseppe Li Pera, in carcere a Roma, venendo a compiuta conoscenza delle relazioni tra mafia, politica e imprenditoria e delle indagini che il ROS aveva condotto al riguardo.
Nel corso del processo di primo grado sulla trattativa Stato-mafia, al termine del quale sono stato condannato a otto anni di reclusione, la richiesta di ascoltare il dottor Di Pietro fatta dalla mia difesa e dal colonnello Mori fu respinta dal presidente della corte d’assise, in quanto ritenuta superflua.
L’intesa tra le procure di Milano e Palermo, a detta del dottor Di Pietro, si ruppe quando i giudici siciliani, accettando la richiesta di patteggiamento, alleggerirono nettamente la posizione di Filippo Salamone, indagato anche a Milano, derubricando in associazione per delinquere semplice l’imputazione all’imprenditore agrigentino che originariamente era per associazione di tipo mafioso. L’inchiesta relativa ad alcune accuse rivolte ad Antonio Di Pietro e trattate per competenza dalla procura della Repubblica di Brescia fu assegnata al sostituto procuratore Fabio Salamone, fratello dell’imprenditore Filippo. Secondo il magistrato di «Mani pulite» costituì una delle cause che lo portarono alla successiva decisione di abbandonare la magistratura.
Appare veramente singolare che a indagare il dottor Di Pietro che procedeva nei confronti di Filippo Salamone, fosse proprio il sostituto procuratore della Repubblica di Brescia, che si era dovuto allontanare dalla Sicilia per le vicende giudiziarie del fratello.
Un altro caso, questo, come l’altro verificatosi in Sicilia con protagonista Giuseppe Pignatone, di incompatibilità ignorata dagli interessati nel silenzio degli uffici sovraordinati ai due magistrati.
Le vicende giudiziarie di Filippo Salamone dopo un secondo arresto per associazione a delinquere mafiosa, effettuato dal ROS il 4 ottobre 1997, si conclusero nel marzo 2000.
In quella circostanza Salamone ricevette una condanna definitiva a un anno e mezzo sulla base dell’asserto, da lui sostenuto e accettato nella sentenza, di avere elargito ai politici una serie di «contributi volontari».
Giova a questo punto accennare, dopo l’imprenditore Filippo Salamone, a un altro protagonista del sistema prima indicato, l’onorevole Rino Nicolosi. L’uomo politico della Democrazia Cristiana resta alla presidenza della Regione Siciliana dal 1° febbraio 1985 al 12 agosto 1991 e successivamente divenne parlamentare nazionale.
Coinvolto nell’indagine sul condizionamento degli appalti pubblici nell’ottobre 1997, l’onorevole Nicolosi, prossimo alla fine – morì, infatti, per tumore nel corso del successivo 1998 – consegnò, di sua iniziativa, ai magistrati della procura della Repubblica di Catania un memoriale nel quale descriveva il meccanismo illecito di finanziamento ai partiti da parte delle imprese destinatarie di appalti pubblici; un sistema che comprendeva tutti i partiti e di cui Rino Nicolosi si autoaccusava di farne parte a pieno titolo, unitamente a diversi maggiorenti politici non solo regionali.
Nell’intesa descritta dall’onorevole Nicolosi era compreso anche il Partito Comunista Italiano, all’opposizione anche nel Parlamento della Regione Siciliana, a cui in particolare giungevano i contributi tramite la Lega nazionale delle cooperative, cosiddette «cooperative rosse».
L’accordo, secondo l’onorevole Nicolosi, era stato realizzato sulla base di una precisa definizione di regole che attribuivano alle imprese locali il compito di finanziare i componenti di rilievo dei partiti politici siciliani, mentre alle grandi imprese nazionali competeva il compito di versare alle segreterie nazionali.
Il documento, che elencava nominativamente i collettori delle tangenti, più di venti esponenti di rilievo, suddivisi per partiti e per imprese, fu consegnato alla procura della Repubblica di Catania.
Per la DC venivano indicati, tra gli altri, Calogero Mannino, Salvo Lima, Nino Drago; per il PCI Luigi Colajanni e Michele Russo; per il PSI Salvatore Lauricella, Salvo Andò, Nicola Capria; per il PRI Aristide Gunnella ed Enzo Bianco; per il PSDI Carlo Vizzini.
Tra le imprese Nicolosi indicava come a lui legata quella di Filippo Salamone, mentre quella agrigentina di Antonio Vita veniva posta in relazione a Calogero Mannino. In questa ricostruzione l’imprenditore catanese Gaetano Graci aveva come riferimento i politici socialisti Salvatore Lauricella e Salvo Andò, mentre l’azienda dei Costanzo, che si rapportava agli esponenti democristiani, in successione nel tempo aveva fornito un contributo anche ad esponenti socialisti.
L’impresa Mangiapane, attraverso le coop, era la referente del Partito Comunista.
Al sistema di erogazione dei partiti, sempre secondo l’onorevole Nicolosi, si sottraevano esclusivamente i sostenitori siciliani del senatore Andreotti che, tramite l’assessore regionale ai lavori pubblici, Salvatore Sciangula, per il suo specifico incarico, provvedeva direttamente al finanziamento della corrente di appartenenza.
Il memoriale Nicolosi non causò danni di natura penale ai politici indicati. Infatti, soltanto Salvatore Lombardo, deputato regionale del PSI, nel quadro delle inchieste della cosiddetta «Tangentopoli siciliana», fu condannato in primo grado risultando successivamente assolto.
Al riguardo c’è una piccola considerazione da aggiungere. Nel suo memoriale l’onorevole Nicolosi parla del periodo 1989-1991 come un triennio tumultuoso e lo individua come la fase di maggiore espansione dell’intesa illegale causata dalla gestione degli appalti pubblici.
Si tenga conto che proprio in quel periodo – febbraio-marzo 1991 –, seppure illegalmente, politica e cosa nostra apprendono dell’indagine del ROS sugli appalti pubblici. Alla luce delle sofferte confessioni di Nicolosi mi pongo una domanda. Poiché all’epoca erano in corso iniziative praticamente contemporanee del ROS a Palermo e a Catania, la decisione di quei magistrati che non hanno concesso deleghe di indagine sugli aspetti politici e le inchieste, e archiviato la maggior parte delle politiche segnalate, era motivata esclusivamente dalla mancanza di adeguati elementi di conoscenza, ovvero archiviare inizialmente parte del dossier Mafia e appalti, con i suoi aspetti relativi al mondo politico, smembrare l’indagine catanese del dottor Lima, non considerare i contenuti dell’inchiesta del dottor Lama, tutto questo non era un modo di condizionare il processo in altro modo?
La risposta, a mio modo di vedere, si ricava dalle dichiarazioni espresse dal dottor Falcone quando sosteneva che le scelte riduttive assunte dal dottor Giammanco derivavano dall’esigenza di evitare il coinvolgimento di personaggi politici e dalle sollecitazioni ricevute da qualche uomo politico.
Il 30 giugno 1992 e seguenti il collaboratore di giustizia Leonardo Messina, sentito dal dottor Borsellino, riferisce che Salvatore Riina, attraverso l’imprenditore Antonino Buscemi, venne cointeressato nella Calcestruzzi. Secondo le successive dichiarazioni del pentito Brusca Giovanni, con l’enorme flusso di denaro costituito dall’avvio del processo SIRAP, Salvatore Riina, attraverso la Reale Costruzioni, società di proprietà del suocero di Vito Ciancimino e del citato «Benny» D’Agostino, praticamente fallita, era entrato in maniera occulta come socio di Buscemi nei grandi appalti.
Se il dottore Borsellino avesse avuto il tempo di sfruttare l’indicazione del Messina, mettendola in relazione ai dati dell’inchiesta della procura di Massa-Carrara, avrebbe potuto valutare a pieno i rapporti del costruttore Buscemi e dell’ingegner Gardini.
Elaborando queste acquisizioni poste sulla base delle spiegazioni richieste in una riunione della direzione distrettuale antimafia del 14 luglio, l’inchiesta del ROS sarebbe saldata anche tecnicamente a quella milanese di Mani Pulite assumendo una dimensione nazionale.
Paolo Borsellino non ebbe il tempo di farlo. Altri, a Palermo, pur avendo tutta la possibilità di valutare già in quei momenti la enorme documentazione inviata da Augusto Lama e collegarla all’acquisizione raggiunta dalla nostra informativa, non apprezzarono le potenzialità di questa indagine e si perse un’occasione.
Il 1° luglio 1992 il dottor Borsellino interroga il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, il quale, sebbene informalmente, gli riferisce che un suo collega, il sostituto procuratore Domenico Signorino, titolare dell’accusa al maxiprocesso, e il dirigente del SISDE, Bruno Contrada, sono collusi con la mafia.
Nel corso dell’interrogatorio di Mutolo, il magistrato, su invito del Capo della polizia dell’epoca, Vincenzo Parisi, sospende l’incontro e si reca al Viminale dove quel giorno si teneva una cerimonia per l’insediamento dell’onorevole Nicola Mancino come nuovo Ministro dell’interno.
Nella circostanza il dottor Borsellino incontra anche Bruno Contrada, accompagnato dal prefetto Parisi. Nel breve scambio di convenevoli il funzionario del SISDE dimostra di essere a conoscenza che il magistrato stava interrogando Mutolo, fatto che, unito a quanto poco prima appreso dal collaboratore, lo impressionò profondamente.
Questo è il periodo che costituisce la fase di maggiore impegno professionale del dottor Borsellino al suo rientro alla procura di Palermo.
In questo lasso di tempo che non riesco meglio a precisare, ma orientativamente circoscrivibile dal periodo che va da maggio a fine giugno del 1992, Giovanni Brusca, che era stato precedentemente indicato da Salvatore Riina di preparare l’omicidio di Calogero Mannino, riceve l’ordine di sospendere quelle attività perché vi erano esigenze più immediate. Secondo il collaboratore Brusca, Riina, per una serie di notizie ricevute e valutazioni connesse, riteneva prioritaria l’eliminazione del dottor Borsellino.
Il 2 luglio il dottor Borsellino incontra a Palermo il giornalista del Corriere della Sera, Luca Rossi. In quel colloquio, successivamente riferito in sede processuale, il magistrato parla delle indagini relative agli appalti e gli attribuisce grande importanza.
Il dottor Borsellino – si legge in quell’articolo – pensava che potesse esistere una connessione tra l’omicidio di Salvo Lima e quello di Falcone e che il trait d’union fosse una questione di appalti in cui Lima era stato in qualche modo coinvolto e che Falcone stava studiando.
Sempre il magistrato, a proposito del suo dissenso con la proposta di nomina a Procuratore nazionale, disse: «Se me ne vado da qui, da Palermo, non ho più nessuno che mi faccia da sponda. Qui non è rimasto nessuno. Non ci sono più inchieste, non c’è un lavoro organico. Che cosa posso coordinare da Roma se nessuno fa le indagini in Sicilia?».
Il 13 luglio 1992 i sostituti procuratori Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato chiedono al procuratore Pietro Giammanco l’archiviazione per diversi soggetti segnalati nell’inchiesta Mafia e appalti.
Tra le posizioni archiviate risultano anche quelle di Claudio De Eccher, titolare della Rizzani De Eccher di Udine, Piero Catti De Gasperi, responsabile della Tor di Valle, Antonino Buscemi, fondatore della FINSAVI, posseduta per metà dalla Calcestruzzi del gruppo Ferruzzi, Antonino Spezia, che era il commercialista di Pino Lipari.
PRESIDENTE. Data?
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. 13 luglio 1992.
L’annotazione del ROS del 16 febbraio 1991 aveva documentato i collegamenti tra tutti questi imprenditori e Angelo Siino. In tempi successivi alcuni magistrati della procura della Repubblica di Palermo sosterranno che le archiviazioni decise in quella circostanza avevano riguardato solamente posizioni residuali. Si è già accennato alla rilevanza mafiosa di Buscemi, ma tengo a evidenziare che intanto la sua dubbia attività imprenditoriale aveva provocato una richiesta di sequestro di beni da parte della procura della Repubblica di Palermo. La notoria posizione rivestita all’interno di cosa nostra dal fratello Salvatore, capo del mandamento di Passo di Rigano-Boccadifalco, era nota alla procura di Roma. I legami da tempo segnalati dal dottor Augusto Lama della procura di Massa alla procura di Palermo erano già stati acquisiti.
Le dichiarazioni del collaboratore Leonardo Messina, da cui emergevano i collegamenti di Salvatore Riina, tramite l’imprenditore, con il gruppo Ferruzzi, erano acquisite.
Questi sono tutti fatti già da tempo noti alla DDA di Palermo prima che i sostituti Lo Forte e Scarpinato chiedessero l’archiviazione della posizione nel quadro di Mafia e appalti.
Il 26 novembre del 2021, nel corso del processo Mario Bo + 2, i magistrati Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato, intesi come testimoni a richiesta della parte civile della famiglia Borsellino, hanno affermato di non avere ricordo della documentazione inviata nell’agosto 1991 dal dottor Lama alla procura della Repubblica di Massa-Carrara e a quella di Palermo, documentazione che, evidenziando le connessioni imprenditoriali tra il gruppo Ferruzzi di Raul Gardini e l’indiziato mafioso Antonino Buscemi, avvalorava e avrebbe dato sostegno all’inchiesta del ROS sugli appalti che stavamo trattando.
Risulta arduo ammettere che un procedimento che trattava di un colosso industriale quale il gruppo Ferruzzi, legato a un imprenditore in sospetto di far parte di ambienti mafiosi palermitani qualificanti, passasse per tanti mesi inosservato a due tra i più esperti componenti di quella direzione distrettuale e questo tenuto anche conto del fatto che la circolarità informativa tra i componenti fosse uno dei fondamenti su cui si basava il presupposto istitutivo delle direzioni distrettuali antimafia che, attraverso previste e periodiche riunioni, ottenevano il costante adeguamento conoscitivo da parte di tutti i componenti; indirizzo procedurale, sempre decisamente sostenuto, quale regolare modalità operativa, in particolar modo dai membri della DDA palermitana, che ne sottolineavano anche la funzione ai fini della sicurezza salvo il fatto che, adottando questa modalità, nessuno di loro risultava depositario esclusivo di aspetti sensibili ai fini investigativi.
Il 14 luglio 1992, nella riunione della direzione distrettuale antimafia, il dottor Borsellino chiede notizia dell’inchiesta Mafia e appalti, osservando come una sua specifica indagine non era stata collegata a quella del ROS. Infatti, mentre alla procura della Repubblica di Marsala il magistrato apprese l’annotazione del ROS che coinvolgeva quali elementi Angelo Siino e Rosario Cascio da lui indagati, ma soprattutto Antonino Spezia, chiese di collegare questa indagine ad alcuni appalti connessi al comune di Pantelleria. Chiese ed ottenne da me copia dell’informativa.
Rilevati i significativi collegamenti, aveva inviato per connessione investigativa atti del suo procedimento a Palermo. La documentazione gli era stata restituita dalla procura di Palermo in quanto alcuni suoi colleghi non ravvisavano nessuna utilità per il prosieguo delle indagini. In pratica, la decisione era una conferma dell’indirizzo privilegiato dalla DDA di Palermo secondo cui ogni ufficio giudiziario doveva curare separatamente queste indagini.
Quel 14 luglio le richieste di chiarimento del dottor Borsellino nella riunione ottennero risposte vaghe e nessuno comunque in quella sede, neppure il dottor Lo Forte, alla presenza del procuratore Giammanco, lo informa che il giorno precedente era stata chiesta l’archiviazione.
D’altra parte, per quanto risulta dalle dichiarazioni quasi immediatamente rilasciate dal CSM, che consacravano ricordi sicuramente più nitidi e attendibili di quelli rassegnati in tempi successivi da taluni magistrati anche a questa Commissione, nemmeno nei giorni che precedettero la strage di via D’Amelio qualche collega palermitano, nonostante il manifesto e dichiarato interesse del dottor Borsellino al caso, ritenne di informarlo di questa richiesta di archiviazione.
Anni dopo, e precisamente il 25 maggio 1921, il dottor Ingroia, sentito dalla commissione antimafia della Regione Siciliana a proposito dell’assemblea della DDA di Palermo del 14 luglio 1992, dichiarerà che Paolo Borsellino, al termine della riunione, rivolto ai colleghi Guido Lo Forte e Giuseppe Pignatone così esclamò: «Voi non mi raccontate tutta la vera storia del rapporto del ROS».
Sul punto preme ricordare che nel corso dell’audizione davanti al CSM dei magistrati della procura di Palermo avvenuta nei giorni 28, 29 e 31 luglio 1992 emerse chiaramente come il dottor Borsellino in questa riunione avesse fatto importanti osservazioni sull’indagine Mafia e appalti. In particolare, il dottor Gozzo sottolineò il contrasto più che latente visibile tra alcuni colleghi e il dottor Borsellino.
PRESIDENTE. Siccome c’era un accordo sulla durata dell’audizione, il generale Mori concorda che le sue conclusioni siano rimandate alla seduta che sarà dedicata alle domande dei colleghi.
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. Va bene. Chiedo scusa, però purtroppo se saltiamo alcuni argomenti…
PRESIDENTE. Non salti niente.
GIUSEPPE DE DONNO, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo. In particolare, il dottor Domenico Gozzo sottolineò come il contrasto era più che latente e visibile tra alcuni colleghi e il dottor Borsellino, che chiese di rinviare la riunione per poter affrontare meglio la questione dell’inchiesta del ROS e lamentò che non fosse stata acquisita agli atti la documentazione relativa al procedimento della procura della Repubblica di Marsala.
La dottoressa Antonella Consiglio affermò, invece, che sino al suo arrivo in procura a Palermo aveva avuto la sensazione che le cose funzionassero formalmente in modo ineccepibile, ma che ci fosse una notevole spaccatura fra i sostituti e non vi fosse lealtà di rapporti. Anche il dottor Patronaggio dichiarò che il dottor Borsellino aveva espressamente detto che i carabinieri si aspettavano risultati giudiziari maggiori e che alla domanda postagli se si riferisse alla posizione dei politici disse: «In realtà no, non è solo nei confronti dei politici, ma anche nei confronti degli imprenditori», perché il nodo era valutare a fondo la loro posizione. Su questo punto il collega Lo Forte si dilungò spiegando il delicato meccanismo e la posizione degli imprenditori.
Peraltro, il dottor Patronaggio il 29 novembre 2023, in questa sede, ha tenuto a sottolineare la specificità dei quesiti di chiarimento rivolti al dottor Borsellino e al collega Lo Forte che faceva il punto sull’indagine Mafia e appalti. Un altro magistrato, a distanza di tempo, ha parlato della sua deposizione al CSM: si tratta del dottor Lorenzo Matassa, che era stato assegnato al tribunale di Palermo quale sostituto procuratore della Repubblica nel corso del 1992. Il dottor Matassa, il 23 luglio 2022, ha rilasciato un’intervista al giornalista Morici del periodico La Valle dei Templi sostenendo che nel giugno-luglio 1992 l’ufficio della procura all’epoca era una polveriera pronta a esplodere e che l’autorità del dottor Giammanco si era praticamente dissolta, ma il procuratore godeva ancora del supporto di numerosi colleghi, che per questo motivo venivano chiamati i «nipotini». Alcuni tra i «nipotini» avevano successivamente avuto carriere professionali fulminanti nel quadro dell’antimafia militante. Nella riunione del 14 luglio 1992 il procuratore Giammanco aveva accennato a un nuovo importante pentito, che però voleva parlare solo con il dottor Borsellino. Tale affermazione aveva provocato la reazione di un «nipotino», che replicava chiedendo di non dare seguito a quella richiesta, dicendo testualmente: «Io e te, Pietro, andiamo io e te ad ascoltare questo pentito». Tutti erano rimasti perplessi e Borsellino era rimasto in silenzio.
Il dottor Matassa ha aggiunto che, dopo la strage di via D’Amelio, il dottor Giammanco avevano nuovamente riunito la DDA per chiedere un sostegno legittimante, che era stato prontamente concesso dai «nipotini». Pochi tra i magistrati della procura avevano conosciuto e partecipato alle vicende di Mafia e appalti.
Il documento di contestazione verso il procuratore Giammanco, presentato da otto magistrati il 23 luglio 1992, comprendeva riflessioni e considerazioni che attenevano al rapporto tra mafia e politica e alle regole di ingaggio, che facevano degli uomini dello Stato carne da macello. Aveva concluso la sua deposizione al CSM lasciando a verbale il convincimento dell’inutilità dell’audizione a fronte della percepita volontà di non essere correttamente ascoltato. Attribuiva all’azione del CSM un valore formale ma non volto effettivamente a comprendere la realtà che era nella procura di Palermo.
Il 15 dicembre 2021, nel processo Mario Bo, il dottor Antonio Ingroia, sentito quale teste, ha indicato, oltre agli aggiunti Vittorio Aliquò ed Elio Spallitta, nei sostituti procuratore Guido Lo Forte, Giuseppe Pignatone e Giusto Sciacchitano i fedelissimi del dottor Pietro Giammanco alla DDA di Palermo.
Per due volte, a distanza di anni, l’avvocato Milio ha chiesto alla procura di Caltanissetta la consultazione degli atti connessi in qualche modo al procedimento «Stato-mafia», ottenendone un diniego. Al terzo tentativo, esperito insieme all’avvocato Romito, mio difensore – siamo ormai nel 2019 – i due legali ottennero la possibilità di consultare l’intera documentazione. Negli atti relativi alla morte del dottor Borsellino rinvennero quelli dell’inchiesta svolta dal CSM a seguito della strage di via D’Amelio, che sino ad allora erano stati segretati. Il CSM li pubblicherà solamente nel corso del 2022. Le audizioni dei magistrati della DDA di Palermo furono la conseguenza di un documento che il 23 luglio 1992 otto componenti dell’ufficio avevano redatto per denunciare le criticità che affliggevano la procura, prospettando le proprie dimissioni, affinché fossero chiare a tutti la gravità delle rimostranze e l’urgenza delle loro preoccupazioni, fondate in particolare sulla sicurezza personale, ma anche rivolta a una gestione più formale dell’ufficio.
Il 28 luglio 1992 venne ascoltato dal CSM il dottor Roberto Scarpinato, uno degli otto sottoscrittori del documento, e riporto al riguardo testualmente questa parte del suo intervento: «E poi c’è un altro fatto che mi ha molto inquietato e ha molto pesato dentro di me, cioè che Paolo Borsellino conducesse delle indagini su fatti di grande rilevanza all’insaputa del procuratore. Su queste indagini naturalmente non posso dire niente per motivi di ufficio. Sul fatto che Paolo Borsellino raccomandasse il segreto nei confronti di Giammanco potrà essere sentito il sostituto Ingroia, quantomeno non solo sull’esistenza e non tanto sull’esistenza del filone di indagine in sé, ma su alcune informazioni all’interno di quel filone particolarmente importante. Questa cosa io la apprendo dal sostituto Ingroia, poi me la conferma Paolo Borsellino. Io vivo questa cosa dentro di me malissimo, mi inquieta e mi chiedo: cosa sta succedendo a questa procura? Com’è possibile che accadano cose di questo genere?».
Il 15 luglio 1992 il dottor Tinebra diventa procuratore della Repubblica di Caltanissetta. Il 4 ottobre 1994 il tribunale di Caltanissetta inizierà il processo per la strage di via D’Amelio. Giovanni Tinebra morirà il 6 maggio 2017.
Il 16 luglio 1992 il dottor Borsellino, unitamente ai colleghi Guido Lo Forte e Gioacchino Natoli, in un locale della DIA di Roma procede all’interrogatorio di Gaspare Mutolo. Il pentito parla informalmente delle collusioni con cosa nostra di Domenico Signorino e Bruno Contrada, che saranno ufficializzate solamente il successivo 23 ottobre 1992.
Nella serata del 16 luglio 1992 in Roma si tiene una cena tra il dottor Borsellino, l’onorevole Carlo Vizzini e i magistrati Lo Forte e Natoli. Come testimonierà processualmente l’uomo politico, Paolo Borsellino in quella cena tratta diffusamente del sistema illecito degli appalti, individuando questo come causa della possibile morte di Giovanni Falcone. Anche in questa circostanza non risulta che il dottor Lo Forte accenni alla proposta di archiviazione inoltrata tre giorni prima.
Il 18 luglio 1992 il dottor Borsellino, rientrato a Palermo, come si ricava dall’esame del carteggio, declassificato su decisione di questa Commissione, lascia traccia nel prelievo del fascicolo dell’imprenditore Luigi Ranieri, ucciso il 14 dicembre 1988, in quanto si era opposto al sistema mafioso per il condizionamento degli appalti. Al magistrato ne aveva parlato Leonardo Messina nelle sue dichiarazioni rese il 1° luglio. L’attività conferma anche la specifica attenzione del magistrato alla problematica e in particolare all’inchiesta del raggruppamento operativo speciale (ROS), che nell’annotazione del 16febbraio 1991, alle pagine 339 e 340, descrive la vicenda dell’omicidio Ranieri, mettendolo in diretta connessione all’assunto complessivo delle indagini.
Aggiungo una mia considerazione personale. Dal verbale di sequestro dei materiali acquisiti nell’ufficio del dottor Borsellino dopo la sua morte, risulta che la maggior parte dei documenti rinvenuti riguardava un’indagine sugli appalti e personaggi che si ritrovano nella nostra annotazione del 16 febbraio. In sostanza, emergeva un febbrile lavoro di ricostruzione, sintesi e collegamento sulla problematica del condizionamento degli appalti pubblici.
Il 19 luglio 1992, domenica, intorno alle 7.30 del mattino, secondo la testimonianza della signora Agnese Borsellino, per telefono il procuratore Giammanco informa il marito di avergli conferito delega per le indagini nella provincia di Palermo. Appare del tutto anomala l’urgenza della chiamata fatta dal dottor Giammanco, considerato che all’indomani in procura avrebbe potuto informare il collega della sua decisione, senza disturbarlo nelle prime ore del mattino, per di più in un giorno festivo, e poco prima che lo stesso, come d’abitudine, andasse a messa e poi, sempre in mattinata, si recasse in via D’Amelio a trovare la madre. In quella giornata, tuttavia, il dottor Borsellinocambia programma e si reca dalla madre solo a pranzo. Nel pomeriggio a Palermo, in via D’Amelio, per l’esplosione di un’auto riempita di esplosivo, il magistrato muore e con lui cadono cinque agenti della Polizia di Stato, Agostino Catalano, Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina. Si salva solo l’agente Antonino Vullo.
Nel corso delle indagini che hanno dato vita ai procedimenti fin qui tenutisi presso la corte d’assise di Caltanissetta sulla morte di Borsellino, né quei giudici, né il dottor Tinebra, né i suoi successori alla procura della Repubblica, Francesco Messineo, Sergio Lari e Amedeo Bertone, hanno ritenuto che, per completezza delle indagini, fosse necessario sentire formalmente il dottor Giammanco, che muore il 2 dicembre 2018. Non viene mai sentito sulle sue determinazioni assunte circa l’inchiesta Mafia e appalti e sui suoi difficili rapporti con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. In particolare, nessun magistrato, anche di altri distretti, a titolo personale, ha voluto fare chiarezza sull’indubbia anomalia di questa telefonata fatta al collega Borsellino il giorno della sua morte.
Il 19 luglio 1992 il primo magistrato ad arrivare in via D’Amelio è il dottor Napoli, effettivo alla procura distrettuale di Palermo. Il dottor Napoli è uno degli otto firmatari del documento sulla protesta della situazione della procura della Repubblica di Palermo, noto solo il 23 luglio 1992. In un successivo colloquio svoltosi il 31 ottobre 2023, riportato dal ricercatore Vincenzo Ceruso in un suo libro, il magistrato parla delle vicende da lui vissute in quei giorni e, a proposito di Mafia e appalti, il dottor Napoli definisce come risaputo il fatto che il documento fosse di contenuto esplosivo, perché per la prima volta descriveva il meccanismo di condizionamento degli appalti e che tra i colleghi corresse la voce che fosse stato «agghiuniato», termine dialettale siciliano che dovrebbe avere accezione come «accantonato» o «nascosto».
Subito dopo il dottor Napoli e prima ancora dei colleghi di turno Salvatore Pilato e Luigi Patronaggio, sopraggiunti a distanza di un’ora sul luogo dell’esplosione, arrivarono in via D’Amelio il procuratore della Repubblica Pietro Giammanco, Guido Lo Forte, Giuseppe Ayala e Gioacchino Natoli. Di certo non era presente il dottor Arnaldo La Barbera, dirigente della squadra mobile, perché fuori sede, non a Palermo. Sono stati, quindi, i requirenti palermitani giunti nell’immediatezza che hanno avuto la possibilità di sovraintendere e dirigere le operazioniPag. 52degli organi di polizia giudiziaria nella fase preliminare dell’acquisizione di elementi di prova rinvenibili sul luogo della strage. Pertanto, ogni atto immediatamente successivo, sino al sopraggiungere, in serata, dei colleghi titolari dell’indagine, è da attribuire alle loro decisioni.
Se ne deve, quindi, concludere che, pur ammettendo l’indubbia difficoltà psicologica dell’agire in quei drammatici momenti, le loro attività, se non altro, sono state connotate da improvvisazione e sciatteria, così da produrre gravi danni, tuttora riscontrabili, alla storia processuale dell’inchiesta. In tale contesto, infatti, uno degli aspetti che ancora risultano non chiariti è costituito dalla scomparsa di un’agenda del 1992, con copertina rossa, data dall’Arma dei carabinieri al dottor Borsellino in quell’anno, che, unitamente ad altre due agende, portava sempre con sé. A detta delle persone a lui vicine, in quella rossa annotava esclusivamente appunti e considerazioni del tutto riservati e personali, tanto che nessuno, nemmeno i suoi familiari, era in grado di indicarne il contenuto. Quel pomeriggio del 19 luglio 1992 con ogni probabilità, stante il fatto che non avrebbe avuto molto senso portarla a casa della madre, il magistrato la lasciò nella sua borsa, rimasta nell’auto. Se l’avesse portata con sé, sarebbe andata senz’altro incenerita dall’esplosione. In caso contrario e più probabile, l’agenda, per qualche tempo dopo l’esplosione, sarebbe rimasta incustodita nella vettura. La sua sparizione, allora, potrebbe essere avvenuta sul posto della strage, ovvero in altri due luoghi della procura di Palermo, o negli uffici della squadra mobile, che procedeva formalmente per l’attentato, ovvero in quelli della procura della Repubblica di Palermo. In tutti e due i casi, più che di sparizione appare realistico parlare di sottrazione.
In particolar modo, il dottor Salvatore Pilato, il giorno della strage di via D’Amelio magistrato di turno, avrebbe affermato che, rientrato in sede dopo l’attività svolta sul posto, apprese della presenza dell’agenda rossa nell’ufficio del collega Borsellino. Sorvolo su alcune considerazioni per essere più rapido, presidente.
Il 22 luglio 1992 il procuratore Giammanco inoltra una richiesta di archiviazione dell’inchiesta «Mafia e appalti» relativa alla maggior parte delle persone indicate nella nostra informativa. Lui e i due sostituti, chiedendone l’archiviazione, nella circostanza trascurano i motivi e l’importanza del problema degli appalti, sottolineato alla Commissione parlamentare antimafia nel giugno 1990 da Giovanni Falcone, ignorano l’attenzione particolare che Paolo Borsellino, nei suoi ultimi mesi di vita, aveva rivolto all’indagine dei carabinieri, sottovalutano la consistenza probatoria dell’annotazione del ROS del 16 febbraio 1991 e non considerano rilevante che alla pagina 335 del documento risultasse che uno dei soci di Antonino Buscemi, Vito Giuseppe Buscemi, classe 1955, peraltro suo parente, disponesse di una abitazione proprio in via D’Amelio, al civico n. 46, praticamente di fronte a quella del dottor Paolo Borsellino, e non collegano l’indagine del ROS con gli atti del dottor Lama, che erano arrivati a Palermo da Massa-Carrara.
Questi aspetti, già di per sé significativi nella drammaticità di questo momento, segnato dalla morte del magistrato più qualificato della procura, che aveva mostrato una particolare attenzione a Mafia e appalti, avrebbero dovuto essere valutati a prescindere. In questi casi, infatti, l’abbiccì di chi sovraintende le indagini per gravi delitti prevede di accertare, in primo luogo, quali siano le più recenti attività svolte dalla vittima e, di conseguenza, individuare con chi si rapportasse negli ultimi giorni di vita, quali intendimenti professionali manifestasse e, infine, di quali documenti e informazioni disponesse in merito a queste problematiche. Tutto ciò, attraverso l’affrettata proposta di archiviazione, è stato colpevolmente disatteso, non avendo neppure attivato il reparto, ossia il ROS, che stava gestendo le indagini nell’interesse del dottore Borsellino.
Il 22 luglio 1992 il colonnello Mori incontra, a Palazzo Chigi, l’avvocata Fernanda Contri, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, nel corso di una relazione sulla situazione della sicurezza pubblica con riferimento alla strage di Capaci, accenna al tentativo di convincere Vito Ciancimino a qualche forma di collaborazione. L’avvocato Contri riferirà dei contenuti all’onorevole Giuliano Amato, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il 23 luglio 1992, come già accennato, otto sostituti procuratori della Repubblica di Palermo, Ignazio De Francisci, Giovanni Ilarda, Antonio Ingroia, Alfredo Morvillo, Antonio Napoli, Teresa Principato, Roberto Scarpinato e Vittorio Teresi, presentano una lettera di dimissioni. L’iniziativa, a cui si aggiungevano altri magistrati, veniva motivata come atto di protesta per stigmatizzare l’azione inefficace degli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica, sottolineare la mancanza di un’accettabile predisposizione di sicurezza nei confronti dei magistrati, sollecitare l’arrivo di personalità autorevoli che valga a ricompattare lo spirito dell’unità della procura di Palermo. Il dottor Giammanco, a seguito di questa iniziativa, con una memoria scritta confuta queste accuse. Nei giorni successivi, dopo una sua audizione al CSM, il magistrato chiede e ottiene il trasferimento alla Corte di cassazione, dove resterà fino al 2 ottobre 1999, data del pensionamento. Il dottor Giammanco muore a Palermo il 2 dicembre 2018.
Il dottor Giammanco, per le accuse di corruzione formulate da più pentiti, è stato coinvolto, unitamente ad altri colleghi, in una specifica inchiesta giudiziaria. Gli accusatori erano Giuseppe Marchese, che gli attribuì il fatto di aver intascato denaro Pag. 55per ammorbidire la posizione degli imputati, Giuseppe Li Pera, che lo indicò quale percettore di denaro, unitamente ai colleghi De Francisci, Lo Forte e Pignatone, per mitigare la posizione di alcune personalità, e Angelo Siino, che lo accusò di aver procurato ad estranei, sempre per denaro, una copia dell’informativa «Mafia e appalti». La posizione del magistrato, così come quelle dei suoi colleghi, verrà archiviata dalla procura della Repubblica di Caltanissetta.
Già un’altra sentenza, il 22 aprile 2006, a Catania, della corte d’assise, terza sezione, nel processo contro gli autori della strage di Capaci, conferma l’interesse del dottor Borsellino alla problematica degli appalti. Sulla base delle dichiarazioni di vari collaboratori, in particolare Antonino Giuffrè, quei giudici affermarono che le ragioni dell’anticipata uccisione del dottor Borsellino si rinvengono nei timori basati su due motivi: la possibilità che venisse ad assumere la Direzione nazionale antimafia e soprattutto la pericolosità che egli avrebbe potuto svolgere indagini in materia di mafia e appalti.
La conduzione dei primi tre procedimenti connessi alla strage di via D’Amelio ripropone le negative considerazioni sulla concretezza degli accertamenti questa volta svolti dai magistrati della procura della Repubblica di Caltanissetta, anche in questo caso, come a Palermo, caratterizzati da superficialità e approssimazione non giustificabili.
Il 30 luglio 1992 la professoressa Maria Falcone, sorella del dottor Giovanni Falcone, intesa dal Consiglio superiore della magistratura, riferisce che Paolo Borsellino, nel corso del giugno 1992, presente nella circostanza anche il dottor Morvillo, magistrato e fratello di Francesca Morvillo, li pregò di evitare richieste pubbliche volte a ottenere una maggiore determinazione sull’indagine per la morte dei loro congiunti perché stava testualmente – scoprendo cose terribili e che avrebbe fatto saltare parecchie cose.
Il 14 agosto 1992 il GIP del tribunale di Palermo, dottor La Commare, determina l’archiviazione di Mafia e appalti, così come richiesto dalla procura. La notizia non viene pubblicizzata sugli organi di stampa, di norma molto attenti a queste vicende.
Al riguardo, preme sottolineare che nella richiesta di archiviazione «Mandanti occulti-bis» della procura di Caltanissetta si sostiene: «Se il programma investigativo di Falcone e Borsellino era indirizzato all’esplorazione del tema dei rapporti tra mafia e appalti, non solo come terreno di individuazione della mafia operativa, ma soprattutto come punto di convergenza tra interessi mafiosi e terzo livello, la scansione degli eventi, che si muovono tra il trasferimento di Giovanni Falcone a Roma, l’utilizzazione riduttiva del rapporto del ROS da parte della procura diretta dal dottor Giammanco, la strage di Capaci e quella di via D’Amelio, sembra propendere verso la sussistenza di un forte interesse, sia all’interno che all’esterno di cosa nostra, volto a ostacolare l’attuazione di questo programma investigativo e, quindi, a legittimare un movente di tipo stragista».
Rimane il fatto che l’inchiesta relativa alla problematica delle connessioni tra mafia e imprenditoria politica, nella quale emergeva il nuovo atteggiamento assunto da cosa nostra, che da una concezione tradizionalmente parassitaria era passata a una posizione attiva nell’aggiudicazione e nella gestione degli appalti pubblici, venne interrotta per il mancato sostegno che la procura di Palermo offrì a noi investigatori.
A questo punto serve una disamina dell’inchiesta Mafia e appalti svolta a Catania.
Il 30 aprile 1992 giunge al ROS un anonimo nel quale si indica che il geometra della Rizzani De Eccher, Giuseppe Li Pera, in quel periodo detenuto, era in grado di far scoprire gli illeciti su alcuni appalti aggiudicati in provincia di Catania e si chiede di interessare il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Felice Lima.
Questo è un punto fondamentale perché ancora oggi il ROS – in particolare io – viene accusato di avere, sostanzialmente, redatto questa lettera anonima per poter migrare il geometra Li Pera dalla procura della Repubblica di Palermo a quella di Catania. Nulla di più falso, per un semplice motivo: se io avessi scritto questo anonimo per sottrarre Li Pera dalla procura di Palermo per quella di Catania non avrei chiesto l’autorizzazione alla procura della Repubblica di Palermo di andare a Catania con Li Pera. Quindi, l’anonimo non l’ho scritto io.
Quando l’anonimo è arrivato noi, prima di andare a parlare con la procura della Repubblica di Catania, abbiamo chiesto l’autorizzazione – e ce n’è copia scritta – alla procura della Repubblica di Palermo, al dottor Lo Forte e al dottor Pignatone.
Il 6 maggio 1992, infatti, la sezione ROS di Palermo informa per iscritto della ricezione dell’anonimo il dottor Lo Forte, che ne prende atto e autorizza tutti gli atti conseguenti con la procura della Repubblica di Catania.
Il 28 maggio 1992 il dottor Lo Forte autorizza, da me chiestogli, il riascolto delle intercettazioni telefoniche depositate per l’inchiesta Mafia e appalti. La richiesta si pone in relazione agli sviluppi dell’indagine SIRAP. Il 1° ottobre 1992 deposito alla procura della Repubblica di Catania l’annotazione denominata «Caronte» connessa agli accertamenti sulle dichiarazioni rese da Giuseppe Li Pera. Nelle sue affermazioni, il geometra Li Pera, premettendo che la sua richiesta, inoltrata dopo l’arresto, di essere sentito dai magistrati della procura della Repubblicadi Palermo era stata respinta, descriveva al dottor Lima e a me le modalità con cui imprenditori, politici e mafiosi condizionavano gli appalti pubblici in Sicilia. Li Pera sosteneva anche di aver ricevuto da Angelo Siino notizie di dettaglio sui contenuti dell’annotazione Mafia e appalti subito dopo il suo deposito in procura a Palermo.
Sulla base di queste indagini, conseguenti al complesso delle dichiarazioni, il dottor Lima richiedeva l’emissione di ventitrè ordinanze di custodia cautelare in carcere, oltre che per turbativa d’asta, per associazione a delinquere semplice, non mafiosa, evidenziando così la sua intenzione di interessare le procure competenti per gli aspetti relativi al 416-bis.
La richiesta venne bloccata dal procuratore della Repubblica capo di Catania, dottor Giuseppe Alicata, che suddivise l’inchiesta in più parti, assegnandola alla procura della Repubblica di Catania per alcuni appalti relativi che, tra l’altro, porteranno all’arresto di Pasquale e Giuseppe Costanzo, figli del cavaliere Carmelo Costanzo; a Palermo, per i complessivi aspetti relativi a cosa nostra; a Caltanissetta, per il segmento riguardante il comportamento dei magistrati Pietro Giammanco, Giuseppe Pignatone, De Francisci e Lo Forte, accusati, sulla base delle affermazioni di Li Pera, di corruzione in atti giudiziari.
Il dottor Alicata, nel frattempo, non delegò il ROS, organismo che aveva proceduto alle indagini, nemmeno all’esecuzione materiale degli arresti competenti del suo ufficio.
A seguito di queste polemiche originate dal contrasto con la procura di Catania, il dottor Lima venne sottoposto a procedimento disciplinare. Il magistrato, per evitare il trasferimento ad altra sede, chiese e ottenne il passaggio al tribunale civile.
Il mio comportamento, ritenuto illecito dalla procura della Repubblica di Palermo, venne esaminato come ipotesi di abuso d’ufficio dalla competente magistratura di Roma. Nella fattispecie,Pag. 59i magistrati palermitani, in relazione alle indagini da me svolte e all’informativa del 16 febbraio 1991, mi accusarono di non aver trasmesso tutte le intercettazioni svolte su loro delega, intercettazioni che, invece, avrei fornito per intero alla procura della Repubblica di Catania, sviluppate nell’indagine Caronte.
Palermo lamentava, inoltre, anche la mancata tempestività della notizia relativa alla collaborazione del geometra Li Pera, ritardo che avrebbe concorso a non far valutare adeguatamente il complesso delle iniziative di propria competenza.
Posto che secondo Li Pera la sua decisione di collaborare con la procura di Catania derivava dal fatto che i magistrati di Palermo si erano rifiutati di sentirlo, costoro non tenevano conto che il geometra della Rizzani de Eccher venne interrogato mentre era detenuto in carcere di massima sicurezza, insieme a molti esponenti mafiosi, e che qualsiasi fuga di notizie nella fase iniziale della sua collaborazione avrebbe causato pericoli per la sua vita.
In ogni caso, fui sottoposto a procedimento disciplinare e la procura generale della Corte di cassazione il 13 dicembre 1994 definì il procedimento relativo al mio comportamento rilevando che non avevo commesso alcun tipo di irregolarità. Indirettamente, con questa decisione, venne respinta la tesi della doppia informativa, sostenuta all’epoca dalla procura di Palermo, che ancora torna. Infatti, con questa denominazione si è tentato e si tenta ancora di dimostrare il comportamento proceduralmente scorretto del ROS nei confronti della procura di Palermo. L’asserto sarebbe dimostrato dall’esame dei contenuti dell’annotazione relativa alla società SIRAP depositata a Palermo il 5 settembre 1992 e di quella denominata «Caronte» relativa agli accertamenti sulle affermazioni di Palermo, consegnata a Catania il 1° ottobre 1992 e posta in relazione con l’informativa del 1991.
La SIRAP – Siciliana incentivazioni reali per l’attività produttiva –, fortemente voluta dall’onorevole Lima, era alla diretta dipendenza della Regione Siciliana.
La società era incaricata di gestire i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, ammontanti a quell’epoca a circa mille miliardi di lire, previsti per la realizzazione di venti aree attrezzate. La SIRAP era controllata dall’Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), un istituto della regione, il cui presidente era Francesco Pignatone, padre del sostituto procuratore della Repubblica, Giuseppe Pignatone. Francesco Pignatone, già parlamentare nazionale, era esponente della Democrazia Cristiana, inserito nella corrente dell’onorevole Lima. Giuseppe Pignatone, sostituto procuratore dell’epoca, da me immediatamente informato del fatto che il congiunto era emerso nel corso di alcune intercettazioni telefoniche, ne prese atto, ma non ritenne di doversi astenere dalla trattazione del procedimento.
In merito a questo particolare aspetto, la dottoressa Loforti, GIP del tribunale di Caltanissetta, sempre nella sua ordinanza del 15 marzo 2000, sostenne: «Avuto riguardo, quindi, alla qualità del di lui padre, presidente dell’ESPI, una più attenta valutazione di opportunità avrebbe, forse, potuto suggerire al dottor Pignatone, pur in assenza di un evidente obbligo di astensione tenuto conto che, almeno formalmente, la società oggetto di indagine era diversa dall’ESPI, di evitare di occuparsi delle vicende in questione fin dal momento in cui si trattò di richiedere le autorizzazioni alle intercettazioni telefoniche proprio sulle utenze SIRAP.
Tale rapporto di filiazione può avere obiettivamente ingenerato il convincimento che le strategie processuali, seguite all’epoca dalla procura della Repubblica di Palermo, fossero state, sia pure indirettamente dalla loro valutazione di carattere prettamente tecnico, influenzate dal fatto che il presidente di uno dei due unici soci azionisti della SIRAP fosse, per l’appunto, il padre del dottor Pignatone».
Peraltro, all’epoca il dottor Giuseppe Pignatone avrebbe dovuto anche considerare che nel corso degli anni Ottanta, come già accennato, i componenti della sua famiglia avevano acquistato a Palermo una serie di appartamenti dall’immobiliare Raffaello, società gestita da indiziati mafiosi. Il dottor Pignatone come co-assegnatario dell’indagine Mafia e appalti non poteva ignorare che sia Bonura che Buscemi erano stati segnalati nell’informativa del 16 febbraio 1991.
In relazione alle indagini del ROS trasmesse a Catania, in seguito a separata e successiva acquisizione, la procura della Repubblica di Palermo sviluppò alcune attività sulla «tangentopoli siciliana», dizione con cui vengono coinvolte varie attività. I relativi esiti non causarono danni penali al mondo politico siciliano e modeste conseguenze al mondo imprenditoriale.
Non ho gli elementi per riferire dettagliatamente su questa attività.
I sostenitori della tesi della doppia informativa affermano che l’annotazione del 16 febbraio 1991 consegnata a Giovanni Falcone differiva da quella relativa alla società SIRAP depositata il 5 settembre 1992, in quanto nella prima erano state omesse le intercettazioni con i nomi dei politici, che emergevano, invece, nella seconda. Questa posizione, già propria dei responsabili della procura della Repubblica di Palermo all’epoca, è tuttora sostenuta da alcuni magistrati, quali Vittorio Teresi e Gioacchino Natoli, e da alcuni politici e cronisti giudiziari, in particolare dal senatore Roberto Scarpinato e anche dalla pubblicazione Antimafia Duemila, periodico per iniziati che tratta della lotta alla mafia, pubblicazione diretta da Giorgio Bongiovanni, che gode di ampia considerazione presso alcuni magistrati distintisi nel contrasto a cosa nostra, quali Antonino Di Matteo, Roberto Scarpinato, Giuseppe Lombardo, Luca Tescaroli e Sebastiano Ardita, con cui partecipa a diverse iniziative antimafia, come quella, ad esempio, tenutasi nel maggio 2022 in occasione del triennale della strage di Capaci. Il Bongiovanni è anche detto «uomo delle stigmate», in quanto sostiene di averle ricevute direttamente dalla Madonna nel corso del 1989 durante una visita al santuario di Fatima.
L’infondatezza della tesi sulla doppia informativa è dimostrata dall’ordinanza del GIP di Caltanissetta, dottoressa Loforti, mai ufficialmente contestata, a mia conoscenza, da nessuno dei protagonisti di queste vicende. A riguardo, la dottoressa afferma testualmente: «Se ne deve dedurre, quindi, che la omessa trasmissione da parte dell’organo di polizia giudiziaria, nel febbraio 1991, di parte delle intercettazioni telefoniche era ben nota ai magistrati dottor Lo Forte e Pignatone, i quali avevano autorizzato e seguito lo sviluppo delle intercettazioni ed erano, inoltre, in possesso, come ufficio, dei brogliacci e delle bobine, sicché erano bene in condizioni sia di leggere i primi che, rilevata l’assenza della trascrizione delle intercettazioni sulle utenze SIRAP, di richiederne l’immediata trascrizione allo stesso organo di polizia giudiziaria, ovvero di disporla loro stessi.
Infatti, dalla documentazione acquisita in esecuzione dell’ordinanza di questo ufficio, è emerso che l’informativa del 20 febbraio 1991 era stata, in realtà, preceduta dalle annotazioni dei carabinieri del 23 aprile 1990, del 2 luglio 1990, del 5 agosto 1990 e del 30 agosto 1990, delle quali le prime due risultano espressamente richiamate nell’informativa del 20 febbraio 1991. Deve, dunque, concludersi che non può ritenersi affatto provata la cosiddetta “teoria della doppia informativa” e che, al contrario di quanto ritiene il dottor Lo Forte» – sono parole testuali del GIP di Caltanissetta – «non può affatto escludersi, in via d’ipotesi, che nella illecita divulgazione delle notizie e dei documenti riservati, oggetto del presente procedimento, possono essere stati coinvolti, o per denaro o in ragione degli asseriti rapporti di amicizia con svariate personalità politiche, i magistrati oggi indagati».
Nel medesimo senso definiva anche, la sentenza, l’insussistenza di una doppia informativa, cui si è espressa la corte d’assise d’appello di Palermo, nel processo relativo alla trattativa Stato-mafia, sostenendo, nelle motivazioni depositate il 5 agosto 2022, che «non è vero o almeno non è provato che già all’epoca dell’informativa Mafia e appalti, depositata il 20 febbraio 1991, ne esistesse una seconda copia o una seconda versione molto più ricca perché comprensiva degli atti che vennero poi allegati alle successive informative».
Al riguardo, il dottor Lima il 4 maggio 2021, davanti alla commissione d’inchiesta dell’assemblea regionale che lo ascoltava, sostenne: «Io avevo le stesse carte dei colleghi palermitani, ma mentre sul mio tavolo queste carte portarono i frutti contenuti in quelle 230 pagine di richiesta di ordinanza cautelare, a Palermo non era praticamente successo niente. Anzi, c’era stata una dolorosa, dal mio punto di vista, richiesta di archiviazione».
Stante le difficoltà dei rapporti tra la procura della repubblica di Palermo e il ROS, nel corso del 1993 il colonnello Mori decise l’impiego del mio reparto fuori dalla Sicilia in aree del territorio nazionale comunque connotate da organizzazioni di criminalità mafiosa. In particolare, in Campania il ROS ripropose lo stesso modello d’indagine adottato in Sicilia, questa volta con il pieno sostegno della procura della Repubblica di Napoli.
Nell’aprile del 1996, infatti, ebbe inizio l’indagine denominata «Avvio», originata da una denuncia dell’amministratore delegato pro tempore della Calcestruzzi, l’ingegner Giuseppe Parrello, espressione della fattiva collaborazione e della Pag. 64nuova lineare gestione della società. Emergeva che la Calcestruzzi, capofila dell’associazione temporanea di imprese destinata alla realizzazione della linea ferroviaria alta velocità, TAV, Roma-Napoli, aveva subìto una serie di danneggiamenti e minacce. Il presupposto operativo concordato con i magistrati della procura di Napoli si fondò sulla presenza di un agente infiltrato, che avrebbe dovuto prendere contatto con gli autori delle azioni criminose, risalendo fino ai loro mandanti. Attraverso la brillante e coraggiosa opera del tenente colonnello Vincenzo Paticchio, alto ufficiale del ROS, che tenne i difficili rapporti con i responsabili di un articolato sistema criminale, rifacendosi al clan dei casalesi, si giunse a individuare un complesso intreccio di responsabilità che, come nel caso siciliano, in perfetta intesa, vedeva anche qui protagonisti criminali, imprenditori e amministratori pubblici.
L’operazione, conclusa il 9 settembre 1996, portò alle reazioni da parte di alcuni esponenti politici, con l’accusa nei confronti del colonnello Paticchio di essere stato non un infiltrato, bensì un provocatore.
Il 7 maggio 2015 la Corte di cassazione confermava le condanne penali solo per la componente camorristica, sulla base del principio che quest’ultima, con le sue attività criminali, era preesistente alle vicende di causa, mentre assolveva la parte politica coinvolta sulla base della considerazione di aver deciso il proprio orientamento illecito non solo dopo l’attività posta in essere dall’agente sotto copertura, autorizzata dalla magistratura procedente. Peraltro, la Suprema Corte riconobbe la correttezza giuridica e l’operato del ROS e dei magistrati requirenti, il procuratore Agostino Cordova, i sostituti procuratori Paolo Mancuso e Federico Cafiero de Raho, oggi componente di questa Commissione. L’operazione otteneva anche la legittimazione istituzionale rappresentata dall’apprezzamento manifestato dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione che la Camera dei deputati, in sede di Commissione Giustizia, espresse il suo favore anche in futuri casi di impiego dell’agente infiltrato nell’operazione Avvio.
Il 14 novembre 1992 la Corte di cassazione emette la sentenza per l’omicidio del capitano Emanuele Basile, condannando Francesco Madonia e i figli.
Il 3 dicembre Domenico Signorino, sostituto procuratore della Repubblica di Palermo e pubblico ministero nel maxiprocesso, si suicida esplodendo un colpo di pistola alla testa.
Il 19 dicembre 1992 a Roma viene nuovamente arrestato Vito Ciancimino, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla corte d’appello di Palermo.
Il 24 dicembre viene arrestato il dottor Bruno Contrada.
Il 27 gennaio 1993 Vito Ciancimino inizia a rendere deposizioni ai magistrati della procura della Repubblica di Palermo, Giancarlo Caselli e Antonino Ingroia. Nel corso delle stesse, il 23 marzo 1993, descrive tutti gli incontri che si sono svolti insieme tra il capitano De Donno e il colonnello Mori.
A questo punto, presidente, direi che possiamo fermarci qui. Non tedio più l’attenzione dei componenti. Grazie.
PRESIDENTE. Devo dire che difficilmente ho sentito tanto silenzio. La ringrazio.
Se il generale Mori conferma di essere d’accordo, accorpiamo le sue conclusioni alle domande perché i lavori dell’Aula della Camera sono ripresi.
Ritengo opportuno che prima delle domande leggiate tutti la relazione, decisamente lunga ma necessaria.
Ringrazio gli auditi e dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 16.20.
Commissione antimafia, Pd e 5S “processano” gli uomini di Falcone
In Commissione Antimafia, Mario Mori e Giuseppe De Donno – ex ufficiali del Ros, convocati per proseguire l’audizione sul controverso procedimento nato dal dossier “Mafia Appalti” – hanno subito un nuovo atteggiamento ostile da parte del Movimento Cinque Stelle e del Partito Democratico. All’avvio delle domande, il pentastellato Luigi Nave ha sollevato un singolare rilievo, prontamente respinto dalla presidente Chiara Colosimo, mentre il deputato Verini evidentemente era “distratto”. Il clima, in pratica, resta ancorato alle vecchie accuse mosse dagli ex procuratori di Palermo, tra cui il senatore Roberto Scarpinato, oggi componente della Commissione.
Facciamo chiarezza. Dopo l’intervento conclusivo di Mario Mori, che ha spiegato come – secondo la sua testimonianza – il dossier “Mafia Appalti” abbia subito ostacoli dall’allora procuratore Pietro Giammanco, è intervenuto il senatore Nave del M5S. Questi ha accusato Giuseppe De Donno di aver presentato, durante la scorsa audizione, una memoria piena di inesattezze e mistificazioni, chiedendo il rinvio per consentire ai commissari di studiare un documento di 86 pagine depositato mezz’ora prima della convocazione. La presidente Chiara Colosimo ha respinto l’istanza: non c’erano i tempi tecnici per esaminare un testo arrivato all’ultimo momento. Eppure, dalla prima audizione erano passate settimane: avrebbero potuto consegnarlo prima. Un fatto senza precedenti, poiché mai prima d’ora un gruppo di minoranza aveva chiesto lo slittamento di un’audizione basandosi su una ricostruzione “avversa” depositata all’ultimo minuto.
È prassi, in Commissione Antimafia, ascoltare tutte le versioni ritenute utili: prima degli appartenenti ai Ros, magistrati come Gioacchino Natoli e Luigi Patronaggio avevano già esposto le loro ricostruzioni, con criticità segnalate da Il Dubbio in articoli precedenti, senza che alcuno – né Fratelli d’Italia né Partito Democratico – invocasse rinvii o memorie contrapposte. Di norma, al termine dei lavori si redigono una relazione di maggioranza e una di minoranza. Perché allora il M5S ha voluto fare un’eccezione proprio per gli ex Ros? Questo episodio dimostra che contro di loro non è bastato l’accanimento giudiziario (e mediatico) – puntualmente naufragato – ma si è arrivati a strumentalizzazioni in ambito politico.
Ma la politica è cosa seria, fatta però da persone che possono “sbagliare”. Basterebbe l’esempio del senatore Verini per capire quanto alcuni commissari rimangano ostinatamente ciechi di fronte alla versione degli ex Ros. Nonostante la memoria depositata e l’intervento conclusivo di Mario Mori, che aveva già chiarito quel punto, Verini ha chiesto perché l’incontro riservato su “Mafia Appalti” traBorsellino e gli ex Ros sia emerso solo anni dopo. Una domanda che getta ombre su Mori e De Donno, alimentando le stesse illazioni ospitate da Il Fatto Quotidiano che, evidentemente, ha voce sulla linea anche del Partito Democratico.
In realtà, come ricordato nella memoria e sottolineato da Mori in Commissione, De Donno riferì dell’episodio già nel 1992 davanti ai pubblici ministeri di Caltanissetta, allora incaricati dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Quei magistrati già disponevano dunque di elementi solidi sull’interesse di Borsellino al dossier e sul suo scetticismo verso alcuni colleghi. È invece legittimo chiedersi come mai quel versante di indagine sia stato approfondito solo nei processi successivi, e perfino in modo parziale: grazie all’azione di desecretazione di Chiara Colosimo e soprattutto delle indagini attuali dei pm nisseni guidati da Salvatore De Luca, oggi emergono manoscritti e documenti che Borsellino custodiva nel suo ufficio. Non si tratta certo di un’invenzione degli ex Ros, né – come ha sostenuto il pentastellato Nave – di fumo per nascondere cose “indicibili”.
Tutte le sentenze, del resto, riconoscono nel dossier un fattore decisivo nella scelta dei corleonesi di eliminare Borsellino e, in precedenza, Falcone stesso. Su questo tema abbiamo già scritto ampiamente: ora ci si augura che l’inchiesta della procura di Caltanissetta faccia finalmente luce su quel patrimonio documentale occultato da trentennali teorie giudiziarie (quelle sì, fumose) – dalla trattativa alla pista nera, fino a Gladio.
La memoria depositata dagli ex Ros presenta sicuramente diverse imprecisioni, ma parliamo di dettagli trascurabili. Sono passati oltre 30 anni ed è comprensibile commettere errori. Quello che conta non dovrebbe essere la memoria in sé, ma le carte. Almeno dal comunicato del M5S, si stigmatizza Mori per aver detto, falsamente, che Falcone accusò la procura di Palermo di aver insabbiato alcune indagini relative al dossier “Mafia Appalti”. Ma non è un’invenzione di Mori. Tocca ripeterlo.
Due verbali di assunzione di informazioni sono significativi. Uno, il numero 271/97: la giornalista Liana Milella riferisce di un colloquio avvenuto con Falcone nell’estate del ’91, quando ci furono solo le cinque richieste di arresto scaturite dal dossier: «Falcone, in più occasioni, e in particolare dopo gli arresti, aveva commentato con grande delusione gli sviluppi di quell’inchiesta, dicendomi che riteneva riduttiva la scelta di arrestare solo certe persone». C’è anche il verbale numero 490/94, dove l’ex ministro Claudio Martelli riferisce del singolare episodio in cui, nell’estate del 1991, la procura di Palermo inviò il dossier “Mafia Appalti” al ministero, trasgredendo il segreto istruttorio: «Quel che ricordo è che Falcone osservò che Giammanco aveva trascurato o insabbiato quell’indagine». Quindi, forse, ci vorrebbe maggior rispetto per la memoria di Giovanni Falcone.
Non si comprende perché il M5S citi anche Mutolo. In realtà, sul versante appalti, fondamentale per Borsellino era il pentito Leonardo Messina, colui che – tra le altre cose – corroborò il fatto che la Calcestruzzi della Ferruzzi Gardini fosse in mano a Totò Riina. Lo stesso suo interrogatorio verrà utilizzato nelle indagini successive all’archiviazione. Peccato non prima.
Singolare anche la domanda posta dal deputato dem Giuseppe Provenzano, il quale, riallacciandosi alla questione sollevata dal collega Verini, ha chiesto a Mori una sua valutazione su esponenti politici come Dell’Utri o D’Alì. Magari non era il suo intento, ma sembra quasi che fossero in qualche modo collegati alle stragi. Il che è chiaramente un falso. Mori ha risposto di voler parlare solo di ciò di cui si è occupato direttamente, di ciò che ha “toccato con mano”, non di questioni che conosce tramite i giornali. In realtà, è un comportamento che dovrebbero avere tutti: da investigatori, magistrati e politici ci si aspetta questo, ossia riferire ciò che si conosce personalmente attraverso studi e approfondimenti. Altrimenti si rischiano “incidenti”, come accaduto allo stesso Provenzano, quando pose la domanda all’avvocato Fabio Trizzino, genero di Borsellino, sulla pista nera, citando un documento sponsorizzato da giornali come Il Fatto ma che nella realtà è “carta straccia”.
Detto questo, anche De Donno e Mori un errore lo hanno commesso: dare importanza alle parole di Vito Ciancimino, il quale in realtà aveva tutto l’interesse di allontanare la mafia dalle responsabilità e accusare altri soggetti esterni. Di tutto si può accusare l’allora procura di Palermo, ma non di non aver indagato sui “terzi livelli”. Ed è proprio quello il punto: è l’opposto della visione di Falcone e Borsellino. Loro hanno pagato con la vita il fatto di aver indagato nella profondità della mafia e toccare quegli interessi convergenti con il mondo imprenditoriale che conta, e di riflesso la politica. Borsellino, in una intervista reperibile su raiplay, quando era procuratore a Marsala e indagava sugli appalti locali affermò: «Da tempo è chiaro che è la mafia a servirsi dei politici, non viceversa». E ciò fa il paio con la visione di Falcone cristallizzata nei suoi libri e ordinanze. Ma a chi interessa? IL DUBBIO Damiano Aliprandi
Mori e De Donno, ostacoli a inchiesta Ros su mafia e appalti
L’inchiesta del Ros su mafia e appalti, che aveva avviato un nuovo metodo investigativo, all’inizio degli anni Novanta subì ostacoli anche nell’ambito della magistratura palermitana.
Davanti alla Commissione parlamentare antimafia l’ex comandante del Ros, Mario Mori, e il suo braccio destro Giuseppe De Donno hanno riproposto una linea critica già tracciata durante l’audizione del 16 aprile che oggi è proseguita con qualche approccio polemico.
La tesi di fondo sostenuta da Mori e De Donno accredita l’idea che il dossier su mafia e appalti, su cui nel 1992 aveva rivolto il suo interesse Paolo Borsellino, sia il principale movente dell’attentato di via d’Amelio. Oggi Mori ha alzato il tono della sua audizione sostenendo che quel dossier è stato fortemente ostacolato in quella fase dalla Procura guidata da Pietro Giammanco: non avrebbe voluto valorizzare il collegamento tra gli appalti e il sistema politico. “Si perdeva così di vista – ha osservato Mori – un’attività investigativa che allargava lo sguardo e avrebbe potuto ottenere altri risultati”. Mori ha lamentato che altri freni venivano dalla politica e dal “tombale silenzio” calato su un’indagine sottoposta a un’operazione di “smembramento” tra gli uffici giudiziari di Palermo, Catania e Caltanissetta. L’obiettivo sarebbe stato quello di evitare l’estensione dell’attività investigativa per la quale lo stesso Giovanni Falcone pensava a una interconnessione con l’indagine milanese di Mani pulite.
Gli interventi di Mori e De Donno, che hanno seguito le tracce del loro libro “L’altra verità”, hanno suscitato varie domande e interventi polemici tra esponenti della maggioranza di centrodestra, che hanno sostenuto la tesi dei due ufficiali, e quella dell’opposizione, M5S e Pd.. ANSA 13.5.2025
13.5.2025 Mori e De Donno: “Ostacoli all’inchiesta su mafia e appalti”
Toni polemici durante l’audizione in Commissione parlamentare antimafia. L’ex comandante del Ros, Mario Mori, e il suo braccio destro Giuseppe De Donno sono tornati a parlare dell’inchiesta del Ros su mafia e appalti, un’indagine che, secondo la loro ricostruzione, avrebbe subito ostacoli significativi anche all’interno della magistratura palermitana all’inizio degli anni Novanta.
Davanti alla Commissione, Mori e De Donno hanno riproposto la linea critica già espressa durante l’audizione del 16 aprile, con qualche passaggio dai toni accesi. La tesi centrale sostenuta dai due ex ufficiali accredita l’idea che il dossier su mafia e appalti, sul quale nel 1992 aveva concentrato il suo interesse Paolo Borsellino, rappresenti il principale movente dell’attentato di via d’Amelio.
Mori accusa la procura di Giammanco
Oggi, Mori ha alzato il tono della sua audizione, sostenendo con forza che quel dossier fu fortemente ostacolato in quella fase dalla Procura di Palermo, allora guidata da Pietro Giammanco. Secondo Mori, l’allora procuratore non avrebbe voluto dare il giusto peso al collegamento tra gli appalti e il sistema politico. “Si perdeva così di vista – ha osservato Mori – un’attività investigativa che allargava lo sguardo e avrebbe potuto ottenere altri risultati”.
Mori ha inoltre lamentato ulteriori “freni” provenienti dalla politica e un “tombale silenzio” calato su un’indagine che sarebbe stata oggetto di una vera e propria operazione di “smembramento” tra gli uffici giudiziari di Palermo, Catania e Caltanissetta.
L’obiettivo, secondo la sua prospettiva, sarebbe stato quello di evitare l’estensione dell’attività investigativa, per la quale lo stesso Giovanni Falcone ipotizzava una interconnessione con l’indagine milanese di Mani pulite.
Il dibattito in Commissione
Gli interventi di Mori e De Donno, che hanno seguito le tracce del loro libro “L’altra verità”, hanno suscitato diverse reazioni tra i membri della Commissione. Gianluca Cantalamessa (Lega) ha osservato che i due ufficiali, già assolti in tre procedimenti tra cui quello sulla cosiddetta “trattativa”, meriterebbero “rispetto e risarcimento”.
Di contro, Luigi Nave (M5s) ha accusato Mori e De Donno di aver raccontato “inesattezze e falsità” e di aver colto “mistificazioni in alcune affermazioni”. Nave ha chiesto di discutere i punti sollevati in un documento di 86 pagine presentato dai consiglieri del M5s, ma la presidente Chiara Colosimo ha replicato che il dossier è stato presentato all’ultimo momento e non c’è stato il tempo di valutarne il contenuto.
Un ulteriore momento di tensione si è verificato tra la presidente Colosimo e il consigliere del Pd Giuseppe Provenzano. La discussione è stata innescata dalle domande poste in precedenza da Walter Verini (Pd) e poi da Provenzano, che hanno chiesto a Mori se, oltre al filone mafia e appalti, dal suo osservatorio non avesse valutato quanto accadeva in quel periodo con le stragi del 1992, gli attentati del 1993 e i delitti che lanciavano un feroce attacco allo Stato. Mori ha risposto che, in quanto investigatore “operativo”, poteva parlare delle indagini e non del “contesto politico” in cui quei fatti si collocavano.
LEGGI ANCHE: I miliardi del gruppo Ferruzzi e le stragi: la genesi di “mafia e appalti”
LIVE SICILIA
13.5.2025 Borsellino e il dossier mafia-appalti, Mori e De Donno: «Fu ostacolato»
Toni polemici durante l’audizione in Commissione antimafia
L’inchiesta del Ros su mafia e appalti, che aveva avviato un nuovo metodo investigativo, all’inizio degli anni Novanta subì ostacoli anche nell’ambito della magistratura palermitana. Davanti alla Commissione parlamentare antimafia l’ex comandante del Ros, Mario Mori, e il suo braccio destro Giuseppe De Donno hanno riproposto una linea critica già tracciata durante l’audizione del 16 aprile che oggi è proseguita con qualche approccio polemico.
La tesi di fondo sostenuta da Mori e De Donno accredita l’idea che il dossier su mafia e appalti, su cui nel 1992 aveva rivolto il suo interesse Paolo Borsellino, sia il principale movente dell’attentato di via d’Amelio.
Oggi Mori ha alzato il tono della sua audizione sostenendo che quel dossier è stato fortemente ostacolato in quella fase dalla Procura guidata da Pietro Giammanco: non avrebbe voluto valorizzare il collegamento tra gli appalti e il sistema politico. «Si perdeva così di vista – ha osservato Mori – un’attività investigativa che allargava lo sguardo e avrebbe potuto ottenere altri risultati».
Mori ha lamentato che altri freni venivano dalla politica e dal «tombale silenzio» calato su un’indagine sottoposta a un’operazione di “smembramento» tra gli uffici giudiziari di Palermo, Catania e Caltanissetta. L’obiettivo sarebbe stato quello di evitare l’estensione dell’attività investigativa per la quale lo stesso Giovanni Falcone pensava a una interconnessione con l’indagine milanese di Mani pulite.
Gli interventi di Mori e De Donno, che hanno seguito le tracce del loro libro «L’altra verità», hanno suscitato varie domande. Mentre Gianluca Cantalamessa (Lega) ha osservato che i due ufficiali già assolti in tre procedimenti tra cui quello sulla cosiddetta «trattativa» meriterebbero «rispetto e risarcimento», Luigi La Nave (M5s) ha accusato Mori e De Donno di avere raccontato «inesattezze e falsità» e di avere colto “mistificazioni in alcune affermazioni». La Nave ha chiesto di discutere i punti sollevati in un documento di 86 pagine presentato dai consiglieri del M5s. Ma la presidente Chiara Colosimo ha replicato che il dossier è stato presentato all’ultimo momento e quindi non c’è stato il tempo di valutarne il contenuto. L’ultimo momento polemico, che ha contrapposto la presidente e il consigliere del Pd Giuseppe Provenzano, è stato innescato dalle domande poste prima da Walter Verini (Pd) e poi da Provenzano che hanno chiesto a Mori se, oltre al filone di mafia e appalti, dal suo osservatorio non avesse valutato quello che accadeva a quel tempo con le stragi del 1992, gli attentati del 1993 e i delitti che lanciavano un feroce attacco allo Stato. Mori ha risposto che, come investigatore «operativo», poteva parlare delle indagini e non del «contesto politico» in cui quei fatti si collocavano. GIORNALE DI SICILIA
13.5.2025Antimafia, Movimento 5 Stelle: “Da Mori e De Donno gravi bugie che allontanano la verità sulle stragi del ’92 e ’93”
Le dichiarazioni dei componenti pentastellati della commissione parlamentare Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero de Raho, Michele Gubitosa, Luigi Nave e Roberto Scarpinato

“La memoria depositata da Mario Mori in commissione Antimafia e le dichiarazioni rilasciate in audizione da lui e da Giuseppe De Donno, nell’ambito del lavoro di indagine sulla Strage di via D’Amelio, contengono una serie di falsità e di distorsioni della realtà che lasciano sgomenti per la loro gravità e per il loro numero”. Lo affermano i componenti M5S della commissione parlamentare Antimafia Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero de Raho, Michele Gubitosa, Luigi Nave e Roberto Scarpinato.
“Dopo la prima seduta che li ha visti come auditi, abbiamo fatto una rigorosa verifica documentale e abbiamo raccolto tutto in una relazione depositata oggi in commissione Antimafia – dicono ancora i componenti -. Abbiamo constatato con sconcerto che i due hanno compiuto una totale riscrittura non solo della storia processuale delle stragi, ma anche della storia del Paese, tentando di carpire la buona fede di chi non conosce le complesse vicende in questione. Questa circostanza è particolarmente grave perché così facendo i due aumentano, anziché diminuire, la coltre di fumo che ancora oggi aleggia sull’attentato di via D’Amelio e sulle altre stragi del 1992-93”.
“Solo per fare pochissimi esempi – aggiungono – abbiamo verificato che Mori e De Donno hanno citato una frase che sarebbe contenuta nel cosiddetto diario di Falcone, ma che in realtà in quel diario non esiste affatto! Hanno riportato nella commissione Antimafia una frase che non è mai esistita negli scritti di Falcone! Sempre sul diario di Falcone, Mori e De Donno hanno affermato una cosa opposta rispetto a quello che lo stesso De Donno disse davanti ai magistrati nel 1993. In un assurdo conrtocircuito di falsità e contraddizioni, Mori e De Donno arrivano persino a rivolgere a Falcone l’accusa di avere insabbiato le indagini sui politici nel procedimento mafia-appalti. Si resta basiti dinanzi a simili insinuazioni che non meriterebbero alcun commento. Le informazioni del tutto infondate riportate dai due sono tante altre e tutte gravi, si va dalla bugia secondo cui Borsellino non fosse stato informato dai colleghi sull’archiviazione parziale e temporanea di un filone dell’indagine mafia-appalti, poi riaperto una volta raccolti nuovi elementi, alla falsità sul contenuto delle rivelazioni del pentito Gaspare Mutolo”. “Nel frattempo, in Commissione da due anni qualsiasi iniziativa del M5S viene bloccata. Così la commissione Antimafia sta percorrendo strade del tutto depistanti e sta gettando alle ortiche l’ennesima occasione per scoprire tutte le verità sulle stragi del 1992-93”, concludono i pentastellati. PALERMO TODAY
Antimafia, Forza Italia dopo l’audizione di Mori e De Donno: “Nomi precisi e vicende inquietanti, andremo fino in fondo”
Questa mattina, presso l’aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha svolto il seguito dell’audizione di Mario Mori, generale dell’Arma dei Carabinieri in congedo, e di Giuseppe De Donno, colonnello dell’Arma dei Carabinieri in congedo, nell’ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Dopo l’appuntamento è arrivata la nota congiunta del Capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione Antimafia, il Vicepresidente della Commissione Antimafia di Forza Italia, Mauro D’Attis, il Capogruppo in Commissione Antimafia di Forza Italia, Pietro Pittalis ed i membri Pierantonio Zanettin, Giuseppe Castiglione e Chiara Tenerini: “Vogliamo ringraziare il generale Mori e il colonnello De Donno per la loro audizione in Commissione antimafia. Dove rispondendo alle domande e facendo ulteriori richiami allo storico documento che avevano già illustrato e depositato hanno fatto con coraggio espliciti riferimenti e persone e vicende, sulle quali la commissione si dovrà pronunciare con chiarezza. Mori e De Donno, assolti dopo una autentica e lunga persecuzione, hanno fatto nomi e illustrato vicende inquietanti. Hanno fatto nomi precisi. Da Giammanco a Lo Forte, da Pignatone a Leoluca Orlando. Hanno ribadito la verità sulla torbida vicenda dell’archiviazione dell’inchiesta Mafia-appalti, causa di stragi di mafia. Hanno con coraggio reso un ulteriore servizio alla Repubblica. Sono stati vani i tentativi minoritari e infondati di rallentare l’attività dell’antimafia. Andremo fino in fondo, affinché la verità si affermi su menzogne e manovre politico-giudiziarie i cui promotori sono emersi con chiarezza. Anche con manovrette fallite dell’ultimo secondo che non ci ostacoleranno”. IL TEMPO
La strage di via D’Amelio, De Donno: «Nell’ufficio di Borsellino carte su mafia e appalti»
«Dal verbale di sequestro del materiale acquisito nell’ufficio del dottor Borsellino dopo la morte risulta che la maggior parte riguardava indagini su appalti e personaggi che si ritrovano nella nostra annotazione di febbraio». Lo ha detto Giuseppe De Donno, colonnello dell’Arma dei carabinieri in congedo, durante un’audizione davanti alla Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali nell’ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Nel suo intervento ha ripercorso le tappe dell’attività svolta al Ros. «Il 20 febbraio 1991 consegnai al dottor Falcone, quale procuratore aggiunto di Palermo, un’annotazione a firma del colonnello Mario Mori conosciuta poi come “Mafia e Appalti”, composta da 877 pagine, 483 allegati e 44 schede relative a persone coinvolte nelle indagini – ha spiegato -. Il documento costituiva il compendio di tutta l’attività investigativa eseguita su questo settore fino a quel momento. In precedenza, poiché più volte siamo stati accusati di aver omesso nell’informativa di febbraio ’91 tutta la parte politica che ne era venuta fuori, nel quadro di queste indagini avevo consegnato al dottor Falcone, a Guido Loforte e Giuseppe Pignatone, una serie di annotazioni preliminari, due delle quali il 2 luglio e il 5 agosto del 90, in cui si delineavano i rapporti relativi a responsabilità di personaggi politici nazionali e regionali in merito. Chiedevamo di poter svolgere approfondimenti ed è il motivo per cui nel documento non erano citati parti politiche. Non ricevemmo mai una delega da parte della procura di Palermo». GdS 16.5.2924
Processo Trattativa, famiglia Borsellino: “Ora concentrarsi sul nido di vipere…”
Il Rapporto “Mafia&Appalti” e l’eliminazione del dottor Paolo Borsellino