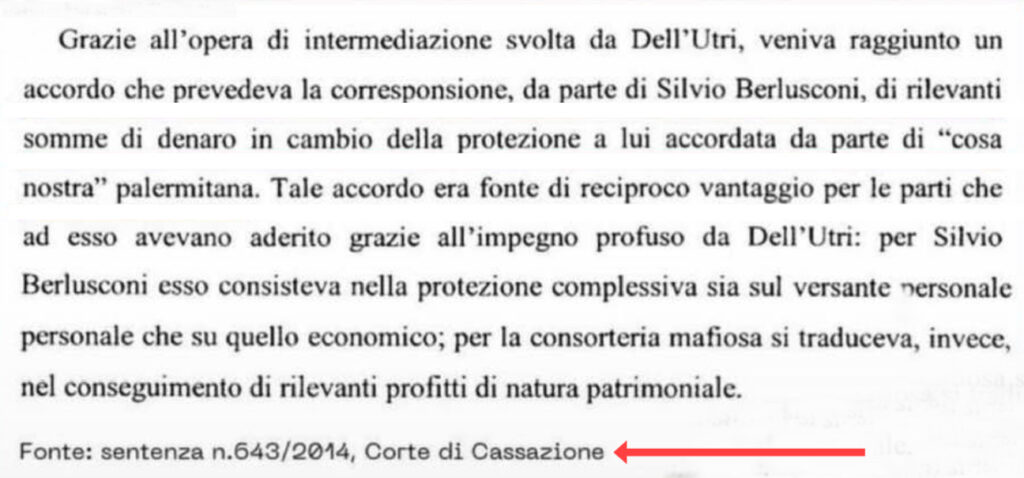13.1.2025 BERLUSCONI era taglieggiato dalla mafia
16.6.2923 Milano avrà l’aeroporto Silvio Berlusconi?
5.5.2023 LA DIA: “’93-’94 COMPRESENZE DI DELL’UTRI E GRAVIANO”
L’ANTIRICICLAGGIO e i sospetti su BERLUSCONI e DELL’UTRI
“BAIARDO MI FECE VEDERE UNA FOTO DI B. CON GRAVIANO”
SENTENZA
La Corte di Cassazione conferma: Fininvest ha finanziato la mafia
Scrivere che “La Fininvest ha finanziato Cosa Nostra ed è stata in rapporti con la mafia” è assolutamente legittimo: così ha stabilito la Corte di Cassazione, che dopo sette anni è andata a chiudere il processo intentato dalla Fininvest, holding fondata nel 1975 da Silvio Berlusconi, contro il magistrato Luca Tescaroli, il giornalista Ferruccio Pinotti ed RCS, la Casa Editrice che ha pubblicato il loro libro dal titolo “Colletti Sporchi”. All’interno dell’opera, uscita nel 2008, gli autori avevano approfondito l’annoso tema dei rapporti tra il gotha della mafia siciliana e la società di Berlusconi, i cui vertici avrebbero versato periodicamente 200 milioni di lire “a titolo di contributo a Cosa Nostra”.
In particolare, nel libro trovavano spazio le dichiarazioni del pentito Salvatore Cancemi, che, nella cornice del processo sulle stragi di Capaci e di via D’Amelio, rivelò che il capo di Cosa Nostra Totò Riina si sarebbe attivato dall’inizio degli anni ’90 al fine di “coltivare direttamente […] i rapporti con i vertici della Fininvest tramite Craxi” e che lo stesso Riina, nel 1991, gli riferì che “Berlusconi e […] Marcello Dell’Utri erano interessati ad acquistare la zona vecchia di Palermo e che lui stesso (Riina, ndr) si sarebbe occupato dell’affare, avendo i due personaggi ‘nelle mani’”. Lo spaccato delineato da Cancemi rispetto all’asse Fininvest-Cosa Nostra è stato confermato dalle testimonianze di altri importanti esponenti della mafia palermitana divenuti collaboratori di giustizia, tra cui Giovanni Brusca, che inquadrò “come regalo, come contributo, come estorsione” il denaro versato da Berlusconi a Cosa Nostra, e Gaetano Grado, che affermò che una parte degli ingenti guadagni del traffico di droga furono investiti dalla mafia, tramite l’azione di Dell’Utri, nelle società di Silvio Berlusconi.
Essendo stato riconosciuto come mediatore tra Cosa Nostra e l’allora imprenditore Berlusconi, nel 2014 Marcello Dell’Utri è stato condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza definitiva che gli ha impartito sette anni di carcere afferma che “grazie all’opera di intermediazione svolta da Dell’Utri veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione da parte di Silvio Berlusconi di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione da lui accordata da Cosa Nostra palermitana. Tale accordo era fonte di reciproco vantaggio per le parti che a esso avevano aderito grazie all’impegno profuso da Dell’Utri: per Silvio Berlusconi esso consisteva nella protezione complessiva sia sul versante personale che su quello economico; per la consorteria mafiosa si traduceva invece nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale. Tale patto non era stato preceduto da azioni intimidatorie di Cosa Nostra palermitana in danno di Silvio Berlusconi e costituiva piuttosto l’espressione di una certa espressa propensione a monetizzare per quanto possibile il rischio cui era esposto”. Secondo i magistrati, tale patto sarebbe stato stipulato nel 1974, in occasione di un incontro tenutosi a Milano tra Silvio Berlusconi, il suo braccio destro Marcello Dell’Utri, l’allora capo della mafia palermitana Stefano Bontate e il mafioso Francesco di Carlo. Esso sarebbe rimasto effettivo fino all’anno 1992. “Il sopravvento di Riina e dei corleonesi [che sconfissero i palermitani nella seconda guerra di mafia e conquistarono il comando dell’organizzazione, ndr] – prosegue la Cassazione – non aveva mutato gli equilibri che avevano garantito l’accordo nel 1974 tra Berlusconi e Cosa Nostra grazie all’intermediazione di Dell’Utri, che aveva assicurato da un lato la generale protezione dell’imprenditore, e dall’altro profitti e guadagni illeciti utili al rafforzamento dell’organizzazione mafiosa, che per circa un ventennio aveva mantenuto contatti con il facoltoso imprenditore. L’avvento dei corleonesi di Totò Riina non aveva inciso sulla causa illecita del patto. Berlusconi aveva infatti costantemente manifestato la sua personale propensione a non ricorrere a forme istituzionali di tutela, ma avvalendosi piuttosto dell’opera di mediazione con Cosa Nostra svolta da Dell’Utri. A sua volta Dell’Utri aveva provveduto con continuità a effettuare per conto di Berlusconi il versamento delle somme concordate a Cosa Nostra e non aveva in alcun modo contestato le nuove richieste avanzate da Totò Riina”.
La via era, insomma, segnata dalle precedenti risultanze processuali. Seguendo la linea dei giudici di primo e secondo grado e respingendo l’ennesimo ricorso della Fininvest, la Cassazione ha effettuato la “verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie” e “della congruità e logicità della motivazione”. La Fininvest sarà ora chiamata a pagare le spese processuali. [di Stefano Baudino
Chi è la misteriosa fonte che nel marzo del 1994 raccontò a Repubblica il contenuto di un verbale del pentito Salvatore Cancemi, bruciando di fatto le prime indagini su presunti collegamenti tra Cosa nostra, Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi? La domanda era stata posta dal fattoquotidiano.it subito dopo aver finito di leggere il libro di Ilda Boccassini, La stanza numero 30 (Feltrinelli). Ora quella stessa domanda è stata posta all’ex procuratore aggiunto di Milano – oggi in pensione – dai magistrati della procura di Firenze che indagano su Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri per le stragi del 1993.
A raccontare che Boccassini è stata sentita dai magistrati toscani è Domani, il quotidiano per il quale lavora Attilio Bolzoni, uno dei due giornalisti che firmò lo scoop di Repubblica nel ’94. I pm avrebbero potuto chiedere a Bolzoni l’identità della fonte di quella notizia ma il giornalista siciliano non l’avrebbe potuta rivelare senza violare il segreto professionale. L’altro autore di quello scoop, Giuseppe D’Avanzo, è invece morto nel 2011. Ecco perché la procura ha interrogato Boccassini. Da tempo la storia dello scoop di D’Avanzo e Bolzoni sulle scottanti dichiarazioni di Cancemi, relative ai contatti tra i clan e Marcello Dell’Utri – come “emissario” di Silvio Berlusconi – impegna investigatori di lungo corso e appassiona generazioni di cronisti di giudiziaria. Nel suo libro Boccassini torna sull’argomento rivelando un particolare inedito: prima di morire D’Avanzo le rivelò l’identità della fonte che le aveva bruciato l’indagine. Ma andiamo con ordine.
Cancemi, reggente del mandamento di Porta nuova e dunque appartenente alla Cupola, è il primo a parlare dell’esistenza di contatti tra Totò Riina e “persone importanti” non affiliate a Cosa nostra: a riferirglielo, sostiene, era stato Raffaele Ganci, boss della Noce e fedelissimo del capo del capi. Nel libro Boccassini racconta quando lo ha interrogato. Prima domanda: “Nei precedenti verbali lei ha riferito di aver saputo da Raffaele Ganci che Salvatore Riina avrebbe avuto un incontro con persone importanti prima che venisse ucciso il giudice Falcone. Personaggi che avrebbero garantito a Riina la revisione dei processi. Conferma queste circostanze?”. È da quel momento che Cancemi comincia il suo clamoroso racconto, riportato quasi integralmente nel libro di Boccassini. “Ho il dovere di riferire queste circostanze, che io ho vissuto in questi anni da protagonista. Nel 1990 o 1991, in questo momento non riesco a essere più preciso […], Ganci Raffaele mi disse che Salvatore Riina voleva parlarmi, ci incontrammo nell’ormai famosa villa di Girolamo Guddo. Riina cominciò parlando di Vittorio Mangano, persona che peraltro non era molto gradita allo stesso Riina perché in passato Mangano era vicino a Stefano Bontade. Riina mi disse di riferire a Mangano che non doveva più interferire nel rapporto che lo stesso aveva instaurato da anni con un tale Dell’Utri, collaboratore di Silvio Berlusconi, perché da quel momento i rapporti con il Dell’Utri li avrebbe tenuti direttamente Riina. Quest’ultimo precisò che, secondo gli accordi stabiliti con Dell’Utri che faceva da emissario per conto di Berlusconi, arrivavano a Riina 200 milioni l’anno in più rate, in quanto erano dislocate a Palermo più antenne (questa è l’espressione che usò Riina, ma ovviamente si riferiva a emittenti private)”. Cancemi aveva aggiunto che quei soldi arrivavano in più “rate da 40-50 milioni. Queste rate venivano consegnate non so da chi a Pierino Di Napoli, reggente della famiglia di Malaspina, compresa nel mandamento La Noce”.
Dopo quei racconti partirono subito, in grande segreto, gli appostamenti e i pedinamenti affidati ai carabinieri del capitano Sergio De Caprio: “Obiettivo principale delle indagini era, ovviamente, il boss Pierino Di Napoli perché attraverso di lui – sempre che le circostanze riferite da Cancemi fossero risultate veritiere – si sarebbe potuto documentare il passaggio di denaro a favore di Riina“, scrive Boccassini. “Su Di Napoli, a piede libero perché formalmente incensurato, venne organizzato un servizio di osservazione costante, affidato al capitano Ultimo e alla sua squadra. Benché libero, il boss di Malaspina si muoveva con estrema circospezione, e per comunicare usava cabine telefoniche nonostante possedesse un apparecchio cellulare. Non si accorse mai, comunque, di essere controllato ed eravamo fiduciosi negli sviluppi dell’operazione, avendo rapidamente individuato e messo sotto controllo i luoghi che frequentava e le persone con cui si accompagnava. Insomma, la rete era stata gettata, ma la quantità di pesci che saremmo riusciti a catturare dipendeva dall’efficienza degli uomini che lo seguivano come ombre, e – perché no – anche da un po’ di fortuna”.
La buona sorte, però, in questa storia non sembra comparire mai. Il 21 marzo del 1994 su Repubblica i giornalisti Bolzoni e D’Avanzo pubblicano i contenuti del verbale di Cancemi. Dalle dichiarazioni del pentito è passato un mese esatto, mentre alle elezioni politiche mancano solo sette giorni. Boccassini sostiene di essere rimasta “sconcertata e annichilita quando, solo pochi giorni dopo, l’effetto sorpresa su cui molto contavamo venne spazzato via” da quell’articolo. “Rimasi sgomenta – insiste – non solo per il vantaggio che i mafiosi avrebbero acquisito su di noi, ma soprattutto perché – data la delicatezza dei temi trattati – quelle dodici pagine di verbale d’interrogatorio di Cancemi non erano state fotocopiate né consegnate a nessuno, nemmeno alle forze dell’ordine con cui operavo.
Gli stessi colleghi di Caltanissetta non ne avevano voluto una copia e l’originale era chiuso nella cassaforte del mio ufficio. Avevo avuto cura di non riportare brani delle dichiarazioni del collaboratore nemmeno nella delega alla polizia giudiziaria per attivare l’azione investigativa. Per farla breve, oltre che nella mia cassaforte, copia di quel verbale era stata trasmessa soltanto alle due procure, Palermo e Firenze, che indagavano sulle stragi”. Eppure, prosegue il magistrato, “dalla lettura dell’articolo di Repubblica appariva chiaro – soprattutto se si conoscevano le dichiarazioni verbalizzate e il contenuto della delega alla polizia giudiziaria – che i giornalisti erano in possesso di entrambi i documenti, o quanto meno li avevano letti. Ma come era stato possibile? Chi aveva aperto una falla nell’assoluta riservatezza di quella delicatissima investigazione?”.
Domande che si sono posti negli anni successivi diversi cronisti e parecchi investigatori. E che Boccassini racconta di avere rivolto più volte allo stesso D’Avanzo, al quale era legata da un rapporto di amicizia. “Anche dopo anni, ho sollecitato Peppe perché mi indicasse la fonte che aveva ispirato e reso possibile la stesura di quel maledetto articolo con il quale aveva vanificato – facendo il suo mestiere, lo so bene – una pista che avrebbe potuto portarci molto lontano. Ma, nonostante la stima e l’amicizia che ci legavano, Peppe ha sempre lasciato cadere il discorso su quell’oscura vicenda, non mi ha mai voluto rivelare alcun dettaglio né indizio”. A un certo punto, però, D’Avanzo decise di raccontare a Boccassini i retroscena di quello scoop. “Proprio pochi giorni prima della sua morte improvvisa (avvenuta il 30 luglio 2011), alla mia ennesima sollecitazione, finalmente mi raccontò cos’era avvenuto diciassette anni prima. Perché si fosse deciso a farlo, sinceramente non lo so, forse oggi lo saprei se la morte non se lo fosse portato via. Ma quella fu l’ultima volta che lo vidi. Eravamo a casa mia, seduti sui divani uno di fronte all’altra. Sul tavolo le mie sigarette, i suoi sigari e il suo bicchiere di whisky con il ghiaccio”.
A questo punto Boccassini riporta quanto sostiene di aver saputo dal giornalista. “In una tiepida notte romana del marzo 1994 – scrive – era squillato il telefono di casa D’Avanzo. Peppe aveva risposto e, con suo grande stupore, aveva sentito dall’altra parte una voce che ben conosceva ma che aveva qualcosa di inusuale. Il tono era basso, grave e anche l’ora della telefonata era insolita. Ma ancora più stupefacente era stata la richiesta ricevuta: ‘Peppe, vieni subito da me. Devo parlarti di una cosa importante’. Impossibile dire di no. D’Avanzo era uscito in fretta da casa, era salito su un taxi e dieci minuti dopo suonava all’appartamento. L’uomo – ricordò Peppe – era scosso, turbato, ‘aveva gli occhi lucidi, che testimoniavano una sorta di disperazione mista a paura che mi ha colto di sorpresa’. D’Avanzo proprio non si aspettava né sapeva spiegarsi una tale agitazione in una persona nota a tutti per l’aplomb, la razionalità, l’estrema freddezza anche nei frangenti più delicati e pericolosi, con una sperimentata capacità di controllare le emozioni: ‘Eppure era lì, proprio davanti a me, con le lacrime agli occhi e delle carte in mano. Ne ho letto velocemente il contenuto e mi sono appuntato qualche frase. Non mi ha lasciato nulla in mano e me ne sono andato subito dopo, senza parole”.
Anche senza fare nomi, però, nel racconto di Boccassini sono presenti alcuni elementi che possono far risalire all’identità della fonte: si tratta con tutta probabilità di un inquirente che lavorava – o aveva rapporti investigativi – con le procure di Palermo o Firenze. Una persona nota per la sua freddezza che abitava a Roma, a poca distanza – dieci minuti in taxi – da casa D’Avanzo. Di chi si tratta? L’ex magistrata non lo scrive, ma lancia una sorta di messaggio all’ignoto personaggio. “Non c’è dubbio che la persona che si era rivolta a Peppe era consapevole del danno che sarebbe derivato alle indagini dalla pubblicazione del verbale di Cancemi, né ho mai dubitato della genuinità del racconto di D’Avanzo, uomo e professionista non incline all’esagerazione o addirittura all’invenzione. Niente nomi, perché Peppe non c’è più e perché il suo interlocutore mi conosce bene. Forse sarebbe importante per tutti se volesse confrontarsi sui motivi che lo hanno spinto ad agire in quel modo”. Quel nome, però, interessa parecchio alla procura di Firenze.
(da “ilfattoquotidiano.it” https://bit.ly/3NO2FsV)
Tra i nomi presenti nell’elenco dei condannati in primo grado al processo sulla Trattativa Stato-Mafia, oltre a quelli dei Carabinieri ai vertici del Ros e di alcuni uomini d’onore, c’è quello di un importante politico: il braccio destro dell’ex Premier Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri, il cui ruolo all’interno del contesto delle connessioni tra Cosa Nostra e le istituzioni italiane è facilmente desumibile dal combinato disposto della sentenza appena citata e di quella che, nel 2014, lo condannò in terzo grado di giudizio a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa: essa attesta che “grazie all’opera di intermediazione svolta da Dell’Utri veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione da parte di Silvio Berlusconi di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione da lui accordata da Cosa Nostra palermitana. Tale accordo era fonte di reciproco vantaggio per le parti che a esso avevano aderito grazie all’impegno profuso da Dell’Utri: per Silvio Berlusconi esso consisteva nella protezione complessiva sia sul versante personale che su quello economico; per la consorteria mafiosa si traduceva invece nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale. Tale patto non era stato preceduto da azioni intimidatorie di Cosa Nostra palermitana in danno di Silvio Berlusconi e costituiva piuttosto l’espressione di una certa espressa propensione a monetizzare per quanto possibile il rischio cui era esposto”. Il periodo in cui questo patto tra Silvio Berlusconi e Cosa Nostra sarebbe stato operativo è stato individuato dai giudici a partire dal 1974, quando in un palazzo di Milano centro si tenne un meeting tra Berlusconi, Dell’Utri, l’allora capo di Cosa Nostra Stefano Bontate (il cui consigliere Mimmo Teresi era in stretti rapporti con Dell’Utri) e Francesco Di Carlo, fino al 1992. Scrive ancora la Cassazione: “La morte di Bontate e Teresi e il sopravvento di Riina e dei corleonesi non aveva mutato gli equilibri che avevano garantito l’accordo nel 1974 tra Berlusconi e Cosa Nostra grazie all’intermediazione di Dell’Utri, che aveva assicurato da un lato la generale protezione dell’imprenditore, e dall’altro profitti e guadagni illeciti utili al rafforzamento dell’organizzazione mafiosa, che per circa un ventennio aveva mantenuto contatti con il facoltoso imprenditore. L’avvento dei corleonesi di Totò Riina non aveva inciso sulla causa illecita del patto. Berlusconi aveva infatti costantemente manifestato la sua personale propensione a non ricorrere a forme istituzionali di tutela, ma avvalendosi piuttosto dell’opera di mediazione con Cosa Nostra svolta da Dell’Utri. A sua volta Dell’Utri aveva provveduto con continuità a effettuare per conto di Berlusconi il versamento delle somme concordate a Cosa Nostra e non aveva in alcun modo contestato le nuove richieste avanzate da Totò Riina”.
La sentenza sulla trattativa Stato-Mafia, invece, va ancora oltre e amplifica il peso del ruolo avuto da Silvio Berlusconi in questo patto con la mafia, asserendo che i pagamenti effettuati da Berlusconi in favore di Cosa Nostra sarebbero proseguiti “almeno fino al Dicembre 1994”. Un dato non da poco, dal momento che Berlusconi, nel Dicembre del 1994, era già da sei mesi il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. Recita la sentenza: “Tali pagamenti sono proseguiti almeno fino al dicembre 1994 quando a Di Natale [mafioso, ndr] fu fatto annotare il relativo versamento di L. 250.000.000 nel libro mastro che in quel momento egli gestiva, perché ciò dimostra inconfutabilmente che ancora sino alla predetta data (dicembre 1994) Dell‘Utri, che faceva da intermediario, riferiva a Berlusconi riguardo ai rapporti con i mafiosi, attenendone le necessarie somme di denaro e l’autorizzazione a versarle a Cosa Nostra”. La Corte ha inoltre attestato che “Con l’apertura alle esigenze dell’associazione mafiosa Cosa nostra, manifestata da Dell’Utri nella sua funzione di intermediario dell’imprenditore Silvio Berlusconi nel frattempo sceso in campo in vista delle politiche del 1994, si rafforza il proposito criminoso dei vertici mafiosi di proseguire con la strategia ricattatoria iniziata da Riina nel 1992 […] Vi è la prova che Dell’Utri interloquiva con Berlusconi anche al riguardo al denaro da versare ai mafiosi ancora nello stesso periodo temporale nel quale incontrava Mangano [mafioso di Cosa Nostra, assunto come stalliere nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore nel 1973, che lasciò tre anni più tardi, definito dal giudice Paolo Borsellino «uno di quei personaggi che erano le ‘teste di ponte’ dell’organizzazione mafiosa nel Nord Italia», ndr] per le problematiche relative alle iniziative legislative che i mafiosi si attendevano dal governo”. “Ciò dimostra – continua la Corte – che Dell’Utri informava Berlusconi dei suoi rapporti con i clan anche dopo l’insediamento del governo da lui presieduto, perché solo Berlusconi, da premier, avrebbe potuto autorizzare un intervento legislativo come quello tentato e riferirne a Dell’Utri per tranquillizzare i suoi interlocutori”. Negli ultimi anni numerosi collaboratori di giustizia sono stati chiamati a testimoniare sui retroscena delle stragi mafiose e sulle relazioni intraprese dalla mafia con importanti settori della politica, dei servizi e dell’imprenditoria italiana. Al centro delle dichiarazioni di molti di loro, tra tanti elementi, spicca un denominatore comune: quello dei rapporti tra Silvio Berlusconi e Cosa Nostra.
A questo proposito, sono scottanti le rivelazioni fatte da Giuseppe Graviano, reggente del mandamento di Brancaccio insieme a suo fratello Filippo dal 1990 al 1994 (quando fu arrestato) e organizzatore della strage di Via D’Amelio, dell’omicidio di don Pino Puglisie delle stragi del 1993 a Firenze, Milano e Roma, quando è stato chiamato a deporre nel Febbraio 2020 al processo di Reggio Calabria contro la ‘Ndrangheta stragista. Il boss ha riferito davanti alla corte che suo nonno, Filippo Quartararo, avrebbe investito denaro in modo occulto nelle società di Silvio Berlusconi negli anni ’70: «Gli dicono che gli avrebbero concesso il 20%. […] Mio nonno voleva partecipare a quella società e curarsi delle sue cose. Andò da mio padre che però gli disse che non voleva saperne e che non voleva che coinvolgesse noi nipoti. […] Morto mio padre, mio nonno dice a me e a mio cugino Salvatore Graviano, che camminava sempre con lui, la verità: ci dice della società con gli imprenditori del Nord, perché non aveva nessun altro a cui rivolgersi. Disse: ‘C’è questa situazione, io sto andando avanti. Tuo papà non vuole che mi rivolga a voi. Io sono vecchio e ora te ne devi occupare tu’. Io e mio cugino Salvo abbiamo detto: ‘ci pensiamo’. Ci siamo consigliati col signor Giuseppe Greco, padre di Michele Greco.Abbiamo deciso di sì e siamo partiti per Milano. E mio nonno ci ha presentati al signor Berlusconi, abbiamo capito cos’era questa società. Poco dopo mio nonno, che aveva più di 80 anni, morì». L’incontro in cui Berlusconi avrebbe presentato la società a Graviano avrebbe avuto luogo all’Hotel Quark. Altri incontri tra l’allora imprenditore Berlusconi e Graviano sarebbero avvenuti, a detta di quest’ultimo, nel 1993: «C’è una riunione preliminare con me, mio cugino e Berlusconi a Milano 3, – continua il boss –, la situazione andava regolarizzata. Siccome Berlusconi aveva detto di sì, dovevamo fissare un appuntamento. C’erano anche altre persone che però non mi sono state presentate in quell’occasione. Penso sapesse che ero latitante. Lo ero dal 1984 e io mi sono presentato col mio nome, sapeva che ero nipote di mio nonno». Riguardo alla discesa in campo di Silvio Berlusconi e della sua creatura politica Forza Italia alle elezioni del 1994, Graviano ha sostenuto che il progetto di Forza Italia sarebbe stato già pronto nel 1992: «Berlusconi ne parla con mio cugino Salvo, gli chiede se giù in Sicilia gli potevano dare appoggio. Mio cugino gli dice ‘non c’è bisogno che ti faccio campagna elettorale, c’è questa situazione a Brancaccio, rendilo un bel quartiere – come voleva fare mio padre, che faceva lavorare tutti – e vedi che la gente ti dà i voti’. Siamo prima della strage di Capaci. Era successo da poco l’omicidio Lima, mi pare». Anche Gaspare Spatuzza, l’autore del furto della Fiat 126 che il 19 Luglio 1992 venne impiegata come autobomba nella strage in cui perse la vita Paolo Borsellino, nonché uno degli esecutori materiali dell’omicidio di don Pino Puglisi nel settembre 1993, ha parlato delle relazioni tra l’ex Cavaliere e la mafia palermitana. Il teste è stato ascoltato nel Febbraio 2019 nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio. Nella sua deposizione si è soffermato sulla fase organizzativa del fallito attentato allo Stadio Olimpico di Roma, previsto dagli uomini di Cosa Nostra per il 23 Gennaio 1994: «Venne pianificato l’attentato contro i carabinieri. Io dissi in quell’occasione che ci stavamo portando dietro dei morti che non ci appartenevano, come Firenze, dove erano morti bambini e persone civili, così come Milano (qui Spatuzza sta citando le stragi di mafia del 1993, ndr). Era qualcosa di esterno a noi. Ed è in quell’occasione che ci disse se capivamo di politica. Lui ci spiegò che ‘era in piedi una cosa che se andava a buon fine avremmo avuto tutti benefici, a partire dai carcerati’». Pochi giorni prima rispetto alla data stabilita per l’esecuzione della strage allo Stadio Olimpico, poi fallita, Giuseppe Graviano, dal quale la squadra dei killer aspettava l’ordine definitivo, raggiunse Spatuzza e i suoi uomini nella Capitale. Il pentito ha raccontato ciò che il boss di Brancaccio gli avrebbe detto in quell’occasione e le sue sono, ancora una volta, dichiarazioni che scottano e pesano moltissimo: «Mi dice che ‘avevamo chiuso tutto ed avevamo ottenuto quello che cercavamo’. Disse che avevamo chiuso grazie a persone serie che avevano portato avanti questa cosa ed ebbe a dire che la personalità, quello che aveva gestito un po’ tutto, era Berlusconi. Chiesi se era quello di Canale 5 e lui rispose affermativamente e che ‘in mezzo c’era il nostro compaesano Dell’Utri’. Mi disse che si doveva andare avanti con l’attentato ai carabinieri perché con questo dovevamo dare il colpo di grazia». Un tema, quello sollevato da Spatuzza in merito alla vicinanza tra pezzi dell’imprenditoria e della politica e i boss della criminalità organizzata palermitana, che va ad intersecarsi in maniera inscindibile con il tema della trattativa Stato-mafia e con i fatti che quella sentenza, così come parzialmente aveva fatto la sentenza Dell’Utri in precedenza, ha accertato. Anche il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, altro ex membro di spicco di Cosa Nostra (condannato per oltre cento omicidi, tra cui quello di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta), è stato sentito nella cornice del medesimo processo e ha fornito altri dettagli sul tema. Egli ha raccontato di alcune presunte confidenze fattegli da suo cugino Ignazio Pullarà, uomo d’onore della famiglia Santa Maria di Gesù, tra il 1987 e il 1988: «Mi raccontò che Giovannello Greco, della famiglia di Ciaculli, aveva fatto irruzione a casa di Antonino Cinà, che finirà imputato con Dell’Utri, minacciando che avrebbe ucciso lui e tutta la sua famiglia se non gli avesse fatto recuperare i soldi investiti con la Fininvest di Dell’Utri e di Berlusconi. Allora si parlava di circa 800 milioni di lire, che gli ha fatto avere. Mi disse – ha continuato Brusca, sempre facendo riferimento a Pullarà – che era stato lui a fargli mettere a Berlusconi la bomba dietro il cancello (attacco dinamitardo davanti alla villa di Silvio Berlusconi in Via Rovani a Milano nel Novembre 1986, ndr) per farlo tornare a pagare il pizzo, perché c’è stato un momento che non lo pagava più. Stefano Bontate era il referente di Berlusconi: dopo il suo omicidio questo patto, la ‘messa a posto’ come si dice in gergo, si era interrotto. Per fare tornare Berlusconi a pagare il pizzo nello stile tipicamente mafioso è stato fatto un segnale, una bomba, un attentato dinamitardo dietro il cancello. So che il tentativo andò a buon fine, questi soldi Riina li divideva a tutti i mandamenti». Nella sua deposizione, poi, come già fatto precedentemente da Gaspare Spatuzza, Brusca ha associato alla figura di Silvio Berlusconi un altro pezzo da novanta della mafia siciliana: Giuseppe Graviano. Il collaboratore di giustizia ha infatti sostenuto davanti ai magistrati di essere venuto a sapere direttamente da Matteo Messina Denaro, ovvero da colui che oggi è il ricercato numero uno in Italia tra i latitanti mafiosi, durante un meeting con altri uomini d’onore (Nicola Di Trapani e Vincenzo Sinacori) che lo stesso Graviano avrebbe visto al polso di Silvio Berlusconi durante un «incontro a quattr’occhi» un orologio da 500 milioni di lire. Lo ribadiamo: i racconti dei pentiti, per essere rilevanti a livello processuale, devono ovviamente trovare tutti i riscontri probatori del caso e, in questa sede, ci limitiamo a raccontare quello che sta avvenendo nelle aule di giustizia in cui si stanno tenendo processi di grande rilievo. In questo momento, Silvio Berlusconi risulta indagato come possibile mandante delle stragi di mafia del 1993 assieme al suo ex braccio destro Marcello Dell’Utri. Su quest’ultimo, già condannato a 7 anni di carcere in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, pende una condanna in primo grado a 12 anni di reclusione nel processo sulla Trattativa Stato-mafia. Stefano Baudino ANTIMAFIA DUEMILA Novembre 2020
- Baiardo, i fratelli Graviano e gli “interessi particolari” per la nascente Forza Italia Durante l’udienza del processo “Ndrangheta stragista” il dirigente della polizia Francesco Messina ha ricostruito i primi contatti con il gelatiere di Omegna che raccontò dei contatti fra Filippo Graviano e l’ex senatore forzista
Il boss Giuseppe Graviano ha parlato con i pm dei soldi di Silvio Berlusconi. di Lirio Abbate. 05 MARZO 2021 ESPRESSO
Aperta a Firenze una nuova inchiesta sui capitali iniziali del leader di Forza Italia, con i giudici che volano a Palermo. Mentre il boss prosegue con la sua strategia, iniziata con una lettera del 2013 all’allora ministra Lorenzin e che oggi passa da un libro in lavorazione
C’è un’inchiesta giudiziaria destinata a creare seri problemi a Silvio Berlusconi. È stata aperta nei mesi scorsi dalla procura antimafia di Firenze. L’inchiesta parte dalle dichiarazioni fatte davanti ai giudici della corte d’Assise di Reggio Calabria dal boss Giuseppe Graviano, già condannato a diversi ergastoli per aver ordinato, tra gli altri, gli omicidi del beato Pino Puglisi, del piccolo Giuseppe Di Matteo, di altre vittime innocenti, donne e bambini, e le stragi di Firenze, Roma e Milano del 1993, quando decise che Cosa nostra doveva attaccare lo Stato.
Il capomafia ha aggiunto che nel periodo in cui era latitante, avrebbe incontrato tre volte a Milano Silvio Berlusconi. E il boss ha sostenuto che l’ex Cavaliere, prima di iniziare la sua attività politica, gli avrebbe chiesto di essere aiutato in Sicilia. Secondo Graviano, però, molte delle attese che Cosa nostra aveva riposto in Berlusconi vennero meno: il “ribaltamento” del regime carcerario del 41bis non ci fu e neppure l’abolizione dell’ergastolo. «Per questo ho definito Berlusconi traditore», ha spiegato Graviano rispondendo alle domande del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, aggiungendo di essere stato latitante dal 1984 e che questa sua situazione non gli ha impedito di incontrare Berlusconi, «che sapeva della mia condizione».
«Mio nonno», un facoltoso commerciante di frutta e verdura, ha detto Graviano «era in contatto con Berlusconi» e fu incaricato da Cosa nostra di agganciare l’ex presidente della Fininvest per investire somme di denaro al Nord. Missione riuscita, a detta del boss, sostenendo che «sono stati investiti nel settore immobiliare una cifra di circa venti miliardi di lire». Graviano dice che suo nonno è stato di fatto socio di Berlusconi: «I loro nomi apparivano solo su una scrittura privata che ha in mano mio cugino Salvo».
L’INTERROGATORIO La procura di Firenze che indaga su Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri nell’ambito delle stragi del 1993, adesso scava pure sui patrimoni iniziali dell’ex Cavaliere. In passato sui soldi di provenienza della mafia avevano indagato anche i pm di Palermo nell’ambito del processo in cui Dell’Utri è stato condannato per concorso in associazione mafiosa. Le dichiarazioni dell’ergastolano sembrano più una minaccia all’ex premier, un modo per tentare di incassare soldi e libertà.
Lo scorso novembre, sulla base di queste esternazioni, i procuratori di Firenze sono andati nel carcere di Terni e hanno interrogato Giuseppe Graviano, che ha accettato di incontrare i magistrati rispondendo pure alle loro domande, assistito dal suo difensore di fiducia. Un lungo interrogatorio che i pm toscani hanno secretato. I riscontri alle sue affermazioni sono già stati avviati.
LA STRATEGIA. Nonostante le condanne all’ergastolo per delitti di mafia a cui Giuseppe Graviano e suo fratello Filippo sono stati definitivamente condannati, dalle loro mosse si intuisce che vogliono lasciare il carcere sfruttando tutti i mezzi possibili per tornare liberi. C’è il tentativo di smontare le accuse dei collaboratori di giustizia per poi chiedere di avviare una revisione dei processi e allo stesso tempo provare ad uscire dal circuito del 41bis, il carcere impermeabile, per transitare nel regime ordinario da cui è più facile ottenere la possibilità di essere scarcerati.
Per questo motivo Giuseppe Graviano da diversi mesi ha coinvolto tutti i componenti della sua famiglia nel raccogliere dati e documenti e far scrivere un libro sulle sue vicende giudiziarie, raccontandole secondo la sua visione e il suo interesse, mettendo in discussione – secondo lui – le vecchie sentenze di condanna.
Emerge il profilo di un uomo presuntuoso, ostinato ma anche di un abile oratore, attento osservatore e opportunista, un personaggio che vuole essere carismatico e al centro dell’attenzione, non a caso è un capo importante fra i corleonesi di Cosa nostra, con solidi agganci con il latitante Matteo Messina Denaro. Il fatto che abbia scelto di parlare in aula di Berlusconi è frutto di un calcolo che ha valutato con accortezza per lo sviluppo della sua strategia.
LA LETTERA ALLA MINISTRA. I segnali lanciati da Giuseppe Graviano a Silvio Berlusconi si leggono già nel 2013, quando il Cavaliere entra con il suo Popolo delle libertà, nel governo delle larghe intese di Enrico Letta. Il boss sceglie di scrivere una lettera di cinque pagine alla nuova ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. Il capomafia apre il suo testo presentandosi e dichiarandosi innocente, «in espiazione dell’ergastolo ostativo», e «condannato solo per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza riscontri», e poi «come ben sapete voi esponenti del Pdl, perché dal primo giorno del mio arresto mi è stato detto che se non avessi accusato il presidente di Forza Italia e collaboratori, venivo accusato di tutte le stragi del 1993 in poi, lo stesso i miei fratelli di altre accuse di associazione mafiosa, invitandomi a confermare le accuse dei collaboratori di giustizia nei confronti del senatore Berlusconi».
Scrive a Lorenzin, e la lettera è stata acquisita dalla procura di Firenze, e ricorda «la provenienza dei capitali per formare il patrimonio della famiglia Berlusconi». All’allora ministra indicata da Berlusconi, Graviano scrive che dimostrerà la sua estraneità «a tutto ciò che mi viene contestato e ingiustamente condannato e non maledico la causa che mi ha portato a questa tragica situazione e non giudico i politici che hanno varato queste leggi, in particolare il Centro destra, inumane e inesistenti in nessun altro paese del pianeta terra, non danno la possibilità di uscire dal carcere, se non si confermano le contestazioni, anche accusando persone innocenti, nel mio caso confermare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia» e sottolinea che ci vorrebbe il coraggio di qualche politico «alle successive elezioni» rivolto ad «abolire la pena dell’ergastolo».
Nel circuito dei detenuti al 41bis c’è molta fibrillazione per il disegno strategico che i Graviano stanno portando avanti. E forse il boss, approfittando del nuovo cambio in via Arenula, sta pure pensando ad una lettera da inviare alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per spiegare le sue ragioni da mafioso ed ergastolano che vuole uscire.
LA DISSOCIAZIONE. Il giorno prima di interrogare Giuseppe Graviano, i procuratori aggiunti di Firenze, Luca Turco e Luca Tescaroli, hanno sentito Filippo Graviano. I pm hanno subito sottolineato il motivo della convocazione:
«Siamo interessati al tema del concorso di altre persone nelle stragi del 1993-1994 e ai rapporti economici tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri, lei (Filippo Graviano ndr) e la sua famiglia. È disponibile a parlarne? Vorremmo partire dal 28 luglio 2009 quando lei ha manifestato il proposito di dissociarsi “verso le scelte del passato”». La risposta del boss è immediata: «Fino al 2009 il mio nome non era di interesse di nessuna procura; nel 2009 ci fu l’inizio della collaborazione di Gaspare Spatuzza, io mi ero reso conto che la mia vita passata non era corretta e stavo facendo un percorso interno. Lui sosteneva che nel carcere di Tolmezzo gli avevo detto che stavamo aspettando qualcosa dall’esterno».
In quell’occasione, come ha ricostruito Spatuzza, il boss gli disse che se certe cose non si fossero verificate, sarebbe arrivato il momento di parlare coi magistrati, annunciando la possibilità di una scelta di dissociazione dall’organizzazione. Per il collaboratore sarebbe l’ulteriore prova che un accordo con pezzi della politica ci fu. Ma il capomafia continua a negare questa circostanza. «Fatta questa premessa», dice ai pm Filippo Graviano, «mi proclamo innocente rispetto ai reati che mi sono stati attribuiti nella sentenza di Firenze (quella sulle stragi del 1993 ndr) e ritengo che, per me, questa sia una questione pregiudiziale rispetto alle domande che mi avete posto. Il mio interesse è quello di ottenere una revisione della mia posizione giudiziaria. Non sono disponibile a rispondere alle vostre domande. Mi sono dissociato da Cosa nostra facendo una dichiarazione espressa di dissociazione».
E poi conclude: «Ammetto la mia responsabilità in relazione alla partecipazione a Cosa nostra palermitana, mandamento di Brancaccio, non sono mai stato capo del mandamento neppure come sostituto». L’interrogatorio, dopo un’ora, si conclude così.
IL SOPRALLUOGO A PALERMO. In relazione a questa indagine sulle stragi e sui soldi che secondo Graviano sono stati versati a Berlusconi, i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Firenze sono stati in trasferta dall’8 al 12 febbraio nella zona di Palermo per effettuare “accessi”, verifiche e sopralluoghi. Una spedizione tenuta riservata in cui i pm erano accompagnati da un gruppo di investigatori che si occupano proprio dell’inchiesta sugli attentati a Roma, Milano e Firenze in cui sono stati già condannati Giuseppe e Filippo Graviano. Questa trasferta, per le modalità con le quali è stata condotta, sembra la stessa usata quando si deve far effettuare il sopralluogo ad un nuovo collaboratore di giustizia che ricostruisce storie di cui è stato testimone o protagonista. Il piano dei Graviano è in atto, aspettano che qualcuno lo porti a compimento.
Trattativa Stato-mafia, i giudici: “Da Berlusconi soldi a Cosa nostra tramite Dell’Utri anche da premier e dopo le stragi” Nelle motivazioni della sentenza Trattativa vengono dettagliate le elargizioni di Silvio Berlusconi (già a Palazzo Chigi) ai mafiosi tramite il co-fondatore di Forza Italia: “È determinante rilevare che tali pagamenti sono proseguiti almeno fino al dicembre 1994”. Non solo. Secondo i giudici, lo stalliere di Arcore – e rappresentante dei clan – Vittorio Mangano era informato in anteprima di novità legislative relative alla custodia cautelare direttamente dal fondatore di Publitalia “per provare il rispetto dell’impegno assunto con i mafiosi” L’Italia ha avuto un presidente del consiglio che pagava Cosa nostra mentre sedeva a Palazzo Chigi. E non negli anni Cinquanta, ma almeno fino alla fine del 1994 quando la mafia aveva già mostrato il suo volto più feroce: aveva fatto a pezzi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, otto agenti di scorta, dieci civili, comprese due bambine. Quel presidente del consiglio si chiama Silvio Berlusconi ed elargiva denaro ai mafiosi sempre nello stesso modo: tramite il fido Marcello Dell’Utri. Ne sono sicuri i giudici della corte d’Assise di Palermo. E lo scrivono nelle motivazioni della sentenza che ha condannato l’ex senatore di Forza Italia a dodici anni di carcere alla fine del processo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. L’ex parlamentare – recentemente scarcerato per motivi di salute – è stato condannato per violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato. Ha cioè trasmesso al primo governo della Seconda Repubblica la minaccia di Cosa nostra: la promessa di altre bombe e altre stragi se non fosse cessata l’offensiva antimafia dell’esecutivo. Che in qualche modo cede. E inserisce una piccola leggina pro mafia in un decreto legge che non aveva visto nessuno. Ma della cui esistenza Vittorio Mangano fu informato da Marcello Dell’Utri. Che di quel governo non faceva parte.
“Berlusconi sapeva dei contatti tra Dell’Utri e Cosa nostra” – D’altra parte quell’esecutivo minacciato dai boss era presieduto da un uomo che i boss li paga da anni. Almeno fino al 1992, diceva la Corte di Cassazione che ha condannato in via definitiva Dell’Utri per concorso esterno. I giudici presieduti da Alfredo Montalto, però, la pensano diversamente. Ci sono “ragioni logico-fattuali che conducono a non dubitare che Dell’Utri abbia effettivamente riferito a Berlusconi quanto di volta in volta emergeva dai suoi rapporti con l’associazione mafiosa Cosa nostra mediati da Vittorio Mangano (ma, in altri casi, anche da Gaetano Cinà). Il fatto che Berlusconi fosse stato sempre messo a conoscenza di tali rapporti è, d’altra parte, incontestabilmente dimostrato dal ricordato esborso, da parte delle società facenti capo al Berlusconi medesimo, di ingenti somme di denaro, poi, effettivamente versate a Cosa nostra. Dell’Utri, infatti, senza l’avallo e l’autorizzazione di Berlusconi, non avrebbe potuto, ovviamente, disporre di così ingenti somme recapitate ai mafiosi”, scrivono nelle 5252 pagine delle motivazioni della sentenza depositate nel giorno dell’anniversario della strage di via d’Amelio.
“Da Berlusconi soldi a Cosa nostra fino al dicembre del 1994” – Il fatto che Berlusconi pagasse Cosa nostra, come detto, era noto ma fino ad oggi ritenuto provato solo fino al 1992, cioè prima dell’inizio delle stragi e a due anni dall’impegno politico dell’imprenditore. “È determinante rilevare che tali pagamenti sono proseguiti almeno fino al dicembre 1994 quando a Di Natale fu fatto annotare il relativo versamento di L. 250.000.000 nel libro mastro che in quel momento egli gestiva, perché ciò dimostra inconfutabilmente che ancora sino alla predetta data (dicembre 1994) Dell ‘Utri, che faceva da intermediario, riferiva a Berlusconi riguardo ai rapporti con i mafiosi, attenendone le necessarie somme di denaro e l’autorizzazione a versare e a Cosa nostra”.
Il pentito: “Soldi dal serpente”. Cioè dal Biscione – I giudici si riferiscono a Giusto Di Natale, pentito della famiglia di Resuttana che ha raccontato di come Cosa nostra etichettasse con la parola “sirpiente” – cioè dal siciliano, serpente – il denaro ricevuto come “pizzo” dalle aziende dal Biscione e cioè da Berlusconi. “Una volta venne il Guastella (il killer Pino Guastella ndr) , non mi portò il denaro, ma mi disse di annotare 250 milioni di lire, dice: Scrivici u sirpiente, che queste sono le antenne televisive di Berlusconi che si trovano a Monte Pellegrino. Il serpente stava per il Biscione, insomma, volgarmente il Biscione che c’era nella pubblicità di Mediaset e invece di scrivere Biscione mi ha detto scrivi u sirpiente, in siciliano, per capire che si trattava delle antenne televisive”. A che periodo si riferisce Di Natale? “Siamo a fine anno, le grosse cifre entravano ogni volta a fine anno: ’94 siamo … nel fatto delle antenne televisive. Ogni gruppo di estorsioni, ogni estorsione aveva il suo referente diciamo”. E il referente di quell’estorsione è Vittorio Mangano.
“Dell’Utri parlava con Mangano parlava di legge” – Se Dell’Utri è la cinghia di trasmissione della minaccia di Cosa nostra al governo Berlusconi, nel 1994 Mangano – lo stalliere di Arcore – rappresenta direttamente la volontà della Piovra. “Dell’Utri interloquiva con Berlusconi anche riguardo al denaro da versare ai mafiosi ancora nello stesso periodo temporale (1994) nel quale incontrava Vittorio Mangano per le problematiche relative alle iniziative legislative oggetto dei suoi colloqui con il medesimo Mangano, così che non sembra possibile dubitare che Dell’Utri abbia informato Berlusconi anche di tali colloqui e, in conseguenza, della pressione o dei tentativi di pressione che, come si detto, anche secondo la Corte di Cassazione, erano inevitabilmente insiti negli approcci di Vittorio Mangano e che, altrettanto inevitabilmente per la caratura criminale dei richiedenti, portavano seco l’implicita minaccia di ritorsioni, d’altra parte, già espressamente prospettata, come si è visto sopra, durante la precedente campagna elettorale”. Per i giudici è il passaggio fondamentale, cioè la prova che effettivamente il governo Berlusconi percepì la minaccia mafiosa.
Le leggi a favore dei boss raccontate “in anteprima” ai boss – Talmente tanto che – in almeno un’occasione – il primo esecutivo guidato da Forza Italia portò avanti iniziative legislative favorevoli a Cosa nostra. E Cosa nostra venne informata prima degli stessi ministri del governo Berlusconi. “Ci si intende riferire al fatto che in quella occasione del giugno – luglio 1994 Dell’Utri ebbe a riferire a Mangano ‘in anteprima’ di una imminente modifica legislativa in materia di arresti per gli indagati di mafia (lo racconta il pentito Salvatore Cucuzza: “Per quanto riguardava il 416 bis, per quanto riguarda l’arresto sul 416 bis c ‘era stata una piccola modifica … “) senza clamore, o per meglio dire nascostamente tanto che neppure successivamente fu rilevata, inserita nelle pieghe del testo di un decreto legge che rimase pressoché ignoto, nel suo testo definitivo, persino ai Ministri sino alla vigilia, se non in qualche caso allo stesso giorno, della sua approvazine da parte del Consiglio dei Ministri del Governo presieduto da Berlusconi”. In pratica Mangano sapeva di modifiche di legge decise dal governo prima che ne fossero informati gli stessi ministri. Di che cosa si parla? “È stato effettivamente riscontrato che tra le pieghe nascoste del decreto 14 luglio 1994 n. 440, v’era anche una ‘piccola modifica‘ dell’art. 275 c.p.p. nella parte in cui stabiliva che per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. dovesse essere sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere salvo che non fossero acquisiti elementi tali da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Si trattava, in sostanza, di quella presunzione di legge che, di fatto, imponeva sempre il carcere per gli indagati di mafia arrestati”. Tradotto: Mangano sapeva prima di molti ministri che il governo voleva alleggerire la norme antimafia e lo sapeva nonostante si trattasse di una norma “mai pubblicizzata e, anche per la sua tecnicalità, non ricavabile dalla lettura di giornali”.
“Leggi anticipate a Mangano per provare il rispetto degli impegni” – Cosa nostra sapeva di proposte di legge che non conosceva nessuno. E lo sapeva perché gliele raccontava Dell’Utri. “A ciò si aggiunga che quel decreto legge era stato deciso per intervenire su reati del tutto diversi da quelli di mafia (v. anche testimonianza Maroni, già riportata,a proposito della sua sorpresa quando gli fu fatta notare dal Procuratore Caselli la modifica concernente la comunicabilità delle iscrizioni nel registro degli indagati: “E io gli chiesi: come è possibile, che cosa c’entra la corruzione e la concussione, la custodia cautelare?”) e che, pertanto, non vi era ragione per la quale un soggetto estraneo al Governo, qual era Dell ‘Utri, fosse informato sino ai più minuti – e, si ripete, nascosti – dettagli di quel provvedimento idonei ad incidere anche sui reati di mafia”, sottolineano i giudic. E ancora: “Ora, il fatto che, invece, Dell’Utri fosse informato di tale modifica legislativa, tanto da riferirne a Mangano per provare il rispetto dell’impegno assunto con i mafiosi, dimostra ulteriormente che egli stesso continuava a informare Berlusconi di tutti i suoi contatti con i mafiosi medesimi anche dopo l’insediamento del Governo da quest’ultimo presieduto, perché soltanto Berlusconi, quale presidente del Consiglio, avrebbe potuto autorizzare un intervento legislativo quale quello che fu tentato con l’approvazione del decreto legge del 14 luglio 1994 n. 440 e, quindi, riferirne a Dell’Utri per “tranquillizzare” i suoi interlocutori, così come il Dell’Utri effettivamente fece”.
“B. destinatario finale”– Cosa vuol dire tutto questo? “Si ha definitiva conferma, pertanto, che anche il destinatario finale della pressione o dei tentativi di pressione, e cioè Berlusconi, nel momento in cui ricopriva la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, venne a conoscenza della minaccia in essi insita e del conseguente pericolo di reazioni stragiste (d’altronde in precedenza espressamente già prospettato) che un’inattività nel senso delle richieste dei mafiosi avrebbe potuto fare insorgere”. Silvio Berlusconi, presidente del consiglio, già definito “utilizzatore finale” e da oggi anche destinatario finale della pressione di Cosa nostra. Pagata anche dopo le stragi. Dall’uomo che sedeva a Palazzo Chigi. È nata così la Seconda Repubblica italiana.di Giuseppe Pipitone | 19 LUGLIO 2018 IL FATTO QUOTIDIANO
GIUSEPPE GRAVIANO CITA BERLUSCONI NEL COLLOQUIO IN CARCERE CON FIAMMETTA BORSELLINO. di F. Q. | 19 MAGGIO 2018
Giuseppe Graviano ha citato Silvio Berlusconi nel suo colloquio con Fiammetta Borsellino, mentre parlava del periodo della sua latitanza a Milano nel ’93 insieme al fratello Filippo. Il boss, condannato all’ergastolo proprio con il fratello Filippo per le stragi del 1992 e 1993, ha fatto questa affermazione (tutta da interpretare e da riscontrare) nel corso del colloquio straordinario nel carcere di Terni, avvenuto con la figlia minore del magistrato ucciso dal suo gruppo di fuoco nel luglio 1992.
A questa storia è dedicata la prima puntata dello ‘Speciale Trattativa Sekret” dal titolo I Gravianos che si potrà vedere su Iloft.it. a partire dal 23 maggio prossimo. La serie condotta e scritta da Marco Lillo ricostruirà senza tabù e senza preconcetti quello che è emerso nei processi ma anche le piste che le investigazioni giudiziarie hanno tralasciato. La serie si avvale infatti di intercettazioni e carte processuali ma anche di testimonianze e documenti non processuali ma utili per ricostruire quello che è successo in Italia nel periodo che va dalle stragi del 1992 alle stragi del 1993 fino alla pax mafiosa iniziata nel 1994. La figlia minore del magistrato ucciso il 19 luglio 1992 ha incontrato quel giorno nel carceredi L’Aquila anche il fratello Filippo, anche lui condannato per le stragi del 1992 e 1993. Filippo non ha accennato a Berlusconi. Entrambi i colloqui sono stati videoregistrati.
La frase di Graviano su Berlusconi è esplosiva ma scivolosa. Il boss infatti lancia il sasso e tira indietro la mano. Le registrazioni di entrambi i colloqui della figlia della vittima della strage di via D’Amelio con i boss sono state trasmesse a tutte le procure che indagano sulle stragi del 1992, 1993 e 1994 e sulla Trattativa Stato-mafia per una valutazione della loro rilevanza. Il boss, dopo aver detto che in quel periodo a Milano e nel nord Italia era latitante ma vedeva persone rispettabili e non appartenenti alla mafia, butta lì: “lo dicono tutti che frequentavo Berlusconi” e poi subito aggiunge: “Più che io era mio cugino che lo frequentava’. Il boss di Brancaccio in 24 anni di reclusione non ha mai parlato nei processi di questi argomenti. L’avvocato Niccolò Ghedini al Fatto dice: “Nessuno ci ha mostrato questa conversazione. Se esistesse bisognerebbe ascoltarla per verificare le reali parole di Graviano. Comunque lui sapeva di essere registrato e potrebbe avere depistato. A me non risulta nessun incontro di Berlusconi con Graviano o con qualcuno legato direttamente o indirettamente a lui. Tanto meno con un suo cugino noto”.
Fiammetta ha incontrato in carcere Giuseppe e Filippo Graviano il 12 dicembre scorso grazie a un decreto straordinario del ministro della giustizia Andrea Orlando. Oggi la figlia del magistrato ha fatto pubblicare una lettera su Repubblica nella quale spiega la ragione della sua richiesta di incontrare i boss. “La necessità di esprimere un dolore profondo inflitto non solo alla mia famiglia ma alla società intera. La richiesta di incontro – scrive Fiammetta – è un fatto strettamente personale e chiedo che tale debba rimanere”. Fiammetta chiede ai boss “un contributo di onestà” e gli ricorda che “soltanto contribuendo alla ricerca della verità i figli potranno essere orgogliosi dei padri”.
Nessuno sa perché Graviano dica quella frase su Berlusconi a Fiammetta. Nessuno sa se voglia depistare o ricattare. Nessuno sa chi sia il cugino. Solo lui può sciogliere i dubbi. La trascrizione del colloquio con Fiammetta è stata spedita alla Procura di Firenze che ha iscritto nei mesi scorsi Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi per concorso in strage a seguito delle conversazioni intercettate (tra il 2016 e il marzo 2017) nel carcere tra Graviano e il detenuto Umberto Adinolfi nelle quali il boss di Brancaccio – per la Dia – parla di Berlusconi e Dell’Utri. Gli audio dei due colloqui con i Graviano sono giunte anche ai pm di Palermo che indagano sulla trattativa e a quelli di Caltanissetta che indagano sulle stragi del 1992 e che in passato ha indagato e poi però archiviato la posizione di Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi. Le registrazioni dei due colloqui sono state inviate anche alla Direzione Nazionale Antimafia e alla Procura di Reggio Calabria, che sta processando Graviano per l’uccisione dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo
Fiammetta Borsellino potrebbe essere chiamata presto a deporre sul colloquio con Giuseppe Graviano.
Lei non è minimamente interessata alla frase di Graviano su Berlusconi. Nel carcere di Terni quel giorno cambia discorso e ora vorrebbe tornare a parlare solo con Filippo Graviano, non con Giuseppe. La richiesta del colloquio pende però da mesi. Tutte le Procure interessate hanno sconsigliato di autorizzare una nuova visita. Fiammetta nella sua lettera però insiste: “Ora è importante che io possa continuare quel dialogo che è stato interrotto, con enorme dispiacere registro la mancanza di una risposta ufficiale da parte delle istituzioni”.
Sekret – Speciale Trattativa Stato-mafia è una video-inchiesta giornalistica esclusiva firmata da Marco Lillo per la piattaforma Loft. Quella che vedete in questo articolo è l’anticipazione della prima puntata della serie dedicata al patto scellerato tra pezzi delle istituzioni e Cosa nostra. Documenti, ricostruzioni, immagini e audio inediti e, soprattutto, scoop che gli abbonati alla App Loft potranno seguire nel lavoro capillare del vicedirettore de Il Fatto Quotidiano. Domenica 20 maggio uno speciale sul Fatto in edicola.
Villa Rovani, l’ombra del patto sporco di B. sulle bombe dei padrini. La sentenza definitiva del processo dell’Utri spiega molti dettagli sugli attentati mafiosi di via Rovani. Ma, dopo 34 anni da quel novembre 1986, resta ancora il mistero del ruolo di Riina e di quello ‘strumentale’ dei catanesi. Due bombe, una nel ’75 e una nell’86. Due presunti autori per altrettanti presunti ‘incidenti’. Sarebbe troppo definirli attentati, considerato come vengono recepiti dal loro destinatario. O almeno, così si evince dal clima che si respira ad Arcore il 29 novembre 1986. È da poco passata la mezzanotte quando l’imprenditore Silvio Berlusconi telefona a Marcello Dell’Utri, dal 1982 amministratore di Publitalia, la società concessionaria dei servizi di raccolta pubblicitaria per conto del Gruppo Mediaset. La procura di Milano, che sta indagando sui rapporti tra Dell’Utri e lo ‘stalliere’ di Arcore Vittorio Mangano (arrestato nel 1980 e in seguito condannato nell’ambito della maxi-inchiesta condotta da Giovanni Falcone sul traffico internazionale di eroina e morfina base tra boss del calibro di Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo, Rosario Spatola e la famiglia Gambino di New York), intercetta la conversazione. È Berlusconi a dire fuori dai denti, a poche ore dall’esplosione, quello che già si sospettava: Mangano ha colpito ancora, dopo l’ordigno piazzato il 26 maggio 1975 nella stessa Villa di via Rovani, a Milano, il cui scoppio aveva causato ingenti danni ai muri d’ingresso e al pianerottolo interno. O, perlomeno, ai due questo fatto appare pacifico. «E questa cosa qui – spiega Berlusconi – da come l’hanno fatta, con un chilo di polvere nera, fatta con molto rispetto, quasi con affetto. Ecco: un altro manderebbe una lettera o farebbe una telefonata: lui ha messo una bomba». Stavolta, poi – a differenza di undici anni prima – «fatta proprio rudimentale… con molto rispetto… perché mi ha incrinato soltanto la parte inferiore della cancellata, un danno da duecentomila lire… quindi – rimarca – una cosa rispettosa e affettuosa». All’altro capo del telefono, Dell’Utri ride. I dubbi iniziali sono solo di circostanza. «Non c’è altra spiegazione – conclude il Cavaliere – è la stessa via Rovani come allora». «Sì, sì… Adesso vediamo…» replica Dell’Utri. «Comunque, credo anch’io che non ci sono altre richieste. Anche perché non ci sono, voglio dire. Si sarebbero fatti sentire, insomma, no?». Intanto, nella conversazione interviene anche Fedele Confalonieri. Tutti e tre danno per appurato anche il fatto che Mangano sia «fuori». Cosa che si rivelerà inesatta: nel novembre 1986 Mangano è in carcere. Non può essere stato lui a piazzare la bomba. Ma sono quelle “altre richieste” e quel “farsi sentire” cui allude Dell’Utri nella conversazione a richiamare, in tutta la sua portata, il patto stipulato tra Berlusconi e Cosa Nostra con la mediazione dello stesso manager palermitano per il periodo tra il 1974 e il 1992 – come confermato da una sentenza definitiva di condanna della Corte di Cassazione (la n. 28225 del 2014) nei confronti di Dell’Utri per concorso esterno in associazione mafiosa. Una sentenza che si rivela fondamentale anche per comprendere cosa ci sia dietro le bombe di via Rovani. A cominciare dalla disponibilità di Berlusconi «a versare anche trenta milioni di lire – scrivono i giudici – qualora contattato telefonicamente» in seguito all’attentato. Senonché proprio Dell’Utri il 30 novembre 1986 tranquillizzerà Berlusconi «dicendogli di aver parlato con “Tanino”». Ovvero Gaetano Cinà, amico di vecchia data di Dell’Utri, ritenuto un esponente di spicco della famiglia Malaspina, vicino ai boss Stefano Bontate e Mimmo Teresi,nonché mediatore nel trasferimento di Mangano e della sua famiglia presso Villa San Martino ad Arcore. In realtà, la ricostruzione dei fatti – così come confermata dalle dichiarazioni concordi dei pentiti – ha indotto i giudici della prima sezione della Cassazione a ritenere che l’attentato del novembre 1986 fosse riconducibile a esponenti di spicco mafia catanese. A deporre in questo senso sono, in particolare, le parole del collaboratore Antonino Galliano, legato dal 1986 alla famiglia mafiosa della Noce e nipote di Raffaele Ganci (membro della commissione provinciale e vicinissimo a Totò Riina). Quelli – non bisogna dimenticare – sono gli anni in cui il Gruppo Fininvest sta espandendo il proprio controllo su decine di emittenti private su scala nazionale (rilevanti gli acquisti di Telemilano, poi Canale 5, tra il 1979 e il 1980, di Italia 1 nel 1981, del 50% di Rete 4 nel 1984), dopo che Dell’Utri, in qualità di consigliere delegato di Publitalia ’80, ha chiesto a Cinà di «occuparsi della “messa a posto per l’installazione delle antenne televisive”». Ma sono anche anni di mutamento negli equilibri interni a Cosa Nostra, dopo l’uccisione di Bontate e Teresi a colpi di ‘lupara bianca’ (è il 1981). Da quel momento a comandare è Totò Riina, mentre uno dei fratelli Pullarà diventa reggente provvisorio della famiglia mafiosa di Santa Maria del Gesù. Una delle famiglie con cui Berlusconi, per il tramite di Dell’Utri, ha siglato nel 1974 – a detta dei giudici – un «accordo di protezione mafiosa», ossia di vera e propria «schermatura rispetto ad iniziative criminali (essenzialmente sequestri di persona) che si paventavano ad opera di entità delinquenziali non necessariamente e immediatamente rapportabili a “cosa nostra”», in cambio di periodiche corresponsioni di «proventi economici» diretti alla «realizzazione dell’evento del finale rafforzamento di “cosa nostra”» stessa. Con l’avvento dei Pullarà, però, comincia ad aversi qualche attrito. «Con riferimento al periodo 1984-1985» si legge nella sentenza – in accordo con le dichiarazioni del pentito Calogero Ganci – Dell’Utri «nell’effettuare i pagamenti, si era detto “tartassato” dai fratelli Pullarà», i quali «avevano iniziato a riscuotere le somme, prima percepite da Bontate». Di qui i lamenti manifestati a un summit mafioso dell’86 da Cinà, il quale – secondo Galliano – «non voleva più recarsi a Milano a riscuotere, per conto di “cosa nostra”, le somme da Dell’Utri, dato che quest’ultimo era divenuto con lui scostante». Il rapporto fra Dell’Utri e Cinà – lo conferma nel processo a carico del primo una testimonianza dello stesso Berlusconi – risale agli anni d’oro della Bacigalupo Calcio di Palermo, dove giocava il figlio del boss e Dell’Utri era allenatore. Il loro è sempre stato un rapporto confidenziale, ed in questo – secondo la Corte – si è consumata parte consistente del “concorso esterno” di Dell’Utri. Un rapporto che si è rafforzato tra il 1974 e il 1977, nella prima stagione del sodalizio mafioso tra Berlusconi e la famiglia di Santa Maria del Gesù, ed è durato anche tra il 1978 e il 1982, periodo nel quale Dell’Utri si allontana (ma solo apparentemente) da Berlusconi, cominciando a lavorare per le società dell’immobiliarista siculo Filippo Alberto Rapisarda, assai contiguo a diversi ‘uomini d’onore’, fuggito in Venezuela per sottrarsi alla condanna legata al fallimento nel 1979 della Venchi Unica 2000. In particolare, come amministratore delegato della Bresciano S.p.A. (che porterà al dissesto) e consigliere di Inim S.p.A. (dei cui fondi si approprierà). La Corte di Cassazione aveva già confermato nel 2012 il permanere del «sinallagma dei pagamenti sistematici in favore di “cosa nostra”» nei periodi 1974-1978 e 1982-1992. Quanto al periodo intermedio, invece, aveva rinviato alla Corte d’Appello di Palermo per un nuovo giudizio e una più congrua motivazione sul perdurare del patto. E, alla fine, anche su questo punto – alla luce delle dichiarazioni (tutte ritenute attendibili) dei pentiti Ganci, Galliano, Francesco Paolo Anzelmo e Angelo Siino – la sentenza del 2014 forma pieno giudicato: i pagamenti alle famiglie di Cosa Nostra sono proseguiti anche tra il ’78 e l’82. Dell’Utri versava «i soldi a Cinà che si recava a ritirarli a Milano presso lo studio» di Dell’Utri medesimo, «senza soluzione di continuità fino alla morte di Bontate». Dopodiché, informato Riina dei ‘mal di pancia’ di Dell’Utri, il capo di Cosa Nostra – scrive la Corte – «estrometteva i Pullarà dai rapporti con Dell’Utri e affidava la gestione degli stessi esclusivamente a Gaetano Cinà». Il quale – nel ruolo di esattore – «si recava a Milano due volte all’anno per ritirare i soldi» che Dell’Utri gli corrispondeva per il tramite di Pippo Di Napoli e Raffaele Ganci. Arriviamo così all’86. Dell’Utri e Cinà sembrano ai ferri corti, o quasi. Ma l’attentato di via Rovani, da imputarsi – come detto, secondo Galliano – all’opera della famiglia catanese di Nitto Santapaola (e comunque non di Cosa Nostra), non dà segno di mutare, nel complesso, i «rapporti di familiarità e cordialità» tra i due. Una bomba definita “affettuosa”, dieci chili di cassata spediti direttamente a casa Berlusconi, telefonate che rassicurano circa l’assenza di rancori reciproci. E intanto, la strategia di Riina si affina. Dopo l’attentato di novembre, il suo potere intimidatorio ed estorsivo ne esce raddoppiato. Come la somma che adesso arriva a pretendere da Berlusconi, a suon di lettere e telefonate minatorie da Catania ordinate a Mimmo Ganci. E, la mancanza di rifiuto nel corrisponderla da parte di Berlusconi stesso o di Dell’Utri da un lato, e la giustificazione del maggior importo sulla base della «mutata posizione imprenditoriale» del Cavaliere dall’altro, rappresentano ulteriori ragioni dell’accresciuto prestigio di Riina, e quindi di Cosa Nostra tutta.A partire dal 1987 Riina mette in atto – a giudizio della Corte, che raccoglie le dichiarazioni di Mimmo Ganci – «una reazione violenta» per «ridimensionare l’atteggiamento arrogante di Dell’Utri». E cioè, tentando «con l’autorizzazione dei catanesi» di «far credere che l’azione provenisse da ambienti catanesi», instillando così in Berlusconi, controparte imprenditoriale del patto mafioso, l’interesse a una maggiore protezione, e quindi a pagare fino al doppio per ottenerla. Che fosse anche quello dell’86 un attentato voluto da Riina? Non è dato saperlo fino in fondo. Sulle bombe di via Rovani permane tutt’oggi il silenzio generale. Fino ad ora nessun processo è stato fatto. Né Berlusconi, del resto, ha mai denunciato le richieste estorsive. Piuttosto, ha preferito onorare il patto, cosa che farà – com’è risaputo – fino al 1992 e, dopo la sua discesa in politica, tramite il solo Dell’Utri ancora alle soglie del ’95. Nel frattempo, altri attentati si susseguono: il 28 gennaio 1988 sempre alla Villa, il 18 e 21 gennaio 1990 ai magazzini della Standa di Catania (acquistati da Fininvest due anni prima), tra il 12 e il 16 febbraio alla Standa di Paternò. In compenso, per questi ultimi due (di cui solo il primo, un incendio, causa un danno di 14 milioni di lire) una sentenza di Corte d’Appello passata in giudicato nel 2001 condanna gli esponenti della famiglia mafiosa catanese Nitto Santapaola e Aldo Ercolano, suo nipote e braccio destro, «quali mandanti degli incendi e della connessa tentata estorsione». WORDNEWS 10.11.2020
L’Inaccettabile rimozione E’ inaccettabile rimuovere ciò che mettono per iscritto i giudici nelle motivazioni della sentenza di primo grado nel processo sulla Trattativa: «È stato effettivamente riscontrato che tra le pieghe nascoste del decreto 14 luglio 1994 n. 440, v’era anche una ‘piccola modifica‘ dell’art. 275 c.p.p. nella parte in cui stabiliva che per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. dovesse essere sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere salvo che non fossero acquisiti elementi tali da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Si trattava, in sostanza, di quella presunzione di legge che, di fatto, imponeva sempre il carcere per gli indagati di mafia arrestati».
L’ex Cavaliere Si dice rimozione da un punto di vista psicanalitico quel procedimento con cui un soggetto esclude dalla coscienza impulsi o ricordi che sarebbero altrimenti fonte di angoscia o senso di colpa. Su un piano metapsicologico la rimozione è l’operazione psichica per la quale si costituisce l’inconscio in quanto deposito di idee o immagini legate alla soddisfazione di pulsioni che non vengono fatte accedere alla coscienza perché ritenute inaccettabili: in questo senso è detta anche rimozione originaria.
Ecco è da questa parole che bisogna ripartire. La rimozione. Sono settimane che il mondo politico è dominato (Covid a parte) da dei retroscena che vedono coinvolte le forze politiche di maggioranze impegnate in un dialogo politico con il partito di opposizione, sulla carta, più moderato: Forza Italia. C’è chi sostiene che il partito di Silvio Berlusconi abbia intenzione di dare il suo contributo per sostenere il Governo; chi interpreta questo contributo in termini di voti utili al Senato, chi invece sostiene un inserimento di Forza Italia nel governo (una sorta di appoggio esterno); poi ci sono coloro i quali vanno avanti dando atto dell’intento collaborazionista degli azzurri a differenza dei partiti più oltranzisti di destra (Lega e Fratelli d’Italia). E’ vero: nelle dinamiche parlamentari Forza Italia e Silvio Berlusconi hanno dimostrato di voler “dare una mano” al governo giallo-rosa.
“Impegnare le energie migliori in questo esecutivo e le massime responsabilità dei partiti di maggioranza per sostenere Conte con una più intensa corresponsabilità di tutti” (Goffredo Bettini, Pd). Poi abbiamo esponenti di maggioranza che sorvolano sull’evidente trattamento di favore che è stato dato con l’emendamento, ormai definito, “Salva Mediaset” (made in Governo Conte II), che di fatto tutela l’azienda di Berlusconi dagli assalti della francese Vivendi.
Abbiamo frasi mozzate di molti esponenti: “non si tratta di aiutare Mediaset in particolare, ma è una legge che tutela a prescindere in futuro le aziende italiane”, e via discorrendo.
E’ come se, per quel processo di rimozione, si stesse indicando Forza Italia e Mediaset, come due realtà distinte dal loro padrone: Silvio Berlusconi. Lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte (persona rispettabilissima che fin qui ha tenuto botta in una situazione non solo politica ma di emergenza pandemica globale) sorvola sul dialogo in atto tra maggioranza e Forza Italia.
Forza Italia senza Silvio Berlusconi non esisterebbe. L’oggetto della rimozione è proprio Silvio Berlusconi ed il contesto che ruota, da sempre intorno a lui. E’ come se si volesse rimuovere l’inaccettabile. Vige una sorta di pensiero sottinteso da parte delle forze di maggioranza (nessuna esclusa): siamo nel 2020 ormai quasi concluso, occorre tirare avanti fino all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. L’inaccettabile va rimosso.
E’ chiaro che nell’italietta nostrana quando si parla di Silvio Berlusconi pressoché tutti fanno riferimento ai suoi percorsi giudiziari, alla vicenda “Ruby nipote di Mubarak”, a Cesano Boscone ecc. Ma in un Paese normale dovrebbe svilupparsi spontaneamente un dibattito sull’inaccettabile in riferimento a Forza Italia e a Silvio Berlusconi.
E’ inaccettabile, sia sul piano politico che sul piano morale, rimuovere dal piatto delle discussioni ciò che il boss Giuseppe Graviano tra il 2017 ed il 2019 ha reso noto ai giudici, sia sul processo Trattativa Stato-mafia (di cui a breve si concluderà l’appello), sia su quello a Reggio Calabria in merito alla ‘Ndrangheta stragista (già concluso in primo grado).
Graviano, esecutore della strage di Via D’Amelio e delle stragi del 1993 in tutta Italia, ha confermato un rapporto di scambio con la figura imprenditoriale e politica che è stato a capo del governo nel 1994-1995 (Berlusconi I), poi dal 2001 al 2006 (Berlusconi II) ed infine dal 2008 al 2011 (Berlusconi III).
E’ inaccettabile rimuovere che pentiti di ogni rango (figura del pentito quanto mai osteggiata in barba alle creazioni giurisprudenziali di Giovanni Falcone) mettano in evidenza come vi sia stato tra il 1994 ed il 1995 una comunicazione continua tra Cosa Nostra, Marcello Dell’Utri (fondatore di Forza Italia e condannato definitivo a sette anni e mezzo per concorso esterno in associazione mafiosa, e condannato a 12 anni in primo grado al processo sulla Trattativa per attentato o violenza a corpo politico dello Stato) e Silvio Berlusconi in termini di leggi, decreti ed eventuali modifiche normative in relazione alla permanenza in carcere dei mafiosi condannati e al regime del 41 bis.
E’ inaccettabile rimuovere ciò che mettono per scritto i giudici nelle motivazioni della sentenza di primo grado nel processo sulla Trattativa: «È stato effettivamente riscontrato che tra le pieghe nascoste del decreto 14 luglio 1994 n. 440, v’era anche una ‘piccola modifica‘ dell’art. 275 c.p.p. nella parte in cui stabiliva che per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. dovesse essere sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere salvo che non fossero acquisiti elementi tali da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Si trattava, in sostanza, di quella presunzione di legge che, di fatto, imponeva sempre il carcere per gli indagati di mafia arrestati».
Qui i giudici fanno riferimento ad un incontro avuto tra Dell’Utri e Vittorio Mangano nel luglio del 1994, in cui l’uomo di Cosa Nostra giungeva a conoscenza in anticipo delle suddette modifiche legislative in tema di custodia cautelare in carcere per i mafiosi. Quindi Cosa nostra, veniva edotta prima di altri, tramite Dell’Utri, sui tentativi che il governo Berlusconi 1 stava mettendo in pratica per continuare a scendere a patti, sotto ricatto della mafia stessa (da qui la violenza o minaccia a corpo politico dello Stato, che nella fattispecie vedeva coinvolti tra il 1992 ed il 1994 tre governi: Ciampi, Amato e Berlusconi 1; reato previsto dall’art.338 di cui dovranno rispondere gli imputati eccellenti già condannati in sede di primo grado, Dell’utri compreso). Cosa vuol dire tutto questo?
I giudici scrivono: «venne a conoscenza della minaccia in essi insita e del conseguente pericolo di reazioni stragiste (d’altronde in precedenza espressamente già prospettato) che un’inattività nel senso delle richieste dei mafiosi avrebbe potuto fare insorgere». E’ inaccettabile una rimozione su questi fatti.
Allo stesso modo è inaccettabile rimuovere un dato fattuale che si vuole ignorare, per il gravissimo senso di colpa che tutto l’arco parlamentare avrebbe se venisse accettato.
E cioè il fatto che attualmente Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri sono indagati a Firenze come mandanti esterni per le stragi del 1993. I famosi “morti che non ci appartegono”, come disse in udienza Gaspare Spatuzza. Le bombe sul continente; la presenza di una donna dei servizi (come emerge dalle ultime dichiarazioni di Riggio); quegli attentati suggeriti da entità esterne, da nuovi referenti politici che in quel momento stavano entrando in scena.
E’ inaccettabile poi rimuovere certe date:
- il fallito attentato allo Stadio Olimpico di Roma, in programma il 23 gennaio 1994 dopo la partita Roma- Udinese in cui nel mirino vi erano i Carabinieri. Il segnale finale di ambienti di Cosa Nostra ed apparati dello Stato interconnessi per far capire “a chi volerva capire” che lo Stato avrebbe dovuto scendere a patti con Cosa Nostra proprio sul tema dell’allentamento al carcere duro.
- Poi abbiamo il 27 gennaio 1994 in cui i fratelli Graviano vennero arrestati ed infine
- il 28 gennaio 1994 quando Silvio Berlusconi annunciò la propria discesa in campo.
Finiscono le bombe, inizia una pax mafiosa, corroborata da quei contatti tra Cosa Nostra ed ambienti berlusconiano fino al gennaio 1995: sono quelle norme contenute nel decreto Biondi che all’epoca vennero osteggiate dalla Lega e che alla fine vennero ritirate. Cosa prevedevano nei dettagli? E’ inaccettabile rimuovere anche questo dettaglio: la modifica più importante del Decreto Biondi riguardava l’obbligo di informare l’indagato delle indagini aperte sul proprio conto, vanificando evidentemente ogni tipo di richiesta; inoltre si proponeva di eliminare la custodia cautelare in carcere anche per i mafiosi.
I boss ci dicono che vi erano grosse speranze in termini di questo decreto e ci riportano con le date al dicembre del 1994 (due anni dopo le stragi del 1992 ed un anno dopo le bombe del 1993), in pieno Governo Berlusconi I, con un dialogo para-istituzionale che vedeva coinvolti Dell’Utri e Berlusconi da una parte e Cosa Nostra dall’altra. La mafia era informata su certe novità normative ben prima che il Decreto Biondi venisse mostrato alle forze politiche dell’epoca, per poi venir cassato.
Ecco le questioni su cui è inaccettabile una rimozione. Ne dovrebbero parlare le forze politiche attuali, i mass media, i talk show, ma forse c’è troppa paura per ciò che tutto questo provocherebbe. Il mondo di Forza Italia e di Silvio Berlusconi ruota intorno a queste indicibile ed inaccettabili vicende. Inaccettabili non per essere ammesse, ma inaccettabili in uno stato “veramente” democratico e voglioso di fare chiarezza sul proprio recente passato (che mai se n’è andato e che invece se ne sta affacciato alla finestra).
E’ la paura che domina tutt’oggi questa nostra democrazia apparente. Ed è più comodo per tutti, in questa situazione di emergenza sanitaria globale, rimuovere l’indicibile. Far finta di nulla ed andare avanti. E’ l’Italia, bellezza. Francesco Bertelli Nov 27, 2020 WORDNEWS
L’intervista nascosta, la versione integrale del lungo colloquio fra il giudice antimafia e i giornalisti francesi di Canal Plus, Fabrizio Calvi e Jean Pierre Moscardo. L’ intervista a suo tempo scomparsa di Paolo Borsellino, è un documento eccezionale. Il lungo colloquio fra il giudice antimafia, all’epoca procuratore aggiunto a Palermo, e i giornalisti francesi di Canal Plus, nella sua casa di Palermo, il 21 maggio 1992: due giorni prima della strage di Capaci e 59 giorni prima di via D’Amelio.
I due reporter stanno girando un film sulla mafia in Europa e intervistano agenti segreti, mafiosi pentiti e non, magistrati, avvocati. Ottengono il permesso di seguire l’eurodeputato andreottiano Salvo Lima nei suoi viaggi dalla Sicilia al Parlamento europeo. Almeno finché,nel marzo ’92, Lima viene assassinato. Intanto Calvi e Moscardo si sono imbattuti nella figura di Vittorio Mangano, il mafioso che aveva prestato servizio come fattore nella villa di Berlusconi ad Arcore fra il 1974 e il 1976, assunto da Marcello Dell’Utri. Così abbandonano il reportage che doveva ruotare attorno a Lima e si concentrano sui rapporti fra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa Nostra. Intervistando, fra gli altri, Borsellino.
L’incontro con Borsellino torna d’attualità quando, nel gennaio ’94, Berlusconi entra in politica. Calvi contatta Leo Sisti dell’Espresso, che pubblica la trascrizione integrale nella primavera ’94. La vedova Borsellino, Agnese, chiede una copia della cassetta come ricordo personale. E la consegna ai pm di Caltanissetta che indagano su Berlusconi e Dell’Utri come possibili “mandanti esterni” di via D’Amelio. Una copia la recuperano anche Sigfrido Ranucci e Arcangelo Ferri, che nel 2000 preparano uno Speciale Borsellino per RaiNews24. Lo speciale va in onda notte tempo il 19 settembre 2000, dopo che tutti i direttori dei tg e dei programmi di approfondimento Rai hanno rifiutato di mandare in onda il video. Ma viene visto da pochissimi telespettatori.
Perché l’intervista è importante? Intanto perché Borsellino parla, pur con estrema prudenza, di Berlusconi e di Dell’Utri in un reportage dedicato alla mafia. Poi perché lascia chiaramente intendere di non potersi addentrare nei rapporti fra Berlusconi, Dell’Utri e Mangano perché c’è ancora un’inchiesta in corso e non è lui ad occuparsene, ma un collega del vecchio pool Antimafia, rimasto solo nell’Ufficio istruzione (ormai soppresso dal nuovo Codice di procedura penale del 1990) a seguire gli ultimi processi avviati fino al 1989 col vecchio rito processuale.
Borsellino ricorda di aver conosciuto Mangano negli anni Settanta in vari processi: quello per certe estorsioni a cliniche private e il maxiprocesso alla Cupola di Cosa Nostra, avviato a metà degli anni Ottanta grazie alle dichiarazioni dei primi pentiti Buscetta, Contorno e Calderone. Aggiunge che Falcone l’aveva pure processato e fatto condannare per associazione a delinquere al processo Spatola, mentre nel “maxi” Mangano fu condannato per traffico di droga: 13 anni di galera in tutto, che Mangano scontò fra il 1980 e il ‘90. Borsellino sa che Mangano era già un mafioso a metà anni Settanta, uomo d’onore della famiglia di Pippo Calò, implicato addirittura in un omicidio con Saro Riccobono mentre stava ad Arcore. L’avevano pure intercettato al telefono con un mafioso, Inzerillo, mentre trattava partite di cavalli e magliette che nel suo gergo volevano dire “eroina”. Non era uno stalliere o un fattore: era la “testa di ponte dell’organizzazione mafiosa al nord”.
Graviano: “Da latitante ho incontrato Berlusconi almeno 3 volte. Me lo ha presentato mio nonno negli anni ’80. Tramite mio cugino avevamo un rapporto bellissimo, nel 1993 abbiamo cenato insieme”. Dopo il prologo di due settimane fa, Graviano ha continuato la sua deposizione durante il processo ‘Ndrangheta stragista. E se la prima volta ha parlato genericamente di “imprenditori del nord”, questa volta ha pronunciato esplicitamente il nome di Silvio Berlusconi: “Negli anni ’70 mio nonno aveva messo i soldi nell’edilizia al nord. Il contatto è col signor Berlusconi, glielo dico subito”, ha detto al pm. Poi ha raccontato di aver incontrato personalmente l’ex premier, che avrebbe annunciato a suo cugino già nel 1992 l’intenzione di scendere in politica. Ghedini: “Parole prive di fondamento”
Il boss che custodisce il segreto delle stragi ha rotto un silenzio lungo più di un quarto di secolo. E ha fatto il nome più atteso: quello di Silvio Berlusconi. Giuseppe Graviano sostiene di aver incontrato più volte il leader di Forza Italia. “Da latitante l’ho incontrato per tre volte“. L’ultima volta risale al dicembre del 1993, poche settimane prima dell’arresto del boss di Cosa nostra e della discesa in campo del futuro presidente del consiglio. In quell’occasione, dice sempre il padrino, “con Berlusconi abbiamo cenato insieme. È accaduto a Milano 3 in un appartamento”. All’imprenditore di Arcore, sostiene sempre il boss di Brancaccio, erano finiti i soldi di suo nonno e di altri palermitani che negli anni ’70 avevano investito nell’edilizia in Nord Italia. Anzi: a sentire Graviano Berlusconi aveva anche rapporti economici con Totuccio Contorno, uno dei primi pentiti di Cosa nostra. Rischia di provocare un vero e proprio terremoto la deposizione del capomafia di Brancaccio, l’uomo che custodisce i segreti delle bombe del 1992 e 1993. Dopo il prologo di due settimane fa, Graviano ha continuato la sua deposizione durante il processo ‘Ndrangheta stragista, in corso davanti alla corte d’Assise di Reggio Calabria, dove è accusato dell’omicidio di due carabinieri. Non è un pentito, ma un mafioso stragista sepolto al 41 bis da molteplici ergastoli. Non è un collaboratore ma un imputato: come tale può mentire. E infatti nega praticamente ogni accusa. Sostiene che “sono state fatte leggi incostituzionali, perché la corte costituzionale li sta dichiarando incostituzionale”. Quali leggi? “Quelle fatte per non farci uscire dal carcere, dopo che ci hanno accusato delle stragi“.
“Mio nonno investì al nord” – Graviano parla per sei ore e mezza e di nuovo – come due settimane fa – dice al pm di conoscere la soluzione di vari misteri: “Le darò gli elementi da cui lei potrà trovare l’agenda rossa e chi ha ucciso il poliziotto D’Agostino”. Parole che rimangono sospese senza alcuna spiegazione. Ma se nella prima parte della sua deposizione, il boss ha parlato genericamente di “imprenditori del nord”, questa volta ha pronunciato esplicitamente il nome di Silvio Berlusconi. Lo ha fatto confermando una pista battuta dal pool della procura di Palermo che ha indagato sulla Trattativa Stato-mafia: Filippo Quartararo, nonno materno del boss di Brancaccio, è il primo contatto tra la famiglia e i palermitani che hanno investito denaro a Milano. “Negli anni ’70 mio nonno aveva messo i soldi nell’edilizia al nord. Mio nonno materno, Quartanaro Filippo, era una persona abbastanza ricca. Era un grande commerciante di ortofrutta. Il contatto è col signor Berlusconi, glielo dico subito”, spiega Graviano al procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo.
“Venti miliardi al 20%” – La smentita dell’avvocato Niccolò Ghedini e l’annuncio di querele sono arrivate praticamente a udienza in corso. Nell’aula, però, era già calato il silenzio. Graviano, infatti, ha continuato a parlare ed è entrato nel dettaglio degli investimenti citati: “Venti miliardi di lire con il venti percento. Mio nonno si rivolge a mio papà e mio papà dice: io non faccio queste cose. Quindi quando Di Carlo dice che mio papà aveva queste società a nord Italia dice una bugia: era mio nonno“, ci tiene a specificare il padrino di Brancaccio. Quei soldi investiti a Milano, quindi, non erano del padre mafioso ma del nonno benestante: una precisazione cui Graviano dimostra tenere molto. Ma la parte principale dell’interrogatorio deve ancora arrivare: “Quando è morto mio padre, mio nonno mi prese in disparte e mi disse ‘Io sono vecchio e ora te ne devi occupare tu. Poco dopo mio nonno, che aveva più di 80 anni, morì”. Il vecchio Quartararo muore nel 1986, Michele Graviano, padre di Giuseppe nel 1982. In quei quattro anni Graviano sostiene di aver avuto il tempo di fare la conoscenza di Berlusconi. “Dopo la morte di mio padre, mio nonno mi dice: c’è sta situazione, io sto andando avanti. Tuo papà non vuole che mi rivolgo a voi. Io e mio cugino Salvo abbiamo detto: ci pensiamo. Ci siamo consigliati col signor Giuseppe Greco. E abbiamo deciso di sì e siamo partiti per Milano. E mio nonno ci ha presentato al signor Berlusconi, abbiamo capito cosa era questa società”.
“Ho incontrato Berlusconi all’hotel Quark” – L’interrogatorio di Graviano diventa serrato. Il pm chiede dettagli su quel primo incontro con Berlusconi: “Se non erro era l’Hotel Quark“a Milano. Chi c’era? “Mio cugino Salvatore, mio nonno Quartaro Filippo“. Berlusconi era da solo. “Sì”, risponde Graviano, aggiungendo subito: “Poi io casco latitante, quindi la situazione la comincia a seguire mio cugino Salvatore”. Insomma a sentire Graviano, il nonno aveva investito in modo occulto denaro nelle società dell’imprenditore di Arcore. E quegli investimenti sarebbero poi stati ereditati da lui e dal cugino. “Per adesso va bene, però noi dobbiamo entrare scritti che facciamo parte della società. Noi vogliamo essere partecipi, però questa cosa si andava procrastinando”, dice sempre il boss, facendo intendere che la condizione “occulta” dell’investimento doveva essere poi regolarizzata. “I nomi di quei soggetti non apparivano”, dice riferendosi al fatto che i presunti soci occulti dell’imprenditore di Arcore non comparissero nelle partecipazioni societarie. “Ma c’era una carta privata che io ho visto, la copia di mio nonno la ha mio cugino Salvatore Graviano”. Una frase che sembra essere un vero e proprio messaggio: su quello che dice il padrino di Brancaccio sostiene esistano addirittura delle prove.
“Ho cenato con Berlusconi” –La figura del cugino Salvatore, morto di tumore nel 2002, compare nei racconti di Graviano durante l’incontro in carcere con Fiammetta Borsellino. Il boss di Brancaccio aveva detto alla figlia del giudice assassinato: “Lo dicono tutti che frequentavo Berlusconi, più che io era mio cugino che lo frequentava”. A Reggio Calabria conferma: “Era mio cugino Salvatore che aveva questi incontri. Io al massimo Berlusconi tre volte l’ho incontrato. Tramite mio cugino avevamo un rapporto bellissimo”. L’ultima risale al dicembre del 1993. “C’è una riunione a Milano. A fine del 1993, dicembre, si è arrivato alla conclusione che si regolarizzava questa situazione. E si fissa un appuntamento nel febbraio del 1994“. È durante quell’incontro alla fine del 1993 che Graviano sostiene di essersi seduto a tavola con l’ex presidente del consiglio: “È successo a Milano 3, è stata una cena. Ci siamo incontrati io, mio cugino e Berlusconi”. C’era qualche altra persona? “C’era ma io non l’ho riconosciuta. Discutiamo di formalizzare le società”.
“Berlusconi disse a mio cugino che aveva pronto il partito già nel 1992” – Ma Berlusconi sapeva che stava incontrando un latitante? “Non lo so, penso di sì. Lo sapeva come mi chiamavo“, dice il padrino. Che ci tiene a specificare come da ricercato si muovesse tranquillamente sotto la Madonnina: “Io ho condotto la mia latitanza tra shopping in via Montenapoleone e teatri, insomma facevo la bella vita”. Il racconto di Graviano è pieno di colpi di scena. Per esempio: quell’appartamento dove i Graviano incontrano Berlusconi sarebbe stato nelle disponibilità del cugino del boss di Brancaccio. “Mio cugino mi ha detto: sai mi hanno dato un appartemente a Milano 3”. Graviano ha trascorso in quella casa parte della sua latitanza? “La mia latitanza era a Omegna. Serviva a mio cugino per quando saliva a Milano“. Il pm continua a incalzare il mafioso: “Quando vi incontrate a Milano 3, ricava la certezza che i 20 miliardi sono stati investiti e tra i 20 miliardi c’era Milano 3? “Tutto quello che aveva fatto, c’era le televisioni, Canale 5″. La pubblica accusa ha contestato a Graviano l’ormai nota intercettazione in cui il boss dice al compagno d’ora d’aria Adinolfi: “Nel 1992 Berlusca mi chiese questa cortesia, lui già voleva scendere”. A cosa si riferiva il padrino? Non lo dice. Spiega solo che “nel 1992 Berlusconi annunciò a mio cugino Salvo che voleva entrare in politica. Io non lo incontrai, ma lo incontrò mio cugino Salvo a cui Berlusconi parlò di questo progetto di entrare in politica“. Poi specifica un passaggio cruciale per gli inquirenti: “Nel 1992, no come dicono nel 1993. Già il partito era preparato nel 1992. Prima della strage di Capaci”. E dunque quando la Prima Repubblica era ancora lontana dall’essere travolta da Tangentopoli: a cosa doveva servire un nuovo partito già all’epoca?
“Berlusconi è un traditore” – Di sicuro c’è che nel gennaio del 1994 Graviano viene arrestato a Milano insieme al fratello Filippo. Un arresto che definisce “anormale“. E spiega pure perché nelle intercettazioni in carcere definisce Berlusconi “un traditore“: “Perché quando si parlò della riforma del Codice penale e si parlava di abolizione dell’ergastolo mi hanno detto che lui chiese di non inserire gli imputati coinvolti nelle stragi mafiose”. Il pm gli contesta le intercettazioni del 19 gennaio 2016, quando conversando con Adinolfi, dice: “Berlusconi prese le distanze e fece il traditore” .Oggi ha confermato quella frase e ha spiegato i motivi di quel tradimento. “Un avvocato di Forza Italia mi disse che stavano cambiando il Codice penale – dice ancora Graviano – e che doveva darmi brutte notizie. Perché in Parlamento avevano avuto indicazioni da Berlusconi di non inserire quelli coinvolti nelle stragi. Lì ho avuto la conferma che era finito tutto. Mio cugino Salvo era morto nel frattempo per un tumore al cervello. E nella riforma del Codice penale non saremmo stati inseriti tra i destinatari dell’abolizione dell’ergastolo”. E aggiunge: “Questo mi portò a dire che Berlusconi era un traditore”. Di più, Graviano si lamenta anche per come è andata l’avventura politica di Berlusconi: “Dopo quello che ha fatto mio nonno per lui… non solo economicamente. Visto che io ho rapporti economici, e lui politici, e le confidenze che avevamo… certo che potevamo avere soddisfazioni, ma non di criminalità ma di cose belle, perché l’Italia potrebbe essere il migliore paese del mondo”.
“Quando dico non volevano più le stragi non dico Berlusconi” –Durante la sua deposizione Graviano ha spiegato che quando, in una delle intercettazioni dice “non volevano più le stragi“, non si riferiva a Berlusconi.”Quando dico ‘non volevano le stragì parlo di quello della montagna nelle intercettazioni è chiaro, non di Berlusconi”. Nell’intercettazione si legge: “nel ’93 ci sono state altre stragi ma no che era la mafia, loro dicono che era la mafia. Allora il governo ha deciso di allentare il 41 bis, poi è la situazione che hanno levato pure i 450″. E ancora: “Non volevano più le stragi… la montagna mi diceva, è troppo”. E oggi ha spiegato che il riferimento non è a Berlusconi. “Io parlo a quello della Montagna. La montagna sono i napoletani”.
“Io adesso sto dicendo solo qualcosa” – Graviano non cita quasi mai Marcello Dell’Utri. Il pm glielo fa notare e gli chiede perché nel 2009, chiamato a deporre al processo all’ex senatore di Forza Italia, Graviano si sia avvalso della facoltà di non rispondere: “All’epoca? Dotto’, veda che a me hanno ucciso il padre. Non mi faccia parlare. Avevo subito brutte situazioni. Io fiducia nella giustizia italiana non ne ho. Non è ho fiducia nella pubblica accusa e ai presidenti ora tutti indagati con la Saguto… insomma, io tutta sta fiducia nella giustizia italiana non ce l’ho. Quello che vi sto dicendo è per il benessere del Paese”. E perché allora ha fatto questa scelta ora? Dopo un quarto di secolo di silenzio? “Io adesso non sto facendo niente, io adesso sto dicendo qualcosa. Solo qualcosa , ma posso dire ancora tante altre cose”. Un altro messaggio, l’ennesimo.
Ghedini: “Da Graviano diffamazioni” – A udienza ancora in corso è arrivata la replica di Berlusconi, attraverso una nota del suo legale, Niccolò Ghedini: “Le dichiarazioni rese quest’oggi da Giuseppe Graviano sono totalmente e platealmente destituite di ogni fondamento, sconnesse dalla realtà nonché palesemente diffamatorie. Si osservi che Graviano nega ogni sua responsabilità pur a fronte di molteplici sentenze passate in giudicato che lo hanno condannato a plurimi ergastoli per gravissimi delitti. Dopo 26 anni ininterrotti di carcerazione improvvisamente il signor Graviano rende dichiarazioni chiaramente finalizzate ad ottenere benefici processuali o carcerari inventando incontri, cifre ed episodi inverosimili ed inveritieri. Si comprende, fra l’altro, perfettamente l’astio profondo nei confronti del Presidente Berlusconi per tutte le leggi promulgate dai suoi governi proprio contro la mafia. Ovviamente saranno esperite tutte le azioni del caso avanti l’autorità giudiziaria”. di Lucio Musolino e Giuseppe Pipitone | 7 FEBBRAIO 2020
- Mafia, il boss Graviano: “Incontrai Berlusconi tre volte. Investimenti di mio nonno in Mediaset, tv e Milano 3”. L’audio
- “Nel dicembre 1993, mentre ero latitante, incontrai Berlusconi a Milano. Berlusconi sapeva come mi chiamavo.E sapeva che ero latitante da dieci anni. Alla riunione ha partecipato anche mio cugino Salvo e con Berlusconi c’erano persone che non conoscevo. Dovevamo discutere dell’ingresso di alcuni soci nelle società immobiliari di Berlusconi”. Lo ha detto il boss di Cosa Nostra, Giuseppe Graviano, detenuto dal 1994 e condannato all’ergastolo, durante la sua deposizione in videoconferenza nel processo ‘Ndrangheta stragista a Reggio Calabria, in cui è imputato. “I venti miliardi di lire investiti sono finiti nella costruzione di Milano 3? No, tutto ciò che ha costruito (Silvio Berlusconi, ndr), c’erano le televisioni, Canale 5, Mediaset, Milano 3”. Mostra meno
Ecco perché Cosa nostra salvò Berlusconi dalla ‘Ndrangheta 06.04.2013 – int. Paolo Pollichieni Nella seconda metà degli anni ‘70 la ‘Ndrangheta era decisa a rapire Silvio Berlusconi, ma Cosa nostra glielo impedì. E’ quanto rivela il Corriere della Calabria diretto da PAOLO POLLICHIENI Nella seconda metà degli anni Settanta la ‘Ndrangheta era decisa a rapire Silvio Berlusconi, ma Cosa nostra glielo impedì. E’ quanto rivela un’inchiesta giornalistica del settimanale “Corriere della Calabria”, diretto da Paolo Pollichieni, che si basa sulla testimonianza del pentito Angelo Siino. L’accordo tra mafia e calabresi fu proprio all’origine della frattura nella ‘Ndrangheta che portò alla sanguinosa faida tra le famiglie dei Condello e dei De Stefano. Ilsussidiario.net ha intervistato il direttore Pollichieni.
Per quale motivo la ‘Ndrangheta era pronta a rapire Berlusconi? Nella seconda metà degli anni ’70 Cosa nostra era leader nel narcotraffico internazionale, e la ‘Ndrangheta era leader nell’anonima sequestri. Le cosche calabresi individuavano dei grandi imprenditori del Nord e li sequestravano. In questo contesto a Pavia fu rapito Giuliano Ravizza, re delle pellicce Annabella, l’imprenditore Borghetti, l’armatore D’Amico. A essere interessati al rapimento di Berlusconi erano i clan di Platì, che a Milano e a ridosso di Milano 2 erano molto forti. Per questo si pensò che Berlusconi potesse essere l’obiettivo ideale dell’anonima sequestri.
Quindi che cosa accadde? Ciò configgeva con altri piani e con altri rapporti che facevano capo a Cosa Nostra. L’obiettivo della ‘Ndrangheta era molto banalmente quello di fare soldi, quello di Cosa Nostra era tenersi buoni i rapporti con Berlusconi e far fare bella figura a Dell’Utri. Per le cosche siciliane la ‘Ndrangheta andava quindi bloccata. Dai verbali in nostro possesso emerge che non fu una cosa indolore, anzi che all’interno della ‘Ndrangheta ci furono i primi strappi tra la famiglia Condello e i De Stefano, che dal 1985 in poi scatenarono una faida che provocò 621 morti.
Per quali motivi Cosa nostra riteneva che Berlusconi andasse protetto? Per la ‘Ndrangheta Berlusconi era solo un ricco imprenditore. Per Cosa nostra, che all’epoca era la leadership criminale, il Cavaliere era molto di più. Non dimentichiamo che era l’uomo della P2, tanto è vero che per salvarlo si mobilitò anche la Massoneria. Berlusconi stava iniziando a gestire le reti e i ripetitori per costruire il suo impero televisivo e si accingeva ad acquistare la Standa, da cui avrebbe tratto benefici anche Cosa nostra. Era inoltre un imprenditore vicino al Partito Socialista, cioè agli ambienti craxiani e quindi ai cementi della famiglia Gardini. Per Cosa nostra poteva rendere quindi molto di più farsi amico Berlusconi piuttosto che rapirlo.
Chi è Siino, il pentito che ha rivelato come la mafia evitò il rapimento del Cavaliere? Il pentito Angelo Siino è stato il “ministro” dei Lavori pubblici di Cosa nostra, l’uomo che teneva i rapporti con le grandi aziende che andavano a investire in Sicilia.
Per quale motivo ritiene che le sue rivelazioni, a differenza di quelle di altri pentiti, siano attendibili? I magistrati che hanno condannato Dell’Utri si sono basati molto su Siino, dichiarandolo attendibile come era avvenuto in precedenza nel corso di molti processi passati in giudicato. Quando avvenne l’incontro tra Mafia e ‘Ndrangheta per discutere sull’eventuale rapimento di Berlusconi, Siino racconta che li accompagnò ma che non si sedette a tavola con loro. Capì quindi che c’erano stati momenti di frizione perché durante il viaggio di ritorno in macchina da Milano il boss Bontade era molto contrariato, tanto che esclamò: “Ma questi chi si credono di essere, ci hanno trattato con superficialità”. Siino quindi non racconta nulla di più di quello che cade sotto la sua diretta percezione, non interpreta i fatti ma li descrive e basta. Pietro Vernizzi Il SUSSIDIARIO
Il silenzio s’è rotto Ma il boss non ha chiarito la “cortesia” che gli chiese B. Silvio Berlusconi, nato a Milano, 83 anni, è stato il politico italiano più potente per almeno 18 anni dal 1994 al 2011. Tuttora resta probabilmente l’italiano più ricco e famoso nel mondo. Giuseppe Graviano, 56 anni, nato a Palermo invece è il boss condannato per le stragi del 1992 in Sicilia e del 1993 a Firenze e Milano nonché per gli attentati del 1993-94 a Roma e dintorni. Il protagonista della stagione del terrorismo mafioso che ha eliminato i magistrati più importanti della recente storia dell’Antimafia, Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e Paolo Borsellino, gli uomini delle loro scorte, e tante persone innocenti. Quelle stragi, secondo le testimonianze dei pentiti recepite nelle sentenze della magistratura, sono state compiute per cambiare le leggi e la politica italiana a cavallo tra Prima Repubblica e Seconda Repubblica.
IERI IL BOSS ha detto chiaramente per la prima volta in un’aula di Tribunale quello che aveva sussurrato nell’orecchio di un compagno di detenzione, Umberto Adinolfi, nel 2016-2017 nel carcere di Ascoli Piceno.
E che, chiamato in aula da una Corte a Palermo, si era rifiutato di spiegare. Il racconto di Graviano (tutto da riscontrare) è impressionante: Graviano dice di avere conosciuto Berlusconi, di averlo incontrato tre volte, di avere cenato con lui nel 1993 poco prima del suo arresto e di considerarlo un traditore.
- Il racconto diretto di ieri di Graviano rende più comprensibili alcuni messaggi presenti nelle conversazioni intercettate contro la sua volontà nel 2016.
- Quelle parole vanno decrittate alla luce di quel che ieri ha detto.
- E questo sarà il compito dei magistrati, non solo quelli di Reggio Calabria che lo hanno interrogato ieri nel processo ’Ndrangheta stragista’.
- Anche i pm di Firenze che indagano da due anni su Berlusconi e sul suo ex collaboratore Marcello Dell’Utri per l’ipotesi che abbiano avuto un ruolo nelle stragi del 1993 a Firenze e Milano (dieci morti) e negli attentati di Roma dovranno cercare di capire quel che ha voluto dire il boss.
- Probabilmente anche i pm di Caltanissetta che indagano sulle stragi del 1992 (che non hanno iscritto Berlusconi dopo le conversazioni intercettate in cella nel 2016-7) dovranno ristudiare le sue parole in cella alla luce di ciò che ha detto in aula.
- In particolare c’è una frase detta da Graviano nel carcere di Ascoli il 10 aprile 2016 che merita di essere riletta dopo l’interrogatorio di ieri. Il perito della Corte di Assise di Reggio Calabria, come quello della Corte di Palermo nel processo Trattativa, a differenza della difesa di Marcello Dell’Utri, ritiene che Graviano abbia confidato al compagno di detenzione: “Berlusca mi chiese una cortesia”.
- Il boss dice questa frase dopo aver detto altre due frasi criptiche che sembrano riferite sempre a Berlusconi: “1992 già voleva scendere, voleva partecipare (…) ed era disturbato” e poi “volevano indagare”.
- Quando il pm Giuseppe Lombardo ha cercato di farsi dire da Graviano cosa volesse dire con quel “era disturbato”, il boss ha evitato di rispondere.
- La novità di ieri è che Graviano ha detto chiaramente in aula alla Corte che in cella parlava di Berlusconi e che – a detta del boss – il Cavaliere incontrò il cugino del boss nei primi mesi del 1992, prima delle stragi di Capaci e via D’Amelio, per comunicare alla loro famiglia che voleva scendere in politica e chiedeva una mano.
- Alla luce di questa “chiave di lettura” bisognerà ridomandarsi cosa sia “la cortesia” che a suo dire sarebbe stata chiesta da ‘Berlusca’ a Graviano (sempre nel suo discorso in cella) e poi perché questa cortesia c’entri con “l’urgenza” di fare qualcosa e con il fatto che “volevano indagare”.
- Un’ipotesi formulata in via del tutto teorica dal pm Antonino Di Matteo, quando sosteneva l’accusa del processo Trattativa, è che “quando Graviano parla di cortesia si riferisca alla strage di via D’Amelio”. Comunque Graviano, ove anche avesse espresso quel concetto, potrebbe mentire.
IL RACCONTO fatto ieri dal boss parte dal 1970 quando il nonno materno Filippo Quartararo, grande commerciante di frutta, si sente chiedere 20 miliardi di vecchie lire per avere il 20 per cento di un investimento a Milano.
- Il nonno non li aveva ma insieme ad altri amici siciliani arriva a coprire una quota di 4,5 miliardi, dei quali 1,5 miliardi li mette Antonio La Corte, un ristoratore.
- Poi altri 10 miliardi li mette l’ereditiere Carlo Alfano e altri soldi li avrebbe messi la famiglia Chiazzese che però lascia la mano dopo l’uccisione di un rampollo della famiglia nel 1981.
- Altri soldi li metterebbe anche la signora Serafina, vedova di Salvatore Di Peri.
- I soldi secondo Graviano sarebbero puliti. Nel 1981 muore il padre Michele Graviano, un imprenditore che secondo il pentito Franco Di Carlo era stato inserito in Cosa Nostra in età avanzata.
- Graviano padre è stato ucciso dai perdenti e in particolare dal mafioso Gaetano Grado, della famiglia di Stefano Bontate.
- Il nonno materno, ormai ultra-ottantenne, dopo la morte del padre, mette Giuseppe e il cugino Salvatore Graviano al corrente degli investimenti effettuati una dozzina di anni prima a Milano e chiede a Giuseppe di seguirlo a Milano per prendere in mano il rapporto.
- Il nonno riteneva che non ci fosse nulla di male e che i soci siciliani occulti dovessero diventare pubblici.
- Così Giuseppe, dopo essersi consigliato con Giuseppe Greco, padre del “Papa della mafia” Michele Greco, sale sotto la Madunina. Giuseppe è ancora in lutto ma toglie l’abito nero per non dare nell’occhio e incontra Berlusconi insieme al cugino Salvatore e al nonno Filippo.
- L’incontro avviene – aggiunge con qualche incertezza Graviano (“se non erro”) – nell’hotel Quark di Milano.
- Non un posto qualunque. In questo hotel Graviano racconta di avere festeggiato il Capodanno 1990.
- Sempre qui Graviano dà appuntamento a un suo favoreggiatore che voleva far giocare il figlio al Milan e gli aveva chiesto una mano per trovare lui un lavoro. Insieme al fratello Filippo e al favoreggiatore il 27 gennaio 1994 sarà arrestato nel ristorante Gigi il Cacciatore.
- L’arresto a Milano secondo Graviano è anomalo.
- La tesi (anche questa tutta da riscontrare) di Graviano è che si siano uniti tre soggetti contro di lui: “L’imprenditore del nord (Berlusconi, ndr), una parte della Procura di Palermo e Totuccio Contorno”.
- In questo quadro molto confuso, Giuseppe Graviano ha inserito le sue confidenze sui rapporti tra il nonno e Berlusconi.
- Nella precedente udienza Graviano ha suggerito al pubblico ministero di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo di indagare sui misteri del suo arresto a Milano per capire i segreti delle stragi del 1992 e 1993 e l’omicidio del poliziotto Antonino D’Agostino dell’agosto 1989.
- Quanto ai rapporti con Berlusconi, Giuseppe Graviano sostiene di avere letto una carta privata (“la copia ce l’ha mio cugino Salvatore Graviano con la firma dell’imprenditore del nord”) con i nomi del nonno e degli altri soci occulti di Berlusconi che volevano emergere, tra questi Carlo Alfano e Antonio La Corte più altri.
- Secondo Graviano, non solo i cantieri edili degli anni settanta ma anche le televisioni di Fininvest create più avanti facevano parte dell’accordo con i siciliani.
- Nel 1993 il cugino Salvatore chiede al boss latitante di andare a Milano.
- Proprio quando Berlusconi sta per scendere in politica ufficialmente, a dicembre 1993, secondo lo stesso Graviano avviene l’incontro al quale partecipa anche il cugino Salvatore.
- I tre cenano insieme in un appartamento di Milano 3, il villaggio residenziale costruito da Silvio Berlusconi.
- A detta di Graviano un appartamento sarebbe stato concesso in uso a Salvatore Graviano e poi offerto anche in uso da Salvatore a Giuseppe.
- L’incontro ha per oggetto la questione societaria ma poi non se ne fa nulla perché all’appuntamento successivo con Berlusconi, fissato a febbraio del 1994, non si possono presentare i due cugini: Giuseppe è arrestato il 27 gennaio e Salvatore il 2 febbraio 1994, poi sarà assolto e morirà nel 2002 per un tumore.
- OLTRE AI RAPPORTI economici con Silvio Berlusconi, Graviano ha ripercorso anche l’origine della “stagione politica”.
Nei primi mesi del 1992 Silvio Berlusconi incontra il cugino Salvatore Graviano e gli racconta che vuole scendere in politica e chiede un appoggio. Il racconto di Giuseppe Graviano può sembrare un romanzo per chi non abbia mai seguito le vicende delle indagini sulle stragi di Firenze e Caltanissetta e quelle della Procura di Palermo sulla Trattativa Stato-mafia.
Però non arriva come un fulmine a ciel sereno. Si può dire invece che tanto tuonò (senza chela politica e i media reagissero in modo opportuno) che alla fine Giuseppe Graviano è stato costretto a far piovere un diluvio di dichiarazioni per ottenere un po’di attenzione.
- Le dichiarazioni di Giuseppe Graviano non vanno prese come se fossero quelle di un testimone attendibile e nemmeno come se fossero quelle di un collaboratore di giustizia.
- Un pentito che mente rischia di perdere la protezione dello Stato e i vantaggi della sua condizione.
- Un imputato che non collabora, come Graviano, invece può mentire impunemente. Il boss ha presentato (in diretta web di Radio Radicale) un racconto suggestivo ma che presenta evidenti zone oscure e passaggi poco coerenti.
- Per esempio Giuseppe Graviano nega qualsiasi responsabilità nelle stragi.
- Smentisce totalmente i pentiti che lo accusano, in particolare Gaspare Spatuzza e Fabio Tranchina.
- Si professa innocente su tutta la linea. Colora il suo rapporto con Berlusconi con una serie di personaggi che paradossalmente tenderebbero a renderlo lecito.
- I soldi investiti a Milano non sono del padre o di altri soggetti tacciati dai pentiti di essere mafiosi ma del nonno e di altri insospettabili.
- I rapporti politici con Berlusconi sono stati tenuti principalmente dal cugino Salvatore, anche lui considerato un personaggio minore finora e comunque deceduto nel 2002.
- Inoltre ci sono alcune cose che non tornano con quello che è stato detto in carcere a bassa voce al compagno di detenzione Umberto Adinolfi.
- In quelle conversazioni in cella registrate nel 2016-2017 il boss per esempio non nomina mai il cugino Salvatore Graviano in relazione a Berlusconi e parla in prima persona dei suoi rapporti con l’imprenditore milanese.
Comunque il suo racconto, anche se depistante e dal sapore ricattatorio, non può più essere ignorato. IL FATTO QUOTIDIANO 8.2.2020 MARCO LILLO
Il pentito Brusca: “I calabresi volevano rapire uno dei figli di Berlusconi”. di Claudio Cordova – Erano i De Stefano e i Piromalli i referenti di Cosa Nostra in Calabria. A ripercorrere i rapporti tra la mafia e la ‘ndrangheta è il pentito Giovanni Brusca, l’uomo che azionò il congegno per la strage di Capaci, citato nel processo “Gotha dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. I De Stefano, in particolare, sarebbero stati legati a Stefano Bontade, il boss di Palermo ucciso dai Corleonesi di Totò Riina, a sua volta legato ai Piromalli di Gioia Tauro. Negli anni criminali, Brusca viene soprannominato “u verru” per la sua ferocia. Da uomo di fiducia di Riina sarebbe venuto a conoscenza di diverse trame sulle due sponde: “Riina intervenne in Calabria come paciere dopo la guerra di ‘ndrangheta”. Brusca parla anche di don Giovanni Stilo, il controverso prete di Africo, da sempre sospettato di vicinanza con la criminalità organizzata, ma non solo: “Era molto vicino ad Antonino Salamone, aveva rapporti politici e massonici e li metteva a disposizione”. Brusca racconta di aver incontrato don Stilo a Roma per discutere dell’aggiustamento in Cassazione del maxiprocesso a Cosa Nostra istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il collaboratore depone in videoconferenza al cospetto del Tribunale presieduto da Silvia Capone nel processo che vede alla sbarra la presunta componente occulta della ‘ndrangheta. E parla dei rapporti con i catanesi di Nitto Santapaola, ma anche della presenza dei calabresi a Messina: “Sotto il profilo organizzativo – spiega – i calabresi erano più liberi di noi, che eravamo più rigidi. Loro avevano maggiore spazio di manovra”. Nel racconto di Brusca, quindi, ci sono anni e anni di storia criminale che, inevitabilmente, si intreccia con la storia d’Italia. Dalle stragi alla fine della seconda Repubblica con l’avvento di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Proprio a questo punto arriva il riferimento all’ormai noto stalliere di Arcore, quel Vittorio Mangano che sarebbe stato un uomo d’onore e anche di grande peso. Brusca spiega il perché di quella presenza nella villa di Berlusconi: “I calabresi volevano rapire il figlio di Berlusconi, quindi Bontade mise Mangano lì, come segnale”. IL DISPACCIO 9.5.2019
C’è un contatto diretto, nel 1994, tra Silvio Berlusconie un uomo al lavoro per costruire il «partito di Cosa nostra». È emerso nel 2003, al processo palermitano per mafia contro Dell’Utri C’è stato un contatto telefonico diretto, nel 1994, agli albori di Forza Italia, tra Silvio Berlusconi e un uomo allora impegnato a costruire «il partito di Cosa nostra». Lo ha raccontato un consulente della procura di Palermo, Gioacchino Genchi, in una delle udienze del processo in corso nella città siciliana con imputato Marcello Dell’Utri, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. A telefonare ad Arcore, al numero riservato di Berlusconi, alle ore 18.43 del 4 febbraio 1994, è il principe Domenico Napoleone Orsini.
Esponente dell’aristocrazia nera romana, massone, Orsini è in contatto con il capo della P2 Licio Gelli, che va anche a incontrare a villa Wanda, ad Arezzo. Dopo una gioventù nell’estrema destra neofascista, nei primi anni Novanta Orsini si scopre leghista. Nel novembre 1993 accoglie Umberto Bossi che scende nella Roma ladrona per incontrare i suoi sostenitori nella capitale: si riuniscono nella villa di Trastevere di Gaia Suspisio per una cena e brindisi con Veuve Cliquot, costo politico centomila lire, a cui partecipano, tra gli altri, il giornalista Fabrizio Del Noce, la vedova del fondatore del Tempo Maria Angiolillo e Maria Pia Dell’Utri, moglie di Marcello. Mentre viene servita la crostata di frutta, Bossi si avventura in un comizio di tre quarti d’ora, che si conclude solo quando la brigata si trasferisce al Piper, storica discoteca romana.
Orsini si impegna nella Lega Italia federale, articolazione romana della Lega nord. Ma, forte dei contatti con Gelli, lavora per un progetto più ampio: riunire tutti i movimenti «separatisti», tutte le «leghe» nate in quei mesi nel Sud del Paese. Sono per lo più uomini della massoneria a fondare in molte regioni del Sud, dalla Calabria alla Lucania, dalla Puglia alla Sicilia, piccoli gruppi che si ispirano alla Lega di Bossi. I partiti storici, Dc in testa, sono allo sbando, anche per effetto delle inchieste di Mani pulite. Molti lavorano sotto traccia per riempire quel vuoto politico, mentre le stragi del ’92, in cui muoiono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e del’93, a Firenze, Roma e Milano, destabilizzano il Paese.
Il principe Orsini è tra i più attivi in quei mesi: contatta i notabili che hanno fondato le «leghe del Sud», li riunisce, si offre come loro candidato unico alle elezioni, proponendo la costituzione di un’unica, grande «Lega meridionale», in rapporti ambivalenti con la Lega di Bossi: contrapposizione polemica, dichiarata riscossa del Sud contro il Nord, ma sostanziale alleanza e convergenza d’intenti, nel comune progetto di spezzare e frantumare l’Italia.
Nello stesso periodo, qualcun altro era molto attivo negli stessi ambienti. Lo racconta Tullio Cannella, uomo molto vicino al capo militare di Cosa nostra, Leoluca Bagarella, impegnato nelle stragi: «Sin dal 1990-91 c’era un interesse di Cosa nostra a creare movimenti separatisti; erano sorti in tutto il Sud movimenti con varie denominazioni, ma tutti con ispirazioni e finalità separatiste. Questi movimenti avevano una contrapposizione “di facciata” con la Lega nord, ma nella sostanza ne condividevano gli obiettivi. Successivamente, sorgono a Catania il movimento Sicilia libera e in altri luoghi del Sud movimenti analoghi. Tutte queste iniziative nascevano dalla volontà di Cosa nostra di “punire i politici una volta amici”, preparando il terreno a movimenti politici che prevedessero il coinvolgimento diretto di uomini della criminalità organizzata o, meglio, legati alla criminalità, ma “presentabili”».
È la mafia che si fa partito: dopo aver constatato l’inutilizzabilità della Democrazia cristiana, che aveva lasciato diventare definitive le condanne al maxiprocesso di Palermo, Totò Riina e i suoi cercano figure «presentabili» per varare in proprio una nuova forza politica.
«Nell’ottobre 1993», continua Cannella, «su incarico di Bagarella costituii a Palermo il movimento Sicilia libera», che apre una sede in via Nicolò Gallo e ha tra i suoi animatori, oltre allo stesso Cannella, anche Vincenzo La Bua. A Catania era nata la Lega Sicilia libera, controllata da Nando Platania e Nino Strano. Programma: la separazione dall’Italia della Sicilia, che doveva diventare «la Singapore del Mediterraneo», con conseguente possibilità di varare leggi più favorevoli a Cosa nostra, bloccare i «pentiti», annullare l’articolo 41 bis dell’ordinamento carcerario che aveva introdotto il carcere duro per i mafiosi, formare in Sicilia una autonoma Corte di cassazione…
I fondatori di «cosa nuova» Agli uomini di Cosa nostra non sfugge fin dall’inizio che questo progetto è ambizioso e di difficile realizzazione. Per questo si lasciano aperta un’altra possibilità: cercare rapporti e offrire sostegno a nuove forze politiche nazionali che stanno nascendo sulle rovine del vecchio sistema dei partiti. «Le due strategie già coesistevano», racconta Cannella, «e lo stesso Bagarella sapeva della prossima “discesa in campo” di Silvio Berlusconi».
È Forza Italia, dunque, la carta di riserva di Cosa nostra. I suoi uomini sono informati in anticipo, attraverso canali privilegiati, dei programmi di Forza Italia. Li conoscono addirittura prima che il nome Forza Italia sia lanciato da Berlusconi sul mercato della politica. Prosegue infatti Cannella: «Bagarella, tuttavia, non intendeva rinunciare al programma separatista, perché non voleva ripetere “l’errore” di suo cognato (Riina, ndr), cioè dare troppa fiducia ai politici, e voleva, quindi, conservarsi la carta di un movimento politico in cui Cosa nostra fosse presente in prima persona. Inoltre, va detto che vi era un’ampia convergenza tra i progetti, per come si andavano delineando, del nuovo movimento politico capeggiato da Berlusconi e quelli dei movimenti separatisti.
Si pensi al progetto di fare della Sicilia un porto franco, che era un impegno dei movimenti separatisti e un impegno dei siciliani aderenti a Forza Italia. Si pensi ancora che, all’inizio del 1994, da esponenti della Lega nord (Tempesta, Marchioni e il principe Orsini), con i quali avevo avuto diretti contatti, ero stato notiziato dell’esistenza di trattative fra Bossi e Berlusconi per un apparentamento elettorale e per un futuro accordo di governo che prevedeva, fra l’altro, il federalismo tra gli obiettivi primari da perseguire. Marchioni mi aveva riferito che un parlamentare della Lega nord, questore del Senato, aveva confermato che il futuro movimento, che avrebbe poi preso il nome di Forza Italia, aveva sposato in pieno la tesi federalista».
Giovanni Marchioni, un imprenditore vicino alla Lega Italia federale, l’articolazione romana della Lega nord, ha confermato che i promotori delle «leghe del Sud» si sono riuniti a Lamezia Terme. Erano presenti, tra gli altri, La Bua e Strano per Sicilia libera, oltre ai rappresentanti di Calabria libera, Lucania libera e Campania libera. In questa occasione il principe Orsini si propone come candidato unico del futuro raggruppamento di tutte quelle organizzazioni. Orsini conferma tutto ai magistrati palermitani e ammette «di avere chiaramente intuito il tipo di interessi che Sicilia libera intendeva tutelare», scrivono i magistrati di Palermo, «specialmente dopo che Cannella gli disse esplicitamente che “occorreva tenere un discorso all’Ucciardone per poi perorare la causa del noto 41 bis dell’ordinamento penitenziario”».
Già verso la fine del 1993, comunque, un boss di Cosa nostra impegnato in prima persona nella strategia delle stragi avverte Cannella che quella del movimento separatista non è l’unica via: «Nel corso di un incontro con Filippo Graviano, questi, facendo riferimento al movimento Sicilia libera di cui ero notoriamente promotore, mi disse testualmente: “Ti sei messo in politica, ma perché non lasci stare, visto che c’è chi si cura i politici… Ci sono io che ho rapporti ad alti livelli e ben presto verranno risolti i problemi che ci danno i pentiti». Graviano e, nell’ombra, Bernardo Provenzano, nei mesi seguenti constatano che la strada separatista non è percorribile. È in questo clima che si intrecciano rapporti frenetici tra esponenti delle «leghe» e uomini di Forza Italia.
Gioacchino Genchi è un poliziotto esperto in analisi dei traffici telefonici. Da tempo è in aspettativa dalla Polizia e dal suo ufficio di Palermo pieno di computer svolge il ruolo di consulente per diverse procure italiane. Per quella di Palermo ha analizzato, con i suoi programmi e i suoi data base, i flussi telefonici dei protagonisti della stagione di Sicilia libera. Scoprendo nei tabulati della Telecom e degli altri gestori telefonici una serie di contatti insospettabili.
Il giorno chiave è il 4 febbraio 1994. Il principe Orsini alle 10.50 telefona a Stefano Tempesta, esponente leghista vicino a Sicilia libera. Nel primo pomeriggio, alle 15.55, raggiunge al telefono Cannella, l’inviato di Bagarella nella politica. Subito dopo, alle 16.14, chiama la sede di Sicilia libera a Palermo. Alle 18.43 chiama Arcore: il numero è quello riservato a cui risponde Silvio Berlusconi. Immediatamente dopo chiama Marcello Dell’Utri. Alle 19.01 telefona di nuovo a Tempesta, che raggiunge ancora alle 19.20. Nei giorni successivi i contatti di Orsini continuano. Il 7 febbraio 1994, alle 17.34, chiama Sicilia libera. Il giorno dopo parla due volte con Dell’Utri. Il 10 febbraio alle 13.26 telefona a Cesare Previti. Il 14 febbraio contatta ancora Dell’Utri e, alle 16.04, Vittorio Sgarbi.
L’analisi al computer dei tabulati di migliaia di telefonate, naturalmente, non può far conoscere i contenuti dei contatti. Ma rivela i rapporti, le connessioni. Un deputato regionale siciliano dell’Udc, Salvatore Cintola, per esempio, nel periodo tra il 9 ottobre 1993 e il 10 febbraio 1994 chiama 96 volte il cellulare di Tullio Cannella, l’uomo di Sicilia libera. In quei mesi cruciali a cavallo tra il ’93 e il ’94 sono molti i contatti tra la sede di Sicilia libera e i numeri della Lega nord, a Roma, a Verona, a Belluno. Poi, quando l’opzione «leghista» tramonta, crescono i rapporti telefonici con uomini di Forza Italia. Gianfranco Micciché, Gaspare Giudice, Pippo Fallica, Salvatore La Porta. E Giovanni Lalia, che di Forza Italia siciliana è uno dei fondatori. È lui che dà vita al club forzista di Misilmeri, che anima il gruppo che si riunisce all’Hotel San Paolo di Palermo, formalmente posseduto dal costruttore Gianni Ienna, ma considerato dagli investigatori proprietà dei Graviano e per questo confiscato. È sempre lui, Lalia, che cede il suo cellulare a mafiosi di Misilmeri, il giro di Giovanni Tubato (poi ucciso) e Stefano Benigno (cugino di Lalia, in seguito condannato per le stragi del ’93).
Le analisi dei traffici telefonici mettono in risalto anche gli intensi rapporti tra Marcello Dell’Utri e un gruppo di imprenditori siciliani attivi a Milano nel settore delle pulizie, capitanati da Natale Sartori e Antonino Currò, arrestati poi nel 1998 a Milano. Il gruppo di Sartori e Currò era a sua volta in strettissimi rapporti con il mafioso Vittorio Mangano, un tempo «stalliere» nella villa di Berlusconi ad Arcore. Un capomafia del peso di Giovanni Brusca ha testimoniato a Palermo che il tramite tra Berlusconi e Cosa nostra, a Milano, sarebbe proprio «un imprenditore nel settore delle pulizie». Chissà, si sono chiesti gli investigatori del caso Sartori-Currò, se ha a che fare con i nostri eroi. Ma per ora quell’imprenditore – ammesso che esista – è rimasto senza volto e senza nome. Restano soltanto i fili sottili dei rapporti intrecciati, nel momento forse più drammatico della storia italiana del dopoguerra, tra gli uomini di Cosa nostra, i promotori delle leghe, i fondatori di Forza Italia. Che questi contatti ci siano stati è ormai certo. Che cosa si siano detti, quali trattative, quali eventuali promesse si siano fatti non è invece ancora dato di sapere con certezza. Il momento fondativo della cosiddetta Seconda Repubblica resta avvolto nel mistero. (Gianni Barbacetto, Diario, 21 marzo 2003)
“Bisogna ripartire dalle parole di Graviano su Berlusconi”. Roberto Tartaglia, 37 anni, il più giovane dei pm che ha sostenuto l’accusa nel processo sulla Trattativa Stato-mafia a Palermo, dopo l’approvazione del Csm, ha lasciato la Procura per fare il consulente della Commissione parlamentare antimafia e si è insediato alla vigilia dell’anniversario della strage di Capaci.
Lo abbiamo incontrato. Dottor Tartaglia, di cosa si occuperà in Commissione Antimafia? Il presidente Nicola Morra ha fatto due scelte non scontate come insediare un comitato apposito sulla Trattativa Stato-mafia e poi scegliere come consulente me. Io sono onorato anche perché la Commissione, storicamente, ha svolto un ruolo pionieristico: la relazione di minoranza del 1976, firmata da Pio La Torre e Cesare Terranova riuscì a prevenire l’azione della magistratura. Certo, allora era solo la minoranza a sostenere che ‘la mafia è un fenomeno di classi dirigenti’. Oggi invece il primo comitato è intitolato dalla presidenza alla Trattativa Stato-mafia. Il passo avanti è enorme.
Sono passati 27 anni dalla strage di Capaci. Quando riusciremo a sapere la verità sui cosiddetti mandanti esterni alla mafia delle stragi del 1992-1993? Una domanda giusta che però non deve far dimenticare i grandi passi avanti compiuti in questi ultimi anni. Sappiamo molte più cose e penso che la Commissione parlamentare antimafia possa svolgere un ruolo importante.
Quali sono i punti fermi da cui partire? Le sentenze sulla Trattativa, la sentenza Borsellino quater e poi la sentenza Montante. Su ciascuna di queste macro-aree poi ci sono filoni meno approfonditi dal punto di vista giudiziario che potrebbero diventare tema di inchiesta per la commissione.
Quali sono i filoni che lei ha incrociato come pm e che le sembrano degni di approfondimento? Certamente le intercettazioni di Giuseppe Graviano in cella nel 2016 quando al compagno di detenzione racconta di avere concepito suo figlio in cella come aveva fatto anche il fratello Filippo. Erano entrambi reclusi allora a Palermo. Quella è una questione da approfondire.
Se un ragazzo nato nel 1992 le chiedesse di spiegare con due tweet quali sono le possibili ragioni dell’inizio e della fine delle stragi, cosa direbbe? Potrebbe esserci stata una convergenza di interessi tra realtà diverse come Cosa Nostra e alcuni esponenti dei Servizi che temevano per la loro sorte in uno scenario politico mutato. Al tramonto della Prima Repubblica queste forze volevano ribaltare l’ordine in modo eclatante per poi accelerare e guidare il processo di transizione. A questo punto abbiamo la risposta anche all’altra domanda, cioè perché le stragi sono finite. Certo, i fratelli Graviano che avevano attuato la politica stragista erano stati arrestati nel 1994 ma restavano liberi altri boss. Credo di più a una risposta diversa. Le stragi terminano quando il nuovo assetto si è determinato.
Riina e Provenzano sono morti in cella e i fratelli Graviano sono sepolti al 41 bis da un quarto di secolo. La mafia cosa avrebbe ottenuto? Ci sono contropartite che non vediamo? Innanzitutto ci sono cose ben visibili come i figli concepiti in cella dai fratelli Graviano, l’isolamento o le floride condizioni economiche delle famiglie dei boss. Infine non mi pare che Graviano sia entusiasta e anzi dice al compagno di detenzione: ‘Umbè non può finire così’. Questa delusione minacciosa è uno dei profili da esplorare. Graviano è stato arrestato a Milano nel 1994 con il papà di un piccolo calciatore che doveva fare il provino al Milan, in precedenza raccomandato da Dell’Utri. Proprio Graviano parla in cella – secondo la sentenza Trattativa – di Berlusconi come di un ‘traditore’… Questo è un altro passaggio importante delle intercettazioni. Graviano fa tutte quelle confidenze al suo compagno di detenzione perché sa che Adinolfi potrebbe uscire di cella e gli vuole affidare un compito: inviare tramite un terzo soggetto un messaggio minaccioso a Berlusconi. Sarebbe molto interessante individuare chi sia il soggetto vicino a Berlusconi che potrebbe essere a conoscenza dei segreti di quel periodo.
Ci sarà una collaborazione tra voi e i magistrati della Procura Nazionale? Il primo comitato insediato in Commissione è quello dedicato a mafia e politica, trattativa e stragi. Anche il procuratore nazionale Federico Cafiero De Raho ha creato un gruppo di lavoro intitolato a mafia ed entità esterne per le stragi, al quale lavora tra l’altro anche Antonino Di Matteo. C’è la possibilità di creare sinergie. Ci sono poi in Commissione tante personalità che hanno grandi capacità ed esperienza come il presidente Pietro Grasso o come l’ex ministro Andrea Orlando. E ci sono tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro.
Quali sono i punti oscuri da chiarire? Graviano in cella parla dell’urgenza e probabilmente fa riferimento alla ragione dell’accelerazione della strage di via D’Amelio in cui fu ucciso Borsellino, 57 giorni dopo Falcone. La sentenza mette in relazione l’urgenza alla consapevolezza di Borsellino della Trattativa. Io penso che sulle ragioni di quell’urgenza dobbiamo lavorare. Un’altra traccia che andrebbe esplorata è il ruolo di Matteo Messina Denaro nell’elaborazione della strategia politica di Cosa Nostra e nella trattativa. Secondo il collaboratore Giuffrè, era lui la creatura di Totò Riina, l’uomo che potrebbe avere ereditato i suoi segreti.
Come valuta le norme antimafia attuali? Valuto positivamente alcune riforme come l’agente sotto copertura nei reati contro la Pubblica amministrazione e la riforma dell’articolo 416 ter, il voto di scambio politico-mafioso.
Holetto critiche che, dal punto di vista giuridico, non condivido. La precedente normativa non puniva lo scambio quando la mafia non usava la minaccia. La riforma estende la punibilità anche al politico che compra il voto senza avvalersi della minaccia ma solo dell’influenza sul territorio della mafia. Basta inoltre la semplice disponibilità politica, non è più necessario che il politico paghi per l’appoggio mafioso. MARCO LILLO FATTO QUOTIDIANO del, 23/05/2019
“Erano diversi i canali di comunicazione tra Riina-Dell’Utri-Berlusconi. È lo stesso Riina che lo racconta mentre è intercettato in carcere senza sapere di essere ascoltato”. È uno dei primi passaggi della requisitoria del pm Nino Di Matteo al processo sulla trattativa tra Stato e mafia.
Il magistrato recita alcune delle frasi intercettate in carcere al capomafia: “Ma noi altri abbiamo bisogno di Giovanni Brusca per cercare Dell’Utri? Questo Dell’Utri è una persona seria…”, diceva Riina al codetenuto Alberto Lorusso. E ancora: “…Berlusconi in qualche modo mi cercava… si era messo a cercarmi… mi ha mandato a questo… Gli abbiamo fatto cadere le antenne – diceva Riina in un’altra intercettazione del 2013 – e non lo abbiamo fatto più trasmettere”.
Le intercettazioni del capomafia di Corleone, morto lo scorso novembre, sono state lette in aula dal pm. “Nei dialoghi intercettati in carcere – dice il magistrato – Riina più volte parla dei canali tramite i quali avrebbe potuto contattare Dell’Utri“, l’ex senatore imputato nel processo per minaccia a corpo politico dello Stato e detenuto perché condannato per concorso in associazione mafiosa. Non solo.
Secondo Di Matteo “Riina dimostra di essere consapevole dei rapporti che i fratelli Graviano avevano per i loro canali con l’imprenditore e poi politico Berlusconi.
Alterna momenti di sincera confidenza con dei momenti in cui invece assume ufficialmente la parte di chi non sa nulla”. Proprio in una controversa intercettazione, pubblicata in esclusiva da Sekret, Giuseppe Graviano, parla riguardo alle stragi mafiose di un favore chiesto a Graviano da ‘Berlusca’ secondo l’interpretazione delle parole data dai periti di pm e giudice.
Pm: “Riina non consapevole di essere intercettato”
Secondo la procura di Palermo comunque Riina “non era consapevole di essere intercettato nello spazio esterno del carcere” in cui era detenuto. “Se fosse stato consapevole o avesse avuto un sospetto serio, non avrebbe parlato così a lungo e approfonditamente di quasi tutti gli omicidi di cui si è reso protagonista e non si sarebbe vantato, con profili di autoesaltazione che stridono con la purezza del racconto delle stragi e di omicidi eccellenti. Inoltre, non avrebbe parlato tante volte dei suoi congiunti, della moglie e dei figli” ha proseguito Di Matteo nell’udienza in corso all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo.
Una replica a distanza a chi sostiene da tempo che il capomafia di Corleone “sapeva di essere intercettato in carcere”.
Le intercettazioni a cui fa riferimento il pm della Dna sono quelle del 2013 tra Totò Riina e il codetenuto Alberto Lorusso, che sembrava il depositario degli sfoghi e dei propositi di morte del boss.
L’odio per i magistrati Chinnici, Falcone e Borsellino
In quelle lunghe ore di conversazioni, tutte registrate dalle cimici del carcere, Riina aveva parlato degli anni Ottanta e inizio Novanta, e del suo odio contro i magistrati, da Rocco Chinnici a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fino allo stesso Nino Di Matteo e gli altri pm antimafia.
E quasi si lamentava, Riina, che gli affiliati a Cosa nostra ancora liberi avessero seguito la strategia dell’inabbissamento: “Mi viene una rabbia a me… ma perché questa popolazione non vuole ammazzare a nessun magistrato?”, diceva a Lorusso. “Se avesse saputo di essere intercettato – prosegue il pm Di Matteo – Riina non avrebbe parlato così approfonditamente di suo nipote Giovanni Grizzafi e delle aspettative che nutriva rispetto alla prossima scarcerazione di Grizzafi che gli avrebbe permesso di tessere le fila di tante situazioni.
Se avesse avuto un serio sospetto di essere intercettato nello spazio esterno non avrebbe mai parlato di beni patrimoniali riconducibili alla sua famiglia. In alcuni momenti delle conversazioni con Lorusso parla di beni che ha nella disponibilità di cui nessuno aveva sospettato”. “Inoltre – dice ancora il pm Di Matteo – Riina non avrebbe sollecitato l’eliminazione di uno dei pm del processo”, facendo riferimento a lui stesso, nel mirino del capomafia Riina. Parlando del magistrato, Riina aveva detto nelle intercettazioni: “Ti farei diventare il primo tonno, il tonno buono… Ancora ci insisti? Perché, me lo sono tolto il vizio? Inizierei domani mattina… Minchia ho una rabbia… Sono un uomo e so quello che devo fare, pure che ho cento anni”. Il nome del pm venne fuori anche in riferimento alle polemiche seguite alla citazione come testimone dell’ex capo dello Stato Giorgio Napolitano (‘Questo Di Matteo, questo disonorato, questo prende pure il presidente della Repubblicà), a cui Riina immagina di fargli fare la fine del procuratore Scaglione, assassinato nel 1971: “A questo ci finisce lo stesso”.
Nelle intercettazioni Riina parlava anche della strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, sua moglie Francesca e tre agenti di scorta. Per Riina fu “una mangiata di pasta”.
“Riina disse che fu lo stato a cercarlo”
Nel 1992, secondo la procura, non sarebbe stato il boss mafioso a volere avviare una trattativa con pezzi dello Stato. Ma sarebbero stati esponenti delle Istituzioni a volere dare vita a un accordo per fare cessare le stragi mafiose. Di Matteo, durante la requisitoria, ha letto la relazione fatta nel 2013 da due assistenti penitenziari del carcere di Opera a Milano sulle parole pronunciate dal boss Riina.
Riina disse “Non mi hanno arrestato i Carabinieri ma Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano – dice il magistrato – E lo stesso Riina ha poi sottolineato, come emerge dalla relazione dei due assistenti penitenziari: ‘Non ero io a cercare loro per trattare con loro ma era loro che cercavano me per trattare, io non cercavo nessuno‘”. Secondo il pm Di Matteo un “riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cancemi e Brusca” ma anche del “dichiarante Massimo Ciancimino“, quest’ultimo imputato nel processo per concorso esterno in associazione mafiosa.
Comunque Riina “è stato il principale ideatore e artefice ed esecutore di quel vero e proprio ricatto allo Stato condotto a suon di bombe ed omicidi eccellenti. Successivamente c’è stata una evoluzione della trattativa – dice ancora il magistrato – con la individuazione, sotto l’aspetto del terminale mafioso, di Provenzano, a partire da una certa data in poi, quale soggetto mafioso più affidabile per trattare”. 10.1.2018 IL FATTO QUOTIDIANO
Riina, il pentito Mutolo: “Io non immagino una politica senza mafia. Berlusconi? Non dimentichiamo che Dell’Utri è in galera”. “Io non immagino una politica senza mafia“. Parola di Gaspare Mutolo, ex mafioso fedelissimo di Salvatore Riina e poi tra i pentiti più importanti della storia di Cosa nostra. “Riina era un uomo carismatico, per me è stato un papà. Siamo stati in galera insieme. E lì è nata una profonda amicizia. Lui era un personaggio carismatico. Non era prepotente, lui conquistava le persone con le belle parole. Non abbiamo mai litigato, solo che a un certo punto ognuno ha preso la sua strada”, ha raccontato il collaboratore di giustizia che nel giorno della morte del capo dei capi ha partecipato ad un incontro alla
Incappucciato, ha riavvolto indietro il nastro della storia, sostenendo che dietro l’arresto di Luciano Liggio ci fosse proprio Riina. “Fino al 1973/74 Riina è stato agli ordini di Luciano Liggio. Poi Liggio lo voleva estromettere e allora lui l’ha fatto arrestare a Milano nel 1974. E lì Riina ha preso il potere. Perché Riina era diverso da Bernardo Provenzano che era un bonaccione“, sono le parole usate da Mutolo. Che poi dà una sua personale visione della seconda guerra di mafia scatenata dallo stesso Riina. “Riina – ha detto il pentito – arrivò a costruire questo sistema che induceva le persone a lui affezionate a tradire i loro capi. Lui ha fatto uccidere i suoi migliori amici perché a un certo punto è diventato pazzo e aveva paura di essere tradito a sua volta”.
Quindi spazio anche ai rapporti tra mafia e politica. “In Cosa nostra – ha detto Mutolo – c’erano anche i cugini Salvo che con Salvo Lima erano il potere. Erano amici di Andreotti. La mafia era ben vista finché non si è messa contro il governo. Nei Paesi comandavano tre persone: il prete, il mafioso e il maresciallo. Il maresciallo non perseguitava il mafioso perché non era un criminale come gli altri”. E quando parla di rapporti tra mafia e politica Mutolo poi tira in ballo anche Silvio Berlusconi. “Anche Berlusconi: l’amico intimo di Berlusconi che è Dell’Utri è in galera: vogliamo fare scomparire questo? Noi a Palermo vedevamo che Mangano faceva lo stalliere ad Arcore” IL FATTO QUOTIDIANO 18.11.2017
PROCESSO ‘NDRANGHETA STRAGISTA Pubblicate le 1078 pagine delle MOTIVAZIONI della Sentenza – “Non può affatto escludersi, anzi appare piuttosto assai probabile, che dietro tali avvenimenti vi fossero dei mandanti politici che attraverso la ‘strategia della tensione’ volevano evitare l’avvento al potere delle sinistre, temuto anche dalle organizzazioni criminali, che erano riuscite con i precedenti referenti politici a godere di benefici e agevolazioni. Si può, quindi, affermare che in tale circostanza si era venuta a creare una sorta di convergenza di interessi tra vari settori che hanno sostenuto ideologicamente la strategia stragista di Cosa Nostra”.
22.1.2021 – NDRANGHETA STRAGISTA: SENTENZA,NON ESCLUSI MANDANTI POLITICI “Non può affatto escludersi, anzi appare piuttosto assai probabile, che dietro tali avvenimenti vi fossero dei mandanti politici che attraverso la ‘strategia della tensione’ volevano evitare l’avvento al potere delle sinistre, temuto anche dalle organizzazioni criminali, che erano riuscite con i precedenti referenti politici a godere di benefici e agevolazioni. Si può, quindi, affermare che in tale circostanza si era venuta a creare una sorta di convergenza di interessi tra vari settori che hanno sostenuto ideologicamente la strategia stragista di Cosa Nostra”. È quanto si afferma nelle motivazioni della sentenza del processo”’Ndrangheta stragista” con la quale la Corte d’Assise di Reggio Calabria, su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dell’aggiunto Giuseppe Lombardo, sono stati condannati all’ergastolo lo scorso 24 luglio il boss siciliano Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, considerato dalla Dda il referente della cosca Piromalli. Graviano e Filippone sono ritenuti i mandanti degli attentati ai carabinieri Antonio Fava e Vincenzo Garofalo uccisi il 18 gennaio 1994 sulla Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Scilla. “Le conclusioni cui è pervenuta questa Corte in ordine alla responsabilità degli imputati – è scritto nella sentenza – costituiscono soltanto un primo approdo, dal momento che la complessa istruttoria dibattimentale, ivi comprese le dichiarazioni di Giuseppe Graviano, lascia intravedere il coinvolgimento di ulteriori soggetti che hanno concorso nella ideazione e deliberazione degli eventi in esame. Ciò che si ricava è che dietro tutto ciò non vi sono state soltanto le organizzazioni criminali, ma anche tutta una serie di soggetti provenienti da differenti contesti (politici, massonici, servizi segreti), che hanno agito al fine di destabilizzare lo Stato per ottenere anch’essi vantaggi di vario genere, approfittando anche di un momento di crisi dei partiti tradizionali”. Per questo motivo, “con riferimento alla identificazione di tali soggetti”, la Corte d’Assise di Reggio Calabria ha trasmesso alcuni atti del processo alla Procura della Repubblica perché continui a indagare. (ANSA 22.1.2021).
I GIUDICI: “MANDANTI POLITICI DIETRO AGLI ATTENTATI. C’ERA UNA STRATEGIA UNITARIA PER DESTABILIZZARE LO STATO”. TRASMESSI GLI ATTI IN PROCURA: “ORA FARE LUCE SULLE ACCUSE DI GRAVIANO A BERLUSCONI”
Le MOTIVAZIONI – Nelle 1078 pagine di sentenza del processo, che si è concluso con l’ergastolo per il boss di Brancaccio e per Filippone, la Corte d’Assise di Reggio Calabria scrive che “l’attentato ai danni dei carabinieri” del dicembre ’93 e il duplice omicidio di Fava e Garofalo si collocano “all’interno di una strategia omogenea e unitaria” portata avanti da una serie di soggetti provenienti da differenti contesti (politici, massonici, servizi segreti)”. I giudici ricostruiscono le dinamiche che hanno portato Cosa nostra ad appoggiare prima la Dc e poi Forza Italia. E chiedono di accertare la natura del “risentimento” di Graviano verso l’ex premier
“L’attentato ai danni dei carabinieri avvenuto nella notte tra il 1 e 2 dicembre 1993 e il duplice omicidio del 18 gennaio 1994 sono da considerarsi un antecedente necessario del più eclatante attentato (la fallita strage dell’Olimpico, ndr) che si sarebbe dovuto compiere, nelle intenzioni del Graviano, a distanza di pochi giorni, in un crescendo che si colloca all’interno di una strategia omogenea e unitaria”. È quanto scrive la Corte d’Assise di Reggio Calabria nelle motivazioni della sentenza del processo “’Ndrangheta stragista” che a fine luglio si è concluso con la condanna all’ergastolo per il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e per Rocco Santo Filippone, ritenuto dalla Dda espressione della cosca Piromalli di Gioia Tauro. Per i giudici, però, le “responsabilità degli imputati costituiscono soltanto un primo approdo”: dietro agli attentati è “assai probabile” che oltre alla ‘Ndrangheta e a Cosa nostra vi fossero “dei mandanti politici che attraverso la ‘strategia della tensione’ volevano evitare l’avvento al potere delle sinistre”. La presidente Ornella Pastore, il giudice a latere Vincenza Bellini e i giudici popolari hanno sposato in pieno l’impianto accusatorio del procuratore Giovanni Bombardieri e dell’aggiunto Giuseppe Lombardo. Quest’ultimo è riuscito, “a distanza di circa venticinque anni dai fatti, a fornire una nuova e diversa lettura delle ragioni” che hanno portato alla morte dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, trucidati sulla Salerno-Reggio Calabria all’altezza dello svincolo di Scilla.
“Cinico piano di controllo del potere politico” – Secondo la Corte d’Assise, Graviano e Filippone sono i mandanti di quell’agguato e degli altri due attentati consumati a Reggio Calabria ai danni dei carabinieri. Stragi che rientravano in una “comune strategia eversivo-terrorista” e “hanno costituito uno dei momenti più significativi di un cinico piano di controllo del potere politico (fortunatamente fallito) nel quale sono confluite tendenze eversive anche di segno diverso (servizi segreti deviati) per effetto anche della ‘contaminazione’ o ‘evoluzione’ originata dall’inserimento della mafia siciliana e calabrese all’interno della massoneria”. “Il culmine di tale attacco allo Stato – si legge nella sentenza di primo grado – si sarebbe dovuto raggiungere il 23 gennaio 1994 con l’attentato allo Stadio Olimpico di Roma che, se portato a termine, avrebbe certamente determinato l’uccisione di decine e decine di carabinieri, piegando in maniera definitiva lo Stato, già colpito dalle stragi avvenute negli anni precedenti”. Il tutto si è incastrato “in un momento in cui le organizzazioni erano alla ricerca di nuovi e più affidabili referenti politici, disposti a scendere a patti con la mafia, che furono individuati nel neopartito Forza Italia di Silvio Berlusconi in cui erano confluiti i movimenti separatisti nati in quegli anni come risposta alle spinte autonomistiche in Sicilia e Calabria”.
La corte d’Assise: “Ci sono mandanti politici” – Nonostante il procuratore Lombardo, “con un notevole sforzo investigativo, protrattosi anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale”, sia riuscito a fare luce su una delle pagine più buie del nostro Paese, ci sono anche altri responsabili di quella strategia stragista: “Le conclusioni cui è pervenuta questa Corte in ordine alla responsabilità degli imputati – scrive infatti la presidente Pastore – costituiscono soltanto un primo approdo, dal momento che la complessa istruttoria dibattimentale, ivi comprese le dichiarazioni di Giuseppe Graviano, lascia intravedere il coinvolgimento nelle vicende esaminate di ulteriori soggetti che hanno concorso nella ideazione e deliberazione degli eventi in esame”.
E ancora: “Non può affatto escludersi, anzi appare piuttosto assai probabile, che dietro tali avvenimenti vi fossero dei mandanti politici che attraverso la ‘strategia della tensione’ volevano evitare l’avvento al potere delle sinistre, temuto anche dalle organizzazioni criminali, che erano riuscite con i precedenti referenti politici a godere di benefici e agevolazioni. Si può, quindi, affermare che in tale circostanza si era venuta a creare una sorta di convergenza di interessi tra vari settori che hanno sostenuto ideologicamente la strategia stragista di Cosa Nostra”.
I voti di Cosa nostra: dalla Dc a Forza Italia – Nelle 1078 pagine di sentenza, la Corte d’Assise ricostruisce le dinamiche che hanno portato Cosa Nostra ad appoggiare la Democrazia Cristiana fino a quando erano andate in fumo, nel gennaio 1992, le speranze di ottenere un annullamento della sentenza del maxi processo. Dopo l’omicidio Lima, i voti della mafia siciliana “erano stati dirottati sul ‘Partito Socialista’ e anche sul partito Radicale”. Con la crisi dei partiti tradizionali, però, “Cosa Nostra aveva deciso di uniformarsi a ciò che stava accadendo nel resto del sud Italia creando movimenti autonomisti”. Un progetto questo che, presto, non era apparso più conveniente ed “era stato quindi accantonato in favore dell’appoggio al nascente partito politico Forza Italia”. Un cambio di rotta condiviso con la ‘ndrangheta. Lo dimostra ciò che avvenne il 24 febbraio 1994 quando il boss “Giuseppe Piromalli, durante il processo celebrato a Palmi per l’estorsione per i ripetitori Fininvest, prendeva la parola in aula e dalla cella gridava: “Voteremo Berlusconi, voteremo Berlusconi”.
Graviano al bar Doney con Dell’Utri – Nelle motivazioni della sentenza, inoltre, ha trovato spazio il famoso incontro tra il boss Giuseppe Graviano e Marcello Dell’Utri avvenuto in via Veneto a Roma nel gennaio 1994 e “finalizzato a discutere del nuovo partito politico che stava per nascere, Forza Italia”. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale è stato sentito il pentito Gaspare Spatuzza a cui il boss di Brancaccio aveva mostrato “la sua felicità per il fatto di essere riuscito ad ottenere ‘tutto quello che cercava’, con ciò facendo riferimento a Berlusconi ‘quello del Canale 5’ e al ‘compaesano’ Dell’Utri”. Al collaboratore di giustizia, infatti, aveva detto di avere “il paese nelle mani” e che bisognava dare il “colpo di grazia” con l’attentato ai carabinieri.
Durante il processo, la Procura ha dimostrato che negli stessi giorni dell’incontro di via Veneto, a poche centinaia di metri all’Hotel Majestic Dell’Utri era impegnato in una serie d’incontri preparatori alla discesa in campo di Berlusconi. Sul punto, la Corte d’Assise non ha dubbi: “Può ragionevolmente ritenersi che il Graviano il 21 gennaio 1994, prima di incontrare lo Spatuzza per discutere degli ultimi dettagli riguardanti l’attentato allo stadio Olimpico, avesse avuto modo di colloquiare con il Dell’Utri che nello stesso giorno si trovava a Roma poco distante dal bar Doney”.
Il boss di Brancaccio rompe il silenzio – A differenza del processo di Firenze quando il boss siciliano si è avvalso della facoltà di non rispondere nel momento in cui gli erano state poste domande su Marcello Dell’Utri, dopo 26 anni in riva allo Stretto Graviano ha rotto il silenzio. Nelle udienze dedicate al suo interrogatorio, ha reso numerose dichiarazioni spontanee e ha risposto pure alle domande del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo. Per i giudici, “ha inteso a suo modo sciogliere tale riserva riferendo diffusamente, in ordine ai suoi rapporti con Silvio Berlusconi, descrivendone le origini, che ha indicato in ragioni di carattere economico. Ha inoltre spiegato le ragioni del risentimento nei confronti dell’esponente politico che è arrivato persino ad indicare come il mandante del suo arresto”.
Sarà la Procura, a cui la Corte d’Assise ha trasmesso le “copiose dichiarazioni rese dal Graviano”, a fare luce sulle accuse mosse dal boss e a verificare se siano calunnie o verità. Tuttavia, per i magistrati, si tratta di “dichiarazioni di estremo rilievo che, unitamente al contenuto delle conversazioni intercettate presso il carcere di Ascoli Piceno intercorse con l’Adinolfi, confermano l’esistenza di aspettative da parte del Graviano nei confronti del nuovo governo, in quanto a seguito dell’avvicendamento politico venutosi a creare, egli sperava che potessero intervenire modifiche legislative riguardanti il regime detentivo ed altro”. Aspettative rimaste tali e questo “ha determinato nel Graviano rabbia e risentimento, essendo egli peraltro persuaso di essere stato tratto in arresto deliberamente per evitare la formalizzazione del suo accordo economico con Berlusconi”.
Il presunto ruolo strategico che il leader di Forza Italia avrebbe avuto nell’arresto di Graviano riguarderebbe, infatti, una serie di investimenti fatti dal nonno del boss a Milano negli anni ’60 e ’70. Il capocosca di Brancaccio riporta la vicenda pure nel memoriale consegnato alla Corte d’Assise pochi giorni prima di essere condannato all’ergastolo: “L’imputato ribadisce che dall’ascolto delle conversazioni è possibile comprendere la vera natura del rapporto che lo lega al predetto (Berlusconi, ndr), il quale, grazie alla manovre messe in atto da ‘qualcuno’ o più di ‘qualcuno’, avrebbe guadagnato ‘alla fine degli anni 60, la cifra di ben 20 miliardi di lire, che si dovevano tradurre nel 20% degli investimenti fatti negli anni dallo stesso’”. I “rapporti di natura economica” con Berlusconi, secondo i giudici, “risultano totalmente indimostrati essendo sul punto le dichiarazioni del Graviano prive di qualunque riscontro”.
La strage di Via d’Amelio, l’agenda di Borsellino – Come è stato per le udienze in cui ha reso dichiarazioni, anche con il suo memoriale Giuseppe Graviano ha dimostrato di essere un geloso custode del suo “bagaglio di conoscenze”: dall’omicidio del poliziotto Agostino (in cui “sarebbero coinvolti soggetti che si sono resi responsabili dell’omicidio di suo padre”) alla strage di Via D’Amelio (“è stato imbastito – ha detto – un disegno criminoso per tutelare gli interessi di qualcuno o più di qualcuno”), fino alla sparizione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino per la quale il boss ha fatto chiaramente intendere di sapere chi l’ha presa dal luogo della strage.
Se non è un invito a collaborare con la giustizia, lo sembra molto quello della Corte d’Assise di Reggio Calabria: “Deve certamente ritenersi – scrive, infatti, la presidente Ornella Pastore – che l’imputato potrebbe fornire un contributo rilevante per fare piena luce, oltre che sui fatti per cui è processo, anche su altri gravi episodi criminosi che hanno insanguinato il nostro Paese all’inizio degli anni ’90, tra cui la strage di via D’Amelio, a meno che, a distanza di quasi 27 anni dal suo arresto, non continui ancora a sperare che possa accadere qualche ‘bella cosa’”. “In ogni caso – si legge sempre nella sentenza – le circostanze riferite dal Graviano meritano certamente di essere valutate ed approfondite nelle sedi competenti nella speranza che possano giovare finalmente a fare completa chiarezza su avvenimenti che hanno segnato e continuano tuttora a segnare la storia dell’Italia”.
Strategia stragista, le indagini della Dda continuano – Quanto emerso dal processo è certamente un tassello importante sui tanti misteri che hanno insanguinato l’Italia nei primi anni novanta con una strategia stragista cercata e voluta da un sistema che il procuratore aggiunto Lombardo ha più volte definito “comitato d’affari che comprende al suo interno ‘Ndrangheta, Mafia siciliana, politica collusa, pezzi di istituzioni e pezzi di servizi segreti”. Da qui le considerazioni della Corte D’Assise che, analizzando quanto emerso nell’istruttoria dibattimentale, ha concluso: “Ciò che si ricava ancora è che dietro tutto ciò non vi sono state soltanto le organizzazioni criminali, ma anche tutta una serie di soggetti provenienti da differenti contesti (politici, massonici, servizi segreti), che hanno agito al fine di destabilizzare lo Stato per ottenere anch’essi vantaggi di vario genere, approfittando anche di un momento di crisi dei partiti tradizionali. Anche con riferimento alla identificazione di tali soggetti, compito certamente non agevole in considerazione altresì del lungo lasso temporale decorso rispetto ai fatti in esame, si impone quindi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica”. di Lucio Musolino | 22 GENNAIO 2021 FATTO QUOTIDIANO
‘NDRANGHETA STRAGISTA: LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA “Non può affatto escludersi, anzi appare piuttosto assai probabile, che dietro tali avvenimenti vi fossero dei mandanti politici che attraverso la ‘strategia della tensione’ volevano evitare l’avvento al potere delle sinistre, temuto anche dalle organizzazioni criminali, che erano riuscite con i precedenti referenti politici a godere di benefici e agevolazioni. Si può, quindi, affermare che in tale circostanza si era venuta a creare una sorta di convergenza di interessi tra vari settori che hanno sostenuto ideologicamente la strategia stragista di Cosa Nostra”.
È quanto si afferma nelle motivazioni della sentenza “‘Ndrangheta stragista” con la quale la Corte d’Assise di Reggio Calabria, su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dell’aggiunto Giuseppe Lombardo, sono stati condannati all’ergastolo lo scorso 24 luglio il boss siciliano Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, considerato dalla Dda il referente della cosca Piromalli. Graviano e Filippone sono ritenuti i mandanti degli attentati ai carabinieri Antonio Fava e Vincenzo Garofalo uccisi il 18 gennaio 1994 sulla Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Scilla. “Le conclusioni cui è pervenuta questa Corte in ordine alla responsabilità degli imputati – è scritto nella sentenza – costituiscono soltanto un primo approdo, dal momento che la complessa istruttoria dibattimentale, ivi comprese le dichiarazioni di Giuseppe Graviano, lascia intravedere il coinvolgimento di ulteriori soggetti che hanno concorso nella ideazione e deliberazione degli eventi in esame.
Ciò che si ricava è che dietro tutto ciò non vi sono state soltanto le organizzazioni criminali, ma anche tutta una serie di soggetti provenienti da differenti contesti (politici, massonici, servizi segreti), che hanno agito al fine di destabilizzare lo Stato per ottenere anch’essi vantaggi di vario genere, approfittando anche di un momento di crisi dei partiti tradizionali”. Per questo motivo, “con riferimento alla identificazione di tali soggetti”, la Corte d’Assise di Reggio Calabria ha trasmesso alcuni atti del processo alla Procura della Repubblica perché continui a indagare.
Con attentati a carabinieri strategia eversiva Rientravano in una “comune strategia eversivo-terrorista” gli attentati ai carabinieri, avvenuti tra il 1993 e il 1994 e per i quali sono stati condannati i boss Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone. Nelle motivazioni della sentenza, il presidente della Corte d’Assise di Reggio Calabria Ornella Pastore scrive che “di tale strategia, i tre attentati ai carabinieri (fortunatamente non tutti andati a buon fine) hanno costituito uno dei momenti più significativi di un cinico piano di controllo del potere politico (fortunatamente fallito) nel quale sono confluite tendenze eversive anche di segno diverso (servizi segreti deviati) per effetto anche della ‘contaminazione’ o ‘evoluzione’ originata dall’inserimento della mafia siciliana e calabrese all’interno della massoneria”. “Il culmine di tale attacco allo Stato – scrive sempre la Corte d’Assise – si sarebbe dovuto raggiungere il 23 gennaio 1994 con l’attentato allo Stadio Olimpico di Roma che, se portato a termine, avrebbe certamente determinato l’uccisione di decide e decine di carabinieri, piegando in maniera definitiva lo Stato, già colpito dalle stragi avvenute negli anni precedenti”.
“Fi referente organizzazioni” L’attentato ai carabinieri in Calabria e la tentata strage dell’Olimpico sarebbero avvenuti ‘in un momento in cui le organizzazioni erano alla ricerca di nuovi e più affidabili referenti politici, disposti a scendere a patti con la mafia, che furono individuati nel neopartito Forza Italia di Silvio Berlusconi in cui erano confluiti i movimenti separatisti nati in quegli anni come risposta alle spinte autonomistiche in Sicilia e Calabria’”.
È quanto si legge ancora nella sentenza del processo “‘Ndrangheta stragista” in cui sono stati condannati all’ergastolo il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e il referente della cosca Piromalli, Rocco Santo Filippone accusati di essere i mandanti del duplice omicidio in cui persero la vita i carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, la Corte d’Assise di Reggio Calabria affronta pure il tema dell’incontro che, secondo il collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, sarebbe avvenuto nel gennaio 1994 tra Graviano e Marcello Dell’Utri in via Veneto a Roma.
I due avrebbero discusso “del nuovo partito politico che stava per nascere, Forza Italia”. “Può ragionevolmente ritenersi – scrivono i giudici – che il Graviano il 21 gennaio 1994, prima di incontrare lo Spatuzza per discutere degli ultimi dettagli riguardanti l’attentato allo stadio Olimpico, avesse avuto modo di colloquiare con il Dell’Utri che nello stesso giorno si trovava a Roma poco distante dal bar Doney”. TVLEN 21.1.2021
LA TRATTATIVA Graviano cita Berlusconi. Accellerò via D’Amelio. Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta muoiono per l’improvvisa accelerazione della decisione stragista di Riina determinata dalla trattativa Stato-mafia, e in particolare “dai segnali di disponibilità al dialogo – e di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci – pervenuti al boss Totò Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Amelio”.
E Silvio Berlusconi era perfettamente consapevole della minaccia mafiosa veicolata da Dell’Utri al suo governo, fino al dicembre del ’94: è lui, inoltre, a essere citato in carcere dal boss di Brancaccio Giuseppe Graviano con quel “Berlusca” che la Corte ritiene pronunciato dal boss, “togliendo qualsiasi dubbio’.
Nel giorno del 26° anniversario della strage di via D’Amelio la Corte d’assise di Palermo deposita nei 90 giorni previsti le motivazioni della sentenza rilanciando la tesi di una strettissima connessione tra l’uccisione di Borsellino e il dialogo Stato-mafia e gettando l’ombra di una pesantissima responsabilità morale nei confronti degli ufficiali dei carabinieri Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno che quella trattativa avviarono e condussero all’insaputa della magistratura, coinvolgendo la politica per la contropartita richiesta.
Nelle 5200 pagine della sentenza con cui hanno motivato le condanne di mafiosi, ufficiali dei carabinieri e politici, i giudici Alfredo Montalto e Stefania Brambille ribaltano le conclusioni della Procura nissena che nella requisitoria del Borsellino quater non aveva ritenuto sufficientemente provata la relazione: “Non c’è dubbio che quell’invito al dialogo pervenuto dai carabinieri attraverso don Vito costituisca un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino”, con la finalità di approfittare “di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato”.
La Corte si spinge oltre e scrive che “non vi è alcun elemento di prova che possa collegare il rapporto mafia e appalti all’improvvisa accelerazione della strage Borsellino”, come sostenuto dalle difese degli ufficiali del Ros, per cui, secondo i giudici, “non vi è dubbio” che i contatti fra Mori, De Donno e Ciancimino “ben potevano essere percepiti da Riina come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa, nella misura in cui quegli ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato”.
Ancor più, concludono i giudici, se si tiene conto del fatto che l’indagine su mafia e appalti “non era certo l’unica, né la principale di cui Borsellino ebbe a interessarsi in quel periodo”.
GRAVIANO E “BERLUSCA”, ALTRO CHE “BRAVISSIMO”
Per il perito della Corte era “Berlusca’’, per i consulenti della difesa invece “bravissimo”. Due cuffie e un pc con scheda audio sciolgono ogni dubbio sul riferimento del boss Graviano a Berlusconi: “È stato possibile percepire con sufficiente chiarezza – scrive la Corte dopo avere ascoltato la registrazione – la parola Berlusca’’.
Ma a togliere “qualsiasi dubbio’’ è statala versione ripulita del file audio messa a disposizione dei difensori di Dell’Utri, “laddove sono chiaramente percepibili le vocali ‘e’ ed ‘u’, inesistenti nella parola ‘bravissimo’’’.
D’altronde, chiosa la Corte, “appare singolare che su oltre 21 ore di registrazione il consulente non abbia concordato sulle uniche due, brevi frasi nelle quali viene nominato, dal Graviano, Berlusconi’’, tenuto conto, aggiungono i giudici, che il boss di Brancaccio si riferisce a Berlusconi, senza citarlo, anche in occasione della sua visita sull’Etna (29 ottobre 2002) e in Bielorussia (30 novembre 2009, negli stessi giorni in cui era chiamato a testimoniare al processo Dell’Utri).
LA RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICIALI DEL ROS
Avviando il dialogo con i vertici di Cosa Nostra, Mori, Subranni e De Donno agirono con “il dolo specifico di colui che abbia lo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso o che comunque abbia fatto propria tale finalità”.
E difatti “il termine trattativa è stato usato sia da Mori che da De Donno, oltre che dal loro interlocutore Vito Ciancimino sino a quando essi non hanno preso consapevolezza delle conseguenze nefaste di quella loro improvvida iniziativa”.
Secondo la Corte di Palermo, gli ufficiali del Ros stimolarono “il superamento del muro contro muro e quindi l’indicazione, da parte dei vertici mafiosi, delle condizioni per tale superamento”.
In questo modo, si legge nelle motivazioni, “si sono inevitabilmente rappresentati…non soltanto il vantaggio che sarebbe potuto derivare per coloro che si temeva potessero essere vittime della vendetta mafiosa (i politici, ndr), ma altresì il vantaggio che sarebbe in ogni caso derivato per Cosa Nostra nel momento in cui fosse venuta meno la contrapposizione frontale e soprattutto la forte azione repressiva dello Stato”, già culminata con il maxiprocesso e, dopo Capaci, col decreto dell’8 giugno ’92.
BERLUSCONI CONSAPEVOLE: OMBRE SU PALAZZO CHIGI
E se Dell’Utri ha veicolato l’ultima minaccia, quella al governo Berlusconi nato nel ’94, il leader di Forza Italia era perfettamente consapevole del ricatto mafioso almeno sino al dicembre ’94.
A quella data le società di Berlusconi proseguono i versamenti alla mafia, e in quel periodo mentre “faceva da intermediario di Cosa Nostra per i pagamenti, Dell’Utri riferiva a Berlusconi riguardo ai rapporti coi mafiosi ottenendone le necessarie somme di denaro e l’autorizzazione a versarle a Cosa Nostra”.
Proprio nello stesso periodo nel quale incontrava Vittorio Mangano “per le problematiche relative alle iniziative legislative che i mafiosi si attendevano dal governo”.
Lo provano le dichiarazioni del pentito Salvatore Cucuzza, secondo cui Dell’Utri informò Mangano di una modifica legislativa in materia di arresti per gli indagati di mafia. “Ciò dimostra – prosegue la Corte – che Dell’Utri informava Berlusconi dei suoi rapporti con i clan anche dopo l’insediamento del governo da lui presieduto, perché solo Berlusconi, da premier, avrebbe potuto autorizzare un intervento legislativo come quello tentato e riferirne a Dell’Utri per tranquillizzare i suoi interlocutori”.
IL RUOLO DELL’EX MINISTRO MANNINO
La Corte d’assise osserva come l’ex ministro Calogero Mannino, (assolto in primo grado nel processo col rito abbreviato e ora imputato in appello), nel ’92 bersaglio di minacce da parte di Cosa Nostra, si sia rivolto “non a coloro che avrebbero potuto rafforzare le misure della sua sicurezza, ma a ufficiali dell’Arma ‘amici’ e in particolare a Subranni”. I giudici fanno rilevare che quest’ultimo “non aveva competenza per preservare Mannino da attentati”, e che dunque il politico lo contattò con l’obiettivo esclusivo di “attivare un canale che per via info-investigativa potesse acquisire notizie dettagliate sui movimenti di Cosa Nostra”.
Non è dato sapere, prosegue la Corte, “come sia stata recepita da Subranni quella sollecitazione”, ma è un dato di fatto che “dopo Capaci, De Donno, sollecitato dai suoi superiori Subranni e Mori, contatta Ciancimino”, lanciando “un oggettivo invito all’apertura di un possibile dialogo con i vertici di Cosa Nostra e all’accantonamento della strategia mafiosa nell’ambito della quale si collocava l’uccisione di Mannino”.
IL “PAPELLO” E IL RUOLO DI DON VITO
Il fatto che il documento sia stato consegnato da Massimo Ciancimino e che possa identificarsi con il “papello” solo per le dichiarazioni di quest’ultimo, scrive la Corte, “è un ostacolo insormontabile alla conclusione che possa trattarsi del vero papello”.
E, d’altra parte, argomentano i giudici, “se anche fosse il vero papello, ci si troverebbe davanti al frutto avvelenato della scellerata condotta di Massimo Ciancimino che impedisce di utilizzare persino quel nucleo di fatti veri sui quali egli poi ha costruito le sue fantasiose sovrastrutture”. Ma attenzione: la “probabile falsità del documento”, non significa che Ciancimino padre “non sia stato effettivamente destinatario di richieste, eventualmente anche scritte, da parte dei vertici mafiosi quali, almeno in parte, quelle del papello esibito da Massimo e acquisito agli atti”.
La questione cruciale, infatti, “è accertare che Riina, anche solo oralmente, abbia posto condizioni per l’abbandono della strategia mafiosa e che queste condizioni siano giunte al destinatario finale (il governo)”.
Queste condizioni sono qualificabili come minacce? Sì.
Sul punto, conclude la Corte, “è stata raggiunta la prova sulla formulazione e l’inoltro, da parte di Riina, tramite il canale Ciancimino aperto dai carabinieri, di alcune espresse condizioni cui subordinare la cessazione della contrapposizione totale di Cosa Nostra allo Stato”.
LA MANCATA PERQUISIZIONE DEL COVO DI RIINA
Fermo il principio del ne bis in idem, scrivono i giudici, “non vi è preclusione ad analizzare i fatti”, tanto più che la sentenza che nel 2006 mandò assolti Mori e Sergio De Caprio per la mancata perquisizione del covo di via Bernini “era basata su un compendio di prove assolutamente esiguo”.
La condotta degli ufficiali del Ros desta ancora oggi “profonde perplessità”, osserva la Corte, che ricorda come anche i giudici dell’appello Mori-Obinu, nel verdetto del maggio 2016, ebbero a definire “davvero singolare” la scelta di non perquisire l’abitazione del boss dopo la sua cattura nel gennaio del ’93.
La stessa “strategia attendista” evocata dai carabinieri come giustificazione, “avrebbe senso solo nel contesto di un’effettiva sorveglianza del covo”, che invece non ci fu.
La sentenza fa dunque riferimento a “condotte omissive” dirette “a preservare da interferenze la propria interlocuzione coni vertici di Cosa Nostra”.
CIANCIMINO JR. TESTE INATTENDIBILE
In sette righe, infine, i giudici decretano la fine della carriera di collaboratore per Ciancimino jr, che con le sue parole, insieme a quelle di Brusca, aveva consentito l’avvio dell’inchiesta: “Ritiene la Corte che non si possa e debba attribuire alcuna valenza probatoria alle dichiarazioni di Massimo Ciancimino per la sua verificata complessiva inattendibilità che ne impedisce qualsiasi uso, ma senza che, però, da ciò possa e debba farsi derivare una valutazione negativa sulla reale esistenza di fatti e accadimenti sol perché gli stessi siano stati eventualmente inseriti nel più ampio racconto dello stesso Ciancimino”. Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza Fatto Quotidiano del 20/07/2018
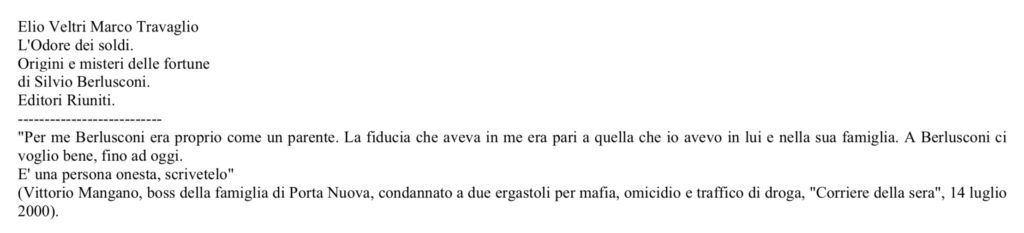
Marco Travaglio L’odore dei soldi
- ‘Ndrangheta Stragista: le motivazioni della sentenza – TEN
- ‘Ndrangheta stragista: le motivazioni della sentenza – CityNow
- ‘Ndrangheta Stragista, le motivazioni della sentenza: “Non …
- ‘Ndrangheta Stragista, le motivazioni: rapporti tra … – Newz.it
- ‘Ndrangheta stragista, i giudici: “Mandanti politici dietro agli …
- ‘Ndrangheta stragista, motivazioni della sentenza “non si …
- ‘Ndrangheta Stragista, le motivazioni: rapporti tra … – GeosNews
- Ndrangheta stragista: sentenza,non esclusi mandanti politici …
- ‘Ndrangheta stragista, «mandanti politici dietro il terrore che …
- Ndrangheta Stragista le Motivazioni della Sentenza Non …
- Berlusconi e la mafia, per Forza Italia è vietato citare le sentenze in tv. Tutti contro Di Matteo che parla di Dell’Utri e i boss: “Mitomane”
- Dell’Utri: “Socialmente pericoloso, decisivo per accordo mafia-Berlusconi”
- Stragi, Silvio Berlusconi indagato anche per il tentato omicidio del pentito Salvatore Contorno (quand’era già stato eletto premier)
- Trattativa Stato mafia, la difesa di Dell’Utri chiede citazione di Berlusconi nel processo d’appello
- Tratta Stato-mafia, i punti che rimangono oscuri: l’ultima intervista di Borsellino, stragi ’93, mandanti a volto coperto
- Trattativa Stato-mafia, l’Appello inizia senza Massimo Ciancimino: “Ha avuto un ictus”. “No, è lucido”. Richiesta perizia
- Trattativa Stato-mafia, Salvatore Borsellino: “Depistaggio? O Dolo o incompetenza dei magistrati”. Scarpinato: “Costituire pool nazionale per trovare verità”
- Trattativa Stato-Mafia, sentenza storica: Mori e Dell’Utri condannati a 12 anni. Di Matteo: “Ex senatore cinghia di trasmissione tra Cosa nostra e Berlusconi”
- Trattativa Stato-Mafia, sentenza storica: Mori e Dell’Utri condannati a 12 anni. Di Matteo: “Ex senatore cinghia di trasmissione tra Cosa nostra e Berlusconi”
- Trattativa, “Berlusconi sapeva dei rapporti tra Dell’Utri e la mafia. E l’ex senatore rafforzò la strategia di Riina”
- Trattativa, accusa contro difesa sul video di Berlusconi che nega pressioni mafiose: “Quest’aula non è uno studio televisivo”
- Trattativa, Berlusconi testimone sceglie di avvalersi della facoltà di non rispondere
- Trattativa, condannati Mori, De Donno, Ciancimino e Dell’Utri, assolto Mancino. La lettura della sentenza
- Trattativa, è il giorno di Berlusconi testimone. Chiamato a salvare l’amico Dell’Utri. Ecco cosa può decidere di fare l’ex premier in aula
- Trattativa, la Falange armata e i servizi segreti deviati. I giudici: “Ravvisabili gli indizi di concorso nelle stragi mafiose”
- Trattativa, su molti giornali il ruolo di Berlusconi scompare dai titoli
- Via d’Amelio, il ministro Bonafede incontra Fiammetta Borsellino: “Ha chiesto atti del Sisde. Vaglieremo la richiesta”
Il tesoro del Cavaliere. La lente dell’Antimafia su 70 miliardi di lire
Intercettazione BERLUSCONI/DELL’UTRI /CONFALONIERI e la “bomba affettuosa”