IL CACCIATORE ispirato alla vita del magistrato Alfonso Sabella

Le vicende di Saverio Barone, un giovane PM che nei primi anni Novanta diventa il protagonista della “caccia” ai mafiosi nella stagione immediatamente successiva alle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Liberamente ispirato alla vera storia del magistrato antimafia Alfonso Sabella.
| Stagione | Episodi | |
|---|---|---|
| Prima stagione | 12 | 2018 |
| Seconda stagione | 8 | 2020 |
| Terza stagione | 8 | 2021 |
Il cacciatore la fiction di Raidue che ha come protagonista Francesco Montanari che interpreta Saverio Barone, magistrato impegnato nella lotta contro la mafia. Dietro la figura di Saverio Barone c’è il magistrato Alfonso Sabella oggi in servizio come giudice del Riesame al Tribunale di Napoli. Il personaggio di Saverio Barone, in particolare, è stato ispirato Il cacciatore di mafiosi, libro di Alfonso Sabella che ha sposato la magistratura non pensando di lavorare nella lotta contro la mafia. Figlio di due avvocati, Sabella si è sempre visto come civilista.
Alfonso Sabella, storia vera Il Cacciatore “Non ho incontrato uomini d’onore…”
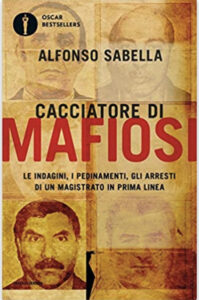
La spietata, difficile realtà della lotta alla mafia raccontata in presa diretta da un protagonista.
Come si riesce a catturare un boss latitante? Come si organizza una caccia alla preda più diffIcile, l’uomo? Alfonso Sabella ha condotto in prima persona alcune delle indagini più importanti del pool antimafia palermitano, culminate nella cattura di boss come Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Pasquale Cuntrera. In questo libro racconta la sua verità quotidiana, fatta di trionfi ma anche di continue difficoltà, di orrori ma anche di inaspettati momenti di ilarità, e soprattutto di competenza, caparbietà e astuzia (oltre a un pizzico di fortuna).
Alfonso Sabella, il cacciatore di mafiosi
- Il 15 gennaio del 1993, in una ancora misteriosa operazione dei reparti speciali, cade dopo un quarto di secolo Totò Riina. Ma la grande caccia è appena cominciata.
- Sabella conosce la mafia, i suoi intrecci familiari e le sue relazioni esterne, le abitudini e le fragilità dei boss. Indaga sui “gruppi di fuoco” di Brancaccio, sui capi di San Giuseppe Jato, sui fedelissimi corleonesi dello “zio Totò”.
- Le indagini sono diventate un libro, Cacciatore di mafiosi, da cui è stata tratta, per la Rai, una fortunata serie tivù.
Giravano tranquilli per Palermo, non li prendevano mai. A volte erano latitanti a casa loro, ricercati e liberi. Intoccabili. Fino a quando, dopo le uccisioni di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, in Sicilia cambia tutto. È lo Stato che, per la prima volta nella sua storia, decide di fare la guerra a Cosa Nostra. Il nuovo procuratore capo della repubblica di Palermo è Gian Carlo Caselli, riorganizza l’ufficio, c’è anche un pool che ha compito di stanare i grandi latitanti di Cosa Nostra. Nel settembre del 1992 i poliziotti hanno già catturato Giuseppe Piddu Madonia, il numero 2 della Cupola che si nascondeva in Veneto.
Il 15 gennaio del 1993, in una ancora misteriosa operazione dei reparti speciali, cade dopo un quarto di secolo Totò Riina. Ma la grande caccia è appena cominciata. A Palermo, uno dei magistrati che coordina le indagini sui latitanti è Alfonso Sabella, sostituto procuratore della repubblica appena arrivato al Palazzo di Giustizia dopo le bombe per Falcone e Borsellino. Conosce la mafia, i suoi intrecci familiari e le sue relazioni esterne, le abitudini e le fragilità dei boss. Indaga sui “gruppi di fuoco” di Brancaccio, sui capi di San Giuseppe Jato, sui fedelissimi corleonesi dello “zio Totò”. Uno dopo l’altro cadono nella rete: Leoluca Bagarella, il cognato di Totò Riina; Nino Mangano e Pasquale Di Filippo, Giovanni Brusca “’u verru” e suo fratello Enzo e tanti altri ancora. Sono tutti i rappresentanti dell’anima stragista di Cosa Nostra, quelli che con le stragi volevano costringere lo Stato a trattare. Dopo anni e, in qualche caso decenni, i latitanti finiscono tutti nei bracci infernali del 41 bis.
Dietro ogni inchiesta e dietro ogni cattura, c’è una meticolosa conoscenza del territorio, dei comportamenti criminali, dei linguaggi e dei simboli. Poi la tecnologia, le intercettazioni, le miscrospie. E i pedinamenti, in mezzo al traffico di Palermo o nelle sperdute campagne nel cuore della Sicilia. Indagini che sono diventate un libro per la Mondadori, Cacciatore di mafiosi, firmato da Alfonso Sabella insieme ai giornalisti Silvia Resta e Francesco Vitale. E dal libro è stata tratta, per la Rai, una fortunata serie tivù. Il nostro Blog Mafie, per una trentina di giorni, pubblicherà ampi stralci del racconto di uno dei protagonisti dell’antimafia giudiziaria degli Anni ‘
ALCUNI CAPITOLI…
- Il “signor Franco” era lui, il pericolosissimo Leoluca Bagarella
- Bagarella, l’anima stragista di cosa nostra
- Sul comodino il boss aveva il libro di Giovanni Falcone
- Il covo
- Cose di Cosa Nostra, il libro del giudice
- Il sequestro del bambino, i silenzi, le faide fra i grandi boss
- Trasferito più volte tra Agrigento, Trapani e Palermo
- Un negozio, un paio di jeans, le tracce che portano al boss di Corleone
- La collaborazione di Di Filippo
- La caccia ai “piccioli” della mafia che arrivano fino agli amici di Lugano
- Si cerca il tesoro
- I soldi restano in Svizzera
- Madonne e santi e crocifissi nella camera della morte
Il “signor Franco” era lui, il pericolosissimo Leoluca Bagarella
Leoluca Bagarella era stato in galera da giovane, nel 1979, dopo aver ucciso il capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano. E’ stata la sua prima missione importante come killer, portata a termine con freddezza e vigliaccheria, colpendo alle spalle Giuliano. Poi era uscito per scadenza dei termini di custodia cautelare. E così la sua fama di mafioso era salita alle stelle. Latitante dal ’91, era uno dei ricercati più pericolosi
È un pomeriggio di fine giugno. È sabato e a Palermo fa caldo. Soffia il primo scirocco della stagione. Si suda stando fermi e quei maledetti condizionatori del palazzo di Giustizia funzionano a sprazzi.
Chi non è andato al mare cerca refrigerio in una «bella» granita di limone. Anch’io, per allentare la tensione, porto i ragazzi della scorta a prendere un gelato nel bar di fronte al tribunale. È una giornata calda in tutti i sensi. Se tutto va come deve andare…
Corso Tukory, strada affollatissima tra l’università e la Stazione centrale, a un passo da palazzo dei Normanni, è uno dei cuori pulsanti della Palermo popolare. Una lunga fila di magazzini, botteghe e gastronomie a basso costo.
Da un negozio di abbigliamento esce un uomo di mezza età, ray-ban a goccia e baffi neri. Stringe in mano una busta. Deve aver fatto acquisti. È solo. Si guarda attorno con circospezione: marciapiede di destra e di sinistra. Un colpo d’occhio. Lentamente, con il suo sacchetto in mano, si avvicina a una macchina, un’anonima Opel Swing celestina. Sale, si guarda ancora attorno, poi mette in moto e cerca di infilarsi nel traffico.
Percorre pochi metri quando due auto altrettanto anonime, senza scritte né lampeggianti, lo affiancano. Con una manovra discreta ma sincronizzata, lo stringono a tenaglia. Lo bloccano. L’uomo coi baffi capisce di essere in trappola. Per un attimo ha paura, pensa al peggio. Pensa che a bordo di quelle due auto possano esserci dei killer mandati da chissà chi pronti a scaricargli addosso una pioggia di fuoco. Pensa che sia giunta la sua ora.
Invece è arrivato lo Stato. La sua corsa finisce lì. Due agenti in borghese lo prendono in consegna. Qualcuno si occupa di prelevare l’Opel e di portarla via. Sulla strada c’è un gran viavai di persone, ma nessuno si accorge di nulla. L’uomo prova a fare l’ultima mossa disperata, ma sa già che è inutile. Tira fuori da una tasca una carta d’identità contraffatta e dichiara: «Deve esserci un errore, sono Franco Amato, impiegato postale». Ma gli agenti della Dia di Palermo, nonostante i baffi, lo hanno riconosciuto. Hanno riconosciuto il suo sguardo tagliente. Per mesi hanno studiato la sua foto segnaletica, ai primi posti della top ten dei ricercati del ministero dell’Interno. Per tre giorni hanno tenuto sotto osservazione quel dannato negozio, con la speranza che prima o poi si facesse vivo, e quel momento è arrivato.
Lo portano via. A bordo dell’utilitaria, nel tragitto da corso Tukory alle Tre torri, sede della Dia, finalmente si rilassa. Ammette la sua identità e si complimenta con gli agenti che lo hanno preso.
Forse in cuor suo tira un sospiro di sollievo. Meglio finire in prigione che accoppato in mezzo alla strada per mano di qualche boss emergente. In Sicilia si dice megghiu séntiri scrusciu di catini ca sonu di campani, meglio udire il rumore delle catene che il suono delle campane; a morto ovviamente.
Lo abbiamo catturato così, Leoluca Bagarella, uno dei più spietati capi di Cosa nostra, uno dei più pericolosi latitanti di mafia. Un «padrino». Lo abbiamo arrestato come «signor Franco», questo era il suo ultimo nome di battaglia, in pieno giorno, in mezzo a una strada del centro di Palermo.
È il 24 giugno 1995. Giornata indimenticabile. Notizia da edizione straordinaria dei telegiornali. Per noi della procura di Palermo quel che si dice un «colpo grosso». Per me, che insieme ad altri tre colleghi avevo costruito l’indagine passo dopo passo, centimetro per centimetro, un grandissimo risultato: la cattura del boss, all’anagrafe Leoluca Biagio Bagarella, classe 1946, corleonese doc, mafioso da sette generazioni, cognato di Salvatore Riina, era un colpo al cuore dell’organizzazione mafiosa. Forse il ko decisivo per quell’ala stragista che negli anni Novanta aveva portato nel Paese tanta devastazione e tanti lutti.
Bagarella, l’anima stragista di cosa nostra
In quel periodo, infatti, Bagarella era il vero capo di Cosa nostra. Dopo l’arresto di Totò Riina, più di due anni prima, tutta la forza militare dell’organizzazione era passata nelle sue mani. Sostanzialmente erano al suo comando i gruppi di fuoco delle famiglie più importanti. Poteva contare sui killer di Brancaccio, su quelli della cosca di Misilmeri, sui sicari del quartiere palermitano di Resuttana, su tutti quelli della provincia di Trapani. Così aveva il polso dell’intera organizzazione e, di fatto, il comando vero. Era quantomeno sullo stesso piano di Bernardo Provenzano che, pur essendo il capo formale di Cosa nostra, non aveva però alcun esercito. E poi Bagarella incarnava il vero spirito dei corleonesi che per noi non erano più, semplicemente, i mafiosi di Corleone. I corleonesi rappresentavano adesso l’anima stragista di Cosa nostra, quegli uomini che, sotto la guida di Riina prima e di Bagarella poi, avevano sferrato un attacco frontale allo Stato con le bombe del 1992 e 1993. Paradossalmente Bernardo Provenzano, che pure era di Corleone, per noi non era un vero «corleonese», o, meglio, non si poteva più considerarlo tale. Dopo l’attentato di Capaci e forse già prima della strage di via d’Amelio, aveva imboccato un’altra strada: aveva scelto una tattica «attendista», aveva deciso di sommergersi, quasi di sparire. ‘U zu Binu aveva ritenuto vincente per Cosa nostra una linea di basso profilo, aveva stabilito di non combattere più le istituzioni ma di convivere con lo Stato, forse anche di trattare con alcuni suoi rappresentanti, garantendo una sorta di pax mafiosa. Tanto che, tramite Brusca, si era addirittura lamentato con Bagarella per l’esecuzione degli attentati di Firenze, Roma e Milano del 1993. E il cognato di Riina, in modo sprezzante, gli aveva mandato a dire: «Se vossia non è d’accordo, se ne vada in giro con un bel cartello al collo con la scritta: io con le stragi non c’entro». ‘U zu Binu, a quel tempo, aveva dovuto incassare: non poteva certo competere con la potenza militare degli «altri» corleonesi. Don Luchino, così ancora oggi gli amici chiamano Leoluca Bagarella, aveva al suo attivo decine e decine di omicidi. Le inchieste, ma soprattutto i racconti dei collaboratori di giustizia, ce lo descrivevano come un duro, un sanguinario. Nelle inchieste sulle stragi era uno dei principali indagati. Di sicuro aveva preso parte a quella di Capaci ed era stato il capo operativo degli attentati del 1993. Il regista e il coordinatore, insomma, delle bombe di Firenze, Roma e Milano. Forse non la vera testa pensante, ma certamente uno dei fautori della strategia di attacco frontale allo Stato. Bagarella era già stato in galera da giovane, nel 1979, dopo aver ucciso il capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, la sua prima missione importante quale killer. E l’aveva portata a termine con estrema freddezza ma anche con grandissima vigliaccheria, colpendo alle spalle quel poliziotto che per primo aveva intuito e dimostrato la connection tra mafia americana e siciliana nel grande traffico di eroina. Giuliano aveva sequestrato all’aeroporto di Punta Raisi una valigia piena di dollari. La contropartita pagata dalle famiglie americane a quelle siciliane per la raffinazione di centinaia di chili di «roba». Omicidio «eccellente» e fondamentale per Cosa nostra. Leoluca Bagarella finì in galera per alcuni anni, poi, puntuale, la scarcerazione a causa della solita scadenza dei termini di custodia cautelare. E così la sua fama di mafioso era salita alle stelle. Latitante dal ’91, per noi del pool antimafia della procura di Palermo, era uno degli obiettivi più importanti. L’indagine che ha portato alla sua cattura è scattata, di fatto, all’improvviso, meno di un mese prima dell’arresto. Tutto sommato è stata un’investigazione rapidissima, ma anche particolarmente complessa e delicata. Con qualche colpo di fortuna, siamo riusciti a chiudere il cerchio in poco più di tre settimane. Un tempo record, tenuto conto dello spessore del latitante.
Forse, con il senno di poi, avremmo potuto anche stringere i tempi, ma tatticamente abbiamo voluto usare tutta la prudenza necessaria. Un personaggio particolare, Bagarella: astuto, attentissimo e altrettanto sospettoso. Ossessionato dai pedinamenti, dalle intercettazioni telefoniche e da quelle ambientali. Dopo l’arresto di Riina, la sua prudenza era aumentata. Si era procurato un apparecchio radio che manteneva costantemente sintonizzato sulle frequenze di polizia e carabinieri. Nel suo rifugio segreto stava in ascolto tutto il giorno ed era diventato paranoico. Ogniqualvolta c’era un allarme, un intervento in città per una vicenda qualsiasi, entrava in fibrillazione, pensava sempre che stessero per arrivare a lui.
Racconta un collaboratore di giustizia che un giorno, esasperato, aveva scagliato quella radio contro il muro, mandandola in frantumi: «Quando minchia mi vogliono pigliare, mi pigliano!».
E poi, in fondo, si sentiva sicuro. Palermo, per questo, è una città particolare. Può accadere a chiunque di essere vicini di casa di un boss e non saperlo, non riuscire ad accorgersi di nulla. Del resto quasi mai dei mafiosi si conosce il volto attuale. Le uniche indicazioni spesso vengono da vecchie e sbiadite foto segnaletiche.
Si racconta, ma è una storia vera, di un giornalista che per diversi mesi era stato vicino di pianerottolo di uno dei più spietati killer di Cosa nostra, Giuseppe Lucchese, detto ‘U lucchisieddu, responsabile di un centinaio di omicidi e delle cui famigerate «gesta» il cronista scriveva di frequente. Non lo sapeva, ma ci abitava di fronte. Lo vedeva uscire con la motocicletta, conosceva anche la moglie: una distinta e riservata signora con un grazioso cagnolino. Non aveva mai sospettato nulla. Nessuno d’altronde sarebbe stato in grado di riconoscere ‘U lucchisieddu.
Il miglior modo di mimetizzarsi per i mafiosi, infatti, è sempre stato quello di vivere un’esistenza normale. E Bagarella aveva scelto un profilo assolutamente anonimo, quello del «signor Franco», appunto, impiegato delle poste, inquilino modello. Viveva in un appartamento come tanti nel centro di Palermo, proprio di fronte al palazzo dove abitano due tra i magistrati più impegnati sul fronte antimafia, Guido Lo Forte, procuratore aggiunto di Palermo e coordinatore della Direzione distrettuale antimafia, e Giuseppe Pignatone, all’epoca sostituto della stessa procura e, guarda caso, proprio titolare delle ricerche di Bagarella, insieme a Franco Lo Voi.
Forse per questa ragione il boss era tranquillo. Spesso, con un binocolo, dalla finestra del suo rifugio, si divertiva a osservare gli spostamenti di Guido e di Giuseppe e delle loro auto di scorta. Se la rideva don Luchino. Ma questa vicinanza costituirà anche il suo tallone d’Achille.
Sul comodino il boss aveva il libro di Giovanni Falcone
L’inchiesta sulla latitanza di Giovanni Brusca si trascinava ormai da quattro anni. Un nuovo impulso alle indagini viene da Tullio Cannella, l’imprenditore edile dell’Euromare Village, il fondatore di Sicilia Libera. Cannella è legato da vecchia amicizia a Tony Calvaruso, l’autista di don Luchino, anche lui finito in carcere. In prigione Tullio si pente; Tony invece, sulle prime, non cede. A fine anno, durante una drammatica udienza di un processo, nell’aula bunker di Rebibbia a Roma, Cannella rivolge un pubblico appello al suo ex amico, invitandolo a fare come lui, a collaborare con la giustizia. Fino ad allora rimasto duro come una roccia, Calvaruso rompe gli indugi, «si mette a Modello tredici» e ci chiama. È il 5 gennaio del nuovo anno. La vigilia della Befana. Per noi, l’autista di Bagarella che collabora è davvero un bel regalo.
Tony Calvaruso ha vissuto per ben due anni fianco a fianco con Leoluca Bagarella e del capo corleonese conosce vizi, abitudini e segreti. Lo ha scarrozzato in macchina qua e là e ha una straordinaria memoria fotografica: ricorda con precisione volti e luoghi. Soprattutto luoghi, covi, tane e rifugi. La sua testimonianza è preziosissima.
Nel parlatorio del carcere Tony esordisce: «Vi posso dare un’informazione utile: so dove Giovanni Brusca si è fabbricato la casa».
Per noi, in quel momento, Brusca rappresenta l’icona del male. Il suo nome è ai primi posti della lista dei latitanti. Insomma, è l’obiettivo numero uno. Si era reso irreperibile quando era stato definitivamente condannato nel maxi processo. «Si era dato latino», come dice il popolo di mafia. È figlio di don Bernardo, vecchio patriarca di San Giuseppe Jato, da sempre legatissimo a Totò Riina.
«Un ragazzo molto sveglio, uno che farà tanta strada» aveva detto di lui, profetico, Tommaso Buscetta, molti anni prima.
I coordinatori delle indagini sulla latitanza di Brusca sono Giuseppe Pignatone e Franco Lo Voi; io entro a far parte del pool alla fine del 1995.
Nei primi giorni del nuovo anno c’è questa bella sorpresa: Calvaruso, factotum di Bagarella, decide di collaborare e ci offre su un piatto d’argento proprio l’indirizzo di Giovanni Brusca. «Una costruzione a fondo Patellaro» dice «località Borgo Molara.»
Lo stesso giorno otteniamo dal ministero l’autorizzazione per far uscire provvisoriamente dal carcere Tony Calvaruso, per condurlo sul posto e farci da guida. La sua collaborazione deve assolutamente rimanere segreta. Ma come sempre in questi casi, sorge l’immancabile problema. Calvaruso divide la cella con altri due mafiosi di «rango». Non devono assolutamente accorgersi della sua improvvisa assenza. Potrebbero mangiare la foglia e far trapelare la notizia. Bisogna escogitare qualcosa. Ci inventiamo un ordine di trasferimento per i compagni di cella: li mettiamo in traduzione per un interrogatorio «qualsiasi» a San Vittore. Trasferiamo i due mafiosi a Milano e Calvaruso a Palermo. Così svuotiamo l’intera cella e il suo spostamento passa inosservato. Andiamo dritti a Borgo Molara: l’ex autista di Bagarella ci accompagna sul posto e ci indica la casa di Brusca. Poi torna in carcere. Ovviamente in un carcere per collaboratori. Giri per le campagne, curve, strade polverose. Posti inaccessibili e posti qualunque. I luoghi di mafia sono quasi sempre normali, assolutamente anonimi. Anche fondo Patellaro, a Borgo Molara, è un posto come tanti: un classico baglio siciliano con il gruppo di case intorno, circondato da mura di pietra e calce. Da generazioni è di proprietà della famiglia Patellaro che ci abita al gran completo. In mezzo a queste costruzioni, per lo più modeste, ce n’è una un po’ meno modesta delle altre. Una palazzina di lusso, perfettamente rifinita. Davanti c’è un bellissimo giardino con piante esotiche e irrigazione automatica.
Il covo
«Quella è la casa di Brusca» ci dice Calvaruso. Il collaboratore ricorda con precisione ma le sue conoscenze sono inevitabilmente datate, vecchie di almeno sette mesi, da quando è finito in carcere.
C’è però pur sempre una probabilità che il killer di Falcone si nasconda ancora lì. Che fare? Fare irruzione, giocarsi il tutto per tutto? Oppure, più prudentemente, aspettare? Decidiamo di non intervenire subito.
Non possiamo permetterci di rischiare, di fare un buco nell’acqua. Probabilmente, col senno di poi, facciamo un errore, errore che mi porto ancora dentro, con grande amarezza. Forse, al momento di quel sopralluogo, il 7 gennaio, Brusca è proprio lì dentro. E quelle sono proprio le ore decisive per la sorte del piccolo Giuseppe Di Matteo, che verrà ucciso quattro giorni dopo, nella notte tra l’11 e il 12. Se fossimo intervenuti subito a Borgo Molara, avremmo potuto arrestare il boss latitante e, forse, salvare la vita a quel ragazzino. Da qui il mio tormento.
In attesa di accertare l’eventuale presenza di Brusca nella villetta, facciamo quattro, cinque giorni di appostamento. Un controllo discreto intorno a quel gruppo di case. A operare, in gran segreto, sono il Servizio centrale operativo della polizia di Stato e la Direzione investigativa antimafia di Palermo e Roma. Intorno alla casa, fuori e dentro, nessun movimento sospetto, a parte un malaugurato elicottero dell’Arma che l’8 gennaio comincia a girare a bassa quota su quella zona. Si sofferma proprio su fondo Patellaro, come un fastidioso moscone che ronza, con la sua elica che solleva terra e polvere. Sapremo in seguito che i carabinieri, ignari della nostra operazione, notando un certo movimento, erano venuti a dare un’occhiata.
Una coincidenza malaugurata perché, proprio a causa dell’elicottero, Rosaria Cristiano, la compagna di Brusca che – come sapremo dopo – è nella casa insieme al figlio Davide di cinque anni, se ne va. Noi non l’abbiamo mai vista uscire, la signora. Ma, una volta pentito, Brusca ci racconterà che, quel giorno, la sua donna era là: «Mia moglie, mentre era in terrazza, si vide spuntare l’elicottero proprio in faccia. E decise di andarsene». Questo ha detto, non una parola di più. La donna ha fatto le valigie e ha abbandonato la casa. Ancora oggi non sappiamo in che modo.
Solo in un secondo momento scopriremo, fra le tante sorprese di quella palazzina, anche un tunnel sotterraneo. Non ancora perfettamente ultimato, ma geniale! Una galleria scavata in profondità. Un enorme tubo d’acciaio interrato, un passaggio segreto che dall’appartamento porta a un fiumiciattolo lì vicino: sbuca proprio sul greto di un torrente, in una zona di vegetazione selvaggia. Probabilmente è stata usata questa via di fuga. Non lo sappiamo, come non sappiamo se anche Giovanni Brusca fosse in casa quando è passato l’elicottero. Lui, in verità, lo nega.
Senza volerlo, i carabinieri hanno determinato la fuga della sua compagna, sotto gli occhi della polizia. Paradossi pirandelliani: siamo pur sempre in Sicilia.
Cose di Cosa Nostra, il libro del giudice
All’alba della domenica successiva, 12 gennaio, decidiamo di fare irruzione. La casa è vuota. Dentro è deserto. Non c’è anima viva. Ma ci sono tracce, segni evidenti di una presenza recente, recentissima.
Troviamo un quotidiano, il «Giornale di Sicilia» del 7 gennaio. Prova del fatto che, quando iniziano i nostri appostamenti, qualcuno in casa c’è. In un cassetto recuperiamo il passaporto della signora Cristiano e alcune recenti fotografie di Davide. Sono le prime immagini del figlio di Brusca di cui entriamo in possesso.
I segni che troviamo raccontano di una fuga precipitosa. Di sicuro anche il capofamiglia ha frequentato quel «covo». Già, il covo! In gergo si chiama così e chissà cosa si pensa. Questa di Brusca, per esempio, è una casa con tutti i comfort.
Una palazzina a tre piani, rifinita in ogni particolare, molto elegante. Decisamente di lusso. Almeno secondo i «loro» gusti. Forse un po’ kitsch: pregiati graniti, rubinetti dorati, sale da bagno con ampie vasche idromassaggio. E aria condizionata, tappeti persiani, frigoriferi con riserve di viveri sufficienti per mesi.
Mi colpiscono le tre stanze armadio. Una per ogni componente della famiglia. Non il classico armadio quattro stagioni, ma tre grandi stanze guardaroba: c’è quella per i vestiti della signora, tutta specchi e abiti firmati. Tailleur di Moschino, pantaloni di Armani, bluse di Coveri.
C’è quella per il figlio Davide e un’altra tutta per Giovanni Brusca e i suoi abiti. Soprattutto le sue camicie. Ne troviamo tantissime, centinaia. Un’intera parete di camicie. Tutte in fila, stirate e inamidate, appese alle stampelle. Sono ordinate secondo il colore: rosa, gialle, azzurre, color menta e color salmone. Un arcobaleno di camicie. A righe, a quadri… Alcune con i polsini per i gemelli. E poi una sfilza di camicie bianche, di seta, di lino, le famose Brooks Brothers venute dall’America.
Scopriamo così, per la prima volta, questo lato vanitoso del boss, questa sua insospettabile eleganza, ricercata e quasi maniacale.
Brusca non c’è, ma ci sono i suoi vestiti. Le pantofole, il pigiama, la schiuma da barba. Insomma tra quelle mura c’è ancora il suo odore. Ci sono le sue tracce. Tracce fresche di un pericoloso capomafia in fuga. Ma non ci sono bigliettini, né documenti, né appunti. Un libro ci incuriosisce: Cose di Cosa nostra, la famosa intervista della giornalista francese Marcelle Padovani a Giovanni Falcone. È in camera da letto, sul comodino. Forse gli è stato regalato da qualche amico per Natale. E magari, mentre noi lo cercavamo, il boss stava leggendo proprio i pensieri della sua vittima «eccellente».
Dopo l’irruzione, Giuseppe Patellaro, il proprietario del fondo che ospita il covo, viene portato via in manette. All’apparenza è un tranquillo signore di mezza età. È il fratello di un noto ciclista siciliano, un campione degli anni Ottanta, Benedetto, che sulle due ruote ha costruito la sua fortuna. Ma la ruota della fortuna gira. E stavolta, per la famiglia Patellaro, gira male. L’accusa di favoreggiamento regge e l’uomo si farà qualche anno di carcere.
In seguito lo stesso Brusca parlerà in dettaglio della sua latitanza, ma sul periodo di Borgo Molara rimarrà sempre molto reticente. Se anche lui fosse lì nei giorni del nostro appostamento; in che modo fosse fuggita la moglie; chi avesse costruito il tunnel sotterraneo… Tutto questo ancora oggi resta un giallo, un mistero. Uno dei tanti.
Quel che è certo è che tra le mura di quel covo avviene il mio primo incontro ravvicinato con l’assassino di Falcone.
Il sequestro del bambino, i silenzi, le faide fra i grandi boss
La collaborazione dei Di Matteo, Santino compreso, è praticamente nulla. Si viene solo genericamente a conoscenza di qualche altro biglietto e messaggio dei rapitori, ma sempre per sommi capi e sempre a distanza di giorni dalla consegna.
Il destinatario dei messaggi è solo il nonno del ragazzino, Giuseppe Di Matteo senior chiamato Piddu, anche lui uomo d’onore di Altofonte. L’emissario di Brusca è un altro soldato della stessa famiglia, un certo Pietro Romeo, solo omonimo del rapinatore di Brancaccio.
Romeo è il personaggio giusto per mantenere i contatti. È un uomo d’onore, è legato a Giovanni Brusca ed è sufficientemente amico di Santino Di Matteo che, infatti, lo aveva «scansato» dalle sue dichiarazioni accusatorie e non lo aveva indicato tra i mafiosi di Altofonte; soprattutto Santino mezzanasca non aveva raccontato che proprio a casa di Romeo era stato occultato l’esplosivo utilizzato a Capaci la sera prima che lo collocassero sotto l’autostrada.
Nessuno dei Di Matteo ci ha mai parlato di Romeo, di cui apprenderemo l’esistenza solo a fine 1996, dopo la collaborazione di Brusca. Non faremo nemmeno in tempo ad arrestarlo perché, mentre stiamo raccogliendo i necessari riscontri, Romeo scompare misteriosamente, vittima di lupara bianca. Il periodo è proprio quello in cui, come accerteremo solo nel settembre del 1997, Santino Di Matteo, insieme a Di Maggio e La Barbera, è tornato in Sicilia a commettere delitti. Inutile dire che ho sempre sospettato di lui come responsabile della scomparsa di Romeo, ma, a quel punto, all’inizio del 1998, non seguo più le indagini sul mandamento di San Giuseppe Jato.
Senza nemmeno un nome su cui lavorare, le ricerche di Dia, polizia e carabinieri non portano a risultati concreti e del resto, anche se avessimo ottenuto l’arresto dei fratelli Vitale, ben poco avremmo potuto fare per individuare la prigione del piccolo Giuseppe.
I suoi familiari, peraltro, fin dall’inizio scelgono decisamente la via mafiosa e, persino cinque anni dopo, nel corso del processo in cui si costituiranno parte civile, manterranno un atteggiamento omertoso e reticente. Un comportamento così fastidioso da indurre spesso me e il mio collega e amico Peppe Salvo, che mi stava dando una mano nella gestione di quel dibattimento, a non porre loro domande e a pensare, addirittura, di chiedere la trasmissione degli atti per procedere nei loro confronti per falsa testimonianza e favoreggiamento. A vantaggio degli assassini del loro figlio o nipote.
Il nonno del ragazzino riesce a contattare, tramite Benedetto Spera, capomandamento latitante di Belmonte Mezzagno, lo stesso Bernardo Provenzano chiedendogli di intercedere presso Bagarella e Brusca per ottenere il rilascio di Giuseppe: la richiesta del vecchio capomafia di Corleone, ovviamente, cade nel vuoto.
Dal canto suo Santino Di Matteo la bocca «se l’è tappata». Per alcuni mesi si rifiuta di rendere interrogatori e di partecipare ai processi. All’improvviso, addirittura, sparisce misteriosamente dalla località segreta dov’era sotto protezione allo scopo di provare a rintracciare il ragazzino. Ma è tutto inutile, Giuseppe, come era prevedibile, malgrado il «silenzio» del padre non viene rilasciato.
Santino, però, è più tranquillo e torna persino a deporre nelle aule di giustizia. Ha capito che il figlio è in mano a Giovanni Brusca e conta sul fatto che il boss di San Giuseppe Jato, che conosce bene il bambino, non avrà il coraggio di torcergli un capello. Ma purtroppo si sbaglia.
Trasferito più volte tra Agrigento, Trapani e Palermo
Dopo la lunga parentesi agrigentina il piccolo Di Matteo, alla fine del periodo estivo del 1994, viene riconsegnato dal dottore di Canicattì a Brusca che adesso ha un luogo dove tenere prigioniero Giuseppe.
Lo scambio avviene sempre allo svincolo di Ponte Cinque Archi e sempre tra uomini con il passamontagna. Il ragazzino è nel cofano di una station wagon, legato e incappucciato, come al solito. Insieme a Brusca stavolta, c’è Giuseppe Monticciolo che, da quel momento in poi, si occuperà della gestione dell’ostaggio.
Giuseppe Di Matteo viene condotto in una masseria nelle campagne di Gangi, un suggestivo borgo madonita a più di mille metri sul livello del mare, e, per qualche ora, assicurato a un anello di ferro infisso nel muro.
La masseria è di Cataldo Franco, un uomo d’onore del posto, che, da qualche anno, l’ha adibita a deposito di olive. In quella specie di palmento Monticciolo aveva già fatto realizzare un bagno e una doccia e aveva fatto murare nel pavimento i piedi di una vecchia branda. Giuseppe resta nelle Madonie per qualche mese, fino a ottobre quando ‘U zu Cataldu, giustamente, ha necessità del locale perché deve cominciare la raccolta delle olive.
Brusca è ancora una volta in difficoltà. Si lamenta di essere stato lasciato solo a gestire il sequestro. Non ha tutti i torti e Matteo Messina Denaro lo autorizza a rivolgersi agli uomini d’onore del Trapanese, il suo territorio.
Da Gangi, Giuseppe viene così portato in una villetta a Castellammare del Golfo e rinchiuso in un bagno dove c’è appena lo spazio per appoggiare a terra un materasso. Nella porta gli uomini d’onore hanno realizzato uno sportellino in basso. Come una gattaiola. E da lì gli passano il cibo.
Tra i carcerieri che si alternano in quel periodo ci sono un paio di latitanti che avevano frequentato la casa dei Di Matteo. Temono che Giuseppe possa riconoscere le loro voci e per questo non gli parlano mai e comunicano con il piccolo ostaggio solo per mezzo di bigliettini scritti. Anche questi passati dalla gattaiola. Peppe Ferro, capofamiglia di Castellammare, viene però a conoscenza del fatto che Giuseppe è nella sua zona e va su tutte le furie. Non ne vuole sapere niente di quella storia: il ragazzino va portato via di là.
Sono molti in Cosa nostra a non approvare quell’operazione. Lo stesso Cataldo Franco si era messo a disposizione di Brusca solo a titolo personale e non aveva nemmeno avvisato, violando le regole dell’associazione mafiosa, Mico Farinella, reggente del suo mandamento: il padre Peppino sicuramente non sarebbe stato d’accordo.
Monticciolo è costretto allora a portar via l’ostaggio da Castellammare. Alla vigilia di Natale del 1994, Giuseppe, come un pacco postale, viene «appoggiato», per pochi giorni, nella casa di contrada Giambascio, a San Giuseppe Jato, dove non è stato ancora costruito il bunker sotterraneo. Dopo le feste il ragazzino viene trasferito ancora. Sempre legato e incappucciato. Sempre trasportato nel cofano di una macchina. Peggio di un cane.
Fino a Pasqua del 1995 il figlio di Mezzanasca viene tenuto nel magazzino di un limoneto, a Campobello di Mazara. Un locale zeppo di casse, con una stanzetta e un séparé dove è stata ricavata una sorta di latrina.
In zona c’è un certo movimento di sbirri. E allora un’altra corda, un altro cappuccio, un altro cofano di macchina, un altro calvario. Fino a Custonaci, alle pendici di monte Erice, in una contrada denominata Purgatorio. Ma che peccati aveva da espiare il piccolo Giuseppe?
Lo spostano sempre durante le feste, quando i posti di blocco sono più rari. L’ennesimo trasferimento del ragazzino avviene il 14 agosto, alla vigilia dell’Assunta. È il suo ultimo viaggio. Giuseppe viene riportato a Giambascio dove, ormai, i solerti uomini di Giovanni Brusca hanno finito di realizzare il bunker sotterraneo con l’ascensore, la piattaforma «magica».
Il ragazzino è ormai una sorta di larva umana. Ha perso peso e forze. Non ha mai più visto la luce del sole. Non ha più respirato all’aria aperta. Nemmeno per un istante. Non oppone più alcuna resistenza. Da mesi si lascia trasportare da un posto all’altro. Si lascia legare e slegare i polsi. Si lascia incappucciare e agganciare alla catena.
Un negozio, un paio di jeans, le tracce che portano al boss di Corleone
La nostra ricerca di Bagarella riparte così da Tony e dalla sua bottega in corso Tukory. La individuiamo: è un negozio di abbigliamento come tanti, un’insegna senza pretese, vestiti da uomo, genere casual. Calvaruso va lì tutti i giorni, gestisce il negozio, vive alla luce del sole. Cominciamo a controllarlo, lo seguiamo con circospezione, cerchiamo di non perderlo di vista: diventa il nostro uomo.
Ci accorgiamo che entra spesso in un portone di via Passaggio Mp1, una traversa di via Malaspina, giusto di fronte al palazzo dove abitano Lo Forte e Pignatone.
È una zona estremamente sorvegliata dalle forze dell’ordine. Siamo negli anni dell’operazione denominata «Vespri siciliani». Per far fronte all’emergenza criminale lo Stato, in quei mesi terribili, ha mobilitato l’esercito. I militari sono «scesi» in Sicilia a presidiare i cosiddetti obiettivi sensibili e alcune camionette sono state piazzate anche davanti alle abitazioni dei magistrati impegnati in prima linea.
È così che scatta l’idea: in via Malaspina ci sono le jeep dell’esercito che presidiano le abitazioni dei due colleghi. Decidiamo di sostituire due soldati con altrettanti investigatori della Dia. In questo modo, notte e giorno, teniamo sotto controllo senza dare nell’occhio il palazzo dove è stato visto entrare Calvaruso: civico 9 di via Passaggio Mp1. Sospettiamo che il covo di Bagarella sia proprio lì, ma non ne abbiamo la certezza matematica.
Nelle operazioni di cattura dei latitanti ogni minimo errore può causarne il fallimento. E in questo caso abbiamo un problema in più, grosso come una casa: riuscire a tenere segreta la collaborazione di Pasquale Di Filippo, fino a operazione conclusa.
Nessuno deve sospettare nulla. C’è in gioco la riuscita dell’indagine e la stessa sicurezza del collaboratore.
Bisogna trovare una soluzione che salvi capra e cavoli. Tecnicamente non posso revocare il decreto di fermo che gli ho fatto notificare, per cui c’è una sola cosa da fare: portare Pasquale Di Filippo, che si trova ancora nei locali della Dia, al carcere dell’Ucciardone, insieme agli altri boss detenuti. Come se nulla fosse.
Gli chiediamo, per qualche giorno, di fare il doppio gioco, e Pasquale accetta. Seppur tra mille timori che sono, peraltro, anche i nostri.
La domanda è una sola: ce la farà a non tradirsi, a fingere, a reggere la pressione? D’altra parte non abbiamo alternative. Se dovesse trapelare la notizia della sua collaborazione, Bagarella cambierebbe tutti i suoi luoghi, i suoi contatti, i suoi riferimenti. E non lo prenderemmo mai.
La collaborazione di Di Filippo
Per Pasquale Di Filippo cominciano forse i quattro giorni più difficili della sua vita. Sta in cella in un reparto di alta sicurezza, come si addice ai mafiosi, con tanti uomini d’onore che non lo perdono mai di vista. Ne conoscono il lato debole, sanno che è abituato alla bella vita, che non è fatto per il carcere. Gli rivolgono mille domande sul cognato, Nino Marchese, e, soprattutto, sul suocero, Masino Spadaro, che è detenuto a Pianosa e che, per i mafiosi, è una sorta di garante del giovanotto. Un inferno, insomma, per il povero Pasquale, che a un certo punto teme di non farcela.
Anche attraverso le segnalazioni della direttrice del carcere, Armida Miserere, capiamo che il ragazzo è allo stremo. Armida, morta suicida alcuni anni dopo, era una donna straordinaria e ci fu di grandissimo aiuto in diverse circostanze. La ricordo con grande affetto e tenerezza.
Pasquale non ce la fa più a reggere quella finzione. Ma l’investigazione su Bagarella non è ancora conclusa. E per chiudere il cerchio ci manca qualche particolare importante. Tra l’altro dobbiamo assolutamente sapere se il negozio di Calvaruso nasconda un’uscita secondaria, una possibile via di fuga, magari nel retrobottega. Dobbiamo cautelarci al massimo, evitare ogni sorpresa.
Accertamenti sul luogo, ovviamente, non ne possiamo fare. L’unico che conosce il posto e può dirci se esiste una seconda uscita, o magari un passaggio segreto, è proprio Pasquale Di Filippo. Ma come fare a parlargli senza insospettire gli altri carcerati, i compagni di cella? Mi viene un’idea.
Ogni sostituto procuratore ha sul suo tavolo decine di richieste da parte dei detenuti, comuni e non, per le esigenze più svariate: da chi non riceve la posta da tre settimane a chi chiede un trasferimento o un colloquio supplementare con i familiari.
Le richieste dei detenuti vengono redatte su un modulo della direzione del carcere, il cosiddetto Modello tredici. Metto insieme tutte le domande arrivate ai colleghi della procura nelle ultime settimane e vado all’Ucciardone, avvisando l’ufficio matricola di preparare tutti i detenuti che hanno chiesto il colloquio con i magistrati.
Li faccio mettere in fila nell’atrio del carcere, nonostante le proteste degli agenti penitenziari che adducono legittimi motivi di sicurezza. Fra i tanti c’è anche Pasquale Di Filippo, a cui Armida, su nostra richiesta, ha fatto debitamente compilare il «suo» Modello tredici.
Per ore li passo in rassegna, uno per uno: ascolto i loro problemi e ne risolvo anche qualcuno. Poi arriva, finalmente, il turno di Pasquale. Di fronte a me si presenta un uomo provato: uno straccio. Stavolta è bianco come un cero e rimane terreo per tutta la durata del colloquio.
Trema, malgrado i trentaquattro gradi del pomeriggio estivo palermitano. Balbetta e ansima, mi dice che ha paura di non farcela. Cerco di calmarlo, di fargli coraggio. Nessuno deve sospettare nulla. Gli raccomando di resistere ancora per poco, perché l’operazione è ormai agli sgoccioli. Mentre firmo sul librone della matricola l’autorizzazione a un colloquio straordinario con una sua amica, giustificando così il nostro incontro, mi faccio dare la notizia che ci serve: nel negozio di Calvaruso non esiste un’uscita secondaria, né una via di fuga. Pasquale ne è sicuro. Ci salutiamo. Lo seguo con la coda dell’occhio e lo guardo rientrare, incerto, nel cortile dell’Ucciardone.
Torno in ufficio con un certo senso di vuoto. Temo per questo ragazzo. Ne parlo con Gian Carlo Caselli e con i colleghi con cui seguo l’indagine. Mi auguro che tutto si concluda al più presto.
E in effetti passano poco più di ventiquattr’ore. Il giorno dopo un uomo con baffi e occhiali, che assomiglia vagamente a Bagarella, viene visto entrare nel negozio di corso Tukory. È proprio lui. Gli agenti che sono appostati fuori lo riconoscono e, con calma, lo aspettano all’uscita. Possono attendere, tanto sanno che in quel negozio non ci sono vie di fuga alternative.
Si decide di intervenire senza fare irruzione, anche per non «bruciare» Calvaruso, il cui successivo pedinamento ci avrebbe potuto dare, come effettivamente ci darà, altri spunti investigativi. Bagarella esce, da solo, con quel sacchetto in mano. Sacchetto che non aveva al momento dell’ingresso nella bottega del suo amico.
Nella busta ci sono un paio di jeans. Il «signor Franco» era scivolato sulla classica buccia di banana. Era andato nel negozio di Calvaruso proprio per ritirare quel paio di pantaloni che aveva comprato qualche giorno prima: gli stavano troppo lunghi e li aveva fatti accorciare. E ci aveva pensato Calvaruso a fare l’orlo. Quel giorno i jeans erano pronti e il boss era andato a ritirarli. Tanto attento a microspie, intercettazioni e pedinamenti, si era fatto prendere per uno stupido, banale paio di Levi’s.
Avevamo avuto ragione ad avere fretta: Bagarella infatti si preparava a cambiare vita. Il boss corleonese, preoccupato per l’arresto di Pasquale Di Filippo, stava sostituendo tutti i suoi punti di riferimento. Aveva distrutto la vecchia scheda del cellulare e se ne era procurata una nuova. In tasca gli troviamo un pezzo di carta su cui si era appuntato il numero del nuovo telefonino. Numero che aveva appena comunicato anche al fedele Calvaruso, durante quella visita al negozio, raccomandandogli di utilizzarlo solo in caso di emergenza. Evidentemente non si sentiva più sicuro nei panni del signor Franco, e, come i fatti hanno dimostrato, non aveva torto.
Quella visita da Tony doveva essere una toccata e fuga. Poi don Luchino sarebbe tornato a casa. Quando, subito dopo l’arresto, entriamo nel suo appartamento, troviamo in cucina un tegame ancora caldo, con la trippa al sugo: forse il piatto preferito del boss. Evidentemente Bagarella l’aveva preparata con cura prima di uscire, per tornare a mangiarla più tardi, dopo aver ritirato i suoi nuovi blue jeans.
Forse stava per traslocare in un nuovo covo, che non abbiamo mai individuato ma dove, probabilmente, doveva trasferire il suo piccolo arsenale personale: alcune pistole e fucili che abbiamo trovato nel box sottostante al rifugio di via Passaggio Mp1 numero 9.
Dopo la sua cattura gli agenti della Dia irrompono in un altro covo che ci ha segnalato Pasquale Di Filippo, quello di Nino Mangano, assicuratore e uomo d’onore della famiglia della Roccella, irreperibile da tempo anche se ancora non formalmente latitante.
Secondo Pasquale Di Filippo, Mangano, per il quale disponiamo il fermo, è il nuovo capo di Brancaccio.
Ha sostituito i fratelli Graviano, detenuti dal gennaio 1994, e ha preso il controllo del ferocissimo gruppo di fuoco del relativo mandamento: è, insomma, il vero braccio armato di Leoluca Bagarella. Nel suo appartamento troviamo un patrimonio di informazioni: il registro delle estorsioni, con tutte le somme in entrata e in uscita, e con tutti i nomi in codice degli uomini d’onore a cui venivano affidati incarichi.
Materiale preziosissimo che ci darà parecchio lavoro nei mesi successivi.
Adesso bisogna pensare a Pasquale, a toglierlo immediatamente da quell’inferno in cui vive ormai da quattro lunghi giorni. La sera stessa del 24 giugno viene prelevato dall’Ucciardone e portato in una località segreta: ha appena accettato la protezione dello Stato. Finalmente si rilassa. Per lui è la fine di un incubo, anche se comincia a pagare da subito un prezzo altissimo. Appena la notizia del suo pentimento diventa pubblica, la moglie, Giuseppina Spadaro, la figlia di don Masino, lo ripudia, per salvare il buon nome di famiglia. Ma l’operazione è ormai conclusa.
Siamo tutti negli uffici della Dia, nel complesso delle Tre Torri. Anche Bagarella è lì, blindato in una camera di sicurezza.
Ricordo Gigi Bruno, ora colonnello dei carabinieri, incaricato di informare la famiglia del boss dell’avvenuto arresto. «Buonasera, casa Riina? La signora Ninetta Bagarella? Sono il capitano Bruno della Dia. Mi scusi se la disturbo a casa a quest’ora, ma volevo informarla che abbiamo tratto in arresto suo fratello Leoluca.»
Dall’altro capo del telefono parte una serie di improperi uniti a grida di disperazione che, però, non turbano per nulla il compassato ufficiale dei carabinieri: «Mi perdoni ancora se l’ho disturbata. Le auguro una buona serata!».
Non c’è nessuno sfottò. Gigi Bruno è fatto proprio così. Quando mette le manette a Bagarella per trasferirlo in carcere gli dice, sempre gentilissimo: «Mi scusi signor Bagarella, ma devo metterle le manette. Sa, è il regolamento…».
Così come Gian Carlo Caselli, che ci raggiunge qualche minuto dopo. Torinese, cortese, misurato, vuole vedere in faccia il boss e verificare le sue intenzioni. «Buonasera! Sono il procuratore di Palermo e sono qui per chiederle se intende dire qualcosa, se ha qualche dichiarazione da fare.»
Leoluca Biagio Bagarella, invece, non è per nulla misurato e, in quell’occasione almeno, per nulla cortese: «’A canusciu buono, a vossia. E non devo dire proprio niente. Lei si facissi ‘u procuraturi, ca io mi fazzu ‘u carzaratu». Della serie: ognuno al posto suo! Risposta rozza e arrogante che non deve essere certo piaciuta al mio capo.
Bagarella esce da quella stanza scortato da due uomini incappucciati, con le armi puntate addosso. Il giorno dopo sarà trasferito nel supercarcere dell’Asinara. Quella sera ho la sensazione che la mafia si può battere. Due episodi banali, ma altamente indicativi. Da un lato il rispetto delle regole, la professionalità e, perché no, la cortesia degli uomini dello Stato; dall’altro l’arroganza dei boss, arroganza ormai tanto inutile quanto perdente.
La caccia ai “piccioli” della mafia che arrivano fino agli amici di Lugano
Non appena il piccolo jet si ferma sulla pista, cinque o sei macchine con i lampeggianti circondano l’aereo. Sembra la scena di un film americano con Bruce Willis. Ma il comandante Mazzacchi, un dirigente della polizia cantonale che ci viene incontro, non porta occhiali scuri, non mastica chewing gum e non ha certo l’aria da duro. È un ticinese gioviale e rubicondo, con un bel paio di baffi biondi, sottili e curatissimi. Ci offre il caffè al bar dell’aeroporto e invita me e Obinu ad andare con lui sulla sua macchina, mentre alcuni dei suoi uomini prendono in consegna Cancemi e lo fanno salire su un furgone. Guardo perplesso il colonnello dei carabinieri che, evidentemente, deve aver fatto il mio stesso pensiero. Un’occhiata dell’ufficiale e tre carabinieri del Ros salgono sul furgone con Cancemi. Anche se hanno lasciato le armi a bordo dell’aereo dove, con i piloti e la hostess, è rimasto un loro collega, hanno l’ordine di non abbandonare un solo attimo il pentito; e la polizia cantonale non ha nulla in contrario.Il comandante Mazzacchi ci intrattiene piacevolmente nel suo ufficio per un’oretta. Ci parla del suo lavoro quotidiano. A me e a Obinu viene spesso da sorridere quando ci illustra le sue tecniche per incastrare gli automobilisti che superano i limiti di velocità o gli italiani che fanno incetta di sigarette e liquori. Mi chiedo se quell’uomo sia in grado di gestire un’operazione così delicata. Ma mi sbaglio; e di grosso. La polizia cantonale svizzera ci darà una straordinaria dimostrazione di efficienza, preparazione, competenza tecnica.
Intorno alle otto arriviamo in tribunale. Abbiamo un appuntamento con il procuratore del Canton Ticino, Carla Del Ponte, il magistrato elvetico che da tempo forniva la sua preziosa collaborazione agli inquirenti palermitani e che, poco più di quattro anni prima, aveva rischiato di saltare in aria proprio a Palermo insieme a Giovanni Falcone e a sua moglie nella villa dell’Addaura. Era il 1989 e Carla Del Ponte lavorava con il magistrato siciliano alle inchieste sul riciclaggio di denaro e sui grandi traffici di cocaina.
Chi ha messo la bomba sul bagnasciuga della villa al mare di Falcone, fortunatamente scoperta prima che esplodesse, forse voleva fare il colpo doppio. Voleva prendere, come usava dire Riina, i classici due piccioni con una fava.
Non avevo mai conosciuto personalmente la Del Ponte e avvertivo una sorta di timore reverenziale. Ma Carla è molto gentile e affabile. Ci diamo subito del tu e, prima di spostarci nella zona dove dovrebbe essere stato sepolto il denaro, mi fa portare l’ennesimo caffè della mia lunga mattinata: sarà stato il settimo o l’ottavo.
Si cerca il tesoro
Sulla base delle indicazioni di Cancemi, che aveva parlato di un fondo appartenente a un suo zio che aveva vissuto a Lugano, gli svizzeri avevano già trovato il posto: nelle campagne tra Pazzallo e Montagnola, a una quindicina di chilometri dal capoluogo ticinese.
Ci arriviamo con una splendida Lancia Thema Ferrari a disposizione del procuratore cantonale. La macchina, come quasi tutte le veloci berline che aveva la polizia svizzera, era stata sequestrata a qualche contrabbandiere o trafficante di droga. L’efficiente legge della Confederazione stabilisce che quei veicoli, a chiunque intestati, vengano confiscati e assegnati a magistrati e forze dell’ordine. Una normativa simile c’è anche in Italia, ma chissà perché, viene applicata raramente e solo per qualche motorino o vecchia carcassa.
Gli svizzeri hanno già portato Cancemi sul luogo, una collinetta della penisola che si inoltra per qualche chilometro nel lago di Lugano dividendolo praticamente in due. C’è una costruzione di blocchetti di cemento a un solo piano con un paio di stanze a destra e una stalla a sinistra. L’aia davanti la casa è parzialmente coperta da una tettoia in eternit appoggiata su pali di legno. No, non sembra proprio di trovarsi nella campagna svizzera. Nessuna graziosa casetta in legno e muratura con finestre e balconi intarsiati, nessun fienile colorato, nessuna corpulenta vacca pezzata che pascola nelle vicinanze. Potremmo essere a Partinico o a Bolognetta. Si vede che nella zona c’è stata la mano di qualche siciliano, anche se adesso quella casa è di proprietà di un contadino del luogo.
Cancemi è perplesso: «Dottore, il posto è certamente questo. Ma c’è qualcosa che non mi torna. E la tettoia, all’epoca, sicuramente non c’era». Si appoggia allo spigolo sinistro della casa e fa alcuni passi in avanti. «Unu, du’, tri, quattru… Provate qui.»
Tre uomini con pale e picconi si avvicinano, ma Mazzacchi li blocca. Da una macchina scendono due tipi in tuta bianca. Uno di loro porta un pesante zaino sulle spalle. Sembra un ghostbuster. Appoggia lo zaino sul punto indicato da Cancemi e ci invita ad allontanarci. È un’apparecchiatura a raggi X. Prudenti gli svizzeri: prima di scavare vogliono vedere cosa c’è sottoterra. Ma nel punto indicato da Cancemi la macchina non dà nessun segnale.
«Qui sotto non c’è nulla» dice sicuro il tecnico «acchiappafantasmi».
«Forse è stato Rotolo. Sarà venuto a prendersi i soldi a mia insaputa. Ma quando lo ha fatto? È in carcere da tanti anni. E poi mi avrebbe lasciato almeno la mia parte. Solo lui e mio zio, oltre a me, conoscevano il posto esatto.»
Invito Cancemi a riflettere meglio. Magari si è sbagliato. Forse la tettoia lo ha confuso. Mi allontano un po’ dal gruppo e temo che, nella migliore delle ipotesi, quel viaggio in Svizzera sia stato inutile. Vado verso il bosco a sinistra. Di fronte a noi, dall’altra parte del lago, c’è Campione d’Italia. Magari con il mio telefonino analogico riesco ad agganciare il segnale cellulare della Telecom e a chiamare Caselli. Nulla da fare, non c’è campo.
Prima di tornare alla casupola noto però un certo movimento nella boscaglia e vedo, nascosti tra le frasche, diversi uomini in tuta mimetica. Tutti armati di fucili di precisione con cannocchiali a infrarossi e visori notturni. Non mi aspettavo tanta attenzione ed efficienza da parte della polizia cantonale. Penso ai racconti di Mazzacchi sugli automobilisti indisciplinati e spero di non commettere mai infrazioni al codice della strada elvetico.
Cancemi adesso è appoggiato con le spalle al muro esterno della casa, in corrispondenza del divisorio tra la stalla e le due stanze destinate ad abitazione. Conta ancora quattro passi in avanti e si ferma proprio accanto a uno dei pali che sorreggono la tettoia. Altra Tac al terreno, ma stavolta la macchina emette dei bip e stampa una specie di radiografia. Il tecnico guarda la foto e ci rassicura: «C’è metallo ma non c’è esplosivo. Potete scavare».
Pochi colpi, a una ventina di centimetri dal palo, e uno dei picconi incontra qualcosa di solido. Si allarga il buco prima con le vanghe e poi, delicatamente, con le mani. Affiorano due bidoni di acciaio inossidabile, di quelli con il tappo a vite, normalmente utilizzati per trasportare il latte. Dentro ci sono i dollari, sigillati ermeticamente. In perfetto stato. Li appoggiamo su un asse di legno e li mettiamo in fila. Su tutte le banconote c’è il ritratto di Benjamin Franklin, sono tagli da cento dollari. Contiamo settantotto mazzette da duecentocinquanta banconote ciascuna: un milione e novecentocinquantamila dollari, tre miliardi e mezzo di lire al cambio dell’epoca. Non avevo mai visto tanto denaro in vita mia.
Cancemi inizia letteralmente a ballare e si produce in una sorta di danza della pioggia sotto lo sguardo basito dei professionali poliziotti ticinesi. Alza più volte le mani in aria in segno di vittoria come in una specie di ola solitaria e ripetuta e si mette a girare in tondo. Come fosse in trance. E non la smette più: «Alè oh oh! Alè oh oh!». Una scena che non dimenticherò mai. È convinto di essersi finalmente guadagnato l’attendibilità, la patente di collaboratore affidabile, anche se gli è costata cara. «Mancano due milioni e cinquantamila dollari» gli dico io per frenare il suo entusiasmo. Cancemi allarga le braccia: «Rotolo sarà venuto a prendere la sua parte o forse l’avrà portata via quando li abbiamo seppelliti e io ricordavo male. E le due mazzette da venticinquemila dollari ciascuno che mancano dalla mia quota probabilmente saranno servite a mio zio, poveretto, per rientrare in Italia».
Mi faccio prestare il cellulare dalla Del Ponte e chiamo in procura a Palermo. Caselli è incredulo. Mi fa ripetere tre volte che avevamo trovato i soldi. Temeva che si trattasse di un bluff di Cancemi, dell’ennesima bufala che ci aveva «servito».
Torniamo al palazzo di Giustizia e chiedo a Carla Del Ponte di autorizzarci a proseguire nelle indagini in Svizzera. Una volta trovati i soldi dobbiamo seguire a ritroso il percorso che hanno fatto.
Cancemi aveva raccontato di essere andato con Rotolo a riscuotere il denaro proveniente dagli acquirenti americani dell’eroina in una banca di Ginevra, banca che sarebbe stato in grado di individuare.
Ma a Ginevra non possiamo andare in quei giorni. Il 16 gennaio nel palazzo delle Nazioni Unite è atteso il presidente americano Bill Clinton per un incontro con il suo omologo siriano Hafiz al-Assad e le misure di sicurezza predisposte dal governo federale sono rigidissime.
Giungeremo solo qualche settimana dopo a individuare la banca e la transazione, estero su estero, dei sei milioni di dollari provenienti da un istituto di credito di Montreal. Ma non riusciremo ad andare oltre perché in Canada i soldi erano arrivati da un anonimo conto acceso presso una sorta di finanziaria di Panama che adesso non esisteva più, come non esistevano più i relativi documenti contabili, sempre che ci fossero mai stati.
Il bilancio della missione è però certamente positivo. Penso alla possibilità di recuperare almeno in parte l’attendibilità di un collaboratore che poteva essere veramente prezioso come Cancemi, al fatto di aver tolto a Cosa nostra una piccola porzione dei suoi profitti conseguiti vendendo morte e, poi, a quei tre miliardi e mezzo di lire che entreranno nelle casse dello Stato e che, spero, serviranno a finanziare il contrasto a Cosa nostra.
I soldi restano in Svizzera
Sull’ultimo punto, però, mi sbaglio. Non ho fatto i conti con la competenza degli svizzeri in materia di soldi e con la furbizia di Carla Del Ponte. Forse non a caso, appena tre mesi dopo, verrà nominata procuratore federale. Si fa portare Cancemi in ufficio e, incurante del fatto che non sia assistito da un difensore, lo interroga ugualmente e si fa mettere per iscritto che si tratta di denaro proveniente dalla vendita di droga. Io non posso far niente per contrastarla. Siamo a casa sua e lì comanda lei. Sulla base della legge federale elvetica tutto ciò che è comunque riconducibile al traffico di stupefacenti e che si trova nel territorio svizzero deve essere confiscato. Le obietto che il ritrovamento del denaro è avvenuto a seguito di una rogatoria internazionale richiesta dal nostro Paese dove, peraltro, si è svolta gran parte dell’attività criminosa e cui, quindi, devono essere consegnati i soldi. Carla mi invita allora a consultare i documenti della rogatoria e mi fa notare che ci aveva autorizzato solo l’ispezione del terreno e non il sequestro del denaro che pure noi avevamo richiesto. Nulla da fare. I dollari restano in Svizzera. Inutili le mie proteste e rimostranze e, poi, tenuto conto dei buoni rapporti tra i nostri Paesi, non è il caso di andare oltre. Mazzacchi, forse per farsi perdonare della beffa, ci invita tutti a cena in un ottimo ristorante e l’indomani, quando andremo a pagare il conto in albergo prima di tornare in Italia, scopriremo di essere stati ospiti della polizia ticinese. Forse era destino che quel denaro rimanesse agli svizzeri. Mi viene spesso in mente il nuovo proprietario del terreno di Montagnola, quello che aveva costruito la tettoia e aveva piazzato i sostegni. Se avesse infisso i pali qualche centimetro più in là avrebbe certamente scoperto quel tesoro. Anche se, probabilmente, non sarebbe campato a lungo per goderselo.
Le spericolate amicizie e le “buone” parentele dei fratelli Di Filippo
L’indagine prende le mosse dal tentativo di suicidio in carcere di Emanuele Di Filippo, un uomo di poco meno di quarant’anni, una vaga somiglianza con Alain Delon, arrestato per associazione mafiosa nell’ambito del procedimento denominato «Golden Market», nome di fantasia collegato alle iniziali del collaboratore di giustizia che aveva consentito l’operazione, Gaspare Mutolo.
Di Filippo non regge la detenzione: è depresso e tenta di impiccarsi in cella con un rudimentale cappio fatto con un lenzuolo e legato alle sbarre del letto.
Per noi magistrati è poco più di uno sconosciuto, se non per una parentela mafiosa importante: la sorella, Agata, ha sposato Nino Marchese, uno dei killer più spietati del gruppo di fuoco storico della borgata di Ciaculli. Nino inoltre è anche il fratello di Vincenzina Marchese, la moglie di Leoluca Bagarella. Un intreccio di famiglie «pesanti» nella geografia mafiosa, dunque.
Il tentativo di suicidio di un boss detenuto fa scattare il campanello d’allarme. L’allora sostituto procuratore nazionale antimafia Piero Grasso lo va a incontrare in carcere; da quel colloquio capiamo che ci sono degli spiragli per una sua collaborazione: «Sul soggetto si può lavorare».
Così, con i miei colleghi Guido Lo Forte e Ignazio De Francisci, in un giorno di maggio, andiamo in trasferta nel carcere di Rebibbia, a Roma, a interrogare Emanuele Di Filippo, e la missione va a buon fine.
Spossato dalla detenzione, sfinito psicologicamente di fronte alla possibilità di trascorrere ancora lunghi anni di carcere, getta la spugna e decide di collaborare. È fondamentalmente timido, fragile, un po’ introverso. È letteralmente distrutto. Certamente il tentato suicidio non ha fatto che peggiorare la sua situazione: non è ben visto in carcere un mafioso che prova a togliersi la vita.
Istintivamente credo subito alla sua sincerità. È diplomato all’istituto d’arte ed è figlio di un funzionario di banca. Inizia a raccontare quel che sa partendo proprio dalla sua famiglia. Ci parla di suo fratello minore, Pasquale, e delle sue «relazioni pericolose». Ci rivela che, pur non essendo ricercato, vive in semiclandestinità. E periodicamente – ci dice – incontra Leoluca Bagarella, di cui sarebbe uno degli uomini di fiducia.
Pasquale Di Filippo, un «mafioso bene»
Pasquale Di Filippo ha trentadue anni, più robusto del fratello, altezza media, con il vezzo di passarsi la mano destra tra i capelli biondo cenere. È, come il fratello, un «mafioso bene». Ha pure fatto un bel matrimonio sposando la figlia di Masino Spadaro, il re della Kalsa, il più noto contrabbandiere della storia di Cosa nostra.
Sulla base delle indicazioni di Emanuele, la Dia individua una casa di campagna, a Misilmeri, dove
Pasquale si nasconde; e dove, come scopriremo dopo, in quei giorni si rifugia anche Salvatore Grigoli, uno dei killer di don Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio di Palermo assassinato in un attentato mafioso.
Riusciamo a piazzare nella casa alcune microspie e ci mettiamo in ascolto nella speranza di captare qualche conversazione interessante che ci porti sulle tracce di Bagarella. Ma accade un imprevisto, un fatto curioso. Una delle cimici comincia a trasmettere su frequenze diverse da quelle da noi impostate: mentre Grigoli sta guardando il telegiornale in salotto, sente in onda la voce della moglie che sta addormentando il figlio nella stanza accanto. È un’interferenza e lo capisce al volo. Si mette alla ricerca della microspia e la trova. Nascosta nell’interruttore della luce: fine delle trasmissioni.
Così, dopo la scoperta della cimice, decidiamo di rompere gli indugi. Dispongo un fermo per Pasquale Di Filippo per il reato di associazione mafiosa, utilizzando tra l’altro le dichiarazioni del fratello Emanuele.
Pasquale viene bloccato dagli uomini della Dia e portato nei loro uffici vicino allo stadio della Favorita. Con me ci sono i direttori dei Centri operativi di Roma e Palermo, Franco Gratteri e Nino Cufalo. Pasquale Di Filippo prende atto delle accuse che gli vengono rivolte dal fratello e della conseguente prospettiva di trascorrere molti anni in carcere; così, terrorizzato, decide anche lui di «saltare il fosso».
Grondante di sudore dichiara, tra le lacrime, di voler collaborare. È talmente emozionato che il suo viso cambia continuamente colore. Passa dal rosso porpora al bianco cadaverico: si accende improvvisamente o impallidisce di colpo.
Operazione “terra bruciata” per scovare i grandi latitanti
Arrivo a Palermo nel 1993, dopo quattro anni passati alla vicina procura della Repubblica di Termini Imerese. L’anno si apre con la cattura di Totò Riina, «capo dei capi» di Cosa nostra, e con l’insediamento al vertice della procura palermitana di Gian Carlo Caselli. Comincia una nuova era nella lotta alla mafia.
Proprio qualche mese dopo l’arresto di Riina, Cosa nostra porta la sua sfida nel cuore dello Stato. Il tritolo mafioso esplode a Firenze, a Roma, a Milano. I corleonesi non si arrendono, anzi, rilanciano. Bisogna fermarli e, per farlo, occorre in primo luogo arrestare i latitanti. La lista è lunghissima. Sono tutti cosiddetti «pezzi da novanta» e tutti introvabili. Controllano il territorio metro per metro, sono protetti da una rete di centinaia e centinaia di persone, maneggiano armi ed esplosivi. Sono il cuore e l’anima di Cosa nostra.
Scovare i latitanti diventa l’obiettivo numero uno della procura di Caselli: sembra un’impresa ardua, disperata. Nonostante anni e anni di processi e condanne, i capimafia sono quasi tutti liberi. Liberi di ammazzare, di far saltare in aria magistrati, poliziotti e carabinieri, di devastare il patrimonio artistico italiano, di violentare il territorio dello Stato, di imporre il loro dominio assoluto sull’economia siciliana.
Ma il momento è estremamente favorevole. È un momento in cui la società civile, messa a dura prova dalle stragi di Capaci e via d’Amelio, si è finalmente schierata dalla parte giusta. È un momento in cui è rinata «la speranza dei palermitani onesti». È un momento in cui da Roma giungono segnali forti e, finalmente, inequivocabili. E i risultati arrivano.
Un lungo elenco di boss da catturare
Decine e decine di latitanti vengono, come si dice, «assicurati alla giustizia». Cifre da record.
L’elenco dei mafiosi irreperibili che ho contribuito a catturare è piuttosto lungo e pesante.
«Capimandamento» come Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Nino Mangano, Pietro Aglieri, Mico Farinella, Nicola Di Trapani, Vito Vitale. Componenti di gruppi di fuoco e responsabili di stragi e decine di omicidi, come Fifetto Cannella, Pino Guastella, Pietro Romeo, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Peppuccio Barranca, Enzo Salvatore Brusca, Giovanni Ciaramitaro. E poi tantissimi influenti «uomini d’onore» come Carlo Greco, Pinuzzu La Mattina, Natale Gambino, Calogero Battista Passalacqua, Bernardo Bommarito, Biagio Montalbano, Paolo Alfano, Melo Zanca, Salvatore Gallina…
Risultati mai più raggiunti dopo. Eppure quegli anni, gli anni della procura di Caselli, vengono malevolmente ricordati solo per i processi ai politici o, peggio, per i cosiddetti «processi politici».
Per me e per gli altri colleghi, invece, quel periodo ha segnato la rivincita delle istituzioni sullo strapotere della mafia. Il momento in cui, dopo tanti anni, lo Stato si riappropriava almeno temporaneamente del suo territorio: Cosa nostra veniva messa in ginocchio e, soprattutto, crollava definitivamente il mito dell’inafferrabilità dei boss. Uno dopo l’altro finivano in manette.
Ogni indagine ha la sua storia. Ci sono investigazioni basate su intercettazioni ambientali, altre su pedinamenti o sofisticate tecnologie. Alcune partono da una soffiata e altre sono invece il frutto di un’idea originale, di un guizzo, di un’intuizione. La cosa fondamentale è capire il modo in cui il latitante si muove, quali sono i suoi legami, i suoi contatti, pensare come lui, entrare nei suoi panni, quasi immedesimarsi.
E per farlo bene è necessario anche saper parlare la sua lingua e quella delle persone che gli stanno
vicino. Cogliere le sfumature delle espressioni, collocare ogni frase, ogni parola nel giusto contesto. Il dialetto dell’Isola è spesso subdolo. Per esempio: in certe zone, l’imperativo moviti può significare muoviti ma anche stai fermo, a seconda del tono della voce usato. Oppure ancora: in dialetto non esiste il verbo al futuro. Forse sarà a causa del nostro atavico fatalismo…
Solo un siciliano può capire fino in fondo un altro siciliano, senza interpreti o traduttori. Un mio collega d’origine milanese era sul punto di arrestare per estorsione aggravata il capo di un ufficio tecnico comunale che stavamo intercettando per una storia di licenze edilizie. Ascoltando le registrazioni si era convinto che si trattasse di un collettore del «pizzo», equivocando sulle pressanti richieste di denaro che il funzionario faceva ai commercianti del suo paese. Sono riuscito a fermarlo appena in tempo e ho faticato parecchio per fargli capire che il «suo esattore» era, invece, molto semplicemente, il presidente del comitato per i festeggiamenti in onore di sant’Anna, la patrona locale: stava solo raccogliendo i fondi per luminarie, fuochi d’artificio e cantanti.
Sicuramente è molto più semplice lavorare su un latitante che si sposta in contesti cittadini o comunque popolosi, in cui una faccia nuova desta minore attenzione. Nei paesi, invece, o in certi quartieri di Palermo, tutto è più complicato. Sono luoghi in cui spesso lo Stato non può arrivare. Ci si deve fermare, occorre restare fuori e attendere. Si può solo aspettare una mossa falsa. Sapendo che, comunque, non si passa inosservati.
Il latitante si muove con molta circospezione. Conosce e controlla ogni palmo del «suo» territorio. Gioca in casa.
L’esempio emblematico per me è stata la cattura di Vito Vitale, il boss di Partinico. Difficile, perché Vitale prediligeva i paesi dove investigare diventa particolarmente complicato: il forestiero viene notato immediatamente, la presenza di un estraneo profuma di sbirro.
Sul territorio esistono decine di «sentinelle». Dal vecchio contadino al ragazzino di undici anni, dal barbiere al calzolaio, dal barista al venditore di càlia e simenza: sono tutte vedette, piccole vedette di mafia.
La notizia che c’è uno sconosciuto in giro passa di bocca in bocca in tempo reale. E arriva sempre a chi deve arrivare.
Mille occhi a cui non sfugge niente. Occhi particolarmente attenti a riconoscere lo sbirro, anche se è in borghese, anche se è camuffato. Quando arriva, lo strànio viene immediatamente schedato, registrato e segnalato. E il gioco può diventare pericoloso, perché da cacciatori si rischia di diventare cacciati.
Occorre essere molto prudenti, muoversi poco alla volta e con passi felpati. Non esporsi mai. Lavorare sottovento affinché la preda non senta l’odore del cacciatore. Anche nei pedinamenti bisogna fare molta attenzione e agire di fantasia: la classica coppietta della polizia, un uomo e una donna che magari fanno finta di baciarsi, viene subito individuata. O peggio ancora due uomini in macchina che sfogliano distrattamente un giornale. L’odore di sbirro lo sentono da lontano. E «loro» non sbagliano quasi mai.
Molti carabinieri in quegli anni, per esempio, sono costretti a uscire in servizio con le loro macchine
private, rischiando anche in prima persona. Le autocivetta dell’Arma, le Fiat Uno che hanno in dotazione, infatti, presentano un banalissimo dettaglio che le rende riconoscibili agli occhi dei mafiosi: sono le uniche senza poggiatesta. Forse per abbassare i prezzi di produzione e aggiudicarsi la fornitura, la fabbrica torinese non le ha dotate di questo optional che costava poche migliaia di lire in più e che tutti gli acquirenti normali facevano montare sulla propria autovettura. Tante volte mi sono sentito dire da pentiti e mafiosi: «Dutturi, l’ho visto subito che erano sbirri. Avevano la macchina senza poggiatesta».
Ma il lavoro sottovento deve cominciare ancor prima. Già quando inizi a subodorare la pista.
Gli uomini d’onore hanno occhi e orecchie ovunque. Anche nel palazzo di Giustizia. Giovanni Falcone e Rocco Chinnici, pur lavorando in quella sorta di bunker che era l’ufficio istruzione di Palermo, non si sentivano mai sicuri. Quando avevano qualche notizia importante da comunicarsi, lo facevano in ascensore e con pochissime parole. E, nei miei anni a Palermo, l’atmosfera non è certo diversa.
Basta il susseguirsi di riunioni nella stanza di questo o di quel magistrato per mettere sul chi vive gli avvocati che difendono i mafiosi.
Ogni mossa del pool antimafia viene scrutata, passata ai raggi X. E ritrasmessa ai boss. Da figlio di due avvocati, mi dispiace prendere atto del ruolo che spesso hanno alcuni legali di mafiosi. Ce lo raccontano senza remore due pentiti di rilievo come Calogero Ganci e Francesco Paolo Anzelmo: in un paio di occasioni erano sfuggiti in extremis all’arresto proprio perché avvertiti dai loro difensori. No, nessuna talpa o fuga di notizie. Agli avvocati era bastato notare carrelli pieni di blocchi di fotocopie che, dall’ufficio del gip al piano terra, venivano portati al secondo piano, in procura. Non potevano che contenere ordinanze di custodia cautelare da eseguire. Per legge ne occorrono quattro copie: una originale, una da consegnare al destinatario, una per il difensore e la quarta per il carcere. Quei carrelli, dunque, sono la prova inequivocabile di un blitz imminente.
Spesso, per evitare buchi nell’acqua, ci siamo fatti consegnare dal gip un solo provvedimento e abbiamo costretto i cancellieri del tribunale ad autenticare le copie in una caserma dei carabinieri o in questura.
Per sottrarci agli sguardi indiscreti ci riunivamo in qualche ristorante o in uffici che altre amministrazioni dello Stato ci mettevano a disposizione. A volte preferivamo addirittura parlare per telefono potendo contare sugli apparecchi «cripto» di cui il ministero dell’Interno ci aveva dotati, a casa e in ufficio.
Era una vera e propria guerra con tanto di spionaggio e controspionaggio e, come si usa dire, «in guerra e in amore tutto è permesso». Per questo anch’io avevo deciso di usare il metodo, poco sportivo ma obiettivamente efficace, dei bracconieri: quello della terra bruciata.
Una strategia che tante volte si è rivelata vincente. Si deve fare il vuoto attorno agli uomini d’onore oggetto delle indagini. Interrompere la loro ragnatela di protezione lasciando i due o tre fili a noi noti e, con la pazienza del ragno, seguire solo quelli.
Tante volte abbiamo messo insieme tutti i dati di cui eravamo in possesso, anche rinunciando a qualche spunto investigativo, al solo fine di eseguire provvedimenti di custodia cautelare che consentissero di neutralizzare alcuni contatti, sicuri o solo probabili, del latitante.
Il ritorno dei pentiti. […]
L’arresto di Giovanni Brusca, l’esecutore materiale della strage di Capaci, per esempio. Nei mesi precedenti la sua cattura gli abbiamo praticamente «bruciato» tutti gli appoggi. È stato costretto a correre ad Agrigento perché ormai non aveva più protezioni: non aveva più nessuno su cui contare in casa sua a San Giuseppe Jato. Nessuno ad Altofonte, nessuno a Borgetto, nessuno a San Cipirello. I boss non lasciano quasi mai il loro territorio: «La presenza è potenza» soleva dire Bagarella. Brusca si è allontanato solo perché gli abbiamo «tagliato i fili». Lo stesso è accaduto, per esempio, nel 1997 quando ci siamo trovati davanti al caso di alcuni collaboratori di giustizia che avevano ripreso a delinquere, vicenda passata alla cronaca come «il ritorno dei pentiti». C’era il forte sospetto che Balduccio Di Maggio, Santino Di Matteo e Gioacchino La Barbera, tre fra i più preziosi collaboratori di giustizia, mentre erano sottoposti al programma di protezione si fossero resi responsabili di alcuni delitti nel mandamento di San Giuseppe Jato.
Non sapevamo che pesci pigliare. Non volevamo credere alla possibilità che i tre avessero commesso addirittura degli omicidi. Ma d’altro canto l’ipotesi investigativa sembrava fondata. Così come ugualmente fondata ci sembrava la possibilità che dietro questa storia ci fosse lo zampino di Giovanni Brusca che, finito in carcere, intendeva delegittimare quei pentiti.
Nel dubbio procediamo con l’operazione «terra bruciata». Arrestiamo contemporaneamente tutti i soggetti che riteniamo vicini ai tre collaboratori e a Brusca, e per i quali, ovviamente, abbiamo elementi di prova sufficienti. Così cerchiamo di isolare i due presunti gruppi contendenti. L’operazione va a buon fine. Persi i loro contatti sul territorio, i tre sono costretti a venire allo scoperto.
Le microspie collocate nelle macchine di La Barbera e Di Maggio iniziano a registrare conversazioni interessanti. Di Matteo si sposta in continuazione dalla località protetta e uno dei fermati, tale Giuseppe Maniscalco, comincia subito a collaborare: ci rivela come i tre, approfittando dell’arresto di Brusca, avessero, di fatto, cercato di riprendere il controllo del mandamento di San Giuseppe Jato.
Ho utilizzato spesso la tattica della «terra bruciata». Tutte le volte che i metodi tradizionali non davano i risultati sperati. Era la mia ultima carta e la giocavo solo quando era indispensabile, perché estremamente dispendiosa. Per arrestare le persone che giravano intorno all’oggetto delle indagini bisognava tirare fuori le prove già raccolte, rivelare l’esistenza di intercettazioni telefoniche o ambientali, buttare alle ortiche mesi di pedinamenti. E tutto solo per togliere dalla circolazione qualche personaggio apparentemente minore.
Se la strategia falliva si doveva ricominciare tutto da capo. Come nel caso delle ricerche di Nino Giuffrè, capomandamento di Caccamo dove abbiamo «tagliato» i fili sbagliati e abbiamo fallito. Tante altre volte, però, l’esito è stato positivo. Questo sistema ci ha permesso di arrestare molti latitanti e di interrompere lunghe catene di morte.
Come è successo, per esempio, nel caso della faida di Misilmeri.
Non dovrei essere molto orgoglioso di questa indagine che ho condotto applicando in maniera scientifica e pressoché perfetta il metodo sleale dei bracconieri, ma i risultati sono stati eccezionali.
Da diversi anni non si riusciva a comprendere cosa stesse accadendo in quel territorio compreso tra Misilmeri, Marineo e Belmonte Mezzagno, a una quindicina di chilometri da Palermo. Morti ammazzati, persone scomparse nel nulla, intere famiglie decimate. E nessun colpevole. Decido di giocare il tutto per tutto. Ottengo un provvedimento di custodia cautelare a carico dei soggetti legati a un certo gruppo mafioso e, di proposito, ne lascio libero solo uno: Cosimo Lo Forte, ventotto anni, figlio adottivo di un uomo d’onore di Misilmeri inghiottito dalla lupara bianca due anni prima. Nel frattempo Michele Facciorusso, il bravissimo capitano dei carabinieri della compagnia di Misilmeri, tiene il giovanotto sotto controllo.
Ma faccio ancora di peggio. Nel provvedimento di custodia cautelare inserisco indiscrezioni, mezze parole, allusioni da cui si poteva dedurre che la sorte di Cosimo era segnata.
Appena quattro giorni dopo Lo Forte abbocca: si presenta spontaneamente dal capitano dei carabinieri e poi nel mio ufficio. Ha paura, non ha più amici liberi, nessuno che lo protegga. Gli ho fatto terra bruciata intorno: ha capito che la prossima vittima non può che essere lui. Così decide di collaborare. Durante il suo primo interrogatorio mi indica il posto dove è nascosto l’arsenale della cosca. Sospendo brevemente il verbale, mando Michele Facciorusso a fare il sopralluogo e continuo a interrogare il «picciotto» che mi racconta le dinamiche che avevano determinato quella lunga serie di morti ammazzati a Misilmeri e dintorni. Dopo poco più di un’ora Michele mi chiama al telefono: «L’ho trovato. È incredibile! Devi venire a vedere».
I carabinieri di Misilmeri avevano scoperto decine e decine di fucili, pistole, mitragliette e kalashnikov, sepolti in una serra abbandonata. Migliaia di proiettili, alcuni chili di tritolo, esplosivo da cava, nitrato d’ammonio, bombe a mano, granate anticarro, un lanciarazzi con decine di munizioni e cariche supplementari di lancio e perfino un lanciamissili Rpg 18 di produzione sovietica.
La stessa sera, grazie alle dichiarazioni di Cosimo Lo Forte, eseguiamo una dozzina di fermi e, da quel momento e per almeno un paio d’anni, nessun cronista di «nera» si è più dovuto occupare di quella zona. Temporaneamente pacificata. Ma perché le indagini diano i frutti sperati è fondamentale che «i cacciatori» vadano tutti nella stessa direzione, che non si sovrappongano, che non si intralcino a vicenda.
Tullio e Tony
Come prima indicazione ci fa il nome di un certo Tony, personaggio chiave nella tutela della latitanza di Leoluca Bagarella: «È il suo autista,» ci dice «il factotum, l’uomo di fiducia. Cercate lui!». E aggiunge che questo Tony ha un negozio d’abbigliamento in corso Tukory, nei pressi della stazione di Palermo. Lo spunto sembra valido e non ci metto molto a identificare Tony in Antonio Calvaruso, nome che non mi è nuovo.
Avevo già avuto modo di conoscerlo qualche anno prima, nel 1991, quando ero sostituto procuratore a Termini Imerese. Mi era capitato di arrestarlo, addirittura, con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione e frode in commercio insieme con il suo amico e datore di lavoro Tullio Cannella, uno dei tanti costruttori palermitani in odore di mafia, ed esperto più di chiunque altro in truffe e raggiri.
I due avevano aperto un locale notturno e lo gestivano per conto dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, i boss di Brancaccio. Con grande fantasia l’avevano chiamato Les Tours d’Orient, le Torri d’Oriente, un nome francese per dare al night un tocco di classe. In realtà era un postribolo, una specie di balera dove venivano fatte prostituire giovani ragazze straniere: rumene, sudamericane, africane. Le Torri costituivano la costruzione centrale dell’Euromare Village, un signorile residence sulla spiaggia, con numerosi miniappartamenti, in località Buonfornello, ai confini di Termini Imerese. A pochi chilometri da Palermo.
Un complesso immobiliare del valore di miliardi di lire, un affare nelle mani delle cosche. Come investimento fruttava bene. Anche il night. Al piano terra c’era il locale, con tavolini, divani, piano bar, luci soffuse e séparé. Al primo piano le stanze da letto delle giovani entraîneuses.
Gli avventori venivano letteralmente spolpati, obbligati a fare una consumazione ogni quarto d’ora: quarantamila lire a bicchiere, che all’epoca non erano certo poche. Per le ragazze, invece, c’era una bevanda speciale, anche questa obbligatoria, chiamata pomposamente «il messicano»: zucchero, limone e acqua. Un miscuglio torbido e totalmente analcolico che all’ignaro cliente, voglioso di far ubriacare la compagna, costava un’aggiunta di altre trentacinquemila lire.
C’era poi la lista delle superconsumazioni, ovviamente con truffa inclusa: semplice spumante spacciato come champagne di grande marca. Travasavano del comune Asti Cinzano in bottiglie vuote di Dom Perignon del ’62, e il gioco era fatto: «Minchia come è buono questo sciampagne» dicevano i clienti contenti.
Bevevano bollicine direttamente dalle scarpe delle fanciulle, così si usava, e non capivano più niente. Tullio Cannella e Tony Calvaruso erano i re di queste «notti d’oriente», il Gatto e la Volpe, li avevo definiti. Anni dopo i loro nomi ritornano.
Un libro mastro da decifrare e un lanciamissili sotto i cuscini del divano.
Romeo è ormai inarrestabile. Ricorda e racconta. Ci conduce in un altro luogo dell’orrore. In un villino a Bolognetta, una ventina di chilometri da Palermo, di proprietà di Salvatore Giuliano, il padre di Francesco, quello dell’attentato alla Galleria degli Uffizi. Nella casa di campagna dei Giuliano c’è un’altra camera della morte, un «laboratorio» specializzato nello scioglimento dei cadaveri. Con un metodo davvero raccapricciante: i corpi vengono messi a bagno nell’acido, solitamente quello usato dai gioiellieri per pulire i metalli preziosi, un liquido biancastro come il latte, ma che, a contatto con un corpo umano, reagisce friggendo come olio bollente.
Per accelerare il dissolvimento, mi spiega Romeo, si usa mettere il cadavere in un fusto di lamiera sopra un grosso bruciatore a gas, del tipo di quelli adoperati normalmente per preparare la conserva di pomodoro. E si fa bollire. In questo modo si alza la temperatura dell’acido e i tempi di scioglimento si dimezzano. Un corpo arriva a sparire completamente – mi racconta Romeo con l’aria del chimico esperto – in tre o quattro ore, tempi che si abbassano ancora se, durante quella macabra bollitura, qualcuno rimescola con un bastone.
Alla fine non resta niente. Soltanto l’oro. Il contenuto del bidone viene disperso nel terreno e in superficie rimangono solamente la fede e le protesi dentarie che si usavano qualche tempo fa. Anello nuziale e denti vengono recuperati e distrutti a martellate.
Ma, si sa, il calcio in Italia qualche volta blocca gli orologi, il tempo. Soprattutto se gioca la Nazionale e se si disputa il campionato del mondo. Alla regola non sfuggono nemmeno i mafiosi. Così, in una di queste occasioni, con la partita che stava per iniziare, non avevano atteso che il cadavere del malcapitato di turno si dissolvesse completamente nell’acido. Non rimaneva altro da fare che spartirsi i pezzi di femore o di tibia residui per lanciarli, dalle auto in corsa, nelle scarpate della strada a scorrimento veloce prima di tornare a casa. Resti umani poi finiti chissà dove e che non ci è mai stato possibile recuperare.
Un’altra barbara prassi del gruppo di fuoco di Mangano era quella di rovistare tra le tasche della vittima e, con i soldi trovati, comprare qualcosa da mangiare nell’attesa dello scioglimento del cadavere. Giovanni Ciaramitaro, un collaboratore di giustizia affiliato allo stesso gruppo, mi ha raccontato che una volta lo avevano incaricato di andare in paese, a Bolognetta, a prendere qualche panino con i soldi sottratti a un giovane ladro appena strangolato. Tornato al villino aveva trovato Gaspare Spatuzza che mescolava con un manico di scopa nel bidone pieno d’acido e che, evidentemente affamato, gli aveva chiesto il panino: «Cu ‘na manu manciava e cu l’avutra arriminava!». Con una mano mangiava e con l’altra rimestava!
Un elenco di soprannomi improbabili
Proprio spietati gli uomini di Mangano. Eppure i loro soprannomi sono così buffi, quasi spiritosi. Alcuni prendono spunto dalle loro caratteristiche fisiche: Giovanni Ciaramitaro, per la sua obesità, è detto ‘U pacchiuni; Giorgio Pizzo è Topino per la morfologia del suo viso che ricorda quella del comune roditore; Gaspare Spatuzza, per l’incipiente calvizie, è ‘U tignusu; Giovanni Garofalo, contrabbandiere e spacciatore, è Culo di paglia per il suo sedere un po’ molle e sproporzionato; Luigi Giacalone, irsuto lupo di mare, è detto Barbanera, come il pirata; Salvatore Faia è Il gobbo, per un lieve difetto fisico; Giuseppe Orilia, esattore del pizzo, è detto ‘U rollò, perché le numerose pieghe della sua corporatura richiamano l’omonimo indigeribile pezzo di rosticceria palermitana preparato con wurstel, pomodoro e qualcosa di simile alla mozzarella. Fifetto Cannella viene chiamato Castagna per la sua straordinaria somiglianza con il presentatore televisivo. Lo cattureremo solo il 24 aprile 1996 a conclusione di una fruttuosa indagine che i ragazzi della Criminalpol hanno voluto, appunto, denominare «Operazione Stranamore» alludendo proprio alla nota trasmissione di Alberto Castagna. Pietro Romeo, infine, è ‘U pitruni, per l’assonanza con il suo nome di battesimo e per la sua massiccia mole e forza fisica; insomma, una sorta di «Cosa» dei Fantastici quattro. Altre volte i soprannomi si riferiscono a caratteristiche comportamentali o al ruolo svolto. Così Francesco Giuliano è detto Olivetti, come la nota marca di computer, per la sua precisione nello svolgere i compiti che gli assegnavano; Cosimo Lo Nigro è Bingo per la sua passione per le scommesse all’ippodromo; Pasquale Di Filippo, per i suoi modi un po’ affettati, è La dama; Salvatore Grigoli, tiratore abilissimo, è Il cacciatore; Giuseppe Barranca, altro killer di punta del gruppo che arresteremo il 23 dicembre 1995 seguendo la sua donna, lo chiamano Ghiaccio per la sua freddezza nell’eseguire gli omicidi; Nino Mangano, reggente e contabile del mandamento di Brancaccio-Ciaculli, è ovviamente ‘U signuri, mentre l’appellativo di Madre natura spetta, altrettanto ovviamente, al capo titolare detenuto, Giuseppe Graviano. Salvatore Benigno è detto ‘U picciriddu, il ragazzino, per quella sua aria da personcina per bene. Tanto per bene da indurre l’intero paese di Misilmeri, sindaco in testa, a organizzare una fiaccolata per richiederne la scarcerazione.
Un elenco dei soprannomi di mafia lo avevamo trovato subito dopo la cattura di Bagarella, a giugno, nel covo in cui abbiamo arrestato Nino Mangano. Si trattava di un vero e proprio libro mastro, un brogliaccio dove erano segnate entrate e uscite, dove erano indicati traffici di droga, estorsioni, spese correnti, incarichi affidati e portati a termine. E c’erano tutti questi strani nomignoli accanto a ogni annotazione. Per i mafiosi, un modo per camuffarsi meglio.
Senza l’interpretazione autentica di Pasquale Di Filippo e di Pietro Romeo difficilmente avremmo saputo a chi si riferissero quelle indicazioni che sono state preziosissime nelle indagini e nei processi.
Ma – me lo dirà Romeo mesi dopo – nella perquisizione del covo di Mangano gli agenti non avevano notato un dettaglio non proprio secondario. Sotto i cuscini del divano del soggiorno era nascosto un lanciamissili Rpg 18 che, forse per la banalità del nascondiglio, era sfuggito alla perquisizione della Dia.
Romeo, nel primo periodo della sua collaborazione, vive notte e giorno con gli agenti della Criminalpol e della squadra mobile di Palermo e, in fondo, aveva ragione Santino Giuffrè: è un ragazzo semplice e di buon carattere, anche se l’aspetto è un po’ rozzo e parla uno slang incomprensibile. Per indicarmi che in un certo luogo avevano seppellito qualcuno, per esempio, mi dice che l’avevano vurricatu, participio passato di un verbo del siciliano antico che io avevo appreso, ragazzino, da mia nonna.
Negli anni successivi alla scarcerazione, però, Romeo ha fatto passi da gigante, e me ne vorrei prendere un po’ di merito. Nei tanti colloqui che ho avuto con lui, gli ho insegnato a esprimersi in un italiano decente. Anni dopo l’ho sentito deporre in un dibattimento: al confronto dei suoi primi interrogatori sembrava quasi un professore universitario.
All’inizio comunicava quasi a grugniti. Dovevamo decifrare quel che diceva prima di trascrivere le sue dichiarazioni. Le prime registrazioni degli interrogatori di Romeo sono praticamente incomprensibili. Una volta, a Milano, andò a interrogarlo per due o tre giorni la bravissima collega romana Olga Capasso. Tornò a Palermo arrabbiatissima, con una paginetta e mezzo di verbale appena: non era riuscita proprio a capirlo, a comprendere il suo siciliano stretto.
Per me era decisamente più facile, perché il modo di parlare di Romeo mi ricordava il dialetto del mio paese. Termini arcaici che si usano ancora talvolta nelle campagne e che mi avevano affascinato ai tempi del liceo, quando cercavo di coglierne l’origine: greca, araba, sveva, francese, spagnola. In Sicilia per questo c’è l’imbarazzo della scelta.
Pietro Romeo, da ladro di camion a sicario su commissione
Finita la conferenza stampa, inizio subito a raccogliere le sue confessioni. Mi dice che può farci catturare alcuni latitanti e che è in grado di indicarci i luoghi dove sono seppelliti esplosivi, armi e cadaveri.
Non è un uomo d’onore e non ha vincoli di sangue con Cosa nostra. È solo un semplice affiliato e, in fondo, è un rapinatore, uno dei tanti ladri del quartiere Brancaccio. Uno abituato a impossessarsi dei Tir a mani nude. Non aveva bisogno né di pistole né di coltelli. Appena si avvicinava gli autisti se la davano a gambe: solo vederlo metteva paura.
Era forse uno dei più abili e determinati ladri della sua zona. Rubava tutto e dappertutto: dalle Fiat Uno, la sua specialità, ai tabacchi lavorati, nelle gioiellerie e negli uffici postali. Non faceva altro che rubare. A volte era bravo, a volte un po’ maldestro. Un giorno, a Bagheria, durante una rapina a un camion che trasportava casse di sigarette, per un suo banale errore, aveva quasi rischiato il linciaggio.
Un suo complice che lavorava ai monopoli di Stato gli aveva fatto avere la notizia «buona» e gli aveva fornito i dettagli di alcune consegne di sigarette alle tabaccherie. Individuato il punto debole del trasporto, Romeo con i suoi amici si era messo al lavoro.
Appena il camion carico di casse di sigarette si ferma davanti a una rivendita, mentre i suoi complici tengono autisti e tabaccaio sotto la minaccia delle armi, Romeo si impadronisce del mezzo e salta su. Agilissimo, nonostante la sua enorme mole, si mette alla guida e se lo porta via.
La classica rapina che, con la sua esperienza, fa ad occhi chiusi. Ma nella concitazione dimentica di chiudere bene una delle portiere posteriori. E scappa, con il cassone semiaperto. Nella fuga lo sportello sbatte a ogni curva e qualche cassa di sigarette si perde per strada. Romeo continua la sua corsa. Troppo rischioso fermarsi in centro città per chiudere la porta.
A un incrocio si imbatte in un corteo funebre, con tanto di feretro, prete, parenti vestiti a lutto e tutto il resto. Invece di fermarsi, accelera e sterza per evitare il funerale. Ma la manovra è azzardata. La maniglia in acciaio dello sportello spalancato aggancia una corona di fiori e se la porta via. Non lo avesse mai fatto.
Il camioncino prosegue, con quella corona sbilenca al seguito, con il nastro nero e la scritta «Per il mio amato cognato» che, ormai strappata, penzola dalla ghirlanda funebre. Un gruppo di parenti del morto, coadiuvati dagli impresari delle pompe funebri, si mette all’inseguimento del mezzo, impacciato a districarsi tra gli stretti vicoli di Bagheria. A piedi, correndo a perdifiato, incitati dalle urla degli altri parenti a lutto: «pigghiatilu, ammazzatilu, ‘stu crastu!».
Romeo normalmente non ha paura di nulla, ma questa volta è in preda al panico. Non sa cosa fare. Dagli sbirri si scappa e, poi, al massimo si rischia qualche anno di carcere; i criminali avversari si combattono e, se necessario, si uccidono; ma con i parenti di un morto non si scherza. Soprattutto se sono inferociti e cercano di recuperare la corona del caro estinto che gli hai appena portato via. Porta male, malissimo. Pietro Romeo legge l’incidente come un brutto, terribile presagio. Appena può abbandona il camion con tutto il suo prezioso carico di sigarette. E se la dà a gambe.
Quando mi racconta questo episodio, mentre io mi trattengo a stento dal ridere, mi confessa che non aveva mai avuto tanta paura in vita sua. L’idea di avere mandato all’aria un funerale non lo aveva fatto dormire per alcune notti. È un ragazzo forte ma semplice e, come tutti i mafiosi, a suo modo religioso e superstizioso al tempo stesso.
Tutto sommato aveva fatto una vitaccia. Rubava quasi sempre in proprio ed era anche capace di colpi milionari. Ma i guadagni non sempre corrispondevano agli sforzi profusi. Anche lui era costretto a versare gran parte degli utili alle famiglie che comandavano in quel territorio.
Una volta, negli anni Ottanta, gli era capitato un furgone carico d’argento. Merce per oltre settecento milioni di lire dell’epoca. Una fortuna! Ma come al solito si era posto il problema del «dazio» da pagare ai boss, che stavolta era particolarmente oneroso. In tutto Romeo, alla fine, era riuscito a intascare appena una decina di milioni.
In Sicilia anche i rapinatori devono corrispondere il pizzo alla mafia. Del ricavato di ogni colpo rimane loro una piccola percentuale calcolata sul valore complessivo della merce: più è alto, più si abbassa la quota di utili che rimane al ladro. Il resto se lo prende Cosa nostra, senza aver mosso un dito.
A Romeo questo sistema proprio non andava giù. Ma d’altra parte non aveva scelta. Anzi, si era trovato di fronte a un bivio: stringere i rapporti con i boss e diventare un mafioso, oppure rischiare di non lavorare più. O, peggio, di essere eliminato come era già accaduto ad alcuni suoi amici e «colleghi». Aveva optato per la prima soluzione e, per le sue indubbie capacità criminali, era stato arruolato nel gruppo di Nino Mangano, e, quindi, di Leoluca Bagarella, diventando uno dei sicari più esperti e affidabili.
L’affiliazione Da rapinatore ad «affiliato» di Cosa nostra il passo è breve. Aveva già fatto il suo primo omicidio utilizzando armi da fuoco. Ma sparare non era proprio cosa sua. Aveva sbagliato più volte la mira, gli si era inceppato il fucile, aveva dovuto ricorrere a una pistola con cui, per errore, aveva ferito donne e bambini. Insomma, era un pessimo tiratore. Al seguito di Mangano e Bagarella, si era specializzato invece negli strangolamenti: «Iu» mi dice candidamente «eru sempri chiddu ca tirava ‘a corda».
Gli affiliati sono i soldati semplici, la base dell’associazione mafiosa. Uomini totalmente a disposizione dell’organizzazione, che intascano un vero e proprio stipendio. Non tantissimo: all’epoca due milioni, due milioni e mezzo di lire al mese. Ma poi ci sono i bonus, gli extra, e soprattutto lo «status» e la possibilità di salire nella scala gerarchica, di fare carriera, di diventare uomo d’onore: un cittadino a pieno titolo di quello Stato illegale che è Cosa nostra, con tutti i diritti e i doveri conseguenti.
L’affiliato, che a differenza dell’uomo d’onore non ha mai ricevuto la punciuta (la puntura di spina di arancio selvatico al dito nel corso della classica cerimonia del giuramento mafioso), non è certo irriducibile e quando si vede davanti la prospettiva dell’ergastolo, in momenti in cui lo Stato manifesta una chiara determinazione nel contrasto al fenomeno mafioso, spesso non ci pensa due volte e vuota il sacco.
Come fa Pietro Romeo, che si dimostrerà nel tempo uno dei più fruttuosi collaboratori di giustizia. Testimone dalla memoria eccezionale, sincerissimo, attendibilissimo. Almeno apparentemente, non si pone alcuno scrupolo morale. «’Sti crasti manco mi davano i sordi p’a benzina.» «I soldi per fare il pieno alla macchina?» gli chiedo. «Ma quali machina! La benzina da mettiri ‘nti i biduna p’abbrusciari i negozi ca nni dicivanu iddi: chiddi di i commercianti ca nun pagavanu ‘u pizzu!»
Le prime fasi della sua collaborazione sono particolarmente attive, dinamiche. Con grande precisione e semplicità, col suo dialetto stretto stretto, pieno di sgrammaticature, Romeo accompagna la polizia in un viaggio mozzafiato fatto di rifugi, cadaveri e luoghi sinistri. Viene messo a bordo di una «balena», un normale furgoncino con delle feritoie camuffate da cui è possibile vedere senza essere notati. Un veicolo chiamato balena, proprio come quella di Giona, con la differenza che dentro questa specie di cetaceo meccanico non c’è un profeta, anche se di cose ne sa ugualmente tante. E ce le dice.
Indica, guida, indirizza: un latitante qui, un covo là. Lì un deposito di armi, qua un cadavere sotterrato.
I compari da arrestare
La notte stessa del suo arresto Romeo ci porta ai nascondigli dei suoi compari irreperibili. Ce ne fa catturare tre sul momento: Cosimo Lo Nigro, Francesco Giuliano e Salvatore Faia. Anche loro giovani rapinatori passati al servizio della mafia, ora affiliati di Cosa nostra, i primi due armati e responsabili di numerosi omicidi.
Lo Nigro e Giuliano sono anche quelli che, nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, avevano collocato il Fiorino Fiat imbottito di esplosivo sotto la Torre del Pulci, accanto alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Gli autori materiali della strage di via dei Georgofili, gli esecutori del più grave attentato al nostro patrimonio artistico e, non lo si deve dimenticare, gli assassini di cinque persone innocenti. Un rapido giro per Palermo e dintorni con Romeo sui mezzi della polizia di Stato: «Qui ci sta Lo Nigro; quello è l’appartamento dove va a dormire Giuliano; là troverete certamente Faia». Tutto facile, tutto semplice. Il quarto latitante di cui Romeo conosce l’indirizzo, Gaspare Spatuzza, ci sfugge per un soffio.
Poi si passa alla ricerca delle armi. Cominciamo da un arsenale nascosto in un posto che Pietro Romeo chiama «la machina dell’acqua». Una grossa pompa a servizio di un pozzo che eroga, ovviamente a pagamento, acqua nella zona di Corso dei Mille. Uno dei tanti pozzi privati che esistono a Palermo in barba alla legge che attribuisce al demanio la proprietà delle acque sotterranee di pubblico interesse.
Sotto la cisterna troviamo numerose armi automatiche da guerra di straordinaria pericolosità: i mitici Uzi, piccole ma efficacissime mitragliette di fabbricazione israeliana, e le omologhe Skorpion americane.
Romeo ci porta anche a un deposito di un paio di quintali di esplosivo, sotterrato nelle campagne di Ciaculli. Un materiale particolare, proveniente dal mare, dalle vecchie mine che erano state disseminate al largo del porto di Palermo durante la seconda guerra mondiale.
Ogni tanto qualcuno di questi ordigni rimaneva impigliato nelle reti dei pescatori che lo tiravano su insieme al pesce di paranza. Invece di chiamare il genio militare e consegnare i reperti bellici, i pescatori li portavano a riva, sulla spiaggia, e li rivendevano alla mafia. Un modo come un altro di arrotondare i loro non certo cospicui guadagni.
Le mine, completamente ossidate e arrugginite, venivano quindi svuotate del loro contenuto. Dentro c’era tritolo, tritolo pietrificato, perché rimasto sigillato in mare per decenni; ma pur sempre tritolo. Portato in una cava, veniva macinato fino a diventare polvere e poi messo ad asciugare al sole per eliminare le residue tracce di umidità. A quel punto l’esplosivo era tornato perfettamente attivo, perfettamente utilizzabile.
Una parte di questo tritolo doveva servire, secondo le dichiarazioni di molti collaboratori, a far saltare in aria il commissariato di Brancaccio a Palermo, che in quel periodo stava facendo «troppe» indagini sul territorio, soprattutto sul fenomeno delle estorsioni ai commercianti.
Le armi fatte ritrovare Le conoscenze di Pietro Romeo superano anche lo stretto di Messina. Ci conduce a Formello, nei dintorni della capitale che raggiungiamo rapidamente e riservatamente grazie a un Observer, il piccolo ed economico aereo che ha a disposizione la polizia di Stato.
Nei pressi della Cassia bis, interrato in una buca, troviamo più di un quintale di esplosivo. Questa volta la qualità è diversa da quel vecchio tritolo ripescato dal mare. Siamo davanti a un tipo di materiale deflagrante molto più moderno, una sorta di miscuglio di T4 e semtex in balle. Roba da far saltare in aria mezzo quartiere, ma non era questo l’obiettivo di chi lo aveva sotterrato lì.
L’esplosivo ritrovato a Formello era la parte rimanente di quello utilizzato per commettere, nell’aprile 1994, il fallito attentato al pentito Salvatore Contorno ed era stato occultato nella campagna romana in attesa di essere trasferito a Pisa, quando sarebbe arrivato l’ordine di far saltare la Torre. Sì, proprio la Torre di Pisa. Progetto vero, questo. Ideato in linea di massima e messo in agenda da Cosa nostra nell’ambito della strategia delle bombe del ’93. E che poi per fortuna non fu attuato. «Se un giorno Pisa si trovasse senza la Torre…» Questo era il messaggio che i boss, guidati dalla regia di Leoluca Bagarella, mandavano in quei giorni.
Operazione “terra bruciata” per scovare i grandi latitanti
Arrivo a Palermo nel 1993, dopo quattro anni passati alla vicina procura della Repubblica di Termini Imerese. L’anno si apre con la cattura di Totò Riina, «capo dei capi» di Cosa nostra, e con l’insediamento al vertice della procura palermitana di Gian Carlo Caselli. Comincia una nuova era nella lotta alla mafia.
Proprio qualche mese dopo l’arresto di Riina, Cosa nostra porta la sua sfida nel cuore dello Stato. Il tritolo mafioso esplode a Firenze, a Roma, a Milano. I corleonesi non si arrendono, anzi, rilanciano. Bisogna fermarli e, per farlo, occorre in primo luogo arrestare i latitanti. La lista è lunghissima. Sono tutti cosiddetti «pezzi da novanta» e tutti introvabili. Controllano il territorio metro per metro, sono protetti da una rete di centinaia e centinaia di persone, maneggiano armi ed esplosivi. Sono il cuore e l’anima di Cosa nostra.
Scovare i latitanti diventa l’obiettivo numero uno della procura di Caselli: sembra un’impresa ardua, disperata. Nonostante anni e anni di processi e condanne, i capimafia sono quasi tutti liberi. Liberi di ammazzare, di far saltare in aria magistrati, poliziotti e carabinieri, di devastare il patrimonio artistico italiano, di violentare il territorio dello Stato, di imporre il loro dominio assoluto sull’economia siciliana.
Ma il momento è estremamente favorevole. È un momento in cui la società civile, messa a dura prova dalle stragi di Capaci e via d’Amelio, si è finalmente schierata dalla parte giusta. È un momento in cui è rinata «la speranza dei palermitani onesti». È un momento in cui da Roma giungono segnali forti e, finalmente, inequivocabili. E i risultati arrivano.
Un lungo elenco di boss da catturare Decine e decine di latitanti vengono, come si dice, «assicurati alla giustizia». Cifre da record. L’elenco dei mafiosi irreperibili che ho contribuito a catturare è piuttosto lungo e pesante.
«Capimandamento» come Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Nino Mangano, Pietro Aglieri, Mico Farinella, Nicola Di Trapani, Vito Vitale. Componenti di gruppi di fuoco e responsabili di stragi e decine di omicidi, come Fifetto Cannella, Pino Guastella, Pietro Romeo, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Peppuccio Barranca, Enzo Salvatore Brusca, Giovanni Ciaramitaro. E poi tantissimi influenti «uomini d’onore» come Carlo Greco, Pinuzzu La Mattina, Natale Gambino, Calogero Battista Passalacqua, Bernardo Bommarito, Biagio Montalbano, Paolo Alfano, Melo Zanca, Salvatore Gallina...
Risultati mai più raggiunti dopo. Eppure quegli anni, gli anni della procura di Caselli, vengono malevolmente ricordati solo per i processi ai politici o, peggio, per i cosiddetti «processi politici».
Per me e per gli altri colleghi, invece, quel periodo ha segnato la rivincita delle istituzioni sullo strapotere della mafia. Il momento in cui, dopo tanti anni, lo Stato si riappropriava almeno temporaneamente del suo territorio: Cosa nostra veniva messa in ginocchio e, soprattutto, crollava definitivamente il mito dell’inafferrabilità dei boss. Uno dopo l’altro finivano in manette.
Ogni indagine ha la sua storia. Ci sono investigazioni basate su intercettazioni ambientali, altre su pedinamenti o sofisticate tecnologie. Alcune partono da una soffiata e altre sono invece il frutto di un’idea originale, di un guizzo, di un’intuizione. La cosa fondamentale è capire il modo in cui il latitante si muove, quali sono i suoi legami, i suoi contatti, pensare come lui, entrare nei suoi panni, quasi immedesimarsi.
E per farlo bene è necessario anche saper parlare la sua lingua e quella delle persone che gli stanno
vicino. Cogliere le sfumature delle espressioni, collocare ogni frase, ogni parola nel giusto contesto. Il dialetto dell’Isola è spesso subdolo. Per esempio: in certe zone, l’imperativo moviti può significare muoviti ma anche stai fermo, a seconda del tono della voce usato. Oppure ancora: in dialetto non esiste il verbo al futuro. Forse sarà a causa del nostro atavico fatalismo…
Solo un siciliano può capire fino in fondo un altro siciliano, senza interpreti o traduttori. Un mio collega d’origine milanese era sul punto di arrestare per estorsione aggravata il capo di un ufficio tecnico comunale che stavamo intercettando per una storia di licenze edilizie. Ascoltando le registrazioni si era convinto che si trattasse di un collettore del «pizzo», equivocando sulle pressanti richieste di denaro che il funzionario faceva ai commercianti del suo paese. Sono riuscito a fermarlo appena in tempo e ho faticato parecchio per fargli capire che il «suo esattore» era, invece, molto semplicemente, il presidente del comitato per i festeggiamenti in onore di sant’Anna, la patrona locale: stava solo raccogliendo i fondi per luminarie, fuochi d’artificio e cantanti.
Sicuramente è molto più semplice lavorare su un latitante che si sposta in contesti cittadini o comunque popolosi, in cui una faccia nuova desta minore attenzione. Nei paesi, invece, o in certi quartieri di Palermo, tutto è più complicato. Sono luoghi in cui spesso lo Stato non può arrivare. Ci si deve fermare, occorre restare fuori e attendere. Si può solo aspettare una mossa falsa. Sapendo che, comunque, non si passa inosservati.
Il latitante si muove con molta circospezione. Conosce e controlla ogni palmo del «suo» territorio. Gioca in casa.
L’esempio emblematico per me è stata la cattura di Vito Vitale, il boss di Partinico. Difficile, perché Vitale prediligeva i paesi dove investigare diventa particolarmente complicato: il forestiero viene notato immediatamente, la presenza di un estraneo profuma di sbirro.
Sul territorio esistono decine di «sentinelle». Dal vecchio contadino al ragazzino di undici anni, dal barbiere al calzolaio, dal barista al venditore di càlia e simenza: sono tutte vedette, piccole vedette di mafia.
La notizia che c’è uno sconosciuto in giro passa di bocca in bocca in tempo reale. E arriva sempre a chi deve arrivare.
Mille occhi a cui non sfugge niente. Occhi particolarmente attenti a riconoscere lo sbirro, anche se è in borghese, anche se è camuffato. Quando arriva, lo strànio viene immediatamente schedato, registrato e segnalato. E il gioco può diventare pericoloso, perché da cacciatori si rischia di diventare cacciati.
Occorre essere molto prudenti, muoversi poco alla volta e con passi felpati. Non esporsi mai. Lavorare sottovento affinché la preda non senta l’odore del cacciatore. Anche nei pedinamenti bisogna fare molta attenzione e agire di fantasia: la classica coppietta della polizia, un uomo e una donna che magari fanno finta di baciarsi, viene subito individuata. O peggio ancora due uomini in macchina che sfogliano distrattamente un giornale. L’odore di sbirro lo sentono da lontano. E «loro» non sbagliano quasi mai.
Molti carabinieri in quegli anni, per esempio, sono costretti a uscire in servizio con le loro macchine
private, rischiando anche in prima persona. Le autocivetta dell’Arma, le Fiat Uno che hanno in dotazione, infatti, presentano un banalissimo dettaglio che le rende riconoscibili agli occhi dei mafiosi: sono le uniche senza poggiatesta. Forse per abbassare i prezzi di produzione e aggiudicarsi la fornitura, la fabbrica torinese non le ha dotate di questo optional che costava poche migliaia di lire in più e che tutti gli acquirenti normali facevano montare sulla propria autovettura. Tante volte mi sono sentito dire da pentiti e mafiosi: «Dutturi, l’ho visto subito che erano sbirri. Avevano la macchina senza poggiatesta».
Ma il lavoro sottovento deve cominciare ancor prima. Già quando inizi a subodorare la pista.
Gli uomini d’onore hanno occhi e orecchie ovunque. Anche nel palazzo di Giustizia. Giovanni Falcone e Rocco Chinnici, pur lavorando in quella sorta di bunker che era l’ufficio istruzione di Palermo, non si sentivano mai sicuri. Quando avevano qualche notizia importante da comunicarsi, lo facevano in ascensore e con pochissime parole. E, nei miei anni a Palermo, l’atmosfera non è certo diversa.
Basta il susseguirsi di riunioni nella stanza di questo o di quel magistrato per mettere sul chi vive gli avvocati che difendono i mafiosi.
Ogni mossa del pool antimafia viene scrutata, passata ai raggi X. E ritrasmessa ai boss. Da figlio di due avvocati, mi dispiace prendere atto del ruolo che spesso hanno alcuni legali di mafiosi. Ce lo raccontano senza remore due pentiti di rilievo come Calogero Ganci e Francesco Paolo Anzelmo: in un paio di occasioni erano sfuggiti in extremis all’arresto proprio perché avvertiti dai loro difensori. No, nessuna talpa o fuga di notizie. Agli avvocati era bastato notare carrelli pieni di blocchi di fotocopie che, dall’ufficio del gip al piano terra, venivano portati al secondo piano, in procura. Non potevano che contenere ordinanze di custodia cautelare da eseguire. Per legge ne occorrono quattro copie: una originale, una da consegnare al destinatario, una per il difensore e la quarta per il carcere. Quei carrelli, dunque, sono la prova inequivocabile di un blitz imminente.
Spesso, per evitare buchi nell’acqua, ci siamo fatti consegnare dal gip un solo provvedimento e abbiamo costretto i cancellieri del tribunale ad autenticare le copie in una caserma dei carabinieri o in questura.
Per sottrarci agli sguardi indiscreti ci riunivamo in qualche ristorante o in uffici che altre amministrazioni dello Stato ci mettevano a disposizione. A volte preferivamo addirittura parlare per telefono potendo contare sugli apparecchi «cripto» di cui il ministero dell’Interno ci aveva dotati, a casa e in ufficio.
Era una vera e propria guerra con tanto di spionaggio e controspionaggio e, come si usa dire, «in guerra e in amore tutto è permesso». Per questo anch’io avevo deciso di usare il metodo, poco sportivo ma obiettivamente efficace, dei bracconieri: quello della terra bruciata.
Una strategia che tante volte si è rivelata vincente. Si deve fare il vuoto attorno agli uomini d’onore oggetto delle indagini. Interrompere la loro ragnatela di protezione lasciando i due o tre fili a noi noti e, con la pazienza del ragno, seguire solo quelli.
Tante volte abbiamo messo insieme tutti i dati di cui eravamo in possesso, anche rinunciando a qualche spunto investigativo, al solo fine di eseguire provvedimenti di custodia cautelare che consentissero di neutralizzare alcuni contatti, sicuri o solo probabili, del latitante.
Il ritorno dei pentiti […] L’arresto di Giovanni Brusca, l’esecutore materiale della strage di Capaci, per esempio. Nei mesi precedenti la sua cattura gli abbiamo praticamente «bruciato» tutti gli appoggi. È stato costretto a correre ad Agrigento perché ormai non aveva più protezioni: non aveva più nessuno su cui contare in casa sua a San Giuseppe Jato. Nessuno ad Altofonte, nessuno a Borgetto, nessuno a San Cipirello. I boss non lasciano quasi mai il loro territorio: «La presenza è potenza» soleva dire Bagarella. Brusca si è allontanato solo perché gli abbiamo «tagliato i fili». Lo stesso è accaduto, per esempio, nel 1997 quando ci siamo trovati davanti al caso di alcuni collaboratori di giustizia che avevano ripreso a delinquere, vicenda passata alla cronaca come «il ritorno dei pentiti». C’era il forte sospetto che Balduccio Di Maggio, Santino Di Matteo e Gioacchino La Barbera, tre fra i più preziosi collaboratori di giustizia, mentre erano sottoposti al programma di protezione si fossero resi responsabili di alcuni delitti nel mandamento di San Giuseppe Jato.
Non sapevamo che pesci pigliare. Non volevamo credere alla possibilità che i tre avessero commesso addirittura degli omicidi. Ma d’altro canto l’ipotesi investigativa sembrava fondata. Così come ugualmente fondata ci sembrava la possibilità che dietro questa storia ci fosse lo zampino di Giovanni Brusca che, finito in carcere, intendeva delegittimare quei pentiti.
Nel dubbio procediamo con l’operazione «terra bruciata». Arrestiamo contemporaneamente tutti i soggetti che riteniamo vicini ai tre collaboratori e a Brusca, e per i quali, ovviamente, abbiamo elementi di prova sufficienti. Così cerchiamo di isolare i due presunti gruppi contendenti. L’operazione va a buon fine. Persi i loro contatti sul territorio, i tre sono costretti a venire allo scoperto.
Le microspie collocate nelle macchine di La Barbera e Di Maggio iniziano a registrare conversazioni interessanti. Di Matteo si sposta in continuazione dalla località protetta e uno dei fermati, tale Giuseppe Maniscalco, comincia subito a collaborare: ci rivela come i tre, approfittando dell’arresto di Brusca, avessero, di fatto, cercato di riprendere il controllo del mandamento di San Giuseppe Jato.
Ho utilizzato spesso la tattica della «terra bruciata». Tutte le volte che i metodi tradizionali non davano i risultati sperati. Era la mia ultima carta e la giocavo solo quando era indispensabile, perché estremamente dispendiosa. Per arrestare le persone che giravano intorno all’oggetto delle indagini bisognava tirare fuori le prove già raccolte, rivelare l’esistenza di intercettazioni telefoniche o ambientali, buttare alle ortiche mesi di pedinamenti. E tutto solo per togliere dalla circolazione qualche personaggio apparentemente minore.
Se la strategia falliva si doveva ricominciare tutto da capo. Come nel caso delle ricerche di Nino Giuffrè, capomandamento di Caccamo dove abbiamo «tagliato» i fili sbagliati e abbiamo fallito. Tante altre volte, però, l’esito è stato positivo. Questo sistema ci ha permesso di arrestare molti latitanti e di interrompere lunghe catene di morte.
Come è successo, per esempio, nel caso della faida di Misilmeri.
Non dovrei essere molto orgoglioso di questa indagine che ho condotto applicando in maniera scientifica e pressoché perfetta il metodo sleale dei bracconieri, ma i risultati sono stati eccezionali.
Da diversi anni non si riusciva a comprendere cosa stesse accadendo in quel territorio compreso tra Misilmeri, Marineo e Belmonte Mezzagno, a una quindicina di chilometri da Palermo. Morti ammazzati, persone scomparse nel nulla, intere famiglie decimate. E nessun colpevole. Decido di giocare il tutto per tutto. Ottengo un provvedimento di custodia cautelare a carico dei soggetti legati a un certo gruppo mafioso e, di proposito, ne lascio libero solo uno: Cosimo Lo Forte, ventotto anni, figlio adottivo di un uomo d’onore di Misilmeri inghiottito dalla lupara bianca due anni prima. Nel frattempo Michele Facciorusso, il bravissimo capitano dei carabinieri della compagnia di Misilmeri, tiene il giovanotto sotto controllo.
Ma faccio ancora di peggio. Nel provvedimento di custodia cautelare inserisco indiscrezioni, mezze parole, allusioni da cui si poteva dedurre che la sorte di Cosimo era segnata.
Appena quattro giorni dopo Lo Forte abbocca: si presenta spontaneamente dal capitano dei carabinieri e poi nel mio ufficio. Ha paura, non ha più amici liberi, nessuno che lo protegga. Gli ho fatto terra bruciata intorno: ha capito che la prossima vittima non può che essere lui. Così decide di collaborare. Durante il suo primo interrogatorio mi indica il posto dove è nascosto l’arsenale della cosca. Sospendo brevemente il verbale, mando Michele Facciorusso a fare il sopralluogo e continuo a interrogare il «picciotto» che mi racconta le dinamiche che avevano determinato quella lunga serie di morti ammazzati a Misilmeri e dintorni. Dopo poco più di un’ora Michele mi chiama al telefono: «L’ho trovato. È incredibile! Devi venire a vedere».
I carabinieri di Misilmeri avevano scoperto decine e decine di fucili, pistole, mitragliette e kalashnikov, sepolti in una serra abbandonata. Migliaia di proiettili, alcuni chili di tritolo, esplosivo da cava, nitrato d’ammonio, bombe a mano, granate anticarro, un lanciarazzi con decine di munizioni e cariche supplementari di lancio e perfino un lanciamissili Rpg 18 di produzione sovietica.
La stessa sera, grazie alle dichiarazioni di Cosimo Lo Forte, eseguiamo una dozzina di fermi e, da quel momento e per almeno un paio d’anni, nessun cronista di «nera» si è più dovuto occupare di quella zona. Temporaneamente pacificata. Ma perché le indagini diano i frutti sperati è fondamentale che «i cacciatori» vadano tutti nella stessa direzione, che non si sovrappongano, che non si intralcino a vicenda.
Farinella cade in trappola perché vuole ritirare a tutti i costi il pizzo
Le indagini sul delitto Capomaccio sono affidate alla squadra mobile ma le indicazioni che ho avuto io sono da ricondurre ai carabinieri. Impossibile pensare di far lavorare insieme due diverse forze di polizia sulla medesima pista. Occorre fare una scelta che, per me, a quel punto è obbligata.
I carabinieri di Cefalù conoscono il latitante, conoscono il territorio dove dovrebbe muoversi, conoscono i posti dove può rifugiarsi e, soprattutto, conoscono le persone che gli stanno vicino, a cominciare da Tommaso Armillieri. Affido a loro le ricerche di Mico e alla polizia lo sviluppo delle altre dichiarazioni di Andrea Randazzo. Visibilissimo il disappunto di Luigi Savina, che dirige la squadra mobile da poche settimane, quando gli comunico le mie decisioni. Ma non posso fare diversamente. Successivamente diventerò amico di quel bravissimo poliziotto. Ci legheranno sincero affetto e grande stima reciproca, ma il nostro rapporto non nasce certo in quell’occasione. Farinella, legatissimo a Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella ai quali aveva anche fornito appoggi durante la latitanza, in quel momento, è una preda troppo ambita. E poi le indicazioni di Michele Capomaccio e Andrea Randazzo sembrano buone. Per la polizia non è facile rinunciare. Arriva anche qualche pressione dall’alto perché io riveda la mia decisione. Ne parlo pure con Caselli che riconosce la mia autonomia e mi dà il conforto necessario sulla correttezza della mia scelta. L’iniezione di fiducia da parte del mio capo è fondamentale per me. È la prima volta che mi metto, da solo, sulle tracce di un latitante di mafia. Per quanto avessi maturato una discreta esperienza con alcuni rapinatori ai tempi di Termini Imerese, il confronto con gli uomini d’onore che si sono resi irreperibili è tutta un’altra cosa.
L’obiettivo principale è ovviamente Tommaso, il venditore ambulante di biancheria. Si capisce subito che l’indicazione è buona. I carabinieri di Cefalù pensavano di seguirlo discretamente nei suoi giri ai mercatini dei paesi delle Madonie e della costa, pensavano di vederlo vendere lenzuola e federe e litigare sul prezzo con casalinghe parsimoniose. Invece in quei giorni si muove come un manager. Si sposta con una vecchia ma sgusciante Autobianchi A112, incontra imprenditori, commercianti, avvocati, gioiellieri e, tanti, sospetti mafiosi. E resta quasi sempre a Palermo. Troppo rischioso per i militari di Cefalù farsi vedere in città. Il venditore di biancheria madonita potrebbe riconoscerli. È necessario fare intervenire gli uomini del Ros con i loro volti anonimi, le loro facce sconosciute e la loro straordinaria capacità di muoversi nell’ombra, silenziosamente e discretamente.
I carabinieri fanno un ottimo lavoro e, già il giorno dopo l’inizio dei pedinamenti, emerge un dato interessante. Tommaso, in uno dei suoi frenetici giri per Palermo, finisce in via Lincoln, la larga strada che dalla stazione ferroviaria arriva fino al mare. Grandi magazzini di abbigliamento, negozi di prodotti per l’agricoltura e di mobili di qualità improbabile, la sede del «Giornale di Sicilia», l’ingresso dello splendido Orto botanico e, al numero 159, il negozio di scarpe di Robertino borotalco. Proprio lì Tommaso si ferma per qualche minuto e poi va via.
La pista del venditore ambulante La conferma decisiva della bontà della pista che abbiamo imboccato arriva l’8 novembre. I carabinieri hanno seguito discretamente Tommaso e, verso le otto di sera, lo hanno visto entrare in un complesso edilizio di fronte all’Università degli Studi, uno di quei mostruosi condomini con dieci ingressi, venti scale e mille interni, con i balconi rigorosamente chiusi, in barba alle leggi urbanistiche, da «rimovibili», si fa per dire, verande in alluminio e plexiglas. Ironia della sorte quella via è intitolata proprio a Ernesto Basile, il grande architetto che, tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, aveva fatto di Palermo una delle più belle città d’Europa.
È già buio e i carabinieri non sono riusciti a capire in quale di quella miriade di appartamenti si è
infilato Tommaso e allora decidono di aspettarlo, ma sono costretti a posizionarsi lontano, rintanati in una macchina parcheggiata in una zona non illuminata. Fortunatamente a Palermo non tutti i lampioni funzionano.
Dopo una ventina di minuti Tommaso esce dal palazzo e, a passo veloce, si dirige verso la sua A112. Pochi secondi dopo dallo stesso cancello d’ingresso, al numero 160, escono altri due uomini e uno è proprio lui, è Mico Farinella. I carabinieri ne sono sicuri. Hanno visionato decine di foto del latitante e hanno passato ore a vedere e rivedere il filmato delle nozze di Massimo Capomaccio facendo attenzione a come si muoveva uno dei testimoni dello sposo.
Ma non c’è tempo per riflettere. I due uomini salgono su una moto parcheggiata proprio lì, una Honda Africa Twin, e spariscono zigzagando tra le macchine che affollano anche a quell’ora via Basile. Una scena analoga si ripete l’indomani sera, alla stessa ora. Seguendo Armillieri, i carabinieri giungono davanti a una gioielleria. Dopo un quarto d’ora Tommaso esce dal negozio e dietro di lui Mico con lo stesso uomo del giorno precedente. Stavolta però i carabinieri fanno almeno in tempo a prendere il numero di targa della grossa enduro. È una moto pulita, intestata a una persona pulita: Giuseppe Mammano, trent’anni, palermitano, consulente finanziario. Il nostro uomo, adesso, dovrebbe diventare lui.
È già difficile pedinare una persona che si muove con un’auto, figuriamoci se si sposta su due ruote. E poi Mammano è attentissimo. Non si ferma agli incroci, passa con il rosso, imbocca vie contro senso. Al massimo rischia qualche multa ma così, per lui, è facile accorgersi se qualcuno lo sta seguendo perché è costretto a fare le sue stesse manovre spericolate. Nei giorni successivi gli investigatori lo perdono in continuazione. Ovviamente si decide di non mollare Tommaso. Si prova a seguirli tutti e due. Ma non emerge nulla di rilevante fino al 22 novembre quando la cosa sembra proprio fatta.
Il Ros non interviene. Alle 18.30 Armillieri e Mammano si incontrano al Foro italico e, il primo con la macchina e il secondo con la moto, imboccano la vicina via Lincoln e si fermano davanti al negozio di Robertino borotalco. Una rapida occhiata in giro e i due entrano.
Sul posto ci sono diversi uomini dei carabinieri, quelli che seguivano Tommaso e quelli che, con le moto, erano dietro a Giuseppe. L’occasione sembra ottimale. Tutti i protagonisti delle nostre indagini si trovano contemporaneamente nello stesso luogo. Anche Mico deve essere lì.
Infatti dopo un’oretta il figlio di don Peppino esce dal negozio ma, caso strano, nemmeno stavolta i militari riescono a bloccarlo, e dire che sono lì in forze. Mico sale sulla moto di Mammano e sparisce con lui per le strade di Palermo.
Questa, almeno, è la versione che mi viene fornita dal Ros. Non ne ho la certezza matematica ma nutro il più che legittimo sospetto che, almeno questa volta, i carabinieri avessero deciso appositamente di lasciarlo andare. Teoricamente non era una brutta idea. L’indagine stava andando bene e nessuno dei soggetti seguiti si era accorto di nulla. Avevamo già isolato almeno tre contatti sicuri: Tommaso, Giuseppe e Robertino; era anche emerso qualche elemento di contorno dalle intercettazioni telefoniche ed erano stati identificati altri personaggi che comunque gravitavano nell’ambiente del latitante. E poi, soprattutto, nel giro di due settimane avevamo già visto fisicamente Mico per ben tre volte. Se si fosse riusciti a seguire il boss madonita ci avrebbe potuto portare dai due latitanti più ricercati del momento, Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella. Forse è proprio questa l’idea del Ros, idea che non mi viene comunicata e che, in quel contesto, mi avrebbe visto decisamente contrario al pari, per quanto mi è sembrato di intuire, dei carabinieri di Cefalù e di quelli del comando provinciale di Palermo che stavano fornendo ausilio logistico all’indagine.
Non ho ancora una grande esperienza nella ricerca dei latitanti di mafia, ma sono perfettamente consapevole che il contatto che abbiamo stabilito con Mico è troppo flebile. Non conosciamo il suo covo, non sappiamo dove va a dormire e dove va a mangiare, abbiamo difficoltà serie a seguire Mammano, il soggetto che «lo porta». So pure che, quando inevitabilmente verrà meno la riservatezza sulla collaborazione di Andrea Randazzo, le piste Armillieri e Raccuglia andranno definitivamente perse, con il rischio che Mico tagli i ponti con tutte le persone collegate ai due. Il caso vuole, peraltro, che nei giorni che seguono Tommaso Armillieri ritorni a vendere biancheria nei mercati, nessuno si faccia più rivedere al negozio di Robertino borotalco e risulti sempre più difficile pedinare Mammano. Vado su tutte le furie e quasi quasi rimpiango di non aver affidato l’indagine alla squadra mobile. Convoco il responsabile del Ros e gli do un termine: «Se non chiude l’indagine entro il mese di novembre, alle otto del mattino del 1° dicembre le ricerche di Farinella passeranno alla polizia».
Fortunatamente nel frattempo c’è stata una novità interessante. Il 18 novembre il capitano Salsano ha convinto a parlare anche un altro fratello di Massimo Capomaccio, Bruno, trentasette anni, più anziano dell’ucciso e più giovane di Michele. Bruno è uno dei tanti imprenditori edili del Palermitano e ha ricevuto alcune confidenze dai suoi colleghi che si sono aggiudicati appalti nella zona delle Madonie. Non ha granché da nascondere e non ha problemi a rivelarmi tutto quello che sa. Tra l’altro mi dice che suo fratello Massimo, per conto di Mico Farinella, quale acconto del pizzo dovuto, aveva già riscosso quindici milioni di lire da certo Lino Lo Scrudato, un imprenditore del Nisseno che stava realizzando alcuni appartamenti a Cefalù per conto di una cooperativa edilizia. Mico aveva richiesto a Lo Scrudato, che si era confidato con Bruno, altri trenta milioni di lire a saldo che doveva consegnargli a Palermo, presso lo studio tecnico di un geometra, tale Vincenzo Catanzaro. Facciamo la visura all’ufficio registro e viene fuori che la ditta individuale di Catanzaro ha sede in via Ernesto Basile al numero 160, proprio in quel palazzo dal quale avevamo visto uscire Mico la sera dell’8 novembre. Non ci vuol molto a tirare le somme e a decidere di intercettare qualche altro telefono.
Il giorno della cattura Il 29 novembre Lino Lo Scrudato parte da Mussomeli per andare a Palermo. Alle sei del pomeriggio ha un appuntamento presso lo studio del geometra Catanzaro. In una tasca dei pantaloni, assicurate da un paio di elastici, ha trecento banconote da centomila lire.
In via Basile alcuni giovanotti camminano con dei libri sotto il braccio. Sembrano proprio studenti che hanno appena finito le lezioni all’università, dall’altra parte della strada. Ma negli zaini, da cui spuntano mazzi di fotocopie, nascondono pistole Beretta calibro 9 parabellum. La mattina un paio di loro, nella sala ascolto della procura, avevano sentito Lo Scrudato e Catanzaro prendere accordi per vedersi quel pomeriggio. Alle 18, puntualissimo, Lino ferma la sua Fiat 131 targata Caltanissetta in via Basile. Entra nel palazzo al numero 160. Davanti, sul marciapiede, c’è parcheggiata una grossa moto da enduro: una Honda Africa Twin. Il costruttore esce dieci minuti dopo, sale sulla sua 131 e si allontana. La moto è ancora lì, davanti a quel palazzo che farebbe letteralmente rivoltare nella tomba Ernesto Basile, e lì sono ancora gli «studenti universitari». Passeggiano e si scambiano appunti sull’ultima lezione di Economia aziendale o di Scienze delle preparazioni alimentari. Dovranno aspettare ancora un’oretta.
Alle 19.20 dallo studio del geometra Catanzaro escono due persone che ormai i carabinieri del Ros conoscono bene. Dagli zaini spuntano le pistole e prima che Giuseppe Mammano possa prendere le chiavi della moto, gli studenti-carabinieri lo hanno già bloccato e ammanettato così come hanno fatto altri loro colleghi con il suo compagno, con il compare di Massimo Capomaccio, con l’uomo che Giuseppina riconoscerà due giorni dopo in una foto segnaletica: Mico Farinella, reggente del mandamento di San Mauro Castelverde.
In tasca ha trecento banconote da centomila lire fissate con degli elastici. Forse pensava di spenderle per acquistare l’ennesimo Rolex d’oro o per dare un anticipo per una nuova Ferrari. Invece ce le deve consegnare tutte, insieme alla sua libertà.
Chissà cosa ne penserà suo padre Peppino. Lui non sarebbe mai andato personalmente a ritirare il pizzo, troppo imprudente, troppo rischioso. E, soprattutto, troppo poco dignitoso.
Un pool di magistrati per trovare quelli che non si trovavano mai. L’idea vincente di Gian Carlo Caselli è stata quella di individuare un pool di sostituti per ogni mandamento mafioso e, soprattutto, uno o due magistrati quali esclusivi titolari delle ricerche di ciascun latitante, cosicché ogni notizia che riguardasse quel territorio o il ricercato di turno finisse sempre alle stesse persone.
Era il famoso coordinamento investigativo che, almeno in quegli anni, ha funzionato benissimo.
Riunioni periodiche con le forze di polizia «obbligate» a rivelare le loro informazioni su questo o quel latitante; investigatori che venivano fermati perché la loro pista era già stata imboccata da altri colleghi; divisione dei compiti tra poliziotti, carabinieri e finanzieri; nessuna inutile sovrapposizione di indagini.
Certo, ogni tanto qualche problema si verificava ugualmente. È successo proprio a me di autorizzare i carabinieri del Ros a collocare una microspia in un garage in cui ne avevo già fatta piazzare un’altra su richiesta dei loro stessi colleghi del comando provinciale. Eravamo sulle tracce di Pietro Aglieri e il Ros, che si muoveva sulla base di informazioni confidenziali, aveva individuato un magazzino nel quartiere della Guadagna come possibile luogo d’incontro dei favoreggiatori del capomandamento di Santa Maria di Gesù. Mi avevano dato l’indirizzo e il nome dell’affittuario dell’immobile, un presunto uomo d’onore della locale «famiglia» mafiosa. Il garage aveva però un altro ingresso da una via limitrofa, via che mi avevano segnalato i carabinieri del comando provinciale insieme, stavolta, al nome del proprietario. Così non mi ero reso conto che si trattava dello stesso magazzino: erano diversi sia la via sia il nome di colui che ne avrebbe avuto la disponibilità. Ci siamo accorti dell’errore solo a operazione conclusa, quando i carabinieri per poco non si sparavano tra loro al momento di recuperare le rispettive microspie.
Le microspie, le «cimici», sono le nostre orecchie sul territorio, strumenti indispensabili per ogni investigazione. Ma occorre saperle usare. Saper scegliere il posto dove collocarle e, soprattutto, il modo in cui farlo.
Se l’operazione è relativamente facile quando si tratta di una masseria o di un garage in disuso, le cose si complicano quando bisogna entrare nelle abitazioni private. Non è certo una questione di serrature.
Non ne esistono di impossibili. I cosiddetti «chiavari» dei servizi segreti sono in grado di entrare dappertutto e aprono ogni porta senza lasciare tracce. Il problema sorge quando gli inquilini escono poco di casa. Allora bisogna ricorrere a qualche stratagemma che non dia sospetto.
Inutile simulare tentativi di furto o effettuare una perquisizione per collocare una cimice. Altrettanto inefficaci con il passar del tempo sono diventati i falsi tecnici della luce o del gas che si presentano per riparare presunti guasti alla rete. Dopo la «visita» gli abitanti, ormai esperti, effettuano un’accurata bonifica e regolarmente individuano la microspia. Sono arrivati perfino a prenderci in giro. Com’è accaduto qualche volta di fronte alle telecamere disseminate nelle campagne di mezza Sicilia. Una di queste, piazzata male per le vie di Marineo, a pochi chilometri da Corleone, non era stata mimetizzata bene ed era diventata il divertimento dei paesani. Passavano davanti all’obiettivo e salutavano con un inchino: «Buongiorno maresciallo, qui tutto a posto! Omaggi alla sua signora!».
Microspie dappertutto Ci si industria come si può. Si ricorre ad altri metodi per tirare la gente fuori di casa e avere il tempo di lavorare senza il rischio di essere scoperti. Perché non è facile collocare una microspia o una telecamera.
Non basta soltanto aprire una porta. Bisogna stabilire in pochi secondi il luogo migliore in cui nasconderla, tenendo conto di alcune variabili: rumori di fondo e interferenze radioelettriche degli elettrodomestici.
I mafiosi sono particolarmente attenti. Mi ricordo di un colloquio intercettato negli uffici della Dia, la Direzione investigativa antimafia, tra un neopentito e i suoi familiari. Non fu possibile comprendere quasi nulla perché i parenti del collaboratore si erano appositamente portati appresso una bambina che aveva un preciso compito: battere fragorosamente su un tamburo di plastica per tutta la durata della conversazione.
Bisogna anche trovare un posto da cui la cimice possa trasmettere le voci all’esterno. Talvolta non è possibile collegarla alla linea telefonica o installarne una ad hoc e allora è necessario utilizzare apparecchi radio con i conseguenti problemi determinati dalla durata delle batterie, dal rischio di interferenze e dalla necessità di collocare dei ripetitori del segnale.
È materiale sofisticato, che costa parecchio. Alcune forze di polizia avevano acquistato delle microspie, ma gli investimenti non si erano rivelati particolarmente oculati. Si tratta di tecnologia in costante evoluzione e, quindi, dopo un po’ ci si ritrova con strumenti obsoleti e non sempre affidabili.
Io preferivo noleggiare le apparecchiature rivolgendomi a fornitori privati. Dopo una mirata indagine di mercato sul rapporto qualità-prezzo ne avevo individuato uno di cui mi fidavo e con il quale avevo stipulato verbalmente un accordo: tu mi fornisci la tecnologia più avanzata, gli ultimissimi modelli, e mi dai, in tempo reale, l’assistenza necessaria. Se riusciamo a catturare il latitante, ti liquido le fatture per intero. In caso contrario, ti pago solo il venti per cento. In fondo un piccolo prezzo alla lotta alla mafia dobbiamo pagarlo tutti. Lui capisce e accetta. Si sente motivato. E lo dimostrerà fornendoci sempre materiale d’avanguardia e rendendosi disponibile per ogni esigenza.
Mentre siamo in piena fibrillazione nella ricerca di Pietro Aglieri, una microspia smette di funzionare a causa di un blackout sul ponte radio. Sono giorni di scioperi selvaggi nei trasporti aerei. Non si vola.
Quella cimice è decisiva: il fornitore noleggia a sue spese un aereo privato da Milano e due ore dopo è a Palermo a riparare il guasto.
La tecnologia di cui potevamo disporre già in quegli anni ci ha dato una marcia in più. È stata un’arma spesso decisiva per contrastare Cosa nostra e a Palermo siamo stati dei veri pionieri nell’applicarla alle investigazioni. Già a partire dal 1997 avevamo telecamere piazzate a centinaia di chilometri di distanza che riuscivamo a manovrare direttamente dalla questura; computer che ci permettevano di archiviare l’algoritmo del volto del latitante e che poi segnalavano se una persona con quelle caratteristiche entrava nell’obiettivo di una videocamera; localizzatori satellitari con margini d’errore minimi; microspie autoalimentate talmente piccole ed efficienti da poter essere nascoste nell’interruttore di un abat-jour; sofisticati software di elaborazione del traffico telefonico… Abbiamo persino sperimentato un piccolo aeromodello riproducente un Md 80 dell’Alitalia che volava a qualche centinaio di metri dal suolo effettuando riprese video e che, dal basso, sembrava un vero e proprio jet della nostra compagnia di bandiera che viaggiava a 8000 metri di quota.
[…] Mi ero specializzato nella caccia ai latitanti e per questo condividevo con Gian Carlo Caselli un piccolo, innocuo segreto.
Avevo cominciato quasi per gioco nel 1994, scrivendo all’interno della copertina dell’agenda del mio capo l’elenco dei latitanti più pericolosi su cui stava lavorando la procura di Palermo. Da allora all’inizio di ogni nuovo anno ripetevo l’operazione, aggiornando periodicamente la lista dei ricercati.
Dopo ogni cattura entravo nella sua stanza, chiudevo la porta, mi sedevo e, con calma, gli consegnavo un foglietto in cui erano riportate le indicazioni sommarie sulla personalità e il profilo criminale del latitante e sulle operazioni che avevano portato all’arresto, dati necessari a Caselli per l’inevitabile conferenza stampa.
Gian Carlo leggeva attentamente il mio appunto e poi apriva la sua agenda. Lentamente, come fosse un rito. Sorrideva e quindi, senza nascondere la sua soddisfazione, depennava dalla lista il nome dell’arrestato di turno. Con un segno netto di inchiostro verde. Tratto inconfondibile della sua stilografica.
Vincenzina, la moglie del boss che si suicida perché non può avere figli«Buongiorno, signor Bagarella. Come sta?» «Come devo stare, dottore? Tra queste quattro mura.»
È il luglio del 1998. Leoluca Bagarella è di fronte a me, nel carcere di Parma. Un po’ meno arrogante di come l’avevo visto tre anni prima, il giorno del suo arresto.
Fisico tarchiato ma possente, difficilmente riesce a stare fermo, e quando lo fa sono i suoi occhi, piccoli e nerissimi, a muoversi nervosamente, a scrutare ogni cosa. Ha il solito look casual: tuta da ginnastica e scarpe da tennis. Come se fosse sempre pronto alla corsa, alla fuga. All’evasione.
Sono venuto a interrogarlo per un reato minore: minaccia aggravata, pena massima prevista fino a un anno di reclusione. Una bazzecola per uno come lui che di ergastoli definitivi ne ha già parecchi.
L’episodio era avvenuto durante un’udienza del processo per il sequestro e l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo.
In un drammatico confronto a distanza Bagarella aveva fatto uno strano riferimento al figlio del suo ex autista, Tony Calvaruso, il titolare del negozio di corso Tukory che, dopo essere stato arrestato, aveva deciso di collaborare e proprio quel giorno stava deponendo in aula. «Ricordati di Spizieddu» aveva urlato don Luchino dalla sua gabbia nel bunker dell’Ucciardone. Spizieddu, peperino, era il nomignolo con cui il boss corleonese chiamava il figlio di Calvaruso. La frase era suonata come un avvertimento. Da qui l’accusa di minaccia aggravata. L’avvocato di Bagarella non è venuto. Inutile arrivare fino in Emilia per un interrogatorio di routine. «Dottore, oggi avevo intenzione di avvalermi della facoltà di non rispondere, ma visto che c’è lei e che si è fatto tutto questo viaggio…»
Sono strani i mafiosi. Fino a quel momento Bagarella non aveva mai parlato con nessun magistrato.
Adesso decideva di farlo proprio con me, con uno dei pubblici ministeri responsabili della sua cattura e, soprattutto, con quello che aveva fatto parlare i suoi fedelissimi e che conosceva, ormai, ogni più piccolo particolare della sua vita da mafioso.
Apro il mio portatile e comincio a scrivere. Normalmente gli interrogatori li facevo da solo, senza segretario. Verbalizzavo io ed ero velocissimo. Avevo tantissime macro e voci di correzione automatica memorizzate nel mio Word. Digitavo cn e sul video appariva Cosa nostra, già in corsivo, scrivevo uo e diventava uomo d’onore, oppure sgj per San Giuseppe Jato, cr per Corleone, bc per Brusca, md per Matteo Messina Denaro, il boss di Trapani, bg, appunto, per Bagarella. L’interrogatorio dura poche battute. Giusto il tempo per Bagarella di spiegarmi che non intendeva minacciare di morte il figlio di Calvaruso, ma solo fargli tornare alla mente una sera in cui aveva tenuto il vivace bambino sulle ginocchia e ci aveva giocato, un banale episodio che il pentito, secondo don Luchino, sembrava aver dimenticato. Archivierò tutto. Del resto nessuno aveva interesse a processarlo per una semplice minaccia.
Un risultato però l’ho ottenuto. Bagarella ha risposto alle mie domande e ha ammesso di conoscere bene Calvaruso, elemento di prova che poteva esserci utile in altri dibattimenti. In quegli anni trascorsi in carcere don Luchino aveva continuato a tenere alto il suo profilo da padrino corleonese. E d’altra parte il suo è un pedigree di tutto rispetto e affonda le proprie radici nella Cosa nostra post rurale, quella degli anni Sessanta e Settanta, la mafia degli appalti e del traffico internazionale di eroina. Suo fratello maggiore, Calogero, era stato uno dei soci fondatori, se così si può dire, dei corleonesi. Era uno dei quattro fedelissimi del primo capomafia storico della zona, il medico Michele Navarra. Gli altri erano Luciano Leggio, Bernardo Provenzano e Salvatore Riina: insomma una specie di poker d’assi. Erano gli anni Sessanta e i quattro giovani leoni volevano mano libera. Così non avevano esitato a uccidere il vecchio Navarra per prenderne il posto. Forse non è un caso che la storia dei corleonesi nasca proprio con un tradimento.
L’amore per Vincenzina Il giovane Leoluca cresce dunque a «pane e mafia», e quando Salvatore Riina sposa sua sorella Ninetta, diventa anche cognato del Capo dei capi, di Totuccio, come lo chiamavano gli amici. Bagarella, che ha grande voglia di farsi strada in Cosa nostra e sa quanto contino i rapporti di sangue, incastona un’altra parentela di rango. Siamo sul finire degli anni Settanta quando s’innamora perdutamente di Vincenzina Marchese, bella fimmina della famiglia di Corso dei Mille, una cosca di killer e trafficanti tra le più antiche e spietate di Palermo.
Il capofamiglia, Filippo Marchese detto Milinciana (melanzana), zio di Vincenzina, scannava la gente con le sue mani nella camera della morte di Sant’Erasmo, sul lungomare di Palermo. Si dice che chiamasse per nome e cognome la vittima, un attimo prima di eseguire il delitto, e aggiungesse la frase, ormai tristemente nota: ca’ finisci la to’ storia, qui finisce la tua storia. Dei tre fratelli di Vincenzina, Nino, Giuseppe e Gregorio, solo l’ultimo è libero.
Ma Vincenzina è, come si dice, pura come un giglio. Quella tra lei e Leoluca è una grande, vera, tragica storia d’amore.
Matrimonio all’inizio degli anni Novanta. Lui è appena stato scarcerato grazie ai soliti cavilli giudiziari. Matrimonio d’amore ma anche matrimonio di mafia, con tutti i suoi sfarzi un po’ pacchiani. Nozze come quelle di Michael Corleone nel Padrino. Come colonna sonora del filmino della cerimonia Bagarella vuole metterci proprio la musica del capolavoro di Francis Ford Coppola, sua pellicola culto al punto che, nei primi tempi della sua latitanza, si faceva chiamare proprio don Vito. Banchetto a Villa Igea, uno dei più lussuosi e affascinanti alberghi d’Italia. Leoluca, un figurino, nel suo mezzo tight; bellissima Vincenzina, con il lungo velo bianco che il marito premuroso le sorregge, mentre scende da una sfavillante limousine. Centinaia di invitati: c’è la folla delle grandi occasioni. Unici assenti, ma giustificati, i latitanti, che da lì a poco potranno annoverare tra le proprie fila anche lo sposo. Servizio d’ordine impeccabile affidato ai picciotti di Corso dei Mille che respingono «con educazione», si racconta, giornalisti e fotografi. Tutto rigorosamente ripreso dalle telecamere della polizia.
Da quel giorno i due sono inseparabili. Lei lo segue fedele durante tutta la latitanza. Se la ricordano anche nel condominio di via Passaggio Mp1. Una donna bella, riservatissima, che non usciva quasi mai di casa e che, da un giorno con l’altro, non si era più vista. Di Vincenzina si erano misteriosamente perse le tracce. Durante la perquisizione nel covo troviamo uno strano biglietto scritto a mano: «mio marito è l’uomo migliore del mondo e si merita una statua d’oro…». La grafia però è dello stesso Bagarella. Scopriremo in seguito che l’originale scritto da Vincenzina era stato consegnato ai suoi familiari e che don Luchino lo aveva ricopiato personalmente.
C’è anche una fotografia di lei, molto bella, col velo da sposa, in una cornice d’argento. Davanti alla foto un vaso con fiori freschi. Particolari che, insieme alla fede della moglie che Bagarella porta al collo al momento dell’arresto, ci fanno ritenere che Vincenzina sia morta. Saranno poi i pentiti a confermare il nostro sospetto: un mese prima della cattura del marito, infatti, la donna si è suicidata.
Sono certo che Bagarella non abbia alcuna responsabilità materiale nella morte di sua moglie. E la mia convinzione è pienamente confermata dalle indagini svolte e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La morte del piccolo Giuseppe Di Matteo la sconvolge È il dramma di Vincenzina, una donna che ha respirato mafia fin da bambina. Destino crudele, il suo. Moglie di Bagarella e sorella di quel Pino Marchese, che nel frattempo è passato dalla parte dello Stato. Il primo «corleonese» pentito, il collaboratore di giustizia più odiato dalla famiglia Riina. Vincenzina forse non ha retto al peso di questo doppio ruolo e si è tolta la vita. Si è impiccata in casa. Proprio in quel covo di via Passaggio Mp1, dopo un lungo periodo di profonda depressione. Uccisa dalla solitudine. Come sua cognata Ninetta, la moglie di Riina, Vincenzina ha seguito il marito in tutta la latitanza. Mai un dubbio su questo uomo che ama e da cui è ricambiata pienamente. Un solo cruccio: non aver avuto figli. Due volte la natura le ha detto di no, e lei non se ne dà pace. Comunque è ancora giovane, e può coltivare il suo desiderio di maternità. È rimasta profondamente turbata, come gran parte del popolo di Cosa nostra, dalla storia del piccolo Giuseppe Di Matteo. Si è fatta un’idea: pensa che non avere figli sia una sorta di castigo di Dio. Una punizione per il rapimento di quel ragazzino innocente eseguito dagli uomini di suo marito. Il boss giura alla moglie che il bambino non è stato ucciso. E in effetti, in quella data, dice la verità. Ma lei non gli crede. E, tra mille tormenti, si toglie la vita.
Il pomeriggio che la trova morta, appesa a quella corda, Bagarella vive un doppio dramma. La scomparsa, tragica, della compagna della sua vita e l’impossibilità di darle una degna sepoltura. Distinguendo per un momento l’uomo dal mafioso, don Luchino vive una vicenda dolorosissima in assoluta solitudine. Il boss fa una telefonata, in lacrime, al fedele Calvaruso. Chiede aiuto, lo prega di raggiungerlo. Insieme, vestono e sistemano alla meno peggio il cadavere della donna e lo portano fuori. Vincenzina è accompagnata a braccia, sorretta dai due uomini, come se fosse stata colta da un malore. È notte. Nessuno li vede. Il cadavere viene caricato in macchina e trasportato in un ufficio dell’impresa di costruzioni di Giusto Di Natale, uno dei fedelissimi di Bagarella. Lo mettono in una bara che hanno ordinato per telefono a un’impresa funebre, potendo certamente contare sulla sua «riservatezza».
Seppellita di notte in un terreno d’amici Il suo ultimo viaggio Vincenzina lo fa verso la collina di Baida, a pochi chilometri da Palermo, dove viene seppellita in un terreno di proprietà della famiglia Di Natale. Ma il suo calvario non è ancora concluso; quel cadavere «scotta».
L’ho cercata a lungo, non tanto per ragioni investigative o processuali, quanto per un fatto di umanità: avrei voluto fosse tumulata in un cimitero, in terra consacrata. Ma nessuno dei collaboratori di giustizia sapeva dove fosse. Solo Tony Calvaruso, alla fine di un interrogatorio, si ricorda quasi per caso di un particolare: di uno schizzo del luogo dove era stata seppellita la donna, che gli aveva tracciato lo stesso Bagarella. Un giardino che il boss aveva fatto appositamente recintare con paletti di castagno. Nella sala colloqui del carcere di Paliano, il pentito mi rifà, su un pezzo di carta, lo stesso disegno.
Ne faccio una copia che consegno alla Dia, cui chiedo di individuare tutti i terreni a disposizione delle persone che erano presenti la sera di quella sorta di funerale: oltre a Giusto Di Natale, Nicola Di Trapani, reggente del mandamento di Resuttana e Pino Guastella, il killer prediletto di don Luchino. Si doveva per forza trattare di una proprietà «pulita». Bagarella non poteva rischiare un’eventuale confisca di quella che era diventata la tomba della sua Vincenzina.
E guarda caso, si scopre che la famiglia Di Natale possiede da generazioni un fondo che, visto dall’alto, fotografato da un elicottero, corrisponde perfettamente allo schizzo fatto da Calvaruso, compresi i paletti di castagno, nuovi, a sostegno della recinzione.
Ma arriviamo in ritardo. Qualche giorno prima infatti, preoccupati della collaborazione di Calvaruso, i mafiosi hanno provveduto a spostare le povere spoglie in un altro luogo che non ho mai individuato. Nel terreno di Baida troviamo solo una pietra tombale di granito grezzo, senza scritte; e della terra smossa.
Datare con esattezza la morte di Vincenzina Marchese è stato piuttosto semplice. Tullio Cannella – il socio di Calvaruso che avevo arrestato dopo la cattura di Bagarella e che aveva deciso di collaborare – mi ha raccontato di non averla più vista dal 13 maggio 1995. È possibile dunque che la donna si sia tolta la vita nel tardo pomeriggio del giorno prima. Proprio la notte tra il 12 e il 13 maggio, Calvaruso telefona a Cannella e con voce emozionata gli dice: «Tullio mio, non c’è pietà nemmeno per le proprie carni!». Una frase enigmatica, che poi abbiamo capito, si riferiva alle modalità di trasporto del cadavere che Calvaruso riteneva forse umilianti per la povera donna.
Ho indagato a fondo sul mistero della morte di Vincenzina, ma nessun elemento mi fa pensare a qualcosa di diverso dal suicidio. Il suo è il dramma di una donna vissuta e morta in latitanza. Una vera storia d’amore finita in tragedia. Punto e basta.
Nell’album di Cosa nostra, quella tra Bagarella e Vincenzina è una delle poche autentiche love story.
Leoluca stravede per la moglie, ed è un marito affettuosissimo. Raccontano i pentiti: «Quando Vincenzina telefonava, dicendo che aveva calato la pasta, don Luchino interrompeva ogni attività e correva a casa». Ma le attività di Bagarella erano un po’ particolari: poteva quindi accadere, come è accaduto, che il boss sospendesse lo strangolamento di qualcuno, andasse a casa a mangiare, e poi tornasse. A tirare la corda al collo di quel disgraziato.
E ora l’obiettivo è catturare “Mico”, il giovane sultano delle Madonie.
Mico Farinella è giovane, alto, magro, piace alle donne forse proprio per quel suo fare decisamente indisponente. Ama la bella vita, i grandi alberghi, gli orologi di marca e le macchine veloci, Ferrari e Lamborghini sopra tutte. Ha anche aperto un paio di autosaloni di lusso tra Tusa e Palermo, intestati ovviamente a qualche prestanome.
Conduce un’esistenza vistosa e dispendiosa. I carabinieri della compagnia di Cefalù me lo descrivono arrogante, presuntuoso, a tratti sprezzante, sicuro del suo potere. Si crede intoccabile. La sua famiglia è imparentata con mezza Cosa nostra: una sorella del padre «si è maritata» con uno degli Scaduto di Bagheria; suo cugino Rodolfo, figlio di un’altra sorella di don Peppino, ha sposato la figlia di Benedetto Capizzi, influente uomo d’onore del mandamento di Santa Maria di Gesù; e lui stesso è convolato a giuste nozze con la figlia di Giovambattista Pullara, capofamiglia di Villagrazia di Palermo. Forse anche matrimoni d’amore, ma certamente matrimoni d’interesse, matrimoni di potere. E perché fosse chiara a tutti l’importanza delle nozze nelle dinamiche mafiose Mico Farinella aveva fatto da testimone, da compare d’anello, a Massimo Capomaccio, suo amico e, soprattutto, sua longa manus nel settore degli appalti.
Adesso Massimo è lì, coperto da un pietoso lenzuolo, morto ammazzato su un marciapiede di via Rapisardi. Mico, cui corrisponde l’identikit dell’uomo che Giuseppina aveva visto nascondersi dopo l’omicidio, è latitante da un annetto, da quando Gioacchino La Barbera ha messo nero su bianco che era il reggente del mandamento di Gangi-San Mauro Castelverde.
La latitanza non lo ha cambiato. Si diverte a sfidare la sorte e a dimostrare la sua incoscienza. Frequenta uno dei più forniti autosaloni di Palermo con scintillanti Porsche Carrera e Lotus Elan in vetrina. Proprio accanto c’è l’abitazione di un magistrato del tribunale, vigilata dai carabinieri. A Mico piace appoggiarsi al blindato dell’Arma per il gusto di far intervenire i militari di guardia, solitamente carabinieri ausiliari che non sono in grado di riconoscerlo e si limitano a chiedergli cortesemente di spostarsi da lì. Cosa nostra non gradisce questo suo atteggiamento e, tutto sommato, nemmeno suo padre. Questo figlio scapestrato e incosciente non appare in grado di reggere da solo un mandamento importante come quello delle Madonie, figuriamoci poi se può mantenere i rapporti con i mafiosi di Catania e Caltanissetta. E allora creano una sorta di protettorato. Gli mettono a fianco il capofamiglia di Caltagirone, Pietro Rampulla, il «tecnico», l’artificiere della strage di Capaci. Una sorta di gran visir che gestisca gli affari per conto di un sultano poco adatto e incompetente.
Il magistrato di turno nel giorno dell’omicidio di Massimo Capomaccio è un altro collega, ma una ventina di giorni dopo il procuratore aggiunto assegna anche a me il fascicolo. Venendo da Termini Imerese sono uno dei pochi che conosce la mafia delle Madonie. È uno dei tanti effetti dell’onda lunga causata dalla frantumazione delle inchieste operata nel 1989 dall’ufficio istruzione di Palermo dopo che il Csm aveva chiamato a dirigerlo Antonino Meli, preferendolo a Giovanni Falcone.
Da allora, e praticamente fino al 1993, nessun magistrato palermitano aveva messo il naso in indagini sul mandamento di Gangi-San Mauro Castelverde il cui territorio ricade nel circondario del tribunale di Termini.
I poliziotti sono stati i primi a intervenire sul luogo del delitto e, quindi, le indagini sono affidate alla squadra mobile di Palermo che ha, giustamente, contattato il fratello maggiore dell’ucciso, Michele, un omone di quarant’anni che si muove impacciatamente e sembra a suo agio solo quando può dirigere un cantiere edile o guidare una pala meccanica. Michele fa qualche confidenza ai poliziotti sui rapporti tra suo fratello e Mico Farinella. Ma ha paura, tanta paura. Non intende raccontare alcun episodio specifico, non vuole firmare alcun verbale. Le sue sono solo confidenze generiche, però pretende la verità sulla morte di Massimo.
Inutili i tentativi dei poliziotti di fargli dire di più, di fargli fare qualche nome. E poi di quegli sbirri non si fida più di tanto. Non li conosce bene e loro non conoscono le persone che giravano attorno a suo fratello. Nomi come quelli di Vincenzo Maranto, Samuele Schittino, Carmelo Corriere, Salvatore Caccamisi forse non direbbero nulla agli investigatori della mobile di Palermo.
Non è certo così per il capitano dei carabinieri di Cefalù, Pietro Salsano, che è pratico di quel territorio, che ha sempre indagato sui Farinella, sui Capomaccio e sul loro entourage e che delle Madonie conosce ogni angolo, ogni sasso, ogni cespuglio. E proprio a Salsano Michele decide di rivolgersi. Quell’ufficiale originario del Salento, intelligente e rigoroso, pur se sta dall’altra parte, merita la sua fiducia.
Il capitano dei carabinieri di Cefalù
Una sera d’ottobre Pietro Salsano si presenta a casa mia. Gli faccio due spaghetti con la bottarga di Favignana, quella vera, quella che, grazie a Dio, viene ancora abusivamente preparata pressando e lasciando stagionare le sacche delle uova di tonno rosso tra assi di conifere mediterranee, resinose e profumate, ma ritenute «impure» dalla legge.
Pietro mi dice che ha parlato a lungo con Michele Capomaccio e che ha avuto da lui centinaia di preziose informazioni sugli uomini d’onore delle Madonie. Per quanto ha capito, Michele ha solo bisogno di una piccola spinta per decidere di metter tutto quanto a verbale. Forse è il caso che lo interroghi io personalmente. Lo convoco in ufficio nel pomeriggio del 27 ottobre 1994. Malgrado avessi in passato indagato su di lui per qualche gara di appalto pilotata non lo avevo mai visto in faccia. Più della sua corporatura decisamente titanica, mi colpiscono i suoi occhi, limpidi e sinceri. Gli faccio subito le condoglianze per la morte del fratello e comincio a parlargli del mio lavoro da pm a Termini Imerese, dei tanti fatti, più o meno rilevanti, di cui avevo appreso l’esistenza ma di cui non avevo mai capito la reale portata, il vero significato. Una scusa per fargli capire che, sia pur dall’esterno, conosco il suo mondo e gli uomini che lo popolano. Michele si fida di me e a poco a poco si apre. E mi racconta i retroscena di quelle vicende. Per me è come spalancare finalmente una porta dalla quale ho sempre potuto sbirciare solo attraverso il buco della serratura. Mi dà anche una dritta buona. Mi dice di aver incontrato circa sei mesi prima Mico Farinella, già latitante, in compagnia di un venditore ambulante di biancheria, un certo Tommaso Armillieri, originario di San Mauro Castelverde, che vive a Palermo. Al momento di firmare il verbale però Michele inaspettatamente si tira indietro. Non se la sente, ha
paura. Cerco inutilmente di convincerlo. Gli spiego anche che quelle cose ormai le ha dette davanti a un magistrato e che quindi, che firmi o non firmi, io potrei comunque utilizzare le sue dichiarazioni. Ma è irremovibile.
Dopo Michele è il turno di Andrea Randazzo, socio in affari di Massimo che, sempre su suggerimento del capitano di Cefalù, avevo pure convocato in ufficio. La paura che trapelava dagli occhi di Michele Capomaccio è addirittura poca cosa rispetto a quella di Andrea Randazzo, laureato in Legge e, come Michele e Massimo, anche lui di taglia XXL. Indossa giacca e cravatta su una camicia evidentemente fatta su misura e ha con sé una valigetta che non molla un attimo.
Verbali non firmati e tanta paura Sono le otto di sera e siamo in autunno inoltrato. La finestra del mio ufficio è aperta per far uscire la cortina nebbiosa prodotta dalle decine di sigarette fumate durante l’interrogatorio precedente, ma Andrea Randazzo suda. Eccome se suda. Il collo della sua camicia è ormai madido e persino il dorso della mano destra, con cui stringe con forza il manico di quella valigetta, luccica per le goccioline prodotte dalla eccessiva traspirazione. Dopo un paio di risposte tecniche sul ruolo che ricopriva nelle società di costruzioni di Massimo Capomaccio, Andrea si alza in piedi. Lascia la valigetta, appoggia entrambe le mani sulla scrivania, e mi dice: «Dottore ho paura, una fottuta paura! È da un mese che non rientro a casa e dormo qua e là. Non ho capito il motivo per cui Massimo è stato ucciso e non so se è per qualcosa che riguarda pure me. La prego, mi aiuti!».
«Certo che posso aiutarla, dottor Randazzo, ma ho bisogno di conoscere tutto quello che sa lei.»
«E io glielo faccio sapere» mi dice risiedendosi. Prende la valigetta, la apre e mi mostra un floppy disk: «Vede, in questo periodo ho preparato un diario di tutto quello che ho fatto con Massimo. Giorno per giorno. Ci ho messo pure le sue confidenze. Il file è in questo dischetto, anche se devo ancora completarlo».
Mi fa allora una strana proposta. Mi dice che non ha il coraggio di verbalizzare quello che sa, ma che il lunedì successivo, ultimato il diario, mi lascerà il floppy a casa sua, dove io, con una perquisizione, potrò trovarlo. Secondo Randazzo in questo modo, quando io, poi, lo dovrò interrogare sul contenuto del dischetto, lui sarà costretto a confermarmelo e, quindi, Cosa nostra non avrà nulla da ridire sul suo comportamento.
Gli faccio presente che, al di là della correttezza formale dell’operazione, per lui sarebbe pur sempre un palliativo. I mafiosi certamente sanno che, in quel momento, io lo sto interrogando, e non ci metterebbero molto a fare due più due. E in ogni caso avrebbe sempre avuto il «dovere», riguardo all’associazione mafiosa, di negare l’evidenza, di disconoscere il contenuto del file, addirittura di sostenere che l’avevamo creato noi per fregarlo.
L’unica cosa da fare è chiudere quel verbale in fretta, fare in modo che, all’esterno, si sappia che il suo interrogatorio è durato qualche decina di minuti e, dunque, che non mi ha detto niente di rilevante. Gli do un paio di giorni per riflettere. Nel frattempo mi impegno a farlo proteggere, discretamente, dai carabinieri. Sono fiducioso perché posso contare su un alleato di prim’ordine: la paura, il terrore del dottor Randazzo.
Ci rivediamo lunedì 31 ottobre, è il ponte dei Morti e il mio ufficio è praticamente deserto. Andrea è stato portato in procura dai carabinieri di Cefalù che sono entrati con una macchina di servizio dall’ingresso laterale, dalle celle del palazzo di Giustizia, da dove passano i detenuti. Nessuno sa niente. Andrea è un fiume in piena. Accetta di collaborare, di essere sottoposto al programma di protezione. È disposto a lasciare la Sicilia, le sue imprese edili, le sue attività di consulenza e a trasferirsi, senza una lira e un lavoro, in qualche paesino del Nord. Pur di salvarsi la vita.
Cominciamo alle nove del mattino e finiamo alle sette di sera. Non è certamente un mafioso. È stato solo l’amico e il «consigliori» di Massimo Capomaccio. Mi dice subito che, il giorno dell’omicidio, Massimo aveva un appuntamento a Palermo proprio con Mico Farinella e poi parla della sua attività. Racconta di intrecci tra banche compiacenti, imprese, enti pubblici. Mi riferisce di gare pilotate, di società intestate a teste di legno, di appalti acquisiti con la forza, di mazzette a politici e funzionari, di noli a freddo e noli a caldo per eludere i divieti di subappalto; e, soprattutto, parla degli uomini d’onore che erano dietro a quegli affari e di pizzo ed estorsioni, tante e capillari.
Si sofferma a lungo sulla Rgl, la Realizzazione grandi lavori, un’impresa su cui si concentravano gli interessi di almeno una decina di famiglie mafiose o presunte tali, dai Pullarà di Villagrazia ai Brusca di San Giuseppe Jato, dal nipote di Bernardo Provenzano, Carmelo Gariffo, ai Bisconti di Belmonte Mezzagno, dai Biancorosso di Castronovo di Sicilia ai Farinella di San Mauro Castelverde, e sull’ultimo appalto che la società si era aggiudicato, il completamento della Palermo-Sciacca, un affare di svariati miliardi di lire finito, ovviamente, in mano a Cosa nostra. C’è da lavorare per un anno intero. Ma prima abbiamo un paio di emergenze: catturare Mico Farinella e scoprire chi ha ucciso Massimo Capomaccio.
Per conoscere il nome del sicario dovremo rimandare di poco più di un anno, quando Tony Calvaruso ci rivelerà che a sparare era stato un certo Michelino Traina, killer alle dipendenze di Giovanni Brusca. Il boss di San Giuseppe Jato pretendeva da Massimo Capomaccio una cinquantina di milioni di lire che quest’ultimo non aveva intenzione o possibilità di fargli avere. Brusca, avendo saputo dell’appuntamento tra Massimo e Mico Farinella, il quale da par suo aveva fatto ben poco per proteggere il suo compare d’anello, aveva mandato Michelino a eseguire il delitto e Mico era stato costretto a nascondersi dietro le macchine in sosta in via Rapisardi.
Riguardo alla latitanza del «sultano» delle Madonie, anche Andrea Randazzo mi conferma quanto mi aveva detto Michele Capomaccio su Tommaso Armillieri, il venditore di biancheria, e mi fa un altro nome: Robertino borotalco, all’anagrafe Alberto Raccuglia, gestore di un negozio di scarpe a Palermo, in via Lincoln, dove Mico ogni tanto si recava. Non sono certo poche due indicazioni secche per cercare un latitante ma, prima di mettermi al lavoro,ma ho un problema diplomatico da risolvere.
Due colpi di pistola, una moto che fugge e una testimone oculare Giuseppina, quarant’anni, sposata con un milanese, è appena uscita di casa. È tornata dalle vacanze e sta per cominciare il suo shopping. Vuole approfittare degli ultimi saldi prima che le vetrine della zona elegante di Palermo, tra via della Libertà e via Notarbartolo, si riempiano di articoli invernali.
È il 24 settembre 1994 e fa ancora caldo, tanto caldo che alle sei del pomeriggio non c’è quasi nessuno in giro. È un sabato e molti palermitani affollano ancora le spiagge di Mondello e Sferracavallo. Giuseppina si sofferma a guardare una delle splendide palazzine liberty sopravvissute al sacco edilizio degli anni Sessanta. Nonostante viva a Palermo da parecchi anni, ancora si stupisce per il verde brillante delle siepi di melograno nano che circondano la villa, per quella miriade di piccoli frutti ornamentali dai colori accesi che, quasi a rimarcare altezzosamente la generosità di quella terra, spuntano superbi dalla recinzione.
All’improvviso due botti e il rumore di una moto che sgomma via. Giuseppina si volta. Non capisce. Sul marciapiede dall’altra parte della strada vede un uomo per terra. È alto e robusto e indossa una giacca sulla camicia aperta. Sotto di lui c’è una macchia rossa, vermiglia e sgargiante come quei melograni, che si allarga e comincia subito a cambiare colore, a scurirsi.
Nessun urlo, nessun lamento. La donna si guarda intorno, guarda in alto verso le finestre aperte che, stranamente e silenziosamente, vanno accostandosi l’una dopo l’altra come spinte da una forza invisibile. Allora si gira, e vede un’ombra, una figura umana che procede carponi dietro una fila di macchine. L’uomo alza la testa. Un istante, giusto il tempo di incrociare gli occhi smarriti di Giuseppina, e scappa via.
A poco a poco qualcuno comincia ad avvicinarsi alla macchia ora di un rosso torbido e che ormai cola fin sotto il marciapiede. Qualche automobile si ferma, qualche finestra si riapre; e quindi le sirene, le macchine della polizia.
Chi è stato ucciso? Chi è che fuggiva?
Un uomo in divisa si avvicina al corpo per terra. Lo tocca sulla fronte e ne afferra delicatamente il polso. Stacca dalla cintura una radio portatile e comincia a parlare. Poi sposta con attenzione la giacca dell’uomo privo di vita, prende il portafogli dalla tasca interna ed estrae un documento: Capomaccio Massimo, nato a Gaeta nel 1958, residente a Cefalù, provincia di Palermo, professione imprenditore, segni particolari nessuno.
«Signora venga con noi, abbiamo bisogno di interrogarla.» Giuseppina capisce che il suo shopping è finito ancor prima di cominciare e sale, mansueta, sulla volante della polizia che la porta in questura. La donna non ha visto uccidere Massimo Capomaccio, ma ha visto bene, in faccia, quell’uomo che scappava. I poliziotti prima la assillano con mille domande e poi la portano in un’altra stanza e le mostrano nasi, occhi, menti, attaccature di capelli come quelli che, da bambina, ritagliava dal «Corriere dei piccoli» e incollava con la coccoina per costruirsi le bambole di carta.
I tecnici della polizia scientifica sono quasi deliranti per la gioia: quando mai a Palermo era capitato di preparare un identikit partendo dalle dichiarazioni di un testimone oculare? Caso più unico che raro. Vogliono fare un buon lavoro perché chissà quando ricapiterà un’altra occasione così.
Consegnano un disegno a Giuseppina, il disegno di un volto come quelli degli attori che aveva visto a Roma, realizzati dagli artisti di strada di piazza Navona: «Sì, mi sembra proprio questo l’uomo che si nascondeva dietro le macchine». La donna firma i verbali e si allontana. Sotto la questura c’è il marito che l’aspetta in macchina.
Un paio di mesi dopo un poliziotto si presenta a casa di Giuseppina e le chiede di seguirlo. Stavolta
niente più figurine di carta. Le fanno vedere due fotografie. Ritraggono un uomo sulla trentina, di fronte e di profilo, e sullo sfondo le righe orizzontali e i numeretti che caratterizzano le segnaletiche degli uffici matricola delle carceri. Una rapida occhiata all’ispettore seduto davanti a lei, uno sguardo interrogativo come a dire «Ma devo proprio farlo?». Appena un cenno d’assenso dalla faccia del poliziotto, inequivocabile e, soprattutto, ineluttabile. Giuseppina chiude gli occhi come a mandar via la paura che l’attanaglia e poi quasi un sussurro: «È lui. Non ho il minimo dubbio.»
Le foto sono state scattate appena due giorni prima, all’Ucciardone. Sotto ci sono un cognome e un nome: Farinella Domenico, di Giuseppe e di Manzone Rosa, nato a San Mauro Castelverde il 22 agosto 1960 – arrestato il 29 novembre 1994.
Si apre la “stagione di caccia” all’esercito di don Luchino
«Dutturi, picchì m’è fari l’incastru (l’ergastolo) pi ‘sti quattru cornuti? Duttu’, scrivissi!»
A parlare, a manifestare la propria volontà di collaborare con la giustizia, è Pietro Romeo, un «soldato» del gruppo di fuoco di Nino Mangano e Leoluca Bagarella.
È davanti a me, senza manette, in piedi, in una minuscola stanza della questura di Palermo che sembra ancor più piccola se rapportata alla sua mole.
Pietro Romeo è alto e robusto: pesa un centinaio di chili. Mi colpiscono anche i suoi denti, larghi e distanziati. Si capisce subito che ha una forza erculea e che sarebbe in grado di uccidere un uomo a mani nude. Del resto proprio per questo lo cercavamo.
Non ho mai avuto paura dei mafiosi. Se si dimostra di temerli è finita. Poi, almeno in quegli anni, lo Stato era decisamente dalla nostra parte. Ed è proprio il conforto dello Stato che cerco in quell’occasione.
Do un’occhiata interrogativa ai due poliziotti che lo sorvegliano e ricevo un cenno inequivocabile: «Non si preoccupi, dottore. Non farà fesserie».
Anche Santino Giuffrè, il dirigente della Criminalpol di Palermo che mi ha guidato fino a quella stanza, del resto mi ha rassicurato: «È una sorta di gigante buono».
«Buono la minchia!» penso io. «È uno che, nella migliore delle ipotesi, ha personalmente strangolato almeno una decina di persone.» Lo cercavamo dal mese di giugno di quel 1995 e, con lui, tutti i componenti del gruppo di Mangano: Salvatore Grigoli, Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Peppuccio Barranca, Salvatore Benigno, Giorgio Pizzo, Fifetto Cannella, Cosimo Lo Nigro, Giovanni Ciaramitaro, Salvatore Faia, Giovanni Garofalo… A parte Spatuzza e Cannella, tutti gli altri erano per noi dei perfetti sconosciuti.
Dopo che si era diffusa la voce della collaborazione di Pasquale Di Filippo si erano tutti dati alla macchia e, per me, si era aperta una vera «stagione di caccia». La caccia al gruppo di fuoco di Bagarella, a quel manipolo di uomini che lo aveva protetto durante la latitanza e gli aveva fatto da braccio armato, la caccia alle loro armi, al loro esplosivo, ai cadaveri che avevano disciolto nell’acido o disseminato per le campagne del Palermitano.
Avevamo mobilitato tutte le forze di polizia per rintracciare quei latitanti. Era un momento veramente particolare, quasi unico: carabinieri, polizia, guardia di finanza e Dia che si muovevano all’unisono, concordemente e lealmente.
Oltre a una dozzina di gregari e personaggi secondari, riusciamo a prendere in prima battuta solo Giorgio Pizzo, il coordinatore delle estorsioni del gruppo, e Salvatore Benigno, stimato laureando in Medicina e Chirurgia di Misilmeri che, tra un esame e l’altro, aveva trovato il tempo di eseguire il fallito attentato a Maurizio Costanzo, di collocare una macchina imbottita di esplosivo allo stadio Olimpico di Roma e di dare una mano ai suoi amici nel sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio tredicenne del pentito Santino, che i cosiddetti uomini d’onore, con il pretesto di indurre il padre a ritrattare, avevano rapito e tenuto segregato per più di due anni. E alla fine avevano barbaramente strangolato dissolvendone il cadavere nell’acido.
Ma qui ci fermiamo. Cosa nostra ha adottato le sue contromisure e l’elenco dei latitanti più pericolosi del ministero dell’Interno si è arricchito di un’altra decina di nomi.
Quattro arresti in due giorni
La svolta si verifica a novembre. In due giorni, ne arrestiamo quattro. Il primo, appunto, è Pietro Romeo. La base di partenza è un’informazione proveniente da una fonte della Criminalpol di Palermo: «Prima dell’arresto di Bagarella, Romeo si voleva sposare e aveva già versato la caparra, una trentina di milioni di lire, per comprare una casa. A Bagheria».
Non è granché come notizia, ma è meglio di niente. I poliziotti si mettono al lavoro. Qualche giro per agenzie immobiliari, accertamenti all’ufficio del registro e al catasto, informazioni raccattate in giro e, in poco tempo, riescono a individuare la casa in questione e i venditori.
Qualche giorno ancora di passaggi discreti vicino l’abitazione dei proprietari della casa opzionata da Romeo e di appostamenti nella zona dove questa è situata e non è difficile arrivare al latitante. Romeo non è un capomafia, non può contare su una fitta rete di protezioni e di favoreggiatori.
Gli uomini della Criminalpol lo fermano a Bagheria il 14 novembre 1995 mentre passeggia, mano nella mano con la sua ragazza, tra le vetrine dei negozi del centro della cittadina famosa per le sue ville settecentesche. Non sono ancora sposati, ma aspettano un figlio. Romeo ha appena ventinove anni.
I poliziotti lo portano in questura a Palermo, dove nel frattempo si prepara il solito incontro con la stampa. Come dopo ogni arresto di mafia. I giornalisti affollano la sala della conferenza e nell’attesa si domandano chi sia quest’ultimo latitante finito in manette.
Poco prima della conferenza stampa, Santino Giuffrè, che aveva seguito le indagini dell’arresto, mi prende in disparte e mi dice: «Credo che con Romeo ci possa essere qualche possibilità di apertura. Vogliamo provarci?». Attraversiamo un paio di lunghi corridoi e arriviamo negli uffici della Criminalpol, nella zona dove ci sono le camere di sicurezza.
Romeo è ora di fronte a me, in stato di fermo. Lo saluto e lo invito a sedersi, un modo come un altro per attenuare visivamente la chiara differenza fisica tra noi due che, indubbiamente, è a suo favore. Gli comunico rapidamente le accuse nei suoi confronti: partecipazione ad associazione mafiosa, omicidi aggravati, porto d’armi, occultamento e soppressione di cadaveri. Gli faccio presente che, per quelle imputazioni, la pena prevista è il carcere a vita, l’ergastolo.
Alla parola ergastolo ha un contraccolpo. Dichiara senza mezzi termini che è disposto a collaborare, che non ha remore a tradire i suoi vecchi compagni. Sembra sincero. A dispetto della sua stazza non è per niente arrogante, mantiene un atteggiamento umile, appare quasi dispiaciuto di averci costretto a lavorare per catturarlo. E tiene gli occhi bassi.
Si esprime solo in dialetto, in siciliano strettissimo, quasi incomprensibile, ma il significato delle sue parole è chiarissimo. Romeo è pronto a passare dalla nostra parte. Metto nero su bianco la sua volontà di collaborare. Pochissime righe, quelle necessarie a non fargli più cambiare idea, a rendere quel passo definitivo, irretrattabile: mi faccio fornire scarni particolari su un paio di omicidi che aveva commesso e che conosceva solo lui. A questo punto Pietro Romeo non ha più scelta: per la mafia è ormai soltanto un «infame», uno «sbirro».
Andiamo all’incontro con i giornalisti. Ma non possiamo certo divulgare la collaborazione del «picciotto». Dobbiamo fingere che Romeo continui a essere un mafioso a tutti gli effetti. Così decidiamo di raccontare una menzogna: «Stiamo trasferendo il pericolosissimo e feroce killer di Cosa nostra a Pianosa. Sottoposto al regime del 41 bis, il carcere duro».
La bugia ci farà guadagnare tempo. Tempo preziosissimo. Con questo escamotage siamo certi che né i familiari né il suo vecchio avvocato cercheranno di incontrarlo. Ufficialmente Romeo non è detenuto a Palermo perché si è detto pubblicamente che è in viaggio verso il supercarcere dell’isola toscana. Prima che si organizzino per raggiungere Piombino e poi Pianosa, otteniamo almeno un paio di giorni di vantaggio. Tempo sufficiente per sfruttare al massimo le conoscenze di Romeo; in assoluto riserbo. Per la prassi dell’epoca, non esiste conferenza stampa delle forze di polizia che non sia «adeguatamente» illustrata da una foto dell’arrestato. E questo è un ulteriore problema.
Per raccogliere i frutti investigativi dobbiamo tenere segreta la sua decisione di collaborare e non dare adito a dubbi, dubbi che sorgerebbero immediatamente senza una sua fotografia. Ma abbiamo anche il dovere, per tutelare la sua riservatezza, di evitare la pubblicazione della sua immagine.
Così, in quattro e quattr’otto, gli agenti vanno a pescare una vecchia segnaletica di Romeo che modificano opportunamente in maniera tale da farla sembrare recente, ma in cui il soggetto ritratto risulta sostanzialmente irriconoscibile. È quella che l’indomani avranno tutti i quotidiani.
Madonne e santi e crocifissi nella camera della morte
Fin qui latitanti, armi ed esplosivi. Ma adesso arriva la parte più dura, la ricerca dei cadaveri. Certo, stiamo facendo un’operazione di polizia e non c’è spazio per altri pensieri, ma è davvero difficile rimanere insensibili di fronte a corpi decomposti o a resti umani seppelliti alla meno peggio. Morti ammazzati di cui non si è più saputo niente. Classici casi di lupara bianca.
Romeo ci fa trovare un corpo sotterrato in un terreno sul litorale di Palermo: il cadavere di un ragazzo extracomunitario, legato mani e piedi e infilato in un sacco nero della spazzatura. Il giovane tunisino era responsabile solo di aver richiesto ai mafiosi il pagamento della sua attività lavorativa prestata come mozzo a bordo di un loro peschereccio, il Lupo di San Francesco, con cui periodicamente importavano qualche quintale di hashish dal Marocco.
Vicino a Bolognetta, Romeo ci fa recuperare un secondo cadavere, quello di un certo Giovanni Ambrogio, e altri resti umani, residui di qualche frettoloso scioglimento nell’acido. Di alcuni di questi delitti ci aveva già parlato Pasquale Di Filippo, il collaboratore che ci ha portato sulle tracce di Bagarella. Era stato lui, prima ancora di Romeo, a spalancarci le porte della cosiddetta «camera della morte», uno dei luoghi più tetri e agghiaccianti che abbia mai visto in vita mia.
Periferia est di Palermo: via Messina Montagne. C’è un grande capannone. Si vede dall’autostrada. Un magazzino circondato da erbacce, rovi e carcasse di veicoli. Un’insegna: La commerciale. Spazio aperto recintato da un muro e, sulla destra, dopo il pesante portone di ferro semiarrugginito, uno stanzino, un piccolo ufficio. Come la guardiola di un custode.
In una nicchia mimetizzata dal rivestimento di finto abete che ricopre le pareti ci sono gli attrezzi: manette, corde, lacci, fili di ferro, guanti di lattice. Tutto l’occorrente per la tortura. Affisse al muro, senza un preciso ordine, tante immagini sacre: santa Rosalia, santa Rita, la Madonna, san Cristoforo, protettore degli automobilisti. È lo strangolatoio di Cosa nostra. Amen.
Pasquale Di Filippo ci aveva parlato di questo luogo nel suo primo interrogatorio dopo la cattura di Bagarella. Il suo racconto, drammatico, parte dalla faida di Villabate, da questo strano gioco di guerra tra mafiosi e dalla paura che aveva Bagarella di essere oggetto di un complotto degli «scappati», i vecchi boss usciti sconfitti dalla guerra di mafia degli anni Ottanta.
La fine di Gaetano Buscemi Perciò il boss di Corleone aveva emesso e fatto eseguire numerose sentenze di morte. I condannati di turno, in quella maledetta primavera del 1995, sono Gaetano Buscemi e Giovanni Spataro, soci in affari. Buscemi è un piccolo imprenditore edile di Villabate, nipote di tale Giuseppe Di Peri, che Bagarella aveva fatto uccidere insieme al figlio, poco più di un mese prima.
Il 28 aprile scatta l’agguato. Spataro e Buscemi vengono attirati in un tranello. Mentre si recano a piedi a visitare un cantiere vedono arrivare una Fiat Croma con il lampeggiante e con a bordo uomini che indossano giubbetti con la scritta «polizia di Stato». Dalla macchina scendono, armi in pugno, i killer di Mangano e Bagarella. Prima che i due abbiano modo di comprendere cosa stia succedendo, Salvatore Grigoli e lo stesso Mangano fanno fuoco e uccidono Spataro. Gli altri prendono Buscemi e lo trascinano a forza nella Croma. Direzione: la camera della morte, dove pochi minuti dopo arriverà don Luchino in persona.
Buscemi viene interrogato per oltre otto ore, schiaffeggiato di continuo e poi strangolato per mano dello stesso Bagarella. Pasquale Di Filippo e Pietro Romeo sono lì, sul posto, insieme a una mezza dozzina di gregari. Entrano ed escono da quella stanza. Quando decidono di collaborare ci raccontano nei dettagli, con estremo disagio, il drammatico «interrogatorio» di Buscemi, sicuramente uno dei più lunghi nella storia di Cosa nostra.
Me lo sono immaginato diverse volte quell’interrogatorio: la luce fredda della lampada al neon, da ufficio di terz’ordine, Gaetano Buscemi bianco come un cencio, con il volto coperto di lividi, legato sulla vecchia sedia di legno impagliata, da quattro soldi. Di fronte a lui, i santini, beffardi, attaccati alla parete. Buscemi ha quarant’anni, è un mafioso di piccolo calibro e, obiettivamente, ha poco da raccontare. È solo capitato in un gioco di potere più grande di lui, un gioco tra Bagarella e i Graviano, da un lato, e Provenzano e Aglieri dall’altro.
Nello stanzino lo interrogano per ore. Bagarella lo incalza. Vuole sapere tutto sulla famiglia Di Peri, anche quello che Buscemi non può dire perché non lo sa.
Gli hanno messo una corda al collo. Una corda sottile e ruvida, i cui capi penzolano dietro la sedia. È terrorizzato, ma è lucido. Tanto lucido da stipulare uno strano quanto macabro patto con i suoi assassini.
Sa che la sua sorte è segnata e che non ha la minima possibilità di salvarsi la vita; mette sul piatto della bilancia l’unica richiesta che potrebbe forse essere accolta. Si dice disponibile a raccontare loro tutto quello che sa a patto che il suo cadavere non venga sciolto nell’acido: che almeno sua moglie e i suoi figli possano avere una tomba su cui piangere. Ancora oggi rabbrividisco a pensare alla forza morale dimostrata nell’occasione da quell’uomo, da quel condannato a morte.
Avuto l’assenso di don Luchino, Buscemi svela che suo zio, Giuseppe Di Peri, faceva esclusivo riferimento a Pietro Aglieri, legatissimo a sua volta a Provenzano, e che di recente aveva incontrato delle persone, forse proprio qualcuno degli «scappati», a Marsiglia. A queste rivelazioni Bagarella «sospende il verbale» e manda Calvaruso a cercare Giovanni Brusca per fargli sentire in diretta quelle informazioni che, secondo lui, costituiscono la prova del doppio gioco di Provenzano. Ma il boss di San Giuseppe Jato non si trova.
Si va avanti così fino a sera inoltrata, fin quando Bagarella capisce di non poter cavare più niente da quel povero cristo. E tira la corda per primo. Poi apre la porta e dice: «Cu ‘u voli salutari ora, lu po’ fari». Gli altri mafiosi entrano, a piccoli gruppi, e finiscono il lavoro. È notte fonda. Certamente qualcuno tra i presenti deve aver provato un senso di nausea e forse di pietà, senza darlo a vedere, ovviamente. Tutti insieme diventano arroganti: fanno branco.
Il corpo di Buscemi viene legato, caricato su un Fiorino Fiat e abbandonato in una via del centro di Villabate, con ancora la corda al collo. Bagarella e Mangano, da uomini d’onore, sono stati ai patti, hanno rispettato l’accordo con il condannato e hanno consegnato il suo cadavere alla famiglia.
Quando vado a fare il mio primo sopralluogo in quel capannone accuso un senso di vertigine, di smarrimento. Malgrado i due mesi trascorsi dall’ultimo omicidio eseguito, avverto in quello stanzino un indefinibile odore di morte. C’è ancora la sedia sgangherata dove è stato legato e strangolato Buscemi, ci sono le corde, le manette, i santini appesi al muro e le tracce di altre esecuzioni, di altri omicidi avvenuti là dentro.
Come quello di certo Vallecchia, noto come Gianni Giannuzzo, detto ‘U cantanti perché faceva l’interprete di canzoni napoletane. Bella voce e un repertorio classico, dicevano: ‘O sole mio, Malafemmena, Reginella, ‘O surdato ‘nnammurato… Si esibiva ai matrimoni e nelle feste di paese.
Al momento dell’esecuzione ha in tasca un telefonino che i killer, per non lasciare tracce, hanno bruciato proprio nell’atrio del magazzino. Così ci hanno raccontato i pentiti. Alla fine lo recupero proprio io quel telefono: trovo in un angolo dei pezzi anneriti, semicarbonizzati, di un e-tacs Motorola. In un frammento è visibile parte del numero di serie dell’apparecchio. E quelle cifre corrispondono al cellulare di Gianni ‘U cantanti! È la conferma che i pentiti dicono la verità e che quel magazzino gronda sangue.
Ne avevano ammazzati tanti, di uomini, lì dentro. Cose di mafia, in fondo, ma, soprattutto, cose da selvaggi. Come quando nel magazzino della Commerciale avevano condotto due cittadini marocchini, uno dei quali sospettato di aver attentato alla virtù della moglie di Pasquale Di Filippo. L’altro viene ucciso subito da Grigoli con un colpo di 7.65 munita di silenziatore. Un colpo solo, dritto in mezzo agli occhi. Il presunto spasimante, invece, viene «interrogato» e schiaffeggiato per un paio d’ore. Poi lo strangolano, lo evirano e gli infilano in bocca i genitali, assicurati con del nastro adesivo.
Nella notte i due corpi incaprettati vengono scaricati da un furgone lungo le vie di Brancaccio, affinché servano da monito per altri eventuali trasgressori del nono comandamento in relazione alle donne dei cosiddetti uomini d’onore.
E Cosa Nostra scende direttamente in politica, per una “Sicilia Libera
”Sappiamo, da Tullio Cannella e da una serie di elementi oggettivi, che a metà del 1993 Bagarella fonda un suo partito. Lo chiama Sicilia Libera: libera dalle leggi e dalle galere, libera dalle tasse. Libera nel senso di porto franco. È incredibile, ma in quel periodo sono in tanti a pronosticare per la Sicilia un futuro da Panama d’Italia. Sicilia Libera vuole, inequivocabilmente, essere il partito della mafia. Ha un suo simbolo, la Trinacria, una sua precisa linea politica, una lista di iscritti e poche, ma certamente qualificate, sezioni sul territorio.
Lo scopo di Bagarella è quello di infilarsi personalmente in politica con uomini e programmi tutti suoi. E con parole d’ordine che corrispondano alle esigenze di Cosa nostra. La mafia, insomma, deve farsi partito, deve arrivare in Parlamento senza intermediari. È un’idea che viene formalmente appoggiata anche da altri in seno all’organizzazione, ma che poi, all’improvviso, viene abbandonata.
Bisogna tener conto anche del contesto di quegli anni: lo scandalo di Tangentopoli, da una parte, e le stragi mafiose, dall’altra, hanno quasi messo in ginocchio le istituzioni e scardinato il tradizionale sistema dei partiti.
Il ragionamento di Bagarella poggia sulla convinzione che «i politici» hanno preso in giro suo cognato. Non sono stati ai patti, non hanno rispettato gli impegni. Ragion per cui è giunto il momento che la mafia si presenti alle elezioni, e magari vada al governo. Questa è la sua pretenziosa visione: condizionare direttamente la vita politica italiana.
Il progetto di un partito indipendentista Il movimento di Bagarella è una sorta di piccola Lega siciliana che rappresenta il primo e forse unico esperimento della partecipazione diretta nelle istituzioni degli uomini di Cosa nostra. Le liste di Sicilia Libera compaiono nelle elezioni provinciali del 1993 e non vanno malissimo. Anzi, a Catania, capolista il vecchio andreottiano Nino Drago, ottengono il 10 per cento dei suffragi. Tullio Cannella, in rappresentanza del movimento siciliano (e di Bagarella in persona), partecipa a una riunione a Lamezia Terme, al fine di dar vita a una sorta di federazione di tutti i movimenti autonomisti del Meridione. Ma poi di colpo il progetto si arena.
Siamo alla fine del 1993 e, secondo alcuni collaboratori di giustizia, Bagarella capisce che la sua creatura politica è destinata a essere messa da parte: gli fanno notare che quello che lui, con tante difficoltà, sta mettendo in piedi ha poche possibilità di concretizzarsi, almeno a breve termine. I voti che Sicilia Libera può raccogliere nell’isola sono, a livello nazionale, una goccia nel mare.
Del resto anche il più ampio progetto delle cosiddette Leghe meridionali, di cui fanno parte alcuni membri di logge massoniche segrete e soggetti legati all’eversione nera, non sembra avere prospettive concrete. La Direzione investigativa antimafia ha già steso alcuni rapporti e diversi esponenti di primo piano (persone perbene, convinti monarchici o veri autonomisti), avendo intuito l’interesse delle grandi organizzazioni criminali per quel movimento, si tirano indietro.
Molti pentiti raccontano poi dell’attenzione di alcuni capi di Cosa nostra per il programma di Forza Italia, neonata formazione politica le cui proposte in materia di liberalizzazione dell’economia, di deregulation nel settore delle pubbliche commesse e, soprattutto, di riforma della giustizia in una logica cosiddetta garantista, potevano sembrare, in parte, corrispondenti alle aspettative del sodalizio mafioso.
Non sappiamo cosa sia successo. Di certo, a Sicilia Libera Bagarella ci crede. Per dar vita a questa sua creatura politica, il boss corleonese tira fuori cento milioni delle vecchie lire che, vista la sua proverbiale oculatezza, non devono essergli sembrati pochi.
Peraltro quella «sagoma» di Tullio Cannella, capace di organizzare una truffa anche mentre dorme, ci ha messo del suo. La festa di presentazione del nuovo partito, don Luchino l’ha appaltata proprio a lui. E Tullio non si è fatto pregare. Banchetto di lusso, musica, vallette e dépliant, centinaia di invitati, esponenti del popolo di mafia, belle ragazze, politici, avvocati, dottori e colletti bianchi.
Al San Paolo Palace, albergo sul lungomare di proprietà dei fratelli Graviano: sala addobbata, caviale e champagne. Qualche giorno dopo Tullio presenta a Bagarella la nota delle spese sostenute. Totalmente falsa.
I Graviano, infatti, per rispetto verso il cognato di Totuccio Riina, non si sono fatti pagare. Hanno offerto loro i locali, il banchetto e tutto il resto. Dunque Cannella non ha tirato fuori nemmeno una lira. Si è intascato i cento milioni, ha fatto, come si dice, la cresta. Uno dei suoi tanti piccoli imbrogli, insomma. «Se Bagarella lo avesse saputo» racconta Tony Calvaruso «a Tullio gli avrebbe scippato (sradicato) la testa.»
Sogni di evasione Un’altra delle imprese titaniche sognate dal boss di Corleone è un progetto di evasione dal carcere dell’Ucciardone dove, prima dell’entrata in vigore della legge sulle videoconferenze, spesso transitava per partecipare ai processi, progetto che Bagarella ha studiato e messo a punto nei minimi dettagli. Lo stratega corleonese, per la sua liberazione, predispone un vero e proprio piano di guerra. Con l’uso di missili terra-aria e granate anticarro per buttare giù il muro di cinta dell’antica fortezza borbonica.
Un commando di picciotti, armati di kalashnikov, sarebbe dovuto quindi entrare nel carcere, avrebbe dovuto ammazzare qualche decina di agenti penitenziari, e portarlo via. Quando il piano viene comunicato a Giovanni Brusca, incaricato della sua realizzazione, il giovane capomafia di San Giuseppe Jato, che non aveva certo voglia di rischiare la sua latitanza e la sua stessa vita per liberare don Luchino, risponde così: «Dicitici a Bagarella che forse s’ha vistu troppi film miricani!».
Madonne e santi e crocifissi nella camera della morte
Fin qui latitanti, armi ed esplosivi. Ma adesso arriva la parte più dura, la ricerca dei cadaveri. Certo, stiamo facendo un’operazione di polizia e non c’è spazio per altri pensieri, ma è davvero difficile rimanere insensibili di fronte a corpi decomposti o a resti umani seppelliti alla meno peggio. Morti ammazzati di cui non si è più saputo niente. Classici casi di lupara bianca.
Romeo ci fa trovare un corpo sotterrato in un terreno sul litorale di Palermo: il cadavere di un ragazzo extracomunitario, legato mani e piedi e infilato in un sacco nero della spazzatura. Il giovane tunisino era responsabile solo di aver richiesto ai mafiosi il pagamento della sua attività lavorativa prestata come mozzo a bordo di un loro peschereccio, il Lupo di San Francesco, con cui periodicamente importavano qualche quintale di hashish dal Marocco.
Vicino a Bolognetta, Romeo ci fa recuperare un secondo cadavere, quello di un certo Giovanni Ambrogio, e altri resti umani, residui di qualche frettoloso scioglimento nell’acido. Di alcuni di questi delitti ci aveva già parlato Pasquale Di Filippo, il collaboratore che ci ha portato sulle tracce di Bagarella. Era stato lui, prima ancora di Romeo, a spalancarci le porte della cosiddetta «camera della morte», uno dei luoghi più tetri e agghiaccianti che abbia mai visto in vita mia.
Periferia est di Palermo: via Messina Montagne. C’è un grande capannone. Si vede dall’autostrada. Un magazzino circondato da erbacce, rovi e carcasse di veicoli. Un’insegna: La commerciale. Spazio aperto recintato da un muro e, sulla destra, dopo il pesante portone di ferro semiarrugginito, uno stanzino, un piccolo ufficio. Come la guardiola di un custode.
In una nicchia mimetizzata dal rivestimento di finto abete che ricopre le pareti ci sono gli attrezzi: manette, corde, lacci, fili di ferro, guanti di lattice. Tutto l’occorrente per la tortura. Affisse al muro, senza un preciso ordine, tante immagini sacre: santa Rosalia, santa Rita, la Madonna, san Cristoforo, protettore degli automobilisti. È lo strangolatoio di Cosa nostra. Amen.
Pasquale Di Filippo ci aveva parlato di questo luogo nel suo primo interrogatorio dopo la cattura di Bagarella. Il suo racconto, drammatico, parte dalla faida di Villabate, da questo strano gioco di guerra tra mafiosi e dalla paura che aveva Bagarella di essere oggetto di un complotto degli «scappati», i vecchi boss usciti sconfitti dalla guerra di mafia degli anni Ottanta.
La fine di Gaetano Buscemi
Perciò il boss di Corleone aveva emesso e fatto eseguire numerose sentenze di morte. I condannati di turno, in quella maledetta primavera del 1995, sono Gaetano Buscemi e Giovanni Spataro, soci in affari. Buscemi è un piccolo imprenditore edile di Villabate, nipote di tale Giuseppe Di Peri, che Bagarella aveva fatto uccidere insieme al figlio, poco più di un mese prima.
Il 28 aprile scatta l’agguato. Spataro e Buscemi vengono attirati in un tranello. Mentre si recano a piedi a visitare un cantiere vedono arrivare una Fiat Croma con il lampeggiante e con a bordo uomini che indossano giubbetti con la scritta «polizia di Stato». Dalla macchina scendono, armi in pugno, i killer di Mangano e Bagarella. Prima che i due abbiano modo di comprendere cosa stia succedendo, Salvatore Grigoli e lo stesso Mangano fanno fuoco e uccidono Spataro. Gli altri prendono Buscemi e lo trascinano a forza nella Croma. Direzione: la camera della morte, dove pochi minuti dopo arriverà don Luchino in persona.
Buscemi viene interrogato per oltre otto ore, schiaffeggiato di continuo e poi strangolato per mano dello stesso Bagarella. Pasquale Di Filippo e Pietro Romeo sono lì, sul posto, insieme a una mezza dozzina di gregari. Entrano ed escono da quella stanza. Quando decidono di collaborare ci raccontano nei dettagli, con estremo disagio, il drammatico «interrogatorio» di Buscemi, sicuramente uno dei più lunghi nella storia di Cosa nostra.
Me lo sono immaginato diverse volte quell’interrogatorio: la luce fredda della lampada al neon, da ufficio di terz’ordine, Gaetano Buscemi bianco come un cencio, con il volto coperto di lividi, legato sulla vecchia sedia di legno impagliata, da quattro soldi. Di fronte a lui, i santini, beffardi, attaccati alla parete. Buscemi ha quarant’anni, è un mafioso di piccolo calibro e, obiettivamente, ha poco da raccontare. È solo capitato in un gioco di potere più grande di lui, un gioco tra Bagarella e i Graviano, da un lato, e Provenzano e Aglieri dall’altro.
Nello stanzino lo interrogano per ore. Bagarella lo incalza. Vuole sapere tutto sulla famiglia Di Peri, anche quello che Buscemi non può dire perché non lo sa.
Gli hanno messo una corda al collo. Una corda sottile e ruvida, i cui capi penzolano dietro la sedia. È terrorizzato, ma è lucido. Tanto lucido da stipulare uno strano quanto macabro patto con i suoi assassini.
Sa che la sua sorte è segnata e che non ha la minima possibilità di salvarsi la vita; mette sul piatto della bilancia l’unica richiesta che potrebbe forse essere accolta. Si dice disponibile a raccontare loro tutto quello che sa a patto che il suo cadavere non venga sciolto nell’acido: che almeno sua moglie e i suoi figli possano avere una tomba su cui piangere. Ancora oggi rabbrividisco a pensare alla forza morale dimostrata nell’occasione da quell’uomo, da quel condannato a morte.
Avuto l’assenso di don Luchino, Buscemi svela che suo zio, Giuseppe Di Peri, faceva esclusivo riferimento a Pietro Aglieri, legatissimo a sua volta a Provenzano, e che di recente aveva incontrato delle persone, forse proprio qualcuno degli «scappati», a Marsiglia. A queste rivelazioni Bagarella «sospende il verbale» e manda Calvaruso a cercare Giovanni Brusca per fargli sentire in diretta quelle informazioni che, secondo lui, costituiscono la prova del doppio gioco di Provenzano. Ma il boss di San Giuseppe Jato non si trova.
Si va avanti così fino a sera inoltrata, fin quando Bagarella capisce di non poter cavare più niente da quel povero cristo. E tira la corda per primo. Poi apre la porta e dice: «Cu ‘u voli salutari ora, lu po’ fari». Gli altri mafiosi entrano, a piccoli gruppi, e finiscono il lavoro. È notte fonda. Certamente qualcuno tra i presenti deve aver provato un senso di nausea e forse di pietà, senza darlo a vedere, ovviamente. Tutti insieme diventano arroganti: fanno branco.
Il corpo di Buscemi viene legato, caricato su un Fiorino Fiat e abbandonato in una via del centro di Villabate, con ancora la corda al collo. Bagarella e Mangano, da uomini d’onore, sono stati ai patti, hanno rispettato l’accordo con il condannato e hanno consegnato il suo cadavere alla famiglia.
Quando vado a fare il mio primo sopralluogo in quel capannone accuso un senso di vertigine, di smarrimento. Malgrado i due mesi trascorsi dall’ultimo omicidio eseguito, avverto in quello stanzino un indefinibile odore di morte. C’è ancora la sedia sgangherata dove è stato legato e strangolato Buscemi, ci sono le corde, le manette, i santini appesi al muro e le tracce di altre esecuzioni, di altri omicidi avvenuti là dentro.
Come quello di certo Vallecchia, noto come Gianni Giannuzzo, detto ‘U cantanti perché faceva l’interprete di canzoni napoletane. Bella voce e un repertorio classico, dicevano: ‘O sole mio, Malafemmena, Reginella, ‘O surdato ‘nnammurato… Si esibiva ai matrimoni e nelle feste di paese.
Al momento dell’esecuzione ha in tasca un telefonino che i killer, per non lasciare tracce, hanno bruciato proprio nell’atrio del magazzino. Così ci hanno raccontato i pentiti. Alla fine lo recupero proprio io quel telefono: trovo in un angolo dei pezzi anneriti, semicarbonizzati, di un e-tacs Motorola. In un frammento è visibile parte del numero di serie dell’apparecchio. E quelle cifre corrispondono al cellulare di Gianni ‘U cantanti! È la conferma che i pentiti dicono la verità e che quel magazzino gronda sangue.
Ne avevano ammazzati tanti, di uomini, lì dentro. Cose di mafia, in fondo, ma, soprattutto, cose da selvaggi. Come quando nel magazzino della Commerciale avevano condotto due cittadini marocchini, uno dei quali sospettato di aver attentato alla virtù della moglie di Pasquale Di Filippo. L’altro viene ucciso subito da Grigoli con un colpo di 7.65 munita di silenziatore. Un colpo solo, dritto in mezzo agli occhi. Il presunto spasimante, invece, viene «interrogato» e schiaffeggiato per un paio d’ore. Poi lo strangolano, lo evirano e gli infilano in bocca i genitali, assicurati con del nastro adesivo.
Nella notte i due corpi incaprettati vengono scaricati da un furgone lungo le vie di Brancaccio, affinché servano da monito per altri eventuali trasgressori del nono comandamento in relazione alle donne dei cosiddetti uomini d’onore.
A cura dell’Associazione Cosa Vostra
