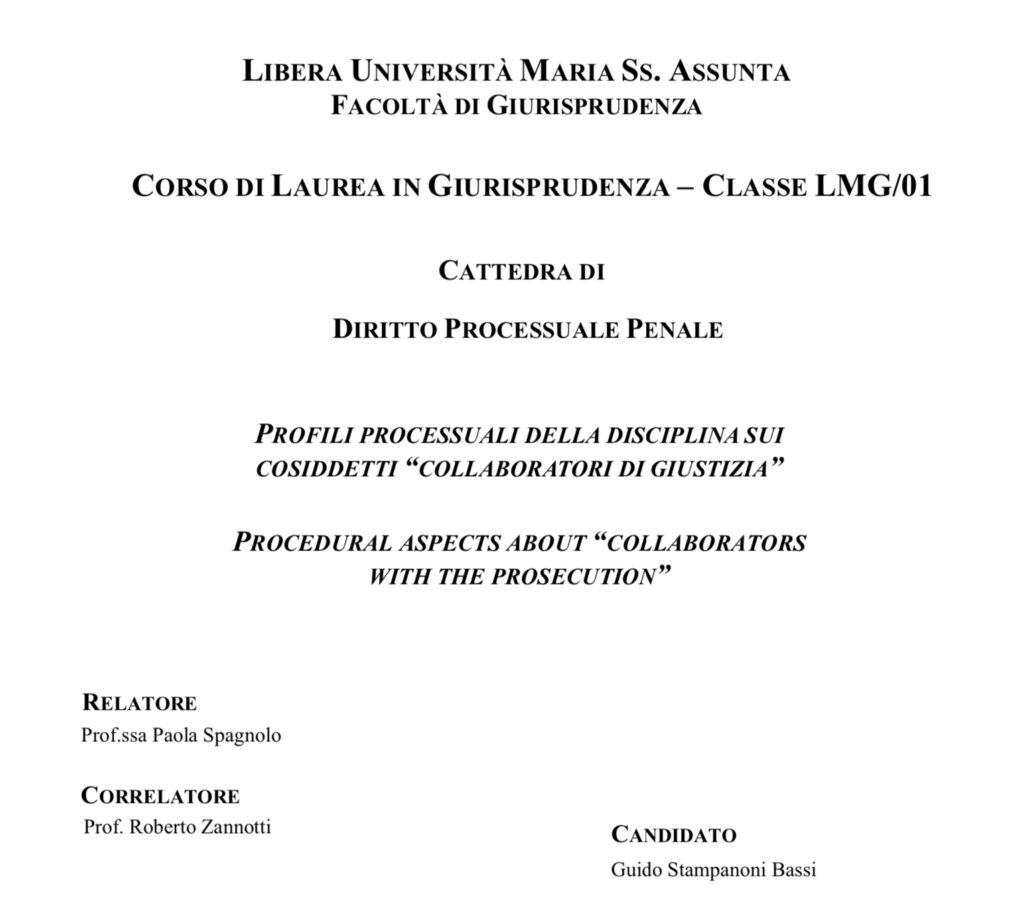D: Dr. Prestipino, “pentiti” o “collaboratori di giustizia”. So che lei fa una certa differenza…
R: Il legislatore usa il termine “collaboratore di giustizia” e credo sia bene attenersi sempre a questo. Il termine “pentito” evoca un parametro valutativo diverso da quello richiesto dalla legge.
Il legislatore non indaga sulle motivazioni interiori del collaboratore fintantochè esse riguardino la personalità del soggetto collaborante. Se poi si trasformano in fatti oggettivi che minano la attendibilità e la credibilità di chi collabora, ovviamente questo acquista rilevanza.
La legge non pretende, da chi collabora, alcun percorso che abbia una connotazione di carattere etico o morale sul proprio vissuto. Si è scelto come unico parametro quello della rottura del vincolo associativo con l’organizzazione di appartenenza e di un contribuito collaborativo che sia leale, genuino e completo. Il che, nella legge del 2001, deve assumere anche i caratteri della novità e della rilevanza.
D: Proprio con riferimento alla legge n. 45 /2001, Armando Spataro la ha definita come una legge “scoraggia – collaborazioni”. Lei è d’accordo? E che giudizio dà della legge del 2001?
R: Guardi, io credo che quando si da un giudizio su una determinata legislazione occorra valutarne sempre i diversi aspetti e, soprattutto, la genesi.
La legge del 2001, secondo me, non nasce in quel coacervo di iniziative legislative che volevano modificare il nostro sistema processuale, ma nasce dalla esigenza di aggiornare la disciplina sui collaboratori che, dopo la grande ondata
Pagina |185
PROFILI PROCESSUALI DELLA DISCIPLINA SUI COSIDDETTI “COLLABORATORI DI GIUSTIZIA” APPENDICE 2
degli anni Novanta, aveva inevitabilmente mostrato delle lacune e delle crepe.
La legislazione originaria era, per capirci, quella voluta fortemente da Giovanni Falcone che aveva come retroterra le grandi collaborazioni degli anni Ottanta, quella che possiamo considerare la “fase iniziale” delle collaborazioni.
Poi, dopo le stragi, a metà degli anni Novanta, si è avuto un forte incremento dei collaboratori che è andato di pari passo con l’incremento dell’iniziativa repressiva da parte dello Stato, il che ha posto problemi nuovi. Di conseguenza, credo che tutti, sia magistrati che gli operatori delle forze di polizia, abbiano avvertito l’esigenza di dare una disciplina a tutti quegli aspetti che prima non erano disciplinati. Credo che l’esigenza, ad esempio, di stabilire un termine di tempo entro il quale chi collabora debba riferire su tutti i fatti di maggiore rilevanza fosse un’esigenza sentita da tutti. La rilevazione di fatti di grande importanza a distanza, a volte, di anni dall’inizio della collaborazione, lasciava uno spazio di valutazione estremamente ampio al giudice.
D: Ci sono invece degli aspetti della legge del 2001 che, secondo lei, suscitano perplessità o riflessioni?
R: Senz’altro. Ad esempio, uno degli aspetti che, secondo me, suscitano maggiori perplessità di carattere formale, intese cioè nel senso di una compatibilità di queste norme con il nostro sistema penalistico e processual–penalistico, è quella relativa all’idea che chi collabora debba, sin dall’inizio, sin dai primi interrogatori, dichiarare tutti i beni dei quali è proprietario direttamente e indirettamente e, sostanzialmente, “consegnarli” all’autorità giudiziaria la quale, poi, valuterà la provenienza dei singoli beni per restituire quelli che si accerteranno essere di legittima provenienza. Questo è, a mio avviso, un aspetto normativo che stride fortemente con il nostro sistema processuale che prevede il sequestro di singoli beni, sia preventivo sia probatorio, solo in caso di una commissione di un reato. Se non c’è la commissione di un reato, non ci può essere il sequestro di un bene. L’idea che chi collabora debba consegnare tutti i beni, e non solo quelli di illecita provenienza, è un’idea che, secondo me, non è pienamente compatibile con il nostro sistema e può, oggettivamente, rendere difficoltosa la stessa scelta di collaborare.
Pagina |186
PROFILI PROCESSUALI DELLA DISCIPLINA SUI COSIDDETTI “COLLABORATORI DI GIUSTIZIA” APPENDICE 2
D: Anche secondo lei era necessario porre un limite temporale alle dichiarazioni? R: Si è molto discusso su questo termine e, in particolare, si è molto discusso da un punto di vista tecnico, della sua compatibilità con principi costituzionali quali quello dell’obbligatorietà della azione penale. Io credo che la previsione di un termine entro il quale chi sceglie di collaborare debba, quanto meno, elencare i fatti di maggiore rilevanza sui quali intende collaborare penso sia una previsione opportuna e corretta che, peraltro, non contrasta con i nostri principi costituzionali.
E’ un principio che tende ad evitare quel fenomeno che tutti ormai conosciamo come le cosiddette “dichiarazioni a rate” che, credo, pone problemi di valutazione importanti da parte del giudice.
D: In base alla sua esperienza, sia alla DDA di Palermo, sia alla DDA di Reggio Calabria, ritiene che 180 giorni rappresentino un termine congruo per raccogliere le dichiarazioni di un collaboratore?
R: Io ho lavorato dal ’96 alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e ho contribuito, con altri colleghi, a gestire da un punto di vista della raccolta delle dichiarazioni diversi collaboratori di spessore di Cosa Nostra, da Angelo Siino ad Antonino Giuffrè. Per Angelo Siino ovviamente il termine dei 180 giorni ancora non esisteva, però per Antonino Giuffrè il termine esisteva e devo dire che noi abbiamo sempre fatto in tempo.
Che poi si possa prevedere un meccanismo di proroga del termine dei 180 giorni io credo che sia possibile e, anche, ragionevole però, chiaramente, si dovranno studiare e valutare le modalità con le quali innestare in un meccanismo di tipo amministrativo, qual è quello del termine, un meccanismo di tipo invece “procedurale”. Se si pensa ad un meccanismo sulla falsariga, diciamo, del termine delle indagini preliminari, allora sorge il problema di una valutazione da parte del Gip che si deve fare su atti e dichiarazioni che sono ancora oggetto di lavoro e in fase di sviluppo. Insomma, bisognerebbe studiare un meccanismo che metta insieme la natura amministrativa e l’aspetto processuale del termine dei 180
Pagina |187
PROFILI PROCESSUALI DELLA DISCIPLINA SUI COSIDDETTI “COLLABORATORI DI GIUSTIZIA” APPENDICE 2
giorni.
D: A cosa attribuisce la diminuzione che si è registrata nel numero dei collaboratori di giustizia negli ultimi anni? La attribuisce a qualche causa in particolare?
R: Io credo che la diminuzione del numero dei collaboratori dipenda da una serie di concause.
Innanzitutto c’è da fare, però, una premessa estremamente doverosa: lo stato delle indagini nei confronti delle diverse organizzazioni mafiose non è assimilabile.
Lo stato della attività di contrasto nei confronti di Cosa Nostra in Sicilia è ad un certo punto, lo stato della attività di contrasto nei confronti della Ndrangheta in Calabria è ad un punto completamente diverso.
Noi, qui in Calabria, ricordiamo sempre che, mentre esiste una sentenza della Cassazione che sin dal 1990 (con la sentenza che ha confermato le sentenze del “Maxi 1”) ha affermato, in via definitiva, da un punto di vista giurisprudenziale, che esiste una organizzazione di tipo mafioso chiamata Cosa Nostra con le sue strutture e le sue regole, sia pure in evoluzione, viceversa, in Calabria, con riferimento alla ‘Ndrangheta, una sentenza di questo tipo ancora non c’è. Questa differenza che è, a mio avviso, il segno più eclatante della diversità in cui versano le fasi della azione di contrasto in Sicilia e in Calabria, è una diversità che non è semplicemente una nota di curiosità intellettuale di analisti e studiosi, ma è un fatto che produce conseguenze importanti anche sul piano processuale.
Per intenderci, se io davanti al Tribunale di Palermo, devo dimostrare la partecipazione di un soggetto alla organizzazione chiamata Cosa Nostra, il tema della prova sarà costituito dai fatti che dimostrano i legami tra quel soggetto e l’organizzazione, ma non dovrò dimostrare che esiste l’organizzazione. Viceversa, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, dovrò fare più passaggi: innanzitutto devo dimostrare che esiste l’organizzazione, poi devo dare prova dei fatti che fondano il legame tra il soggetto e l’organizzazione.
Questa diversità di stato delle indagini è, secondo il mio punto di vista, rilevante nella determinazione a collaborare. La scelta di collaborare avviene da parte di chi o è mosso da ragioni personali di carattere etico oppure, ed è così nella stragrande
Pagina |188
PROFILI PROCESSUALI DELLA DISCIPLINA SUI COSIDDETTI “COLLABORATORI DI GIUSTIZIA” APPENDICE 2
maggioranza dei casi, effettua un mero bilanciamento costi / benefici e quindi, ad esempio, valuta più conveniente collaborare con la giustizia piuttosto che restare segregato in carcere per moltissimi anni.
Oltre a questa noi abbiamo avuto un’altra vicenda che ha inciso profondamente sulla diminuzione del numero delle collaborazioni e mi riferisco, agli inizi degli anni 2000, alla introduzione di quella norma che consentiva il giudizio abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo.
Vede, fu data la possibilità di ottenere la sostituzione della pena dell’ergastolo con la reclusione di anni 30 che, per quanto sia una pena molto pesante, non è però la pena dell’ergastolo… Soprattutto alla luce del fatto che, come sappiamo, le pene detentive temporanee sono delle pene per le quali operano dei meccanismi di “erosione” della quantità di pena da scontare effettivamente in carcere attraverso la applicazione di tutta una serie di istituti penitenziari, assolutamente legittimi e condivisibili per la maggior parte dei detenuti, che però, incidono profondamente sulla analisi costi / benefici che il soggetto condannato effettua. Il che, come abbiamo detto, è la principale motivazione che spinge un detenuto a collaborare. Quindi, se un detenuto, bilanciando costi e benefici valuta che “non vale la pena” sottoporsi allo stress e ai rischi della collaborazione, al mutamento radicale di vita che la collaborazione gli impone, allo sradicamento dalla propria terra di origine, e a tante altre cose, perché tanto sa che, pur non collaborando, ha una “via di uscita” dal carcere che ragionevolmente si attesta nell’arco di alcuni anni, tutto ciò, inevitabilmente, finisce con il determinare una diminuzione nel numero delle collaborazioni.
Pensi che, prima che venissero elevati i minimi edittali per il reato associativo, attraverso meccanismi di applicazione di una prima riduzione di un terzo con il giudizio immediato in primo grado e attraverso la pena concordata in appello (quando ancora esisteva) per il reato associativo, un soggetto poteva ragionevolmente definire la propria posizione con una pena che oscillava tra i quattro e i sei anni. E ovviamente questa è una pena che, per quantità, non incentiva la scelta di una collaborazione.
Quindi, o un soggetto ha motivazioni personali, ma abbiamo detto che sono pochissimi i casi, oppure quelli che scelgono di collaborare sulla base di un calcolo costi / benefici, di fronte alla possibilità di un doppio sconto di pena, si
Pagina |189
PROFILI PROCESSUALI DELLA DISCIPLINA SUI COSIDDETTI “COLLABORATORI DI GIUSTIZIA” APPENDICE 2
sentono, in un certo senso, “disincentivati” a collaborare.
Questo, senza dubbio, ha inciso sulla diminuzione del numero registrata negli anni passati. Poi, con il tempo, da un lato, con una norma interpretativa è stata, di fatto, esclusa la possibilità del rito abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo, dall’altro lato, è venuto meno il concordato in appello, e credo si siano, in qualche modo, eliminate parte di quelle concause che avevano, proprio in concomitanza con la legge n. 45, frenato alcune volontà di collaborare.
In base alla mia esperienza posso dire che, nella valutazione della scelta di collaborare, un ruolo decisivo lo ricopre, e non potrebbe essere altrimenti, la pena a cui si va incontro, che era, spesso, quella dell’ergastolo. Si può dire che la propensione a valutare positivamente una collaborazione sia inversament e proporzionale al tipo di pena a cui si va incontro. Molti di quelli che, alla metà degli anni Novanta in Sicilia hanno collaborato, erano soggetti che andavano incontro alla pena dell’ergastolo. Sono molto più rari i soggetti che hanno collaborato e che non erano condannati per reati punibili con l’ergastolo.
D: Queste concause di cui ha parlato hanno inciso solo sulla quantità delle collaborazioni oppure anche sulla qualità?
R: Da un punto di vista qualitativo non credo vi sia stata una significativa diminuzione.
In Sicilia, nel giugno del 2002, quindi in piena vigenza della legge n. 45, abbiamo avuto la collaborazione di Antonino Giuffrè che è stato ai massimi livelli di Cosa Nostra, occupando per sei o sette anni un posto nella Commissione provinciale di Cosa Nostra. E come lui ce ne sono stati altri che hanno collaborato dopo il 2001. Direi che, complessivamente, la diversa qualità dei soggetti che hanno collaborato prima del 2001 e dal 2001 in poi, sia frutto di un fattore principalmente statistico. Nel senso che, a metà degli anni Novanta, erano molti i soggetti per i quali ancora “la partita era aperta” e che, grazie all’iniziative repressiva dello Stato, sono stati catturati e arrestati e si sono, per così dire, trovati in una situazione in cui scegliere di collaborare diventava una scelta opportuna. Dopo il 2001, per molti di questi soggetti, i giochi erano già fatti: chi aveva scelto di collaborare aveva collaborato e chi aveva fatto altre scelte è rimasto fermo sulle proprie posizioni.
Pagina |190
PROFILI PROCESSUALI DELLA DISCIPLINA SUI COSIDDETTI “COLLABORATORI DI GIUSTIZIA” APPENDICE 2
Inoltre, soprattutto in Sicilia, l’iniziativa repressiva dello Stato con gli anni inevitabilmente ha interessato un altro “ceto” di Cosa Nostra, e soprattutto, negli ultimi anni, ha riguardato dei soggetti completamente diversi rispetto ai capi degli anni Novanta.
Basti pensare a quanti erano i capi Corleonesi dal ’93 al 2000 ancora latitanti o comunque operativi da un punto di vista decisionale e a quanti sono oggi i capi che mantengono questa stessa posizione. Oggi, sostanzialmente, c’è soltanto Matteo Messina Denaro di quel “ceto” mafioso.
D: Quanto alla protezione del collaboratore, come giudica il fatto che la Commissione centrale sia presieduta da un sottosegretario di governo? E’ possibile vedere, come è stato fatto da alcuni, addirittura la possibilità di un’interferenza, seppur non immediata, del potere esecutivo nei confronti di quello giudiziario?
R: No io non vedo questa possibilità. Bisogna guardare alle attribuzioni dei diversi organi. Le attribuzioni di Commissione e Servizio centrale di protezione , da un lato, e direzioni distrettuali, direzione nazionale antimafia e giudice, dall’altro, sono diverse e complementari.
Tutto ciò che riguarda la protezione e gli aspetti amministrativi spetta alla Commissione centrale.
D: Come sono stati i suoi rapporti con la Commissione?
R: Guardi, nella assoluta totalità dei casi la Commissione si attiene ai pareri e alle proposte delle direzioni distrettuali. Nella mia esperienza è capitato che la Commissione chiedesse chiarimenti o approfondimenti ma non mi è mai capitato che “invertisse” una mia proposta o una mia valutazione.
Può succedere il contrario: cioè che nella immediatezza dell’avvio del rapporto di collaborazione si chiedano alla commissione delle misure protettive e poi, nello sviluppo della protezione, il rapporto possa cambiare e quindi si chieda la revoca o la modifica delle misure precedentemente chieste.
Anche per quanto riguarda la durata delle misure e del programma, gli organi
Pagina |191
PROFILI PROCESSUALI DELLA DISCIPLINA SUI COSIDDETTI “COLLABORATORI DI GIUSTIZIA” APPENDICE 2
amministrativi chiedono sempre il parere della autorità giudiziaria che è l’unica autorità in grado di portare alla attenzione della Commissione quegli elementi di fatto necessari per prendere una decisione.
Quindi, in una situazione fisiologica, la diversità delle attribuzioni secondo me non determina l’insorgere di interferenze.
D: Prima del ’91, prima che venisse istituita la Commissione centrale, il tutto era, di fatto, affidato alla magistratura e alle forze di polizia…
R: Si, era, per lo più, affidato alle forze di polizia senza che vi fosse però un quadro normativo di riferimento. E ciò determinava una serie di problemi non indifferenti per gli stessi soggetti che dovevano occuparsi della protezione del collaboratore.
Avere invece un quadro normativo di riferimento in cui è stabilito come si debba orientare la forza di polizia nella protezione del collaboratore, io credo che sia un bene per tutti, innanzitutto per le stesse forze di polizia che sono chiamate ad un compito così delicato.
Tra l’altro, mi preme sottolineare che la nuova disciplina, sotto questo punto di vista, ha fatto una scelta pienamente condivisibile nel momento in cui ha scelto di separare chi protegge e garantisce sicurezza al collaboratore da chi indaga sul contenuto delle sue dichiarazioni. In passato avveniva spesso una commistione: chi proteggeva il collaboratore era la stessa forza di polizia delegata allo svolgimento delle indagini. Aver separato i due ruoli e aver introdotto il Servizio centrale di protezione che si occupa in maniera specifica e professionale della protezione dei collaboratori credo sia stata una scelta assolutamente opportuna che, tra l’altro, ha avvicinato il nostro sistema ad atri sistemi, quali quello degli Stati Uniti che prevede il corpo dei Marshall.
D: Si dice spesso che il nostro sistema abbia fallito per quanto riguarda il reinserimento social del collaboratore? E’ d’accordo? E, secondo lei, quali sono le cause?
R: Io credo che questo fosse l’aspetto sicuramente più difficile sul quale
Pagina |192
PROFILI PROCESSUALI DELLA DISCIPLINA SUI COSIDDETTI “COLLABORATORI DI GIUSTIZIA” APPENDICE 2
intervenire. Credo, però, che si debba fare attenzione alle diverse fasi: c’è stata una fase in cui si sono avviate moltissime collaborazioni e ha prevalso l’esigenza di occultare il collaboratore rendendolo “invisibile”e in questa prima fase il problema del reinserimento non si è posto. Dopo un certo numero di anni, quelli che avevano iniziato a collaborare avevano esaurito la parte “attiva” della collaborazione e si andavano attenuando le esigenze di sicurezza e accentuando i profili del reinserimento. Tra l’altro, le due cose non sono staccate: nel senso che, una buona sicurezza la si ha solo quando il soggetto è reinserito in un tessuto sociale diverso da quello di origine.
Il problema sta anche nel fatto che, quando si sono accentuati, anche quantitativamente, i problemi connessi al reinserimento, si è attraversato un momento di forte crisi economica. Non dimentichiamoci che attualmente siamo al 29% di disoccupazione dei giovani sotto i trent’anni. C’è una difficoltà di reinserimento dei collaboratori che si innesta su una difficoltà ancora maggiore data dalla crisi economica.
Non è un caso che, tendenzialmente, i collaboratori che si sono reinseriti più facilmente sono quelli che, già prima della loro collaborazione, svolgevano, sia pure apparentemente, un certo tipo di attività e, dopo la loro collaborazione, hanno ripreso a svolgere quel tipo di attività. Conosco, per esperienza diretta, soggetti che, dopo la loro collaborazione, grazie alla attività del Servizio centrale di protezione, hanno ripreso, in altro luogo, quelle stesse attività che svolgevano nel luogo di origine. Chiaramente più difficoltà ci sono state per quei soggetti che erano inattivi da un punto di vista occupazionale prima e hanno così dovuto cercare una attività di impiego successivamente.
D: Quanto può aver inciso, sul mancato reinserimento, la durata dei processi?
R: Si, in effetti, un soggetto che continuamente viene chiamato a deporre è un soggetto che difficilmente può reinserirsi. Il reinserimento è tale solo quando prevede un modello di vita che sia compatibile con le nuove esigenze del soggetto che ha collaborato. L’impegno processuale per un soggetto che collabora inevitabilmente implica che, in determinati giorni, il soggetto non si presenti al lavoro. Ed è chiaro che, periodiche assenze dal luogo di lavoro durante l’anno
Pagina |193
PROFILI PROCESSUALI DELLA DISCIPLINA SUI COSIDDETTI “COLLABORATORI DI GIUSTIZIA” APPENDICE 2
finiscano con l’esporre il collaboratore.
Il reinserimento è senza dubbio più facile nel momento in cui il soggetto non ha più impegni processuali.
Si può dire che il reinserimento sociale sia la vera partita su cui si gioca il futuro della collaborazione con la giustizia. Uno dei fattori che può agevolare il superamento delle differenze tra i livelli di lotta alla mafia nelle diverse realtà e, soprattutto, può risultare decisivo nel calcolo costi / benefici effettuato da chi intende collaborare è proprio quello di poter cambiare, in un periodo di lungo respiro, positivamente la propria vita.
D: Che significa “gestire” un collaboratore? Quali sono i problemi che si devono superare nel momento in cui ci si trova di fronte ad un collaboratore?
R: Questo è un problema estremamente complesso e richiede una risposta estremamente articolata. Anche qui è necessaria una premessa.
La persona che proviene da una organizzazione mafiosa e sceglie di collaborare con lo Stato, ha due grossi problemi: innanzitutto deve superare una visione originaria per la quale chi si siede di fronte a lui è un nemico giurato. Non è solo un nemico proprio, della propria famiglia e dei propri figli, ma è un nemico perchè nella testa dei mafiosi chi si trova dall’altra parte è uno che altera le regole, che gestisce i collaboratori “imbeccandoli” con delle dichiarazioni, indirizzandoli contro altre persone, insomma, è “uno che fa male il proprio lavoro”.
Non le nascondo che a me è capitato, diverse volte, di iniziare a sentire dei collaboratori e, dopo due, tre o quattro mesi di interrogatori, sentirmi dire da queste persone, in maniera assolutamente esplicita, frasi del tipo: “Sa, io pensavo che voi facevate i verbali falsi…. Invece devo dire che siete molto attenti e rigorosi.” Capisce?
In secondo luogo, oltre ad avere questa visione dell’interlocutore, ha un altro grande problema: si trova nelle necessità di consegnare la vita propria e dei propri familiari nelle mani di questo interlocutore, nei confronti del quale egli esercita tutta la sua diffidenza, sfiducia e inimicizia.
Questo comporta, da parte di chi collabora, una sorta di preferenza per un rapporto di tipo “personalistico”, in cui il rapporto non è tra il collaboratore e l’ufficio che il
Pagina |194
PROFILI PROCESSUALI DELLA DISCIPLINA SUI COSIDDETTI “COLLABORATORI DI GIUSTIZIA” APPENDICE 2
magistrato rappresenta, ma bensì con il magistrato in persona che tende ad essere personalizzato quanto alle responsabilità relative all’andamento del rapporto di collaborazione. E allora può accadere che i collaboratori imputino al magistrato responsabilità che non gli appartengono con atteggiamenti del tipo: “Ah, ma lei mi aveva promesso che la mia famiglia si sarebbe trasferita in un altro luogo e invece non ci è andata ecc…”
L’approccio corretto deve sempre tenere presente quindi la necessità di consentire al collaboratore di superare gli ostacoli iniziali e del fatto che, in quel momento, il collaboratore sta consegnando la propria vita nelle mani del magistrato; allo stesso tempo il magistrato deve assolutamente, in modo rigoroso, fare in modo che l’iniziale atteggiamento di “personalizzare” il rapporto va disincentivato e frenato. Deve essere instaurato un rapporto tra la persona del collaboratore e l’organo, non la persona del magistrato.
Mi rendo conto che questa è però un’operazione molto complessa che richiede un livello di professionalità estremamente elevato. Gli interrogatori di un soggetto che collabora, soprattutto nei primi 180 giorni, non sono interrogatori “normali” assimilabili a quelli dell’indagato libero, detenuto, o del “teste ostile”.
E’ necessario costruire delle personalità e allargare quelle già esistenti alla luce di tutti i problemi che si affrontano nel gestire un cosiddetto “pentito”
Intervista al Dr. Michele Prestipino
Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria
Reggio Calabria, 29 gennaio 2011 tratta da: