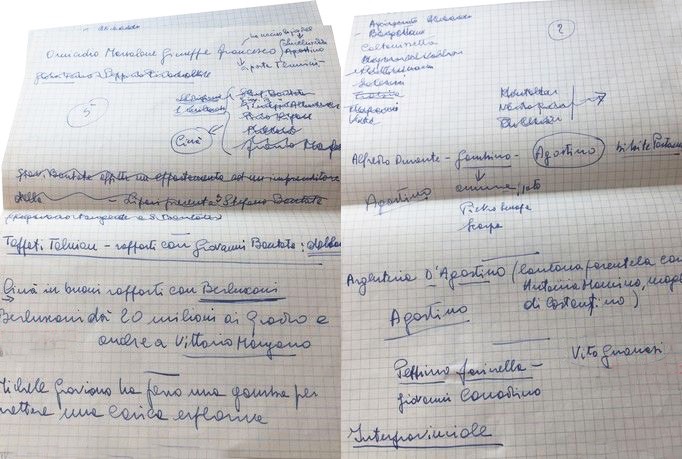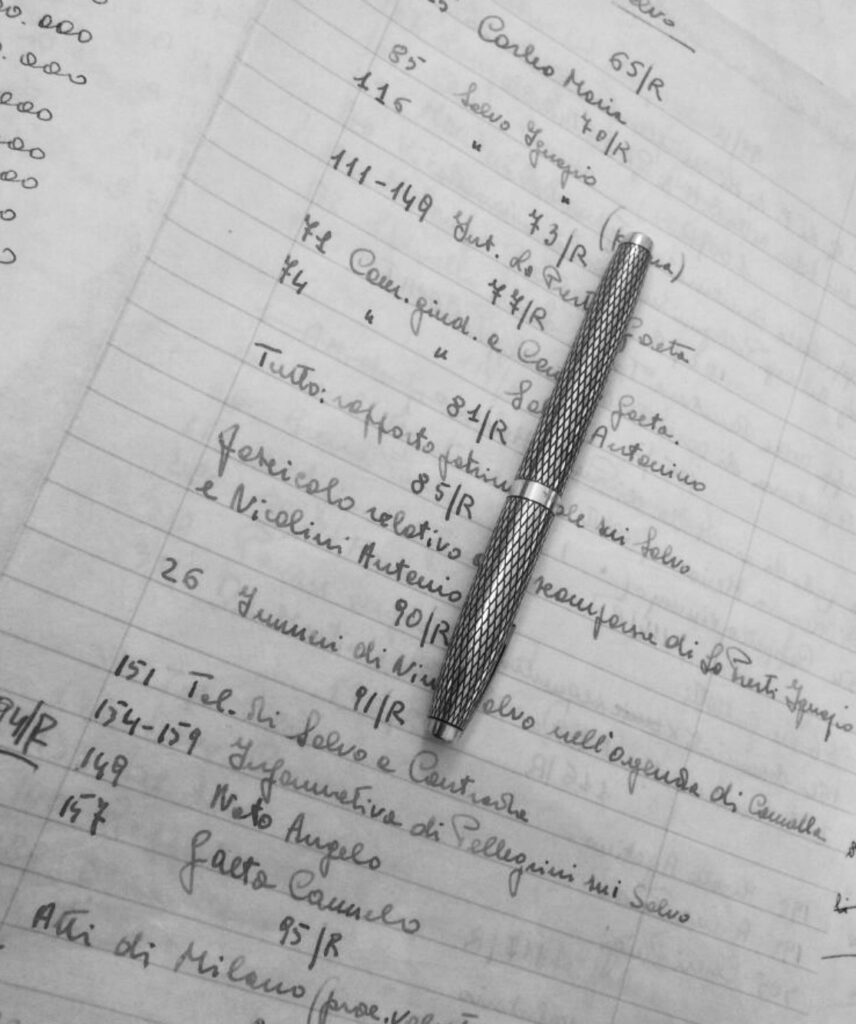La foto del dottore Falcone è di Enzo Signorelli
Sono nato in uno di quei quartieri ieri nobili, oggi più disgregati della vecchia Palermo, dove ho vissuto fino all’età di ventuno anni. Mio padre era una persona seria, onesta, legata alla famiglia.
Mia madre una donna energica, autoritaria.
Entrambi furono genitori che da me pretesero il massimo, con i sette e gli otto, la mia pagella veniva considerata brutta. Il tempo lo trascorrevo nella biblioteca di famiglia, divorando libri di avventura, storia di Francia di Sicilia ecc.ecc..
Dopo il liceo entrai all’accademia navale, volevo laurearmi in ingegneria, ma mi spedirono allo Stato Maggiore perché dicevano che avevo attitudini al comando, mio padre non ostacolò questa scelta ma mi iscrisse in legge e nel 1961 mi laureai con 110 e lode. Tentai così il concorso per entrare in magistratura che vinsi senza alcuna raccomandazione.
A ventisei anni ero Pretore a Lentini con uno stipendio di 110 mila lire al mese, poi il trasferimento d’ufficio a Trapani con la qualifica di Sostituto Procuratore, dove scoprì progressivamente il penale.
Era la valutazione oggettiva dei fatti che mi affascinava.
Durante la guerra ci trovammo sfollati a Corleone, in casa di alcuni parenti, mamma era nata lì. “Corleone” no, quell’episodio non ha avuto un peso particolare nelle mie scelte future certo, era il paese nativo di Luciano Liggio anche se con mio padre non si parlava mai di mafia. Tornato a Palermo ottenni di misurarmi con l’attività di giudice istruttore.
Che idea avevo allora della mafia? allora ogni fascicolo giudiziario era un fatto a se stante, una storia nata in un certo punto e conclusa in un altro.
Ci sfuggiva la veduta d’insieme, l’unicità del fenomeno. Istruì molti processi per delitti di mafia, il lavoro non mi metteva paura e neppure i mafiosi.
Erano già avvenuti delitti gravissimi e a tutti ormai era chiaro un messaggio inequivocabile, più si indaga seriamente sulla mafia, più si corrono pericoli di vita.
Quando fu assassinato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Carini, sul luogo della strage qualcuno tracciò la scritta: I palermitani onesti sono molti di più di quanto si possa immaginare.
Le abitudini peggiori del palazzo di Giustizia a Palermo? i pettegolezzi, le chiacchiere da corridoio, una riserva mentale costante. Di me hanno detto: affogherà nelle sue stesse carte, non caverà un ragno dal buco, ama atteggiarsi a sceriffo, ma chi si crede di essere il ministro della giustizia? No, io ho la coscienza tranquilla.
Nel ruolo di accusatore non ho mai prevaricato i diritti della difesa, non sono mai ricorso a strumenti che non fossero propri del giudice.
Un interrogatorio è una partita a scacchi, un confronto fra intelligenze.
Bisogna compenetrarsi fino in fondo in chi ci sta di fronte, pur sentendosi sempre Giudice. Bisogna capire, ma capire non è perdonare. Eppure ho sempre rispettato persino chi ha ordinato decine di delitti.
Mai dimenticare che anche nel peggiore assassino, vive sempre un barlume di dignità. Giovanni Falcone
Questa è l’ultima testimonianza ufficiale del giudice Giovanni Falcone. L’occasione fu l’inserto di Repubblica Napoli “La Galleria del Giovedì” in cui si parlava delle mafie. Il colloquio, pubblicato il giorno seguente alla strage sull’edizione nazionale di Repubblica, è stato poi ripreso dal Wall Street Journal, da altre testate e in seguito in alcuni volumi come Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi (Paul Ginsborg, Einaudi)
“Cosa nostra non dimentica. Non l’ho mai concretamente vista come una piovra. La mafia è una pantera. Agile, feroce, dalla memoria di elefante. Per questo bisogna fare in fretta e mettersi d’ accordo sulla Superprocura, uno strumento essenziale per arginare l’espansione dei boss. Il nemico è sempre lì, in attesa, pronto a colpire. Ma noi non riusciamo neppure a metterci d’ accordo sull’elezione del presidente della Repubblica…”.
Martedì, mezzogiorno, terzo piano di via Arenula. Giovanni Falcone concede la sua ultima intervista per l’inserto napoletano di cultura di Repubblica. Argomento: analogie e differenze tra camorra e mafia. Ma fuori dall’ufficialità dell’intervista Falcone confessa il suo grande cruccio: le dure e continue polemiche sulla Dna, la Direzione nazionale antimafia, subito ribattezzata Superprocura, l’organismo centrale che dovrebbe coordinare le inchieste sulla criminalità organizzata in tutt’ Italia.
Una breve attesa nella stanza dove lavorano due segretarie. Una camera in cui campeggiano le targhe e i riconoscimenti ottenuti da Falcone nei suoi anni al palazzo di giustizia di Palermo. Tra i ricordi, un quadro del pittore Bruno Caruso che richiama l’estate dei veleni, le lettere anonime che gettarono discredito sul magistrato antimafia: sono disegnati il Corvo, la Talpa, il Falcone.
Arriva Falcone, entriamo in un moderno ufficio con la tv accesa sul televideo in attesa di notizie da Montecitorio, libreria, una originale e divertente collezione di statuette che rappresentano paperi di ogni tipo, colore e dimensione. Giovanni Falcone, da poco più di un anno direttore degli Affari penali del ministero di Grazia e giustizia, si sfoga subito: “Inutile farsi illusioni. Non credo che sarò io il superprocuratore. Ma non mi importa granché. Quello a cui tengo veramente è che la Dna nazionale entri al più presto in funzione. Che a guidarla possa essere io o il procuratore calabrese Agostino Cordova è davvero un dettaglio. Non c’ è tempo da perdere, bisogna mettere da parte le guerre tra il Csm, l’Anm, il Guardasigilli, i partiti. Cosa nostra delinque senza soste, mentre noi litighiamo senza soste”.
Leggermente appesantito nonostante il nuovo hobby (il canottaggio ha sostituito le lunghe nuotate in piscina) Falcone insiste sulla Dna: “Critiche, polemiche strumentali, partiti un contro l’altro armati, che tristezza! Stiamo perdendo un’occasione storica per mettere in piedi una struttura moderna, funzionale; l’unica arma con la quale si può cercare di bloccare l’avanzata mafiosa. Dicevano che ero comunista, adesso mi etichettano come socialista: c’ è sempre una buona ragione per ritardare le misure antimafia e prendersela con Giovanni Falcone”.
E’ un Falcone diverso dai tempi palermitani. Non ha perso l’amara ironia e la cadenza sicula, ma ha messo da parte il linguaggio burocratico e i grandi silenzi che hanno scandito l’incisiva attività di giudice, perno del pool antimafia. Ha voglia di parlare Giovanni Falcone, di spiegarsi: “Mi accusano di volere il pubblico ministero schiavo dell’Esecutivo, succube del potere politico, incapace di esplicare la propria irrinunciabile autonomia. E’ una mistificazione, una scusa per bloccare la Direzione nazionale antimafia. Senza coordinamento quella con la mafia si può già considerare una guerra persa, senza appello. Gran parte dei miei ex colleghi si lamenta: ma cosa vogliono quei giudici? Tornare agli anni in cui erano totalmente dipendenti dal rapportino dei carabinieri e della polizia? Non è possibile, non è adeguato alla pericolosità del nemico, di Cosa nostra. C’ è la Dia, ed ha bisogno della Dna. Ma Falcone era comunista, ora è socialista, e qualunque idea abbia in testa deve per forza essere finalizzata a chissà quale diabolico disegno e dunque va bocciata. Non è così?”.
Sullo schermo del televideo appare una dichiarazione di Achille Occhetto: il leader della Quercia si professa moderatamente ottimista su una prossima elezione del capo dello Stato. Falcone spegne la televisione, scuote la testa: “Tante parole, nessun fatto. Litigheranno ancora. Io il mio candidato ce l’avrei: Spadolini. Ma pare l’abbiano messo da parte durante le loro liti quotidiane”. Falcone entra nel merito dell’intervista, definisce mafia e camorra: “La mafia non è il frutto malato di una società sana, ma una realtà autonoma con leggi severe create al proprio interno. Dotata di una struttura verticistica, piramidale e unitaria. Cosa nostra si fonda sull’assenza dello Stato in Sicilia, un vuoto colmato con regole alternative, elastiche nella loro apparente rigidità formale. Cosa nostra è come una chiesa, dispone di un ordinamento paragonabile a quello ecclesiale. E come la chiesa, sa rinnovarsi senza rinunciare alle propria fondamenta: non è un caso che il capo della Cupola, Michele Greco, sia stato soprannominato il Papa. La camorra, invece, priva di un’organizzazione verticistica, polverizzata in decine e decine di clan, non si oppone, ma vive dei buchi neri del Palazzo”.
Una pausa, telefonata da Palermo. Falcone ascolta l’interlocutore, poi dice: “Ti richiamo ad ora di pranzo”. Riprende l’intervista. “Cosa nostra e camorra hanno comunque una base comune. Sono entrambe ancorate alla subcultura mafiosa del Mezzogiorno, all’omertà che si è trasformata in memoria storica di uno Stato che non ti garantisce. Si tratta di organizzazioni che rispecchiano e travisano valori in sé non censurabili, tipici delle popolazioni meridionali. Capisco che questa affermazione possa far storcere il naso a qualcuno, ma è certo che la famiglia, l’amicizia, il coraggio, la lealtà, tutti presupposti di mafia e camorra, non sono comunque caratteristiche disprezzabili in assoluto, anzi. E’ altrettanto sicuro che il rispetto delle amicizie, della tradizione familiare, il richiamo ossessivo al coraggio e alla lealtà diventano valori strumentali a loschi scopi in camorra e mafia e perdono le caratteristiche nobili caricandosi invece di sentimenti negativi, assolutamente deprecabili”.
Gli domando delle collusioni mafia-politica, camorra-politica. Falcone sorride, si abbandona sulla poltrona, allunga le braccia sulla scrivania: “Cosa nostra è autonoma rispetto alla politica. Il rapporto è alla pari. In parecchie occasioni addirittura di superiorità del boss sul colletto bianco. Mentre la camorra, abilissima ad infiltrarsi all’interno delle pubbliche istituzioni, vive ancora un rapporto subalterno con il politico, non certo di superiorità”. Ancora il telefono. Falcone impreca: “E quando mai!”. Discute di fascicoli giudiziari, promette di richiamare, anche stavolta ad ora di pranzo.
Sono le tredici e qualche minuto. Puntuali, le sue ultime risposte: “Cosa nostra è una pantera, l’immagine della potenza, della ferocia. La camorra è una volpe. Apparentemente non dotata di grandissima forza, ma intelligente, astuta e spietata al momento opportuno. Fanno paura camorra e mafia, non esistono graduatorie di pericolosità nel crimine organizzato. E’ il momento di muoversi, di accantonare simpatie e antipatie, amici e nemici tra politici e magistrati. E’ il momento della Superprocura. Perché la pantera è vigile e non dimentica. Mai”.
Niente è ritenuto innocente in Sicilia, né far visita al direttore di una banca per chiedere un prestito perfettamente legittimo, Né un alterco tra deputati né un contrasto ideologico all’interno di un partito. Accade quindi che alcuni politici a un certo momento si trovino isolati nel loro stesso contesto. Essi allora diventano vulnerabili e si trasformano inconsapevolmente in vittime potenziali. Al di là delle specifiche cause della loro eliminazione, credo sia incontestabile che Mattarella, Reina, La Torre erano rimasti isolati a causa delle battaglie politiche in cui erano impegnati. Il condizionamento dell’ambiente siciliano, l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichiarazioni, certi comportamenti valgono a individuare la futura vittima senza che la stessa se ne renda nemmeno conto.
Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno.
In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere.
Sono andato ad abitare in via Notarbartolo, una strada che scende verso via della Libena, il cuore di Palermo, L’amministratore dello stabile per prima cosa mi ha spedito una lettera ufficiale, che in relazione alla mia presenta in quell’immobile e nel timore di attentati ammoniva: <<L’amministrazione declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero essere recati alle parti comuni dell’edificio>>.Un giorno arrivato davanti a casa, con il mio solito seguito di sirene spiegate, purtroppo, di auto della polizia e di agenti con le armi in pugno, ho avuto il tempo di sentire un passante sussurrare: Certo che per essere protetto in questo modo, deve avere commesso qualcosa di malvagio. (Giovanni Falcone, Cose di cosa nostra).
GIOVANNI FALCONE: «Paolo è un elemento di grande volare. Siamo cresciuti insieme, nessuno lo conosce meglio di me. Sta attraversando un periodo difficile perché gli vengono assegnati solo dei processi di routine. Si sente escluso dai grandi processi di mafia. Io ritengo che possa svolgere un ruolo importante, ne sono certo». da “Falcone-Borsellino e i Segreti di Stato-Mafia”
“Ho tollerato in silenzio in questi ultimi anni in cui mi sono occupato di istruttorie sulla criminalità mafiosa le inevitabili accuse di protagonismo o di scorrettezze nel mio lavoro. Ritenendo di compiere un servizio utile alla società, ero pago del dovere compiuto e consapevole che si trattava di uno dei tanti inconvenienti connessi alle funzioni affidatemi. Ero inoltre sicuro che la pubblicità dei relativi dibattimenti avrebbe dimostrato, come in effetti è avvenuto, che le istruttorie cui io ho collaborato erano state condotte nel più assoluto rispetto della legalità. Quando poi si è prospettato il problema della sostituzione del consigliere istruttore di Palermo, dottor Caponnetto, ho avanzato la mia candidatura, ritenendo che questa fosse l’unica maniera per evitare la dispersione di un patrimonio prezioso di conoscenze e di professionalità che l’ufficio a cui appartengo aveva globalmente acquisito. Forse peccavo di presunzione e forse altri potevano assolvere egregiamente all’esigenza di assicurare la continuità dell’ufficio. È certo però che esulava completamente dalla mia mente l’idea di chiedere premi o riconoscimenti di alcun genere per lo svolgimento della mia attività. Il ben noto esito di questa vicenda non mi riguarda sotto l’aspetto personale e non ha per nulla influito, come i fatti hanno dimostrato, sul mio impegno professionale. Anche in quella occasione però ho dovuto registrare infami calunnie e una campagna denigratoria di inaudita bassezza cui non ho reagito solo perché ritenevo, forse a torto, che il mio ruolo mi imponesse il silenzio. Ma adesso la situazione è profondamente cambiata e il mio riserbo non ha più ragione di essere. Quello che paventavo è purtroppo avvenuto: le istruttorie nei processi di mafia si sono inceppate e quel delicatissimo congegno che è costituito dal gruppo cosiddetto antimafia dell’ufficio istruzione di Palermo, per cause che in questa sede non intendo analizzare, è ormai in stato di stallo. Paolo Borsellino, della cui amicizia mi onoro, ha dimostrato ancora una volta il suo senso dello Stato e il suo coraggio denunciando pubblicamente omissioni e inerzie nella repressione del fenomeno mafioso che sono sotto gli occhi di tutti. Come risposta è stata innescata un’indegna manovra per tentare di stravolgere il profondo valore morale del suo gesto, riducendo tutto a una bega tra «cordate» di magistrati, a una «reazione», cioè, tra magistrati «protagonisti», «oscurati» da altri magistrati che, con diversa serietà professionale e con maggiore incisività, condurrebbero le indagini in tema di mafia. […] Mi auguro che queste mie istanze, profondamente sentite, non vengano interpretate come gesto di iattanza, ma per quello che riflettono: il profondo disagio di chi è costretto a svolgere un lavoro delicato in condizioni tanto sfavorevoli e l’esigenza di poter esprimere compiutamente il proprio pensiero senza condizionamenti di sorta.
“Occuparsi di indagini di mafia significa procedere su un terreno minato”
“Del resto, che cos’è la mafiosità
se non pretendere come privilegio ciò che ti spetta come diritto? L’organizzazione mafiosa in sé è un’altra cosa, e non tollera rapporti di subalternità a niente. Sopra Michele Greco non c’è nessuno. Quando si dice “il terzo livello” si equivoca su una frase detta da me; ma intendevo tutt’altra cosa.
Avevo distinto i reati mafiosi in tre categorie: al primo livello, i reati d’ordinaria amministrazione, come estorsioni e contrabbando; al secondo, reati che servono ad assicurare la funzionalità interna dell’organizzazione, come l’omicidio di chi sgarra; al terzo, quelli che assicurano la sopravvivenza dell’organizzazione nel suo complesso, gli omicidi eccellenti. Invece, ci si è riferiti a un fantomatico terzo livello, intendendo una specie di vertice politicofinanziario della mafia» «Non nego che ci siano rapporti con la
politica, e possano esi stere trame trasver sali, ma pretendere che ci sia una sorta di strategia occulta, con un vertice che dirige la mafia dal di fuori, è sbaglia to. Il mafioso non si sottopone a nessuno.
Quando a Calderone offro no l’iscrizione alla P2, lui si pone il problema: come faccio a giurare fedeltà a due cose diverse? Rifiuta, perché per lui l’unico giuramento che conta è alla mafia.
Un uomo politico può essere affiliato a Cosa nostra, ma solo se ha le qualità dell’uomo d’onore: altrimenti, non conta nulla. Quindi, il problema non è: ma come fa una banda di pecorai a dirigere imperi di miliardi, il problema è che la banda usa e strumentalizza tutti. Chiama Tizio, e gli dice: fa’ fruttare i nostri 30 miliardi. È una realtà semplice, e il collegamento che determina tra criminalità organizzata e criminalità dei colletti bianchi è esplo sivo: ma è cosa diversa dal terzo livello.
Non essere a contatto con la realtà porta a cantonate pazzesche. Quando si parla di mafia, si tende a oscillare tra due poli: o la si sminuisce, negandone l’unita rietà, o la si descrive come un’organizzazione onnipotente che comanda ogni cosa. In entrambi i casi, si impedisce una strategia seria. La realtà è grigia, non è né bianca né nera».
Estratto da un’ intervista del 1992 di Luca Rossi a Giovanni Falcone
L’ultimo editoriale scritto dal dottor Giovanni Falcone su “La Stampa”, pubblicato il 7 gennaio del 1992.
IL LENTO PASSO DELLA LEGGE
Non sono ancora sbiadite le immagini dell’ennesimo funerale di Stato, toccato questa volta al sovrintendente di polizia Salvatore Aversa e alla sua sventurata moglie, uccisi dalla mafia. Immagini, è doloroso doverlo ammettere, che ci hanno rimandato una chiara sensazione di “già visto”. Come se fosse stato riproposto un copione scritto da tempo e “buono” per tutti gli omicidi eccellenti, abbiamo sentito autorevoli opinionisti sollevare pesanti interrogativi sull’efficacia con cui le istituzioni combattono, così si dice, la criminalità organizzata nel nostro Paese. Il Presidente della Repubblica, in particolare, interpretando lo sdegno dell’intera collettività, ha rimarcato la necessità di affrontare in modo serio il problema, prima di dover cedere alla tentazione di ricorrere a leggi eccezionali. Eventualità già “bocciata” da più di un esponente delle istituzioni e della cultura e definita rimedio peggiore del male. Nel bozzetto di prammatica non sono mancate le diatribe tra politici locali e la “ferma e incrollabile decisione” di perseguire esecutori e mandanti della efferata esecuzione mafiosa, rivendicata dalle autorità centrali.
Tutto previsto, dunque. Anche il fatto che tra pochi giorni nessuno si ricorderà più del sovrintendente Salvatore Aversa, come è già stato rimosso dalla memoria collettiva il nome di Antonino Scopelliti o di Rosario Livatino, giudici assassinati soltanto qualche mese fa, e i nomi di tutti gli altri magistrati e investigatori caduti, come si suole dire con pudica metafora, nell’adempimento del proprio dovere.
L’indignazione, così, cede progressivamente il passo all’assuefazione verso crimini indegni di un Paese civile e ci si rassegna all’idea che zone sempre più vaste del territorio nazionale ubbidiscano a regole che non sono quelle imposte dalla legge dello Stato. Nello stesso tempo, tranne isolate eccezioni che rasentano e spesso raggiungono l’eroismo, cresce la disaffezione di magistrati e forze di polizia verso il proprio lavoro. Perde efficacia l’azione di contrasto verso la criminalità, che, di contro, da questa certezza di impunità, riceve sempre più vigore. Eppure c’è chi continua a meravigliarsi ipocritamente della scarsa efficienza dell’azione dell’apparato repressivo, fingendo di dimenticare le quotidiane intimidazioni e le rappresaglie cui vengono ogni giorno sottoposte le forze dell’ordine. Tutto nella più totale e generale indifferenza. Anzi, qualche volta, nella ipocrita negazione di una verità: la lotta alla criminalità non è più un problema di alcune aree del Meridione ma una delle emergenze prioritarie del nostro Paese.
Come non ricordare quanto accade, per esempio, in Puglia, regione fino a poco tempo fa ritenuta immune dal contagio mafioso. Due attentati in pochi giorni contro il palazzo di giustizia di Lecce, che poco allarme hanno suscitato; e, ieri infine, la notizia dell’esplosivo sui binari alle porte della città barocca, che altri lutti non ha provocato solo per un caso. Gli investigatori attribuiscono alla mafia locale la paternità di tali intimidazioni.
Continua a mancare, a nostro avviso, una risposta istituzionale adeguata che faccia comprendere a tutti, e principalmente alla malavita, che quanti, magistrati, poliziotti o anche semplici cittadini si oppongono allo strapotere mafioso, non sono soli ma godono della solidarietà delle istituzioni e di quella società civile alla quale pure si chiede una reazione, per esempio di fronte al dilagare della piaga delle estorsioni. Ma non si può ignorare che, per ottenere una “nuova” solidarietà dai cittadini, lo Stato deve cambiare registro, abbandonando la mentalità burocratica e le tecniche obsolete con cui finora si sono affrontati i problemi legati alla lotta alla mafia per approdare soprattutto ad una “nuova professionalità”.
Le modifiche recentissime dell’ordinamento delle forze di polizia e degli uffici del pubblico ministero sono state adottate appunto per creare organismi agili e moderni in grado di opporre alla malavita efficaci strategie di lotta. Ma bisogna dire con chiarezza che siamo soltanto all’inizio, basti pensare, d’altra parte, che la riforma degli uffici del pubblico ministero non ha ancora esaurito l’iter legislativo. Con queste iniziative si è appena colmato, e solo in parte, il grave ritardo nell’adozione di indispensabili strumenti legislativi per la lotta alla mafia. Sbaglia, dunque, chi ritiene siano stati compiuti decisivi passi in avanti. Adesso viene la parte più difficile: dotare gli uffici di adeguati mezzi logistici e formare le “nuove professionalità”. Certamente non si parte da zero, ma non si può nemmeno parlare di situazione soddisfacente, come confermano i risultati poco esaltanti degli ultimi anni.
La strada è lunga e in salita e non servono scorciatoie di alcun tipo: neppure il ricorso ad eventuali leggi eccezionali. Probabilmente accadrà di trovarsi ancora a dover piangere per lutti di mafia, ma guai se dovessimo lasciarci andare al senso di frustrazione e di impotenza che finora hanno accompagnato le tante, troppe, uccisioni di persone per bene. di GIOVANNI FALCONE
PIU’ FORTE DEI POLITICI LA TESTA DELLA MAFIA
Il tempo è galantuomo. La riflessione, un po’ sciasciana, mi è arrivata spontanea, sfogliando le pagine di cronaca di questi ultimi giorni. Due notizie, a mio avviso, meritano di essere considerate con un’attenzione maggiore di quanta ne sia stata dedicata: il deposito della motivazione della sentenza di appello nel primo maxiprocesso contro Cosa Nostra e le recentissime dichiarazioni del pentito Francesco Marino Mannoia, su due vicende importanti della nostra storia recente. E cioè: il rapimento di Aldo Moro e l’ uccisione del banchiere Roberto Calvi.
Entrambe le notizie mi sembra riportano all’attenzione, rendendo giustizia di certe banali approssimazioni degli anni passati, argomenti centrali per la comprensione del fenomeno mafioso e, quindi, per la scelta delle giuste contromisure: la struttura di Cosa Nostra e il meccanismo che regola la dialettica dei rapporti della mafia con gli “altri poteri” , quello politico compreso.
Andiamo con ordine. Alcuni mesi fa, quando il presidente della Corte d’Appello lesse il dispositivo di udienza che concludeva il primo processone a Cosa Nostra, molti si avventurarono in giudizi catastrofici. Quella sentenza fu bollata come un vistoso e deludente cambio di rotta che vanificava tanti sforzi e sacrifici nelle indagini di mafia. Leggendo, adesso, la motivazione depositata nei giorni scorsi – e in questo senso il tempo è galantuomo – si capisce quanto quelle analisi, superficiali e non condivise dai commentatori più attenti, si siano rivelate del tutto ingiustificate.
Al di là delle decisioni adottate sulle singole imputazioni, il dato più significativo della sentenza oltre al riconoscimento del ruolo decisivo dei pentiti nella ricostruzione dei delitti di mafia e della assoluta trasparenza nella loro “gestione” è costituito dalla motivata riaffermazione della unicità strutturale ed organizzativa di Cosa Nostra. Contrariamente a quanto possa apparire a prima vista, questa è una grande novità. Non dimentichiamo che, solo qualche anno fa, veniva messa in discussione addirittura la stessa esistenza della mafia e che certa stampa isolana liquidava sbrigativamente il problema, attribuendo pudicamente la matrice dei delitti ad “ignota mano assassina”.
È risultato di grande rilievo, quindi, che sia stata autorevolmente confermata dai giudici di secondo grado, dopo ulteriori verifiche rispetto a quelle già particolarmente attente della Corte di primo grado, l’esistenza e l’unicità di una organizzazione criminale che, per numero dei suoi membri e per pericolosità, non ha uguali nel mondo occidentale. La precisazione è d’ obbligo: non perché vi sia da menar vanto per l’esistenza di un fenomeno criminale di tali proporzioni, ma perché finalmente si è giunti ad una incontestabile identificazione della natura e delle dimensioni del da combattere.
Una diagnosi, questa, indispensabile per la scelta di una giusta terapia di contrasto. I termini del problema sono ormai noti a tutti, per cui certe fantasiose ricostruzioni o, peggio, certe strane dimenticanze della realtà mafiosa non sono più consentite e si rivelerebbero fonte di imperdonabili errori nella strategia contro la “piovra”.
E veniamo alla seconda notizia. Ci arriva dalla solita violazione del segreto che dovrebbe accompagnare le indagini del pubblico ministero e che, invece, pare impossibile da rispettare, specialmente nelle vicende più eclatanti. Sembra, dunque, che il pentito di mafia Francesco Marino Mannoia abbia riferito, prima alle autorità statunitensi poi ai magistrati italiani, del rifiuto di Cosa Nostra nonostante la richiesta di autorevoli uomini politici di adoperarsi per la liberazione di Aldo Moro. Il pentito avrebbe parlato anche della uccisione, per mano della mafia, del banchiere Roberto Calvi, “colpevole” di non aver restituito somme di denaro di provenienza illecita e di pertinenza delle “famiglie” palermitane.
Non è certo questa la sede per verificare l’attendibilità delle rivelazioni, né per ipotizzare quale seguito giudiziario queste potranno avere. Ma non si può ignorare come, ancora una volta, la realtà smentisca chi vorrebbe annegare lo specifico del fenomeno mafioso in una genericità priva di qualsiasi riferimento ai suoi collegamenti con la terra d’origine. Penso allo scetticismo di tanti autorevoli esperti che ritengono riduttiva l’indicazione di cercare a Palermo la “testa del serpente”. Ma la realtà smentisce anche chi si ostina a disegnare improbabili scenari dove hanno vita schematici rapporti tra mafia e politica, ipotizzando una subalternità della prima rispetto alla seconda.
L’intreccio è, in realtà, molto più complesso di quanto si pensi e poco adatto a generalizzazioni tanto suggestive quanto infondate. Una costante, tuttavia, a conferma del potere di Cosa Nostra, si può dedurre dalle diverse vicende che costellano la storia siciliana. E cioè: la mafia si è sempre rifiutata seppure in presenza di pressioni politiche o di autorevoli centri di interessi di intervenire in imprese che non siano anche di sua utilità e comunque senza la garanzia del rispetto della propria autonomia.
Mi pare superfluo sottolineare quanto, tali caratteristiche, siano la spia della soglia di pericolosità ormai raggiunta dalla mafia. E della necessità che qualunque attività di contrasto tenga conto della unicità del fenomeno che si vuole combattere, facendo ricorso, dunque, a strategie unitarie e a strutture e uomini altamente specializzati. di GIOVANNI FALCONE
MA LA MAFIA NON È SPETTACOLO
Ho preso parte anch’io alla trasmissione di Costanzo e Santoro in memoria di Libero Grassi. Ho discusso (e sono stato al centro di discussioni) per cinque ore. Confesso che non mi aspettavo tanta attenzione, un ascolto così elevato, la forte partecipazione della gente, testimoniata dalle luci accese nelle case. Ne è uscita un’interessante mappa italiana in cui la mafia sembra essere un problema più avvertito al Nord che al Sud. Ed è venuto fuori il primo timido tentativo di superare, sia pure dialetticamente, le lacerazioni del fronte antimafia. Sì, nonostante i contrasti fra il pubblico del teatro Biondo, nonostante taluni accenni ripetuti a episodi ormai obsoleti e di scarso significato, mi pare che s’è cercato di ragionare partendo da fatti e non da tesi precostituite. Eppure, a mio parere, la lezione che si ricava da questa esperienza invita a un uso molto accorto, per il futuro, del potente mezzo televisivo.
Non bisogna lasciar prevalere la tentazione di fare spettacolo: perché dietro l’angolo c’è sempre il pericolo che accada ciò che è già accaduto per la guerra del Golfo: quando tutti stavamo attaccati al video perdendo la percezione della realtà e della morte che ogni guerra porta con sé. Se la confusione prevale sulla discussione, c’è il rischio che si faccia un polverone in cui ciascuno possa trasformarsi da accusatore a imputato, da condannato a perseguitato, da sospettato a colpevole e così via. Un gran pasticcio in cui tutto, appunto, diventa mafia. Certo, era molto diverso fino a qualche tempo fa. Quando ero alla mia prima indagine antimafia, ricordo ancora che un collega più anziano mi avvicinò con tono scettico chiedendomi: credi davvero che esista la mafia? Ma oggi prevale il rischio opposto: se tutto assume i colori della mafia, non si capisce da dove cominciare per fare una seria antimafia. Rosario Spatola, un condannato per associazione mafiosa che col pentito intervistato mercoledì sera in tv ha in comune solo un’omonimia, nella sua cella alcuni anni fa custodiva un biglietto con su scritto: la vera mafia non è in Sicilia. È a Roma, è una forma di potere che i governi usano contro i più deboli.
Ecco l’esempio di un ragionamento squisitamente mafioso che può essere usato indistintamente in chiave antimafia. Lo dico non per polemica, ma per sottolineare che la mafia è un fatto troppo serio per essere trattata in modo poco serio. E un’esortazione del genere, credo debba valere per le istituzioni, i politici e la società. Perché sensibilizzare bene l’opinione pubblica e la società civile sul problema mafia è un fatto essenziale ed è il presupposto per mettere in mora le istituzioni e costringerle a intervenire seriamente. Per farlo, però, occorre non lasciarsi abbindolare o fuorviare; al contrario, è necessario distinguere e analizzare. Non è possibile, né utile, fare di tutta l’erba un fascio e appioppare l’etichetta mafia a tutto ciò che non va in questo Paese. Le generalizzazioni creano facili alibi: per anni s’è detto che la mafia era difficile da combattere perché connaturata al tessuto economico-sociale sottosviluppato del Sud; salvo ad accorgersi poi sul campo che la mafia si annida in tutti gli ingranaggi e le storture dello sviluppo. Allora, mi domando: che senso ha identificare la mafia con le malversazioni di pubbliche amministrazioni o lo scarso funzionamento della burocrazia? E la mafia con le clientele? E per quale ragione indagini giudiziarie debbono essere utilizzate strumentalmente per fini di parte?
Qualche anno fa un famoso regista mi chiese collaborazione per preparare un film sulla mafia. Parlammo a lungo, ma alla fine mi comunicò che rinunciava perché temeva di fare un’opera agiografica. Una riserva del genere dovrebbe valere anche per la televisione. Certe trasmissioni possono diventare importanti per indurre la pubblica opinione alla coscienza critica di un problema del quale, fino a non molti anni fa, si preferiva perfino negare l’esistenza. Ma appunto, occorre distinguere la cultura del diritto da quella del sospetto, la criminalità comune o la cattiva amministrazione dalla mafia vera e propria. Della quale, in tv, con tutto il rispetto, non si dovrà mai discutere come se fosse il Processo del lunedì.
* Per gentile concessione de La Stampa. di GIOVANNI FALCONE *. (8 settembre 1991)
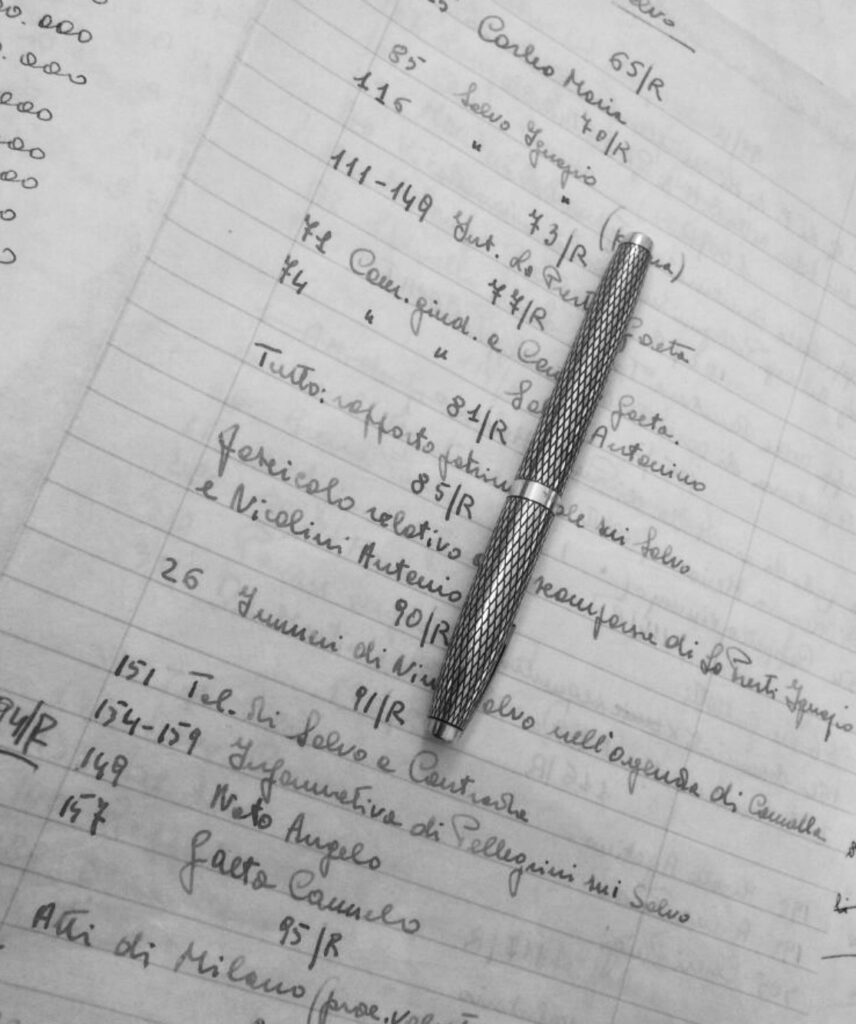
Le MISURE DI PREVENZIONE, RIMEDIO PIU’ FORTE DEL MALE
Agli inizi degli Anni Settanta, specialmente dopo l’assassinio del procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro Scaglione, si fece ricorso in modo massiccio alle misure di prevenzione come rimedio all’insuccesso di importanti processi di mafia. I soggetti ritenuti più pericolosi vennero inviati al soggiorno obbligato in sperduti centri del territorio nazionale, o addirittura in lontane isolette come l’Asinara o Ustica, mentre numerosi altri personaggi in odore di mafia furono costretti ad abbandonare la Sicilia per l’ imposizione del divieto di soggiorno.
Il risultato fu esattamente contrario alle aspettative. Il metodo mafioso fece la sua apparizione in zone fino a quel momento indenni e i soggiornanti, lungi dal recidere i legami con la terra di origine, strinsero nuove e pericolose alleanze con la malavita dei centri dove erano stati relegati. In altri termini, si favorì la diffusione della mafia in tutto il Paese.
Nonostante la negatività dei risultati, non fu facile accertare che il ricorso alle misure di prevenzione era stato rimedio peggiore del male. Si pervenne, comunque, ad un cambiamento di rotta anche sotto la spinta delle vivaci proteste dei Comuni, generalmente siti in zone turistiche, scelti come sedi di soggiorno obbligato.
Ne è trascorso di tempo. Eppure non mi sembra che le idee si siano chiarite se, nonostante l’infausta esperienza del passato, si continuano a riproporre questioni ormai superate. È necessario, allora, rifuggendo da banali e contingenti polemiche su scelte di politica criminale, cercare di fissare alcuni punti fermi.
Una strategia di contrasto al crimine organizzato fondata sulla centralità delle misure di prevenzione personali, quali il soggiorno obbligato o il divieto di soggiorno, è certamente inefficace e addirittura controproducente, perché, come è stato dimostrato da numerose inchieste giudiziarie, oltre a non affievolire gli originari vincoli associativi, favorisce la diffusione delle attività illecite della mafia. Mi sembrano di estrema attualità, ancor oggi, le parole di quel mafioso palermitano il quale, sorridendo ironicamente, ebbe a confessarmi candidamente che, proprio grazie a quel divieto di soggiorno in Sicilia, era riuscito finalmente a fissare la propria residenza a Napoli, potendo così proseguire indisturbato la sua attività nel contrabbando di tabacchi, del quale era uno dei maggiori esperti.
Né sembra praticabile la via della utilizzazione, come luoghi di soggiorno, di piccoli centri urbani o isolette, poiché, a parte le immancabili e fondate proteste dei Comuni interessati, gli attuali mezzi di comunicazione e la ben nota capacità dei mafiosi di eludere qualsiasi divieto, renderebbero assolutamente aleatoria la possibilità di un reale isolamento del soggiornante. A meno che non si voglia ancor oggi pensare a modalità di controllo compatibili solo con lo stato di detenzione, mentre la persona sottoposta a misure di prevenzione, come si dimentica troppo spesso è un libero cittadino.
Ed è questo, in realtà, l’aspetto più singolare dell’attuale polemica: che si continuino ad invocare limitazioni dei diritti di libertà dei cittadini, in funzione di una loro pretesa appartenenza ad organizzazioni criminali e prescindendo da un positivo vaglio giudiziale della effettiva commissione di delitti di matrice mafiosa. A scanso di equivoci, non si intende riproporre, almeno in questa sede, la questione della costituzionalità delle misure di prevenzione, ma solo sottolineare la stranezza che in un Paese dove i “garantisti” abbondano nessuno si sia ancora accorto di quanto sia gravemente distonica, rispetto ai principi dello “Stato dei diritti”, oltre che inefficace, la pretesa di ricorrere massicciamente alle misure di prevenzione contro il crimine organizzato, trascurando il rigoroso accertamento delle responsabilità attraverso il processo penale. 17 giugno 1991 – di GIOVANNI FALCONE
I GATTOPARDI NON MUOIONO MAI
Che cosa resterà delle due settimane cominciate con la fuga del boss Vernengo dall’ospedale Civico di Palermo, dove si trovava in stato di arresto, e finite con l’annuncio da parte del governo dell’istituzione di un'”Fbi” italiana e di una “Superprocura” specializzata nelle inchieste antimafia? C’è da sperare che tutto non si esaurisca nel solito strascico di polemiche, e da ciò che è accaduto possa venire almeno una lezione per il futuro.
Ma senza entrare nel merito dei fatti, ancora al vaglio delle autorità competenti, qualche riflessione si può accennare fin d’ora. Davanti al nuovo allarme per la ripresa della criminalità, in un momento che avrebbe richiesto forte responsabilizzazione e consapevolezza del pericolo, si è assistito a uno scarico di responsabilità, a richiami ai limiti formali delle leggi e dei compiti dei singoli; s’è parlato di Palermo come di una qualsiasi città, come se non fosse, appunto, la capitale di Cosa Nostra. Al governo che non ha fatto nulla per nascondere i rischi di un abbassamento della guardia in una situazione così grave, gli operatori giudiziari hanno risposto con la difesa delle loro prerogative di indipendenza e autonomia.
Formalmente, tutto è a posto: è la Costituzione a garantire che il potere esecutivo e quello giudiziario siano posti sullo stesso piano e salvaguardati da reciproche ingerenze. Quel che resta da capire è se un confronto sul da farsi si possa aprire o debba essere condannato, prima di cominciare, a una rigida contrapposizione fra la difesa del “vecchio” che non si può toccare e la ricerca del “nuovo” che non riesce a farsi strada. Prendiamo ad esempio, tanto per fare un discorso più generale, il nuovo processo penale. Si tratta della più rilevante riforma giudiziaria dal dopoguerra a oggi. Si può pensare, come molti operatori non fanno mistero di pensare, che sia stata fatta solo per eliminare il rischio di nuovi maxi-processi o limitare le ambizioni dei “giudici-sceriffi”? E si può credere veramente che avendo la riforma messo a nudo la crisi dell’apparato giudiziario, fino a quando lo Stato non sarà in grado di adeguare le strutture alle nuove norme, la giustizia sarà destinata a restare paralizzata?
Ovviamente anche interpretazioni del genere, benché paradossali, sono plausibili. O almeno, lo diventano sul terreno formale. Ma la verità è un’altra; e si può solo fingere di ignorarla. Il nuovo processo penale ha introdotto una serie di cambiamenti ai quali, presto o tardi, bisognerà adeguarsi. Ha sancito una differenziazione fra il ruolo della pubblica accusa e quello del giudice giudicante. E prima o poi porterà diversificazioni, specializzazioni, necessità di addestramenti e professionalità mirate. L’idea che tutto possa finire nel vortice di un eterno gattopardismo, in cui si finge di cambiare e poi tutto resta uguale, non regge.
Così, riconoscere che il nuovo processo penale chiude un’era della giustizia italiana, e ne apre un’altra, non vuol dire rinunciare a garanzie e autonomie; né aprire il varco a una rivoluzione, che del resto nessuno vuole. Piuttosto, e più semplicemente, serve a capire che un muro di Berlino è caduto anche nel campo della giustizia italiana. La difesa dei “punti fermi” non basta più davanti a una situazione mutata e segnata da nuovi allarmi, come l’attuale. E se non serve cambiare tutto, bisogna accettare almeno che tutto sia rimesso in discussione, o battere strade conosciute ma con diversa consapevolezza. di GIOVANNI FALCONE 23 ottobre 1991
“A volte ci si chiede se ci sono pentiti « veri » e pentiti «falsi ».
Rispondo che è facile da capire se si conoscono le regole di Cosa Nostra. Un malavitoso di Adrano (Catania), un certo Pellegriti che aveva già collaborato utilmente coi magistrati per delitti commessi in provincia di Catania, aveva stranamente dichiarato di essere informato sull’assassinio a Palermo del presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella. Nel 1989 mi reco con alcuni colleghi a trovarlo in prigione per saperne di più e il Pellegriti racconta di essere stato incaricato da mafiosi palermitani e catanesi di recapitare nel capoluogo siciliano le armi destinate all’assassinio.
Era chiaro fin dalle primissime battute che mentiva. Infatti è ben strano che un’organizzazione come Cosa Nostra, che ha sempre avuto grande disponibilità di armi, avesse la necessità di portare pistole a Palermo; né è poi pensabile, conoscendo le ferree regole della mafia, che un omicidio «eccellente », deciso al più alto livello della Commissione, venga affidato ad altri che a uomini dell’organizzazione di provata fede, i quali ne avrebbero dovuto preventivamente informare solo i capi del territorio in cui l’azione si sarebbe svolta; mai comunque estranei come il Pellegriti. I riscontri delle dichiarazioni di Pellegriti, subito disposti, hanno confermato, come era previsto, che si trattava di accuse inventate di sana pianta. “
Estratto dal libro di Giovanni Falcone e Marcelle Padovani, uscita della prima edizione fine 1991.
PIU’ FORTE DEI POLITICI LA TESTA DELLA MAFIA
IL tempo è galantuomo. La riflessione, un po’ sciasciana, mi è arrivata spontanea, sfogliando le pagine di cronaca di questi ultimi giorni. Due notizie, a mio avviso, meritano di essere considerate con un’attenzione maggiore di quanta ne sia stata dedicata: il deposito della motivazione della sentenza di appello nel primo maxiprocesso contro Cosa Nostra e le recentissime dichiarazioni del pentito Francesco Marino Mannoia, su due vicende importanti della nostra storia recente. E cioè: il rapimento di Aldo Moro e l’ uccisione del banchiere Roberto Calvi.
Entrambe le notizie mi sembra riportano all’attenzione, rendendo giustizia di certe banali approssimazioni degli anni passati, argomenti centrali per la comprensione del fenomeno mafioso e, quindi, per la scelta delle giuste contromisure: la struttura di Cosa Nostra e il meccanismo che regola la dialettica dei rapporti della mafia con gli “altri poteri” , quello politico compreso.
Andiamo con ordine. Alcuni mesi fa, quando il presidente della Corte d’Appello lesse il dispositivo di udienza che concludeva il primo processone a Cosa Nostra, molti si avventurarono in giudizi catastrofici. Quella sentenza fu bollata come un vistoso e deludente cambio di rotta che vanificava tanti sforzi e sacrifici nelle indagini di mafia. Leggendo, adesso, la motivazione depositata nei giorni scorsi – e in questo senso il tempo è galantuomo – si capisce quanto quelle analisi, superficiali e non condivise dai commentatori più attenti, si siano rivelate del tutto ingiustificate.
Al di là delle decisioni adottate sulle singole imputazioni, il dato più significativo della sentenza oltre al riconoscimento del ruolo decisivo dei pentiti nella ricostruzione dei delitti di mafia e della assoluta trasparenza nella loro “gestione” è costituito dalla motivata riaffermazione della unicità strutturale ed organizzativa di Cosa Nostra. Contrariamente a quanto possa apparire a prima vista, questa è una grande novità. Non dimentichiamo che, solo qualche anno fa, veniva messa in discussione addirittura la stessa esistenza della mafia e che certa stampa isolana liquidava sbrigativamente il problema, attribuendo pudicamente la matrice dei delitti ad “ignota mano assassina”.
È risultato di grande rilievo, quindi, che sia stata autorevolmente confermata dai giudici di secondo grado, dopo ulteriori verifiche rispetto a quelle già particolarmente attente della Corte di primo grado, l’esistenza e l’unicità di una organizzazione criminale che, per numero dei suoi membri e per pericolosità, non ha uguali nel mondo occidentale. La precisazione è d’ obbligo: non perché vi sia da menar vanto per l’esistenza di un fenomeno criminale di tali proporzioni, ma perché finalmente si è giunti ad una incontestabile identificazione della natura e delle dimensioni del da combattere.
Una diagnosi, questa, indispensabile per la scelta di una giusta terapia di contrasto. I termini del problema sono ormai noti a tutti, per cui certe fantasiose ricostruzioni o, peggio, certe strane dimenticanze della realtà mafiosa non sono più consentite e si rivelerebbero fonte di imperdonabili errori nella strategia contro la “piovra”.
E veniamo alla seconda notizia. Ci arriva dalla solita violazione del segreto che dovrebbe accompagnare le indagini del pubblico ministero e che, invece, pare impossibile da rispettare, specialmente nelle vicende più eclatanti. Sembra, dunque, che il pentito di mafia Francesco Marino Mannoia abbia riferito, prima alle autorità statunitensi poi ai magistrati italiani, del rifiuto di Cosa Nostra nonostante la richiesta di autorevoli uomini politici di adoperarsi per la liberazione di Aldo Moro. Il pentito avrebbe parlato anche della uccisione, per mano della mafia, del banchiere Roberto Calvi, “colpevole” di non aver restituito somme di denaro di provenienza illecita e di pertinenza delle “famiglie” palermitane.
Non è certo questa la sede per verificare l’attendibilità delle rivelazioni, né per ipotizzare quale seguito giudiziario queste potranno avere. Ma non si può ignorare come, ancora una volta, la realtà smentisca chi vorrebbe annegare lo specifico del fenomeno mafioso in una genericità priva di qualsiasi riferimento ai suoi collegamenti con la terra d’origine. Penso allo scetticismo di tanti autorevoli esperti che ritengono riduttiva l’indicazione di cercare a Palermo la “testa del serpente”. Ma la realtà smentisce anche chi si ostina a disegnare improbabili scenari dove hanno vita schematici rapporti tra mafia e politica, ipotizzando una subalternità della prima rispetto alla seconda.
L’intreccio è, in realtà, molto più complesso di quanto si pensi e poco adatto a generalizzazioni tanto suggestive quanto infondate. Una costante, tuttavia, a conferma del potere di Cosa Nostra, si può dedurre dalle diverse vicende che costellano la storia siciliana. E cioè: la mafia si è sempre rifiutata seppure in presenza di pressioni politiche o di autorevoli centri di interessi di intervenire in imprese che non siano anche di sua utilità e comunque senza la garanzia del rispetto della propria autonomia.
Mi pare superfluo sottolineare quanto, tali caratteristiche, siano la spia della soglia di pericolosità ormai raggiunta dalla mafia. E della necessità che qualunque attività di contrasto tenga conto della unicità del fenomeno che si vuole combattere, facendo ricorso, dunque, a strategie unitarie e a strutture e uomini altamente specializzati.
“Il fatto è che il sedere di Falcone ha fatto comodo a tutti. Anche a quelli che volevano cavalcare la lotta antimafia. In questo,condivido una critica dei conservatori: Per me,meno si parla,meglio è.”
“Questi personaggi prima si lamentano perché non ho fatto carriera; poi se mi presento per il posto di procuratore,cominciano a vedere chissà quali manovre. Gente che occupa i 4/5 del tempo a discutere in corridoio; se lavorassero sarebbe molto meglio. Nel momento in cui non t’impegni,hai il tempo per criticare: guarda che cazzate fa quello che è passato al Pei e via dicendo. Basta,non è serio. Lo so di essere estremamente impopolare,ma la verità è questa.”
Giovanni Falcone in una intervista di Luca
BRUTTA ARIA
Tira una brutta aria sugli ultimi fatti siciliani di mafia e politica. Già gli avvenimenti, nel loro confuso susseguirsi, sono difficili da decifrare. Sembra che un trafficante di stupefacenti pentito, talora indicato come affiliato a “Cosa Nostra” e talaltra no, abbia fatto a un magistrato della procura di Trapani accuse nei confronti di cinque nomi eccellenti indicandoli come appartenenti a “Cosa Nostra”.
Il procuratore di Marsala, che sembrerebbe competente a ordinare un’indagine sulle rivelazioni del pentito, sembra non sia stato informato al momento del primo interrogatorio, un anno fa, ma solo in questi giorni. I verbali di quell’interrogatorio, prima di ulteriori accertamenti o avvisi di garanzia agli interessati, sembra siano scomparsi, ma poi riappaiono pubblicati sui giornali. Dopodiché il procuratore di Marsala, sempre per competenza, chiede la trasmissione degli atti al suo ufficio. I giornali titolano: silurato il magistrato antimafia (cioè, per intenderci, quello di Trapani che non avrebbe avvertito il collega di Marsala). Ne consegue che chi avrebbe reclamato la propria competenza sarebbe un magistrato insabbiatore.
Davanti a un tale pasticcio, non si intende entrare nel merito delle questioni: anche se ci vorrebbe una maggiore cautela nell’affibbiare certe etichette ai magistrati. Né è possibile formulare un giudizio sui fatti: il cui accertamento, tuttavia, a questo punto, dev’essere il più possibile rapido e rigoroso, proprio per non lasciare sospetti, né in un senso né in un altro.
Ma una grande amarezza, questa sì, sarà lecito esprimerla. Per l’approssimazione con la quale, dopo tanto tempo e tanti sforzi spesi per far riconoscere i connotati dell’organizzazione mafiosa, si finisce col mescolare nel calderone di “Cosa Nostra” tutto ciò che può assomigliargli. E per il modo in cui, se un pentito rivela che un candidato è stato aiutato dalla mafia per interessamento di un alto esponente del suo partito, che invece risulterebbe suo avversario, la rivelazione batte la logica, e si va avanti lo stesso.
Né si può fare a meno di rilevare che quanto è accaduto è la dimostrazione palmare degli effetti negativi del mancato coordinamento nelle indagini sulla criminalità organizzata; quel coordinamento da tanti sottovalutato e non di rado perfino calpestato. La certezza è che così non si fa un passo avanti nella dura lotta alla mafia. GIOVANNI FALCONE 9.9.1991
Questa è l’ultima testimonianza ufficiale del giudice Giovanni Falcone. L’occasione fu l’inserto di Repubblica Napoli “La Galleria del Giovedì” in cui si parlava delle
mafie. Il colloquio, pubblicato il giorno seguente alla strage sull’edizione nazionale di Repubblica, è stato poi ripreso dal Wall Street Journal, da altre testate e in seguito in alcuni volumi come Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi (Paul Ginsborg, Einaudi)
“Cosa nostra non dimentica. Non l’ho mai concretamente vista come una piovra. La mafia è una pantera. Agile, feroce, dalla memoria di elefante. Per questo bisogna fare in fretta e mettersi d’ accordo sulla Superprocura, uno strumento essenziale per arginare l’espansione dei boss. Il nemico è sempre lì, in attesa, pronto a colpire. Ma noi non riusciamo neppure a metterci d’ accordo sull’elezione del presidente della Repubblica…”.
Martedì, mezzogiorno, terzo piano di via Arenula. Giovanni Falcone concede la sua ultima intervista per l’inserto napoletano di cultura di Repubblica. Argomento: analogie e differenze tra camorra e mafia. Ma fuori dall’ufficialità dell’intervista Falcone confessa il suo grande cruccio: le dure e continue polemiche sulla Dna, la Direzione nazionale antimafia, subito ribattezzata Superprocura, l’organismo centrale che dovrebbe coordinare le inchieste sulla criminalità organizzata in tutt’ Italia.
Una breve attesa nella stanza dove lavorano due segretarie. Una camera in cui campeggiano le targhe e i riconoscimenti ottenuti da Falcone nei suoi anni al palazzo di giustizia di Palermo. Tra i ricordi, un quadro del pittore Bruno Caruso che richiama l’estate dei veleni, le lettere anonime che gettarono discredito sul magistrato antimafia: sono disegnati il Corvo, la Talpa, il Falcone.
Arriva Falcone, entriamo in un moderno ufficio con la tv accesa sul televideo in attesa di notizie da Montecitorio, libreria, una originale e divertente collezione di statuette che rappresentano paperi di ogni tipo, colore e dimensione. Giovanni Falcone, da poco più di un anno direttore degli Affari penali del ministero di Grazia e giustizia, si sfoga subito: “Inutile farsi illusioni. Non credo che sarò io il superprocuratore. Ma non mi importa granché. Quello a cui tengo veramente è che la Dna nazionale entri al più presto in funzione. Che a guidarla possa essere io o il procuratore calabrese Agostino Cordova è davvero un dettaglio. Non c’ è tempo da perdere, bisogna mettere da parte le guerre tra il Csm, l’Anm, il Guardasigilli, i partiti. Cosa nostra delinque senza soste, mentre noi litighiamo senza soste”.
Leggermente appesantito nonostante il nuovo hobby (il canottaggio ha sostituito le lunghe nuotate in piscina) Falcone insiste sulla Dna: “Critiche, polemiche strumentali, partiti un contro l’altro armati, che tristezza! Stiamo perdendo un’occasione storica per mettere in piedi una struttura moderna, funzionale; l’unica arma con la quale si può cercare di bloccare l’avanzata mafiosa. Dicevano che ero comunista, adesso mi etichettano come socialista: c’ è sempre una buona ragione per ritardare le misure antimafia e prendersela con Giovanni Falcone”.
E’ un Falcone diverso dai tempi palermitani. Non ha perso l’amara ironia e la cadenza sicula, ma ha messo da parte il linguaggio burocratico e i grandi silenzi che hanno scandito l’incisiva attività di giudice, perno del pool antimafia. Ha voglia di parlare Giovanni Falcone, di spiegarsi: “Mi accusano di volere il pubblico ministero schiavo dell’Esecutivo, succube del potere politico, incapace di esplicare la propria irrinunciabile autonomia. E’ una mistificazione, una scusa per bloccare la Direzione nazionale antimafia. Senza coordinamento quella con la mafia si può già considerare una guerra persa, senza appello. Gran parte dei miei ex colleghi si lamenta: ma cosa vogliono quei giudici? Tornare agli anni in cui erano totalmente dipendenti dal rapportino dei carabinieri e della polizia? Non è possibile, non è adeguato alla pericolosità del nemico, di Cosa nostra. C’ è la Dia, ed ha bisogno della Dna. Ma Falcone era comunista, ora è socialista, e qualunque idea abbia in testa deve per forza essere finalizzata a chissà quale diabolico disegno e dunque va bocciata. Non è così?”.
Sullo schermo del televideo appare una dichiarazione di Achille Occhetto: il leader della Quercia si professa moderatamente ottimista su una prossima elezione del capo dello Stato. Falcone spegne la televisione, scuote la testa: “Tante parole, nessun fatto. Litigheranno ancora. Io il mio candidato ce l’avrei: Spadolini. Ma pare l’abbiano messo da parte durante le loro liti quotidiane”. Falcone entra nel merito dell’intervista, definisce mafia e camorra: “La mafia non è il frutto malato di una società sana, ma una realtà autonoma con leggi severe create al proprio interno. Dotata di una struttura verticistica, piramidale e unitaria. Cosa nostra si fonda sull’assenza dello Stato in Sicilia, un vuoto colmato con regole alternative, elastiche nella loro apparente rigidità formale. Cosa nostra è come una chiesa, dispone di un ordinamento paragonabile a quello ecclesiale. E come la chiesa, sa rinnovarsi senza rinunciare alle propria fondamenta: non è un caso che il capo della Cupola, Michele Greco, sia stato soprannominato il Papa. La camorra, invece, priva di un’organizzazione verticistica, polverizzata in decine e decine di clan, non si oppone, ma vive dei buchi neri del Palazzo”.
Una pausa, telefonata da Palermo. Falcone ascolta l’interlocutore, poi dice: “Ti richiamo ad ora di pranzo”. Riprende l’intervista. “Cosa nostra e camorra hanno comunque una base comune. Sono entrambe ancorate alla subcultura mafiosa del Mezzogiorno, all’omertà che si è trasformata in memoria storica di uno Stato che non ti garantisce. Si tratta di organizzazioni che rispecchiano e travisano valori in sé non censurabili, tipici delle popolazioni meridionali. Capisco che questa affermazione possa far storcere il naso a qualcuno, ma è certo che la famiglia, l’amicizia, il coraggio, la lealtà, tutti presupposti di mafia e camorra, non sono comunque caratteristiche disprezzabili in assoluto, anzi. E’ altrettanto sicuro che il rispetto delle amicizie, della tradizione familiare, il richiamo ossessivo al coraggio e alla lealtà diventano valori strumentali a loschi scopi in camorra e mafia e perdono le caratteristiche nobili caricandosi invece di sentimenti negativi, assolutamente deprecabili”.
Gli domando delle collusioni mafia-politica, camorra-politica. Falcone sorride, si abbandona sulla poltrona, allunga le braccia sulla scrivania: “Cosa nostra è autonoma rispetto alla politica. Il rapporto è alla pari. In parecchie occasioni addirittura di superiorità del boss sul colletto bianco. Mentre la camorra, abilissima ad infiltrarsi all’interno delle pubbliche istituzioni, vive ancora un rapporto subalterno con il politico, non certo di superiorità”. Ancora il telefono. Falcone impreca: “E quando mai!”. Discute di fascicoli giudiziari, promette di richiamare, anche stavolta ad ora di pranzo.
Sono le tredici e qualche minuto. Puntuali, le sue ultime risposte: “Cosa nostra è una pantera, l’immagine della potenza, della ferocia. La camorra è una volpe. Apparentemente non dotata di grandissima forza, ma intelligente, astuta e spietata al momento opportuno. Fanno paura camorra e mafia, non esistono graduatorie di pericolosità nel crimine organizzato. E’ il momento di muoversi, di accantonare simpatie e antipatie, amici e nemici tra politici e magistrati. E’ il momento della Superprocura. Perché la pantera è vigile e non dimentica. Mai”.
“A volte ci si chiede se ci sono pentiti « veri » e pentiti «falsi ». Rispondo che è facile da capire se si conoscono le regole di Cosa Nostra. Un malavitoso di Adrano (Catania), un certo Pellegriti che aveva già collaborato utilmente coi magistrati per delitti commessi in provincia di Catania, aveva stranamente dichiarato di essere informato sull’assassinio a Palermo del presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella. Nel 1989 mi reco con alcuni colleghi a trovarlo in prigione per saperne di più e il Pellegriti racconta di essere stato incaricato da mafiosi palermitani e catanesi di recapitare nel capoluogo siciliano le armi destinate all’assassinio. Era chiaro fin dalle primissime battute che mentiva. Infatti è ben strano che un’organizzazione come Cosa Nostra, che ha sempre avuto grande disponibilità di armi, avesse la necessità di portare pistole a Palermo; né è poi pensabile, conoscendo le ferree regole della mafia, che un omicidio «eccellente », deciso al più alto livello della Commissione, venga affidato ad altri che a uomini dell’organizzazione di provata fede, i quali ne avrebbero dovuto preventivamente informare solo i capi del territorio in cui l’azione si sarebbe svolta; mai comunque estranei come il Pellegriti. I riscontri delle dichiarazioni di Pellegriti, subito disposti, hanno confermato, come era previsto, che si trattava di accuse inventate di sana pianta. Nel 1984 ci viene segnalato un altro «candidato» al pentimento: Vincenzo Marsala. Nel corso del processo per l’omicidio del padre, aveva pronunciato accuse molto gravi contro le famiglie di Termini e di Caccamo, sostenendo di aver ricevuto le informazioni in suo possesso dal padre. Lo faccio condurre a Palermo e dal tenore di alcune sue risposte mi convinco che si tratta al novantanove per cento di un uomo d’onore, nonostante i suoi dinieghi. Gli dico allora: «Signor Marsala, a partire da questo momento lei è indiziato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Decida che cosa fare». Mi guarda e insiste di non far parte di Cosa Nostra. Interrompo l’interrogatorio e lo rinvio. Qualche settimana dopo ha fatto sapere di essere pronto a parlare seriamente.” da ” Cose di cosa nostra“Ci si dimentica che il successo delle mafie è dovuto al loro essere dei modelli vincenti per la gente. E che lo Stato non ce la farà fin quando non sarà diventato esso stesso un «modello vincente».”
Appartengo a quella categoria di persone che ritiene che ogni azione debba essere portata a termine. Non mi sono mai chiesto se dovevo affrontare o no un certo problema, ma solo come affrontarlo.
Appena la presenza dello Stato in Sicilia si indebolisce, il livello di scontro di alza. E il mafioso diventa più sicuro di sé, più convinto della propria impunità Il dialogo Stato/mafia, con gli alti e bassi tra i due ordinamenti, dimostra chiaramente che Cosa Nostra non è un anti-Stato, ma piuttosto una organizzazione parallela che vuole approfittare delle storture dello sviluppo economico, agendo nell’illegalità e che, appena si sente veramente contestata e in difficoltà, reagisce come può, abbassando la schiena.
Avete chiuso cinque bocche, ne avete aperte 50 milioni.
Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche ed incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare.
Ci si dimentica che il successo delle mafie è dovuto al loro essere dei modelli vincenti per la gente. E che lo Stato non ce la farà fin quando non sarà diventato esso stesso un «modello vincente.
Ci troviamo di fronte a menti raffinatissime che tentano di orientare certe azioni della mafia. Esistono forse punti di collegamento tra i vertici di Cosa nostra e centri occulti di potere che hanno altri interessi. Ho l’impressione che sia questo lo scenario più attendibile se si vogliono capire davvero le ragioni che hanno spinto qualcuno ad assassinarmi.
Come evitare di parlare di Stato quando si parla di mafia?
Credo che Cosa Nostra sia coinvolta in tutti gli avvenimenti importanti della vita siciliana, a cominciare dallo sbarco alleato in Sicilia durante la seconda guerra mondiale e dalla nomina di sindaci mafiosi dopo la Liberazione. Non pretendo di avventurarmi in analisi politiche, ma non mi si vorrà far credere che alcuni gruppi politici non siano alleati a Cosa Nostra – per un’evidente convergenza di interessi – nel tentativo di condizionare la nostra democrazia, ancora immatura, eliminando personaggi scomodi per entrambi.
Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili.
Di me hanno detto: affogherà nelle sue stesse carte, non caverà un ragno dal buco, ama atteggiarsi a sceriffo, ma chi si crede di essere il ministro della giustizia? No, io ho la coscienza tranquilla. Nel ruolo di accusatore non ho mai prevaricato i diritti della difesa, non sono mai ricorso a strumenti che non fossero propri del giudice. Un interrogatorio è una partita a scacchi, un confronto fra intelligenze. Bisogna compenetrarsi fino in fondo in chi ci sta di fronte, pur sentendosi sempre Giudice. Bisogna capire, ma capire non è perdonare. Eppure ho sempre rispettato persino chi ha ordinato decine di delitti. Mai dimenticare che anche nel peggiore assassino, vive un barlume di dignità.
È tutto teatro. Quando la mafia lo deciderà, mi ammazzerà lo stesso. (Giovanni Falcone in riferimento alle sirene spiegate e ai poliziotti armati fino i denti che lo proteggevano durante l’incontro avuto con lo scrittore spagnolo Juan Arias)
Entrare a far parte della mafia equivale a convertirsi a una religione. Non si cessa mai di essere preti. Né mafiosi.
Fino a quando la regola non scritta è stata quella della non ingerenza tra i due ordinamenti, lo Stato e la mafia, il copione da rispettare era fisso: qualche anno di prigione, il potere di uno Stato «straniero» da sopportare e alla fine il ritorno a casa del mafioso con un’aureola di maggior prestigio.
Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.
Ho imparato che ogni atteggiamento di compromesso -il tradimento, o la semplice fuga in avanti- provoca un sentimento di colpa, un turbamento dell’anima, una sgradevole sensazione di smarrimento e di disagio con se stessi.
I risultati si ottengono con un impegno duro, continuo, quotidiano. Senza bluff. Senza dilettantismi. Dato che la lotta che stiamo combattendo è una vera e propria guerra coi suoi morti e i suoi feriti, come tutte le guerre deve essere combattuta con il massimo impegno e la massima serietà.
Il pensiero della morte mi accompagna ovunque. Ma, come dice Montaigne, diventa presto una seconda natura. Certo, si sta sul chi vive, si calcola, si osserva, ci si organizza, si evitano le abitudini ripetitive, si sta lontano dagli assembramenti e da qualsiasi situazione che non possa essere tenuta sotto controllo. Ma si acquista anche una buona dose di fatalismo; in fondo si muore per tanti motivi, un incidente stradale, un aereo che esplode in volo, una overdose, il cancro e anche per nessuna ragione particolare.
In Sicilia, per quanto uno sia intelligente e lavoratore, non è detto che faccia carriera, non è detto neppure che ce la faccia a sopravvivere. La Sicilia ha fatto del clientelismo una regola di vita. Difficile, in questo quadro far emergere pure e semplici capacità professionali. Quel che conta è l’amico o la conoscenza per ottenere una spintarella. E la mafia, che esprime sempre l’esasperazione dei valori siciliani, finisce per far apparire come un favore quello che è il diritto di ogni cittadino.
Insomma, se qualche risultato avevo raggiunto nella lotta contro la mafia era perché, secondo quelle lettere, avevo calpestato il codice e commesso gravi delitti. Però gli atti dei miei processi sono sotto gli occhi di tutti e sfido chiunque a scovare anomalie di sorta. Centinaia di esperti avvocati ci hanno provato, ma invano.
L’impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata è emotivo, episodico, fluttuante. Motivato solo dall’impressione suscitata da un dato crimine o dall’effetto che una particolare iniziativa governativa può suscitare sull’opinione pubblica.
L’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza.
L’insulto più sanguinoso per un uomo d’onore consiste nell’affibbiargli l’appellativo di « sbirro » o di « infame». Ricordo in proposito che a Trapani negli anni Sessanta, agli inizi della mia carriera, durante un litigio tra Mariano Licari, boss di Marsala, e un altro mafioso, « Sei uno sbirro » gridò il primo. E l’altro ribatté: « Se io sono uno sbirro, tu sei un carabiniere a cavallo ». Ho capito, in quel momento, quale viscerale avversione nutra il mafioso nei confronti dei rappresentanti dello Stato.
La cultura della morte non appartiene solamente alla mafia: tutta la Sicilia ne è impregnata. Da noi il giorno dei morti è festa grande: offriamo dolci che si chiamano teste di morto, fatti di zucchero duro come pietra. Solitudine, pessimismo, morte sono i temi della nostra letteratura, da Pirandello a Sciascia. Quasi fossimo un popolo che ha vissuto troppo e di colpo si sente stanco, spossato, svuotato, come il Don Fabrizio di Tomasi di Lampedusa. Le affinità tra Sicilia e mafia sono innumerevoli e non sono io certamente il primo a farlo notare. Se lo faccio, non è certo per criminalizzare tutto un popolo. Al contrario, lo faccio per far capire quanto sia difficile la battaglia contro Cosa Nostra: essa richiede non solo una solida specializzazione in materia di criminalità organizzata, ma anche una certa preparazione interdisciplinare.
La mafia a volte è articolazione del potere, a volte antitesi dello Stato dominatore.
La mafia è l’organizzazione più agile, duttile e pragmatica che si possa immaginare rispetto alle istituzioni e alla società nel suo insieme.
La mafia è razionale, vuole ridurre al minimo gli omicidi. Se la minaccia non raggiunge il segno, passa a un secondo livello, riuscendo a coinvolgere intellettuali, uomini politici, parlamentari, inducendoli a sollevare dubbi sull’attività di un poliziotto o di un magistrato ficcanaso, o esercitando pressioni dirette a ridurre il personaggio scomodo al silenzio. Alla fine ricorre all’attentato. Il passaggi all’azione è generalmente coronato da successo, dato che Cosa Nostra sa fare bene il suo mestiere.
La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
La mafia non è una società di servizi che opera a favore della collettività, bensì un’associazione di mutuo soccorso che agisce a spese della società civile e a vantaggio solo dei suoi membri.
La mafia si caratterizza per la sua rapidità nell’adeguare valori arcaici alle esigenze del presente, per la sua abilità nel confondersi con la società civile, per l’uso dell’intimidazione e della violenza, per il numero e la statura criminale dei suoi adepti, per la sua capacità ad essere sempre diversa e sempre uguale a se stessa.
La mafia, non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano. Vive in perfetta simbiosi con la miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, grandi e piccoli maestri cantori, gente intimidita o ricattata che appartiene a tutti gli strati della società. Questo è il terreno di coltura di Cosa nostra con tutto quello che comporta di implicazioni dirette o indirette, consapevoli o no, volontarie o obbligate, che spesso godono del consenso della popolazione.
La magistratura ha sempre rivendicato la propria indipendenza, lasciandosi in realtà troppo spesso irretire surrettiziamente dalle lusinghe del potere politico. Sotto la maschera di un’autonomia formale, il potere ci ha fatto dimenticare la mancanza di un’autonomia reale. Abbiamo sostenuto con passione la tesi del pubblico ministero indipendente dall’esecutivo, accorgendoci troppo tardi che, per un pubblico ministero privo di mezzi e delle capacità per un’azione incisiva, autonomia e indipendenza effettive sono un miraggio o un privilegio di casta.
La mescolanza tra società sana e società mafiosa a Palermo è sotto gli occhi di tutti e l’infiltrazione di Cosa Nostra costituisce la realtà di ogni giorno.
“La Sicilia è una terra dove, purtroppo, la struttura statale è deficitaria. La mafia ha saputo riempire il vuoto a suo modo e a suo vantaggio, ma tutto sommato ha contribuito a evitare per lungo tempo che la società siciliana sprofondasse nel caos totale. In cambio di servizi offerti (nel proprio interesse, non c’è dubbio) ha aumentato sempre più il proprio potere. E’ una realtà che non si può negare.”
La Sicilia ha fatto del clientelismo una regola di vita. Difficile, in questo quadro far emergere pure e semplici capacità professionali. Quel che conta è l’amico o la conoscenza per ottenere una spintarella. E la mafia, che esprime sempre l’esasperazione dei valori siciliani finisce per far apparire come un favore quello che è il diritto di ogni cittadino
Le leggi non servono se non sono sorrette da una forte e precisa volontà politica, se non sono in grado di funzionare per carenza di strutture adeguate e soprattutto se le strutture non sono dotate di uomini professionalmente qualificati. Professionalità significa innanzitutto adottare iniziative quando si è sicuri dei risultati ottenibili. Per seguire qualcuno per un delitto senza disporre di elementi irrefutabili a sostegno della sua colpevolezza significa fare un pessimo servizio. Il mafioso verrà rimesso in libertà, la credibilità del magistrato ne uscirà compromessa e quella dello Stato peggio ancora. Meglio è, dopo avere indagato su numerose persone, accontentarsi di perseguire solo quelle due o tre raggiunte da sicure prove di reità.
Le leggi non servono se non sono sorrette da una forte e precisa volontà politica, se non sono in grado di funzionare per carenza di strutture adeguate e soprattutto se le strutture non sono dotate di uomini professionalmente qualificati.
Lo stesso meccanismo di espulsione, praticamente, che si ritrova tra gli eschimesi e presso altri popoli che abbandonano i vecchi, i malati gravi, i feriti perché intralciano il loro cammino in una terra ostile, mettendo in pericolo la sopravvivenza di tutti. In un gruppo come la mafia, che deve difendersi dai nemici, chi è debole o malato deve essere eliminato.
Ma con quali strumenti affrontiamo oggi la mafia? In un modo tipicamente italiano, attraverso una proliferazione incontrollata di leggi ispirate alla logica dell’emergenza. Ogni volta che esplode la violenza mafiosa con manifestazioni allarmanti o l’ordine pubblico appare minacciato, con precisione cronometrica viene varato un decreto-legge tampone volto a intensificare la repressione, ma non appena la situazione rientra in una apparente normalità, tutto cade nel dimenticatoio e si torna ad abbassare la guardia.
Mi hanno accusato di avere con loro rapporti “intimistici”, del tipo “conversazione accanto al caminetto”. Si sono chiesti come avevo fatto a convincere tanta gente a collaborare e hanno insinuato che avevo fatto loro delle promesse mentre ne estorcevo le confessioni. Hanno insinuato che nascondevo “nei cassetti” la “parte politica” delle dichiarazioni di Buscetta. Si è giunti a insinuare perfino che collaboravo con una parte della mafia per eliminare l’altra. L’apice si è toccato con le lettere del “corvo”, in cui si sosteneva che con l’aiuto e la complicità di De Gennaro, del capo della polizia e di alcuni colleghi, avevo fatto tornare in Sicilia il pentito Contorno affidandogli la missione di sterminare i “Corleonesi”!
Mi rimane comunque una buona dose di scetticismo, non però alla maniera di Leonardo Sciascia, che sentiva il bisogno di Stato, ma nello Stato non aveva fiducia. Il mio scetticismo, piuttosto che una diffidenza sospettosa, è quel dubbio metodico che finisce col rinsaldare le convinzioni. Io credo nello Stato, e ritengo che sia proprio la mancanza di senso dello Stato, di Stato come valore interiorizzato, a generare quelle distorsioni presenti nell’animo siciliano: il dualismo tra società e Stato; il ripiegamento sulla famiglia, sul gruppo, sul clan; la ricerca di un alibi che permetta a ciascuno di vivere e lavorare in perfetta anomia, senza alcun riferimento a regole di vita collettiva. Che cosa se non il miscuglio di anomia e di violenza primitiva è all’origine della mafia? Quella mafia che essenzialmente, a pensarci bene, non è altro che espressione di un bisogno di ordine e quindi di Stato. E’ il mio scetticismo una specie di autodifesa? Tutte le volte che istintivamente diffido di qualcuno, le mie preoccupazioni trovano conferma negli eventi. Consapevole della malvagità e dell’astuzia di gran parte dei miei simili, li osservo, li analizzo e cerco di prevenirne i colpi bassi. Ho imparato a riconoscere l’umanità anche nell’essere apparentemente peggiore; ad avere un rispetto reale, e non solo formale, per le altrui opinioni. Ho imparato che ogni atteggiamento di compromesso il tradimento, o la semplice fuga in avanti provoca un sentimento di colpa, un turbamento dell’anima, una sgradevole sensazione di smarrimento e di disagio con se stessi.
Nei momenti di malinconia mi lascio andare a pensare al destino degli uomini d’onore: perché mai degli uomini come gli altri, alcuni dotati di autentiche qualità intellettuali, sono costretti a inventarsi un’attività criminale per sopravvivere con dignità?
Niente è ritenuto innocente in Sicilia, né far visita al direttore di una banca per chiedere un prestito perfettamente legittimo, Né un alterco tra deputati né un contrasto ideologico all’interno di un partito. Accade quindi che alcuni politici a un certo momento si trovino isolati nel loro stesso contesto. Essi allora diventano vulnerabili e si trasformano inconsapevolmente in vittime potenziali. Al di là delle specifiche cause della loro eliminazione, credo sia incontestabile che Mattarella, Reina, La Torre erano rimasti isolati a causa delle battaglie politiche in cui erano impegnati. Il condizionamento dell’ambiente siciliano, l’atmosfera globale hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichiarazioni, certi comportamenti valgono a individuare la futura vittima senza che la stessa se ne renda nemmeno conto.
Noi del pool antimafia abbiamo vissuto come forzati: sveglia all’alba per studiare i dossier prima di andare in tribunale, ritorno a casa a tarda sera. Nel 1985 io e Paolo Borsellino siamo andati in «vacanza» in una prigione, all’Asinara, in Sardegna per stendere il provvedimento conclusivo dell’istruttoria del maxiprocesso.
Non rimpiango niente, anche se a volte percepisco nei miei colleghi un comprensibile desiderio di tornare alla normalità: meno scorte, meno protezione, meno rigore negli spostamenti. E allora mi sorprendo ad aver paura delle conseguenze di un simile atteggiamento: normalità significa meno indagini, meno incisività, meno risultati. E temo che la magistratura torni alla vecchia routine: i mafiosi che fanno il loro mestiere da un lato, i magistrati che fanno più o meno bene il loro dall’altro, e alla resa dei conti, palpabile, l’inefficienza dello Stato.
Per lungo tempo si sono confuse la mafia e la mentalità mafiosa, la mafia come organizzazione illegale e la mafia come semplice modo di essere. Quale errore! Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale.
“Occuparsi di indagini di mafia significa procedere su un terreno minato: mai fare un passo prima di essere sicuri di non andare a posare il piede su una mina «antiuomo». Il principio è valido per tutte le istruttorie che riguardano più o meno da vicino la criminalità organizzata, ma ancora di più per una persona come me nel momento in cui mi avventuravo in una terra ancora quasi vergine sotto il fuoco incrociato di amici e nemici, anche all’interno della magistratura. I miei colleghi sostenevano che ero affetto da vis attractiva; a loro avviso, insomma, volevo avocare a me tutti i processi d’Italia. Un alto magistrato diede questo suggerimento al mio capo Rocco Chinnici:
«Seppelliscilo sotto montagne di piccoli processi, almeno ci lascerà in pace». Al tribunale di Palermo sono stato oggetto di una serie di microsismi, fattisi via via più intensi con il passare del tempo. Davo fastidio.” Tratto dal libro Cose di Cosa Nostra di Giovanni Falcone
Per vent’anni l’Italia è stata governata da un regime fascista in cui ogni dialettica democratica era stata abolita. E successivamente un unico partito, la Democrazia cristiana, ha monopolizzato, soprattutto in Sicilia, il potere, sia pure affiancato da alleati occasionali, fin dal giorno della Liberazione. Dal canto suo, l’opposizione, anche nella lotta alla mafia, non si è sempre dimostrata all’altezza del suo compito, confondendo la lotta politica contro la Democrazia cristiana con le vicende giudiziarie nei confronti degli affiliati a Cosa Nostra, o nutrendosi di pregiudizi: “Contro la mafia non si può far niente fino a quando al potere ci sarà questo governo con questi uomini”. La paralisi c’è stata quindi su tutti i fronti. La classe dirigente, consapevole dei problemi e delle difficoltà di ogni genere connesse a un attacco frontale alla mafia, senza peraltro alcuna garanzia di successo immediato, ha compreso che a breve aveva tutto da perdere e poco da guadagnare nell’impegnarsi sul terreno dello scontro. E ha preteso quindi di fronteggiare un fenomeno di tale gravità coi soliti pannicelli caldi, senza una mobilitazione generale, consapevole, duratura e costante di tutto l’apparato repressivo e senza il sostegno delle società civile. I politici si sono preoccupati di votare leggi di emergenza e di creare istituzioni speciali che, sulla carta, avrebbero dovuto imprimere slancio alla lotta antimafia, ma che, in pratica, si sono risolte in una delega delle responsabilità proprie del governo a una struttura dotata di mezzi inadeguati e priva dei poteri di coordinare l’azione anticrimine.
Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere.
Possiamo sempre fare qualcosa: massima che andrebbe scolpita sullo scranno di ogni magistrato e di ogni poliziotto.
Scelti dopo durissima selezione, obbedienti a regole severe, gli uomini d’onore sono dei veri professionisti del crimine. Anche quando si definiscono « soldati », sono in realtà dei generali. O meglio cardinali di una chiesa molto meno indulgente di quella cattolica.
Se non si comprenderà che, per quanto riguarda Cosa nostra e altre organizzazioni similari, è assolutamente improprio parlare di “emergenza”, in quanto si tratta di fenomeni endemici e saldamente radicati nel tessuto sociale, e se si continuerà a procedere in modo schizofrenico, alternando periodi intensificata repressione con altri di attenuato impegno investigativo, si consentirà alle organizzazioni criminali di proseguire indisturbate nelle loro attività e, in definitiva, sarà stato vano il sacrificio di tanti fedeli servitori dello Stato. E’ necessario, dunque, prescindere da fattori emozionali e procedere ad una analisi razionale della situazione attuale; analisi che, è bene ribadirlo, è non solo legittima, ma doverosa anche in sede giudiziaria, senza perciò ledere prerogative istituzionali di altri organismi statuali.
Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia.
Se vogliamo conoscere il senso dell’esistenza, dobbiamo aprire un libro, là in fondo, nell’angolo più oscuro del capitolo, c’è una frase scritta apposta per noi: Un uomo non muore mai in modo definitivo, finché resta un punto di riferimento delle discussioni e delle azioni di quanti lo seguono.
Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere.
“Sono andato ad abitare in via Notarbartolo, una strada che scende verso via della Libena, il cuore di Palermo, L’amministratore dello stabile per prima cosa mi ha spedito una lettera ufficiale, che in relazione alla mia presenza in quell’immobile e nel timore di attentati ammoniva: <<L’amministrazione declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero essere recati alle parti comuni dell’edificio>>.Un giorno arrivato davanti a casa, con il mio solito seguito di sirene spiegate, purtroppo, di auto della polizia e di agenti con le armi in pugno, ho avuto il tempo di sentire un passante sussurrare: Certo che per essere protetto in questo modo, deve avere commesso qualcosa di malvagio” (Giovanni Falcone, Cose di cosa nostra).
Sono nato in uno di quei quartieri ieri nobili, oggi più disgregati della vecchia Palermo, dove ho vissuto fino all’età di ventuno anni. Mio padre era una persona seria, onesta, legata alla famiglia. Mia madre una donna energica, autoritaria. Entrambi furono genitori che da me pretesero il massimo, con i sette e gli otto, la mia pagella veniva considerata brutta. Il tempo lo trascorrevo nella biblioteca di famiglia, divorando libri di avventura, storia di Francia di Sicilia ecc.ecc.. Dopo il liceo entrai all’accademia navale, volevo laurearmi in ingegneria, ma mi spedirono allo Stato Maggiore perché dicevano che avevo attitudini al comando, mio padre non ostacolò questa scelta ma mi iscrisse in legge e nel 1961 mi laureai con 110 e lode. Tentai così il concorso per entrare in magistratura che vinsi senza alcuna raccomandazione. A ventisei anni ero Pretore a Lentini con uno stipendio di 110 mila lire al mese, poi il trasferimento d’ufficio a Trapani con la qualifica di Sostituto Procuratore, dove scoprì progressivamente il penale. Era la valutazione oggettiva dei fatti che mi affascinava. Durante la guerra ci trovammo sfollati a Corleone, in casa di alcuni parenti, mamma era nata lì. “Corleone” no, quell’episodio non ha avuto un peso particolare nelle mie scelte future certo, era il paese nativo di Luciano Liggio anche se con mio padre non si parlava mai di mafia. Tornato a Palermo ottenni di misurarmi con l’attività di giudice istruttore. Che idea avevo allora della mafia? allora ogni fascicolo giudiziario era un fatto a se stante, una storia nata in un certo punto e conclusa in un altro. Ci sfuggiva la veduta d’insieme, l’unicità del fenomeno. Istruì molti processi per delitti di mafia, il lavoro non mi metteva paura e neppure i mafiosi. Erano già avvenuti delitti gravissimi e a tutti ormai era chiaro un messaggio inequivocabile, più si indaga seriamente sulla mafia, più si corrono pericoli di vita. Quando fu assassinato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Carini, sul luogo della strage qualcuno tracciò la scritta: <> frase disperata e sinistrica. I palermitani onesti sono molti di più di quanto si possa immaginare. Le abitudini peggiori del palazzo di Giustizia a Palermo? i pettegolezzi, le chiacchiere da corridoio, una riserva mentale costante. Di me hanno detto: affogherà nelle sue stesse carte, non caverà un ragno dal buco, ama atteggiarsi a sceriffo, ma chi si crede di essere il ministro della giustizia? No, io ho la coscienza tranquilla. Nel ruolo di accusatore non ho mai prevaricato i diritti della difesa, non sono mai ricorso a strumenti che non fossero propri del giudice. Un interrogatorio è una partita a scacchi, un confronto fra intelligenze. Bisogna compenetrarsi fino in fondo in chi ci sta di fronte, pur sentendosi sempre Giudice. Bisogna capire, ma capire non è perdonare. Eppure ho sempre rispettato persino chi ha ordinato decine di delitti. Mai dimenticare che anche nel peggiore assassino, vive sempre un barlume di dignità.
Sono stato pesantemente attaccato sul tema dei pentiti. Mi hanno accusato di avere con loro rapporti “intimistici”, del tipo “conversazione accanto al caminetto”. Si sono chiesti come avevo fatto a convincere tanta gente a collaborare e hanno insinuato che avevo fatto loro delle promesse mentre ne estorcevo le confessioni. Hanno insinuato che nascondevo “nei cassetti” la “parte politica” delle dichiarazioni di Buscetta. Si è giunti a insinuare perfino che collaboravo con una parte della mafia per eliminare l’altra. L’apice si è toccato con le lettere del “corvo”, in cui si sosteneva che con l’aiuto e la complicità di De Gennaro, del capo della polizia e di alcuni colleghi, avevo fatto tornare in Sicilia il pentito Contorno affidandogli la missione di sterminare i “Corleonesi”!
“Sono semplicemente un servitore dello Stato in terra infidelium… Il mio conto con Cosa Nostra resta aperto. Lo salderò solo con la mia morte, naturale o meno”.
Su queste vicende io credo che ormai ci sia unanimità di diagnosi,di analisi di questi problemi e di questi fenomeni. Noi diciamo,e lo diciamo da sempre,e ormai quello che diciamo è fatto abbastanza scontato,che una delle connotazioni della mafia e delle organizzazioni similari è la territorialità,cioè il controllo del territorio. Controllo del territorio che si esplica quindi nel condizionamento di qualsiasi attività che può avere qualsiasi rilevanza, ivi comprese le attività politico amministrative. In questo senso,quando,io soprattutto, ho negato l’esistenza del terzo livello,ho inteso dire che i fatti sono molto più gravi di quello che si pensi, perché non siamo in presenza di organizzazioni mafiose che eseguono ordini che vengono dall’esterno, ma peggio, di organizzazioni mafiose che controllano e dirigono anche le attività che dovrebbero essere di esclusiva pertinenza dello Stato e degli altri enti pubblici.
Tutte le volte che istintivamente diffido di qualcuno, le mie preoccupazioni trovano conferma negli eventi. Consapevole della malvagità e dell’astuzia di gran parte dei miei simili, li osservo, li analizzo e cerco di prevenirne i colpi bassi.
Il mafioso è animato dallo stesso scetticismo sul genere umano. “Fratello, ricordati che devi morire” ci insegna la Chiesa cattolica. Il catechismo non scritto dei mafiosi suggerisce qualcosa di analogo: il rischio costante della morte, lo scarso valore attribuito alla vita altrui, ma anche alla propria, li costringono a vivere in stato di perenne allerta. Spesso ci stupiamo della quantità incredibile di dettagli che popolano la memoria della gente di Cosa Nostra. Ma quando si vive come loro in attesa del peggio si è costretti a raccogliere anche le briciole. Niente è inutile. Niente è frutto del caso. La certezza della morte vicina, tra un attimo, una settimana, un anno, pervade del senso della precarietà ogni istante della loro vita.
Tutti hanno fatto credere di essermi amici, poi me li sono trovati dall’altra parte: democristiani, socialisti, comunisti…tutti. Non ti sembra la prova più evidente che io cerco di rimanere sempre lo stesso, mentre gli altri cambiano a seconda dei loro interessi? eppure i miei colleghi mi negano questo credito.
Un’affermazione del genere mi costa molto, ma se le istituzioni continuano nella loro politica di miopia nei confronti della mafia, temo che la loro assoluta mancanza di prestigio nelle terre in cui prospera la criminalità organizzata non farà che favorire sempre di più Cosa Nostra.
Uno dei miei colleghi romani, nel 1980, va a trovare Frank Coppola, appena arrestato, e lo provoca: «Signor Coppola, che cosa è la mafia?». Il vecchio, che non è nato ieri, ci pensa su e poi ribatte: « Signor giudice, tre magistrati vorrebbero oggi diventare procuratore della Repubblica. Uno è intelligentissimo, il secondo gode dell’appoggio dei partiti di governo, il terzo è un cretino, ma proprio lui otterrà il posto. Questa è la mafia… ».
Le frasi di Giovanni Falcone, per ricordare e onorare un grande uomo
Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e cambiare, c’è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare.
Si muore perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno.
Senza un metodo non si capisce niente.
I risultati si ottengono con un impegno duro, continuo, quotidiano. Senza bluff. Senza dilettantismi.
Lo stesso meccanismo di espulsione, praticamente, che si ritrova tra gli eschimesi e presso altri popoli che abbandonano i vecchi, i malati gravi, i feriti perché intralciano il loro cammino in una terra ostile, mettendo in pericolo la sopravvivenza di tutti. In un gruppo come la mafia, che deve difendersi dai nemici, chi è debole o malato deve. essere eliminato.
Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere.
Avete chiuso cinque bocche, ne avete aperte 50 milioni.
Non rimpiango niente, anche se a volte percepisco nei miei colleghi un comprensibile desiderio di tornare alla normalità: meno scorte, meno protezione, meno rigore negli spostamenti. E allora mi sorprendo ad aver paura delle conseguenze di un simile atteggiamento: normalità significa meno indagini, meno incisività, meno risultati. E temo che la magistratura torni alla vecchia routine: i mafiosi che fanno il loro mestiere da un lato, i magistrati che fanno più o meno bene il loro dall’altro, e alla resa dei conti, palpabile, l’inefficienza dello Stato.
Nei momenti di malinconia mi lascio andare a pensare al destino degli uomini d’onore: perché mai degli uomini come gli altri, alcuni dotati di autentiche qualità intellettuali, sono costretti a inventarsi un’attività criminale per sopravvivere con dignità.
Le frasi di Giovanni Falcone sul coraggio
Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola.
Dato che la lotta che stiamo combattendo è una vera e propria guerra coi suoi morti e i suoi feriti, come tutte le guerre deve essere combattuta con il massimo impegno e la massima serietà.
L’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza.
Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per quello che ha fatto. Contano le azioni, non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili.
Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.
Ho sempre saputo che per dare battaglia bisogna lavorare a più non posso.
Le leggi non servono se non sono sorrette da una forte e precisa volontà politica, se non sono in grado di funzionare per carenza di strutture adeguate e soprattutto se le strutture non sono dotate di uomini professionalmente qualificati.
Le frasi di Giovanni Falcone sulla legalità
La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
L’avere dimostrato la vulnerabilità della mafia costituisce una forza anche per gli investigatori nella misura in cui dà la consapevolezza che i mafiosi sono uomini come gli altri, criminali come gli altri, e che possono essere combattuti con una efficace repressione.
L’imperativo categorico dei mafiosi, di «dire la verità», è diventato un principio cardine della mia etica personale, almeno riguardo ai rapporti veramente importanti della vita. Per quanto possa sembrare strano, la mafia mi ha impartito una lezione di moralità.
Io credo che occorra rendersi conto che questa non è una lotta personale tra noi e la mafia. Se si capisse che questo deve essere un impegno – straordinario nell’ordinarietà – di tutti nei confronti di un fenomeno che è indegno di un paese civile, certamente le cose andrebbero molto meglio.
La mafia, lo ripeto ancora una volta, non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano. Vive in perfetta simbiosi con la miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, grandi e piccoli maestri cantori, gente intimidita o ricattata che appartiene a tutti gli strati della società. Questo è il terreno di coltura di Cosa Nostra con tutto quello che comporta di implicazioni dirette o indirette, consapevoli o no, volontarie o obbligate, che spesso godono del consenso della popolazione.
Credo che Cosa Nostra sia coinvolta in tutti gli avvenimenti importanti della vita siciliana, a cominciare dallo sbarco alleato in Sicilia durante la seconda guerra mondiale e dalla nomina di sindaci mafiosi dopo la Liberazione. Non pretendo di avventurarmi in analisi politiche, ma non mi si vorrà far credere che alcuni gruppi politici non siano alleati a Cosa Nostra – per un’evidente convergenza di interessi – nel tentativo di condizionare la nostra democrazia, ancora immatura, eliminando personaggi scomodi per entrambi.
Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia.
Possiamo sempre fare qualcosa: massima che andrebbe scolpita sullo scranno di ogni magistrato e di ogni poliziotto.
La mafia si caratterizza per la sua rapidità nell’adeguare valori arcaici alle esigenze del presente, per la sua abilità nel confondersi con la società civile, per l’uso dell’intimidazione e della violenza, per il numero e la statura criminale dei suoi adepti, per la sua capacità ad essere sempre diversa e sempre uguale a se stessa.
Per lungo tempo si sono confuse la mafia e la mentalità mafiosa, la mafia come organizzazione illegale e la mafia come semplice modo di essere. Quale errore! Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale.
La tendenza dei siciliani alla discrezione, per non dire al mutismo, è proverbiale. Nell’ambito di Cosa Nostra raggiunge il parossismo. L’uomo d’onore deve parlare soltanto di quello che lo riguarda direttamente, solo quando gli viene rivolta una precisa domanda e solo se è in grado e ha diritto di rispondere.
Tre magistrati vorrebbero oggi diventare procuratore della Repubblica. Uno è intelligentissimo, il secondo gode dell’appoggio dei partiti di governo, il terzo è un cretino, ma proprio lui otterrà il posto. Questa è la mafia
https://www.youtube.com/watch?v=IAsJRhH5clM