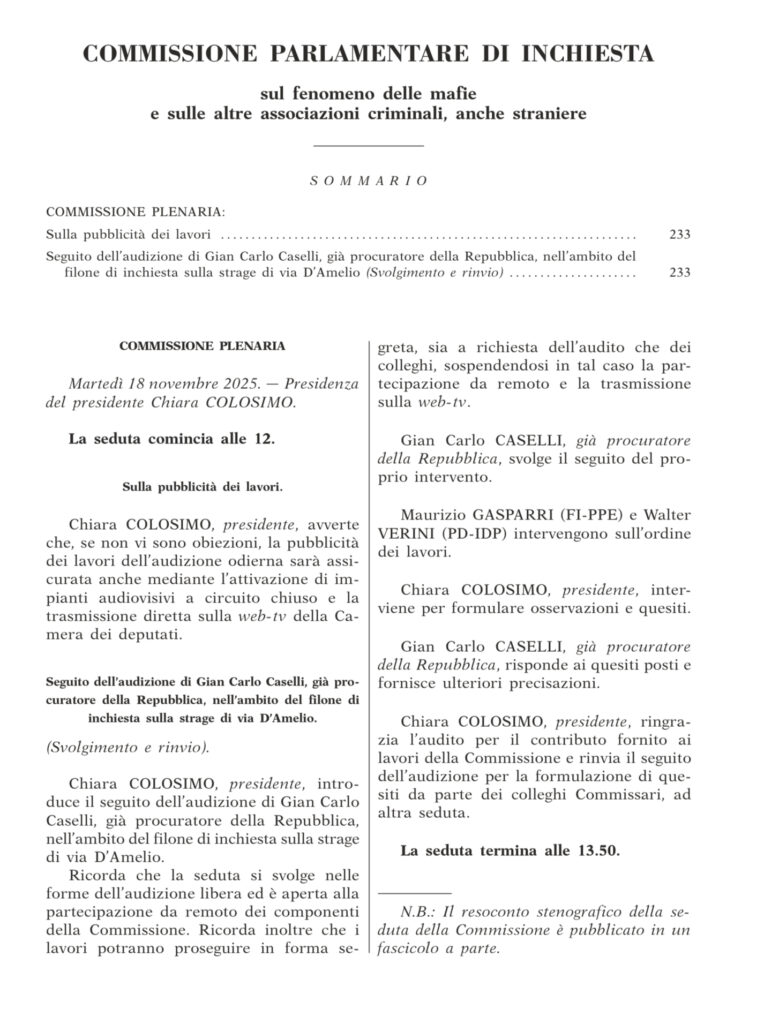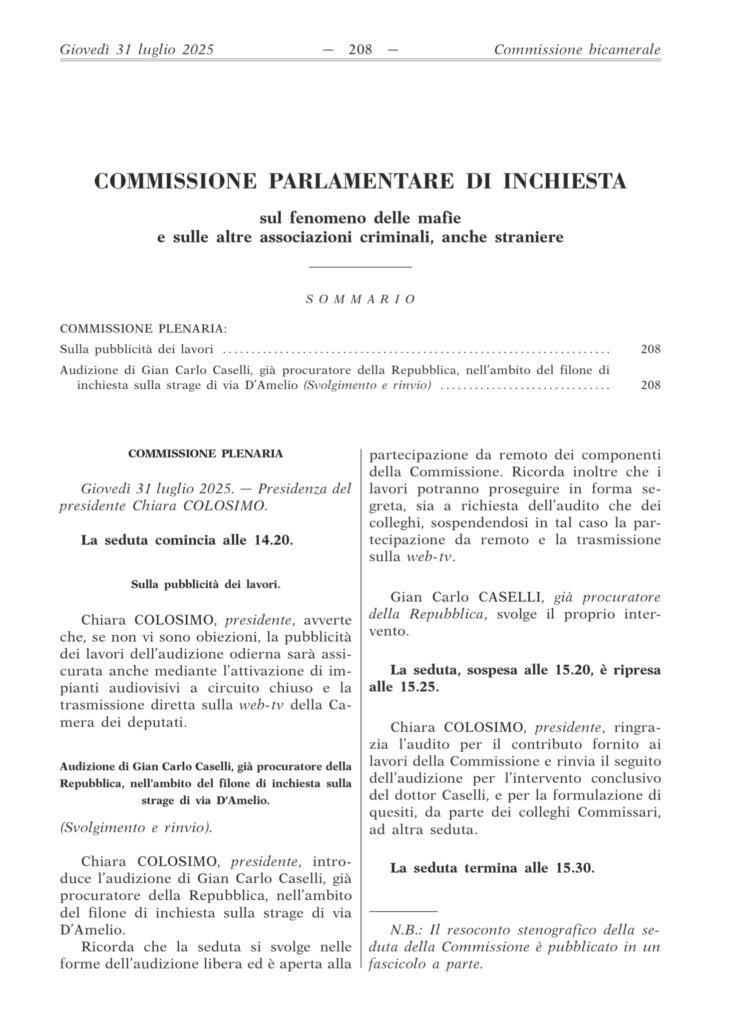AUDIZIONE IN COMMISSIONE ANTIMAFIA – La disarmante e contraddittoria risposta di GIANCARLO CASELLI alla Presidente COLOSIMO
VIDEO 18.11.2025
XIX Legislatura Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Resoconto stenografico Seduta n. 97 di Martedì 18 novembre 2025 Seguito dell’audizione di Gian Carlo Caselli, già procuratore della Repubblica, nell’ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D’Amelio.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHIARA COLOSIMO
La seduta comincia alle 12.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione di Gian Carlo Caselli, già procuratore della Repubblica, nell’ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D’Amelio.
Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell’audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione.
I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell’audito o dei colleghi e in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web-tv.
Do la parola al dottor Caselli, che voglio veramente ringraziare per la sua cortesia e disponibilità nell’essere tornato. Abbiamo tempo fino alle 14. Speriamo di poter fare sia la conclusione della relazione che alcune domande che immagino ci siano da parte dei commissari.
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Grazie a lei, presidente.
Signor presidente, signori commissari, buongiorno a tutti e grazie per la vostra attenzione. Consegno alla presidente una copia scritta integrale del mio intervento, per cui nell’esposizione orale potrò sintetizzare alcuni punti o rinviare allo scritto. Ci sono anche due allegati di cui parleremo.
In premessa vorrei sottoporre alla vostra attenzione un fatto che potrebbe avere ricadute sui lavori della Commissione; un fatto scoperto di recente che riguarda il libro di Mori e De Donno – ometto i titoli ufficiali che non appartengono per brevità, ma non voglio mancare assolutamente di rispetto a nessuno – L’altra verità, edito Piemme, del 2024. È un libro che narra dei rapporti che si instaurarono fra i due autori e Vito Ciancimino per quella che sarà poi nominata la cosiddetta «trattativa».
A pagina 36 di questo libro, il capitolo «Il primo incontro» di De Donno con don Vito inizia con le parole «fine giugno 1992». Il secondo incontro, sempre stando al libro di Mori e De Donno, avviene un paio di settimane dopo (pagina 48). Quindi, se consideriamo fine giugno più quindici giorni, siamo al 15 luglio circa.
A pagina 52 si descrive questo secondo incontro. De Donno entra nella stanza di Ciancimino, che non alza nemmeno gli occhi dal giornale. Si limita con un gesto della mano a indicare dove accomodarsi. Ciancimino sta leggendo con attenzione un articolo sul Corriere della Sera in taglio alto, sopra un pezzo dedicato al mostro di Firenze, Pacciani. Il capitano De Donno riesce a scorrere il titolo: «I diari con i segreti di Falcone».
Devo ringraziare un mio amico, Davide Mattiello, conosciuto nel giro di Libera, l’associazione che fa capo a don Ciotti, perché ha recuperato dall’archivio del Corriere della Sera la pagina in oggetto. Tale pagina risulta essere del 21 giugno 1992, non luglio, ma giugno. Questa è una delle produzioni che mi sonoPag. 4permesso di fare e di controllare. Produco fotocopia della pagina 52 del libro L’altra verità e della pagina del Corriere della Sera del 21 giugno 1992 con gli articoli sul diario di Falcone e su Pacciani. Risulta di conseguenza sbagliata anche la data del primo incontro come riferita da De Donno.
Se il secondo incontro è del 21 giugno il primo non può certamente essere della fine di giugno, come invece asserito da De Donno nel libro. Se poi la cronologia degli incontri con Ciancimino è ricostruita eliminando gli errori di De Donno possa avere una ricaduta nel collegamento con la strage di via D’Amelio, nel senso di indirizzarla più che a mafia-appalti alla cosiddetta «trattativa», lo potrà eventualmente dire la Commissione.
Va considerato che nell’ipotesi della «trattativa» lo spazio temporale comunque ricompreso secondo Brusca tra Capaci e i primi di luglio entro cui Riina prese la decisione di ordinare a Brusca di uccidere non Mannino, ma Paolo Borsellino, con la cronologia sbagliata è troppo breve, mentre con quella giusta, ottenuta grazie all’articolo del Corriere della Sera, diventa compatibile.
Avevamo già trattato nella precedente audizione il tema della attendibilità di De Donno, ricordando a riguardo alcuni episodi specifici e rilevanti. Risulta confermato che per De Donno si pongono obiettivamente problemi di attendibilità.
Nell’audizione del 31 luglio, esaminato il tema del «pessimo affare» di resuscitare il 41-bis che stava morendo, dovendo stringere i tempi, non avevo trattato un’altra questione pregiudiziale che ora vorrei esaminare.
La prima è una pregiudiziale in punto di diritto, a mio avviso non facilmente eludibile. Si basa sul fatto che su mafia-appalti esiste una circostanziata documentazione intitolata «Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini di mafia-appalti negli anni 1989 e seguenti» da me consegnata all’Antimafia nel corso di un’audizione a Palermo del 3 febbraio 1999. Quando parleremo di Relazione 1999 a questa ci riferiremo.
C’era un’altra relazione analoga, del 1992, redatta pochi mesi dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, depositata in quella stessa sede al CSM. Queste relazioni espongono in dettaglio la realtà delle cose, al di là della disinformazione, se non peggio, di chi si ispira a recriminazioni e rancori. In ogni caso, il CSM e la Commissione Antimafia sapevano bene e da molto tempo come erano andate le cose ed erano in possesso di tutti gli elementi necessari per capire e giudicare.
È certamente nelle prerogative di questa Commissione scegliere il proprio campo di indagine. Tuttavia, mi permetto di segnalare che, a mio avviso, non si è verificato alcun fatto nuovo rispetto a quanto già a conoscenza dell’Antimafia e del CSM.
Un’altra considerazione pregiudiziale che si può fare è questa. Per ogni fatto processuale a loro avviso controverso, Mori e De Donno abbandonano il proprio ruolo istituzionale e le responsabilità connesse per indicare la necessità di un diverso modo di procedere funzionale a non altro se non al loro intento. Lamentano di aver subìto una macchinazione giudiziaria organizzata per impedire a loro di portare alla luce le responsabilità dei magistrati.
A pagina 64 dell’audizione di Mori e De Donno si legge addirittura che «Se si indagasse, si scoprirebbe che i più gravi depistaggi della storia italiana, compreso quello sull’agenda rossa, potrebbero essere stati perpetrati dallo stesso gruppo di magistrati della procura». Credo che ci sia una qualche esagerazione dettata da una forma di esasperazione argomentativa che non appare consona al prestigio professionale di cui godono gli ufficiali dell’Arma.
I più gravi depistaggi della storia italiana risalgono al 1969, piazza Fontana, e alle stragi neofasciste successive, come ha più volte chiarito e dichiarato il Capo dello Stato.
I due ex ufficiali sostengono, inoltre, che dal 1992 al 2021 sempre le stesse persone dello stesso ufficio giudiziario si sarebbero accanite contro di loro. Nello spirito che mi anima di agevolare i lavori di questa Commissione, ricordo che quando arrivai a Palermo come nuovo procuratore il 15 gennaio del 1993 riscuotevo piena fiducia del ROS, da me ricambiata, per i positivi trascorsi con il gruppo diretta dal generale dalla Chiesa sul versante antiterrorismo. Eppure nessun ufficiale del ROS mi informò circa gli interessi di Borsellino per mafia-appalti.
Il generale Mori afferma il contrario senza provarlo, ma se fossi stato informato, con il nuovo clima che si era creato su mio impulso nella procura, per il rilievo della informazione, avrei certamente informato a mia volta i colleghi nella prima delle riunioni destinate alla circolazione dei dati fra i magistrati dell’ufficio.
Ho ancora un interrogativo.
Perché il capitano De Donno si reca a Caltanissetta a chiedere interventi dopo qualche decisione di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria non gradita a lui o al generale Mori? Certamente non sono questi i comportamenti che ci si aspetta da ufficiali dell’Arma. È singolare che, dopo la visita del capitano De Donno a Caltanissetta, sui mezzi di informazione vengono pubblicate con ampio risalto notizie dirette a privare di credibilità la procura di Palermo.
Il capitano De Donno agiva per scoprire i delinquenti e gli assassini di Paolo Borsellino e della sua scorta o per togliere reputazione ai magistrati della procura di Palermo? Peraltro, le denunce alla procura di Caltanissetta sono state sempre archiviate da quei magistrati.
A questo punto vorrei fare alcune importanti integrazioni a quanto detto nella precedente audizione del 31 luglio. Abbiamo già esaminato il 31 luglio la fondamentale testimonianza di David Monti. A pagina 48 di un recentissimo libro di Vincenzo Ceruso, Paolo Borsellino. La toga, la fede, il coraggio, San Paolo Edizioni, 2025, troviamo l’intervista fatta a Monti dall’autore.
Vengo alle dichiarazioni di David Monti: «Ricordo molto bene che Paolo Borsellino diceva anche quella sera del 18 luglio – David Monti è l’ultimo che ha parlato con Borsellino la sera prima dell’omicidio – di aver compreso che le organizzazioni mafiose avevano un disegno criminale, una strategia progressiva avviata con Lima e proseguita con Capaci di cui lui, Paolo Borsellino, sarebbe stato sicuramente il prossimo obiettivo dopo Falcone».
È facile rilevare che «strategia progressiva» corrisponde a quel che abbiamo visto nell’audizione del 31 luglio. Paolo Borsellino è stato ucciso con Falcone dalla reazione di cosa nostra dopo la conferma del maxi in Cassazione contro amici traditori e nemici.
Proseguiamo con l’integrazione al 31 luglio e con altri contributi. Per ciascuno dei nominativi che farò sono specificate le fonti delle relative dichiarazioni, ma nell’esposizione verbale salterò questi dati che sono comunque nella relazione.
Agnese Borsellino di mafia-appalti non parla mai, eppure Paolo Borsellino le confidava anche i segreti più delicati e scabrosi, come il fatto di aver appreso che il generale Subranni era «punciutu». All’evidenza il silenzio su mafia-appalti non è circostanza di poco conto, anzi.
Diego Cavaliero, molto amico di Paolo Borsellino, lo incontra in un convegno di MI (Magistratura Indipendente) a Giovinazzo nel giugno del 1992 e poi ancora il 12 luglio 1992 a Salerno per il battesimo del figlio di cui Paolo Borsellino è padrino. Dice Cavaliero che Borsellino appare diverso dal solito; persa l’abituale giovialità, assente, dice che non c’era più Falcone come parafulmine; aveva fretta di trovare la chiave di lettura di Capaci, avrebbe voluto, diceva, le giornate di 48 ore. Non si parla di mafia-appalti.
Ingroia, prediletto fra gli allievi di Borsellino, con lui a Marsala e poi a Palermo: abbiamo soltanto un generico riferimento alla possibilità che Borsellino vedesse in mafia-appalti una delle chiavi per ricostruire Capaci.
Liliana Ferraro, magistrato ministeriale nel ruolo che era stato di Falcone: Paolo Borsellino era interessato soprattutto all’invio anomalo del rapporto mafia-appalti al Ministro Martelli da parte del procuratore Giammanco.
La Ferraro ricorda anche un colloquio con De Donno probabilmente una settimana prima del 28 giugno 1992. De Donno le parla di Ciancimino e la Ferraro lo invita a informare Paolo Borsellino.
Poi abbiamo Alessandra Camassa e Massimo Russo, sostituti nella procura di Marsala quando Borsellino ne era capo. I due hanno con lui un rapporto di amicizia che li porta a incontrare Borsellino più volte anche nel nuovo ufficio di Palermo. In una di queste occasioni, Paolo Borsellino lascia la scrivania, raggiunge il divano, praticamente vi si sdraia, scoppia in lacrime e dice: «Non avrei mai creduto, non posso credere che un amico mi abbia tradito».
Camassa e Russo non chiedono né hanno da Borsellino spiegazioni. Nell’occasione, Borsellino parla anche della procura di Palermo come di un «nido di vipere».
L’incontro si colloca verso la fine di giugno 1992. Nessun accenno a mafia-appalti che possa qui interessare.
Vittorio Teresi, magistrato, oggi responsabile del Centro studi Paolo e Rita Borsellino di Palermo, ha recentemente dichiarato di essere «quasi certo, per quel rapporto che avevo negli ultimi tempi con Borsellino, che se lui avesse in qualche modo avuto mediante questi rapporti con Lo Cicero» di cui parleremo poi «notizia della cosiddetta “pista nera” della strage di Capaci … forse era proprio questo che voleva riferire a Caltanissetta».
Stando a questa dichiarazione di quasi certezza di Vittorio Teresi, non mafia-appalti, ma altro, la pista nera. Svilupperemo questo tema nel capitolo 11 intitolato, appunto, alla pista nera.
Angelo Siino, il cosiddetto «ministro dei lavori pubblici» di Riina, con il suo difensore, Alfredo Galasso, ha scritto un libro intitolato Vita di un uomo di mondo (Ponte alle Grazie, 2017). A pagina 36 precisa di essere «rimasto sempre all’oscuro degli omicidi e delle stragi di cosa nostra, a parte qualche battuta raccolta occasionalmente, specie nelle varie carceri frequentate dal luglio del 1991». E ciò, egli spiega, per due ragioni: «una salvaguardia per i capi mafia e uno scudo per me»: quasi una scelta ontologica di legittima difesa.
Tuttavia, dai ricordi di Siino emergono alcuni dati interessanti: Falcone in cosa nostra era considerato personaggio – dice Siino – «diciamo più politico, mentre di Borsellino si pensava che “se viene questo ci consuma a tutti”».
A pagina 106 del libro si racconta come la strage di via d’Amelio fece infuriare Bernardo Brusca e Salvatore Montalto, capo mandamento di Villabate, detenuti con Siino nel carcere di Termini Imerese. Brusca sosteneva – non sono siciliano, quindi chiedo scusa per la pessima pronunzia – che «doppu Falcone i cosi si stavano quittando» e che la quiete non andava interrotta perché ci avrebbero rimesso i detenuti. È, praticamente, la teoria del «pessimo affare».
Montalto poneva per Borsellino un interrogativo: «A chistu chi ci ‘u purtava a parrare di certe cosi?». Si riferiva, secondo Siino, alle parole pronunciate nel corso del dibattito di Casa Professa, quando Borsellino aveva fatto intendere di conoscere il movente di Capaci e di essere pronto a testimoniare a Caltanissetta.
Ritengo necessaria, a questo punto, una breve esegesi del discorso di Borsellino a Casa Professa la sera del 25 giugno 1992, discorso che mi sembra rivesta una posizione centrale, decisiva nel discorso che stiamo facendo.
Paolo Borsellino esordisce dicendo: «Purtroppo ragioni di lavoro mi hanno costretto ad arrivare in ritardo e forse mi costringeranno ad allontanarmi prima che questa riunione finisca».
In pratica, Borsellino dice che sta lavorando «ventre a terra». Aggiunge che come magistrato ha il «dovere di utilizzare le sue opinioni, le sue conoscenze non in convegni o dibattiti, ma nel suo lavoro».
Vuol dire che sta lavorando su cose importanti da tenere riservate. Parla della sua «lunga esperienza di lavoro accanto a Falcone, delle convinzioni che si è fatto raccogliendo le sue confidenze, elementi che porta dentro di sé, dei quali è testimone» (parole testuali), elementi che deve «assemblare per riferirli all’autorità giudiziaria, l’unica che può valutare se essi siano utili per ricostruire l’evento che ha posto fine alla vita di Falcone».
Le parole di Borsellino, soprattutto nella parte finale del suo intervento a Casa Professa, sono parole di un uomo incupito, addolorato per la scomparsa dell’amico, ma niente affatto disposto ad arrendersi, che non si rassegna, ma vuole continuare la battaglia. Quindi, un discorso che evocava una bomba pronta a esplodere, che non poteva non preoccupare chi aveva le «polveri bagnate», come i mafiosi e i loro complici, «polveri bagnate» nel senso di essere pronti a ogni evenienza e a non farsi cogliere impreparati.
Nel caso di specie, essere pronti, se necessario, a sbarazzarsi di un testimone pericoloso, il che può spiegare la frase di Montalto, ma lascia indefinita
(non mafia-appalti, non la trattativa) la ragione della preoccupazione, che comunque, a mio avviso, può ben essere ricollegata proprio all’intervento di Casa Professa come causa dell’anticipazione dell’attentato contro Paolo Borsellino.
Ricordiamo che Brusca dice di aver ricevuto da Riina l’input per anticipare l’attentato a Borsellino nel periodo compreso tra Capaci e i primi giorni di luglio, ben compatibile con il 25 giugno, data dell’intervento a Casa Professa. Attenzione: unico evento di rilievo nuovo e inaspettato che si potesse conoscere, conoscibile all’esterno.
Borsellino a Casa Professa parla anche dei diari di Falcone pubblicati da Liana Milella su il Sole 24 Ore il 24 giugno 1992 e ne garantisce l’autenticità.
Nei diari Falcone racconta diffusamente dei suoi forti contrasti con Giammanco, specie per gli ostacoli che questi frapponeva a un’inchiesta che Falcone voleva fare su Gladio in collegamento con la procura di Roma-Priore. Nei diari, invece, nessun accenno a mafia-appalti.
Di un procedimento affidato a Enza Sabatino riguardante la regione Falcone parla solo per un sollecito di Giammanco a De Donno, che porta Falcone a ipotizzare che Giammanco puntasse all’archiviazione, altrimenti la regione avrebbe perso certi finanziamenti.
Tornando a Siino, egli rivela che forse nell’estate 1987 già Balduccio Di Maggio – il responsabile dell’arresto operato dai carabinieri, che erano già avanti nel lavoro, comunque l’ultimo tassello lo ha dato lui per l’arresto di Riina – si era interessato di Borsellino per ucciderlo, nel qual caso la pista mafia-appalti svanisce.
Attenzione, sul punto le parole di Siino trovano un preciso riscontro in Antonino Giuffrè, di cui parleremo dopo. C’è quella che giuridicamente si chiama «doppia conforme».
Anche la testimonianza di Vincenzo Scotti, tratta dal citato libro di Mori-De Donno L’altra verità, che a sua volta la trae da una puntata di Report (Rai 3) del 12 maggio 2024. Sostiene Scotti, che aveva incontrarlo Borsellino poco prima della strage:«Una cosa io ho ben chiara, che gli impegni di cui mi parlava Borsellino erano molto più vasti e complessi rispetto all’indagine sugli appalti a Palermo. Perché era troppo coinvolto e preoccupato che si toccasse veramente qualcosa che riguardava a quel punto i rapporti tra le istituzioni, la politica e la mafia».
Da ultimo, le dichiarazioni rese da Giuffrè Antonino, un pentito ascoltato come teste assistito. Dice molte cose importanti. Nel dicembre del 1991 la commissione provinciale di cosa nostra si ritrova per la tradizionale riunione degli auguri, così le chiamavano, e Riina dice: «Le cose si mettono male, il maxiprocesso va male; oggi è arrivato il momento di ognuno di noi di prendersi le sue responsabilità. Dobbiamo chiudere i conti con tutti coloro che ci hanno portato a questa situazione: Falcone, Borsellino e alcuni politici (considerati traditori)».
Per quanto riguarda i magistrati, Giuffrè precisa che – lui li chiama così – i «discorsi» si sono accumulati nel tempo, dall’inizio degli anni Ottanta, sia per Falcone sia per Borsellino, ma soprattutto per Falcone.
Il «discorso» si è fatto via via sempre più incalzante, a marcare la pericolosità di Falcone e Borsellino con le inchieste sulla sanità e sugli imprenditori, ma il «discorso» del maxiprocesso è quello che ha chiuso il cerchio.
Per la prima volta cosa nostra veniva messa con le spalle al muro. Giuffrè sintetizza la crescita di intensità dei «discorsi» con un detto siciliano: «pizzuluna oggi, pizzuluna domani, addiventano tutti nivuri».
Cosa nostra – aggiunge questo ex mafioso – aveva fatto anche «un pensiero su Borsellino» quando era procuratore di Marsala e va notata, segnalata la coincidenza con Siino, la cosiddetta «doppia conforme», che porta a escludere l’ipotesi che Borsellino sia stato ucciso per mafia-appalti.
Parentesi interessante: Giuffrè rivela che cosa nostra, prima di procedere a fatti di questo genere, omicidi eccellenti, «tastava il polso» del danno. Frase mica tanto ermetica, facilmente decifrabile.
Sommando tutti gli elementi fin qui esaminati e tirando le fila del discorso, possiamo dire che è fuori di dubbio, persino scontata, visto l’esito letale, la pericolosità di Borsellino nella valutazione di cosa nostra, ma è ragionevole escludere la configurabilità di mafia-appalti come causa – men che mai esclusiva – della sua eliminazione, con improvvisa accelerazione e cambio di programma ordinato da Riina a Brusca, cambio di programma da Brusca collocato tra Capaci e i primi giorni di luglio.
È certo che, dopo Capaci, Paolo Borsellino, alla ricerca delle cause dell’uccisione dell’amico Falcone, intendeva studiare il rapporto mafia-appalti, del quale aveva avuto copia a Marsala – secondo il maresciallo Canale senza prestargli grande attenzione – e a Palermo, su sua richiesta, dal collega Natoli, che così depone nel processo Trattativa.
È strano, peraltro, che il rapporto mafia-appalti non figuri tra i documenti repertati da questa Commissione dopo la morte di Paolo Borsellino.
Nell’incontro del 25 giugno nella caserma Carini, Borsellino, stando al racconto di Mori e De Donno, ebbe a programmare con loro un nuovo piano su mafia-appalti. L’interessamento in termini generali di Borsellino per mafia-appalti risulta, inoltre, da una deposizione dell’onorevole Carlo Vizzini in occasione di una cena a Roma del 16 luglio 1992, con altri magistrati tra cui Natoli, che conferma.
Confermato anche da colloqui con il procuratore aggiunto Vittorio Aliquò e dalla deposizione già ricordata di Liliana Ferraro.
Tale interessamento non era ancora sfociato in alcuna effettiva attività di indagine e non aveva avuto alcuna risonanza pubblica. Pertanto, non sembranoesservi elementi sufficienti per ritenere che cosa nostra potesse ravvisarvi un qualche pericolo forte, vivo, concreto e attuale.
È quindi ragionevole escludere il collegamento di mafia-appalti all’input di Riina a Brusca perché sospendesse l’attentato contro Mannino per passare urgentemente a quello contro Borsellino.
Quale evento abbia determinato questo input non è dato sapere con certezza, ma vi sono elementi precisi che portano ad ipotizzare che abbia avuto a che fare con l’intervento di Borsellino a Casa Professa.
Ripeto, unico evento di rilievo nuovo e inaspettato che si conosca.
Nel contesto fin qui delineato finisce allora per assumere un rilievo decisivo la «doppia conforme» di Siino-Giuffrè sull’omicidio di Borsellino già progettato quando ancora era a Marsala, progetto riferibile a quando Borsellino era ancora a Marsala che ovviamente e logicamente porta ad escludere l’ipotesi mafia-appalti.
Parliamo dell’inchiesta mafia-appalti. All’inizio di questa mia seconda audizione abbiamo parlato della «Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia-appalti nell’anni 1989 e seguenti» per farne discendere la constatazione pregiudiziale che CSM e Antimafia erano da tempo informati su tutto. Tuttavia, senza rinunziare a questa pregiudiziale, affrontiamo il merito della questione.
Sono due principalmente i capitoli, quello che possiamo chiamare vicenda Li Pera e quello che possiamo chiamare la cosiddetta «doppia informativa».
Ecco alcuni punti salienti.
Negli anni 1988-1991 su mafia-appalti Palermo indaga con Falcone, Lo Forte e Pignatone PM e con De Donno del ROS. Il 20 febbraio 1991 c’è la consegna dell’informativa ROS 000001/2, nota come «dossier mafia-appalti», a Falcone che la dà a Giammanco che la chiude in cassaforte. Falcone si trasferisce a Roma e non può lavorarci, neppure altri PM di Palermo possono perché impegnati nella requisitoria dei processi politici.
A maggio 1991 Giammanco designa a trattare il dossier ROS su mafia-appalti, oltre a Lo Forte e Pignatone, anche Sciacchitano, Morvillo, Carrara, De Francisci, Scarpinato e Natoli, vale a dire a tutti i sostituti del pool antimafia.
Giammanco invia – chissà perché – il dossier al ministro Martelli, che glielo restituisce bruscamente, stigmatizzando l’irritualità, l’anomalia, dell’invio.
L’inchiesta ha un normale svolgimento: arresti, interrogatori, rinvii a giudizio. Senonché viene sollevato un problema di omissis relativamente al deposito dell’informativa mafia-appalti al tribunale della libertà. Vediamo come sono andate le cose.
Deponendo sotto giuramento il 26.11.2021 nel processo «depistaggio Borsellino», Guido Lo Forte chiarisce: «Contrariamente a quello che è stato propagato da dicerie varie e organi di stampa, non è assolutamente vero che questa informativa sia stata depositata priva di omissis. Anzi, è stato omissato quantitativamente un terzo dell’intera informativa, circa 300 pagine su 900, e sono state depositate soltanto le parti necessarie per motivare probatoriamente l’esistenza dell’associazione mafiosa.
D’altra parte, siccome nella grande maggioranza dei casi tutte queste conversazioni vedevano come protagonista il geometra Giuseppe Li Pera, arrestato, le parti riguardanti le convocazioni con lui evidentemente non potevano essere omissate perché altrimenti la difesa avrebbe giustamente fatto questioni e sarebbe insorta. Ma è un dato di fatto documentale e sono in grado di indicare i numeri delle pagine omissate e il numero delle pagine prima di omissis».
Riprendiamo l’esame dell’inchiesta mafia-appalti per punti salienti. C’è una delega molto articolata a De Donno per l’indagine sulla Sirap Spa, che da intercettazioni risultava al centro di forti interessi mafiosi.
Nel marzo del 1992 c’è il rinvio a giudizio, fra gli altri, di Siino, Li Pera e Vito Buscemi. Nel contempo i pubblici ministeri titolari dell’inchiesta mafia-appalti procedono a uno studio approfondito della posizione degli indagati non rinviati a giudizio e dei vari filoni d’indagine, là dove l’informativa consisteva quasi esclusivamente nella trascrizione di numerose conversazioni telefoniche con brevi osservazioni di commento.
Vi è poi un’articolata richiesta di archiviazione, escluso il fascicolo Sirap, vistata dal procuratore Giammanco e formalmente depositata il 13 luglio 1992, accolta dal Gip il 14 agosto. Contro questa archiviazione il generale Mori ha formulato accuse molto gravi. In sostanza, ha avanzato l’accusa di avere artatamente nascosto un’archiviazione indebita effettuandola in piena estate, quando tutti erano distratti dalle vacanze, allo scopo di favorire alcuni mafiosi e i loro complici.
Nel processo «depistaggio Borsellino» il 26 novembre 2021 Lo Forte di nuovo depone sotto giuramento quanto segue: «Nel marzo del 1992 vi è la richiesta di rinvio a giudizio di tutti gli imputati raggiunti da richieste di custodia cautelare.
In questo periodo giunge alla procura di Palermo il dottor Borsellino. Proprio poco tempo dopo il rinvio a giudizio, nell’ambito della direzione distrettuale antimafia cui partecipava anche Paolo Borsellino, naturalmente fu affrontato il tema dello stato degli atti in relazione all’inchiesta mafia-appalti. C’erano state più riunioni perché vi erano state e ancora vi erano polemiche sui giornali di cui non riuscivamo a comprendere le ragioni e il significato.
Il procuratore Giammanco ne aveva fatto quasi una sua fissazione, che in ogni riunione del pool antimafia si doveva fare un aggiornamento sullo stato degli atti dell’indagine mafia-appalti. Quindi, – afferma Lo Forte – di questa inchiesta si è continuato a parlare nelle riunioni del pool antimafia facendo il punto: da un lato di quello che era stato fatto, e cioè le custodie cautelari e quello che si pensava ne potesse derivare, dall’altro il cuore attivo dell’inchiesta, che era lo stato degli atti relativi alla delega Sirap. Infine, si parlò anche della necessità di procedere all’archiviazione di posizioni residuali rimaste prive di supporto probatorio. Tutto il pool antimafia era informato, incluso Paolo Borsellino, e tutto ciò venne condiviso all’unanimità senza alcun rinvio.
Questo lo dico – prosegue Lo Forte – perché ho letto dei giornali in cui si afferma una circostanza assolutamente falsa: io in una riunione di procura del 14 luglio 1992 avrei taciuto o tenuto nascosto a Borsellino il fatto di avere poco prima, insieme a Scarpinato, firmato una richiesta di archiviazione.
Non si trattava di una richiesta di archiviazione dell’inchiesta mafia-appalti, ma soltanto di una tranche residuale priva di contenuti probatori, perché una parte dell’inchiesta era andata avanti e la parte più importante dell’inchiesta era vivissima, non fu mai archiviata e diede poco dopo sviluppi notevoli.
Quindi, la circostanza è assolutamente falsa e non ne comprendo l’origine alla fonte per la semplice ragione che, primo: il dottor Paolo Borsellino era informato di questa prospettiva, quindi della inevitabile archiviazione di tutta una serie di posizioni restate del tutto prive di supporto probatorio; secondo: io stesso ne parlai in una riunione preferiale del 14 luglio di tutti i magistrati della procura. Io riferii tutto. Riferii le decisioni adottate nella direzione distrettuale antimafia. Riferii che vi era una parte che si era deciso di archiviare e che era stata archiviata. A fronte di tutto ciò nessuno fece nessun rilievo. L’unica cosa che il dottor Borsellino chiese riguardava una vicenda relativa agli appalti di Pantelleria, competenza della procura di Marsala di cui era stato capo».
In questo contesto collocare le parole di Borsellino riferite da Ingroia, «voi due non me la contate giusta», dando loro un significato univoco e concreto francamente lo ritengo molto difficile. Non è di aiuto, anzi complica le cose, la frase di Ingroia secondo cui era nello stile di Borsellino esprimere con parole scherzose giudizi sferzanti, perché non si sa dove comincia o finisce lo scherzo e dove comincia o finisce lo sferzante.
Sgombrato il campo dai veleni degli omissis e dell’archiviazione «clandestina», diamo uno sguardo d’insieme al ragionamento complessivo dell’inchiesta mafia-appalti.
Possiamo constatare che furono arrestati circa 150 tra mafiosi, politici, funzionari e imprenditori e che vi fu un ampio ricorso alle misure di prevenzione patrimoniale, colpendo in un caso e nell’altro anche personaggi decisamente di rilievo. Cosicché appaiono gratuite e inconsistenti le recenti accuse mosse ai magistrati inquirenti da Vincenzo Ceruso, che ho citato prima, che nella Palermo dell’estate 1992 vede, con rare eccezioni, inquirenti pigri, incompetenti o paurosi, se non complici.
Per contro, proprio dal lavoro dei PM del 1992 derivano gli importanti risultati del 1993 con numerosi arresti e richieste di autorizzazione a procedere nei confronti di esponenti di rilievo della politica locale e nazionale. Per accertarlo basta delineare le pagine 45 e seguenti della relazione 1999 della procura di Palermo.
Vengo al caso Li Pera, capo area della Rizzani De Eccher in Sicilia. Con i PM di Palermo Giuseppe Li Pera, detenuto, prima si avvale della facoltà di non rispondere e poi il 17.02.1992, tramite il suo legale invia un memoriale ai PM di 54 pagine dove nega tutto.
Lo Forte e Scarpinato, insieme a De Donno, con l’opposizione del difensore, il 6 marzo 1992 nel carcere di Palermo interrogano Li Pera che questa volta parla a lungo, ma continua – era un suo diritto – a negare tutto.
De Donno teme che Li Pera sia condizionato dai difensori e chiede un colloquio riservato, che però all’epoca non era concepibile perché non c’era il mezzo. Si scoprirà poi che effettivamente Li Pera era condizionato da un avvocato vicino ai Graviano.
La scena da Palermo si trasferisce a Catania, base di partenza di un biglietto apparentemente scritto da Li Pera, rinvenuto e sequestrato in occasione di una perquisizione eseguita dai carabinieri su disposizione della procura di Palermo negli uffici della Rizzani De Eccher. Protagonisti a Catania sempre Li Pera e un fascicolo (Caronte) che nasce da indagini del ROS.
Il PM di Catania, Felice Lima, assistito da personale del ROS, assume a verbale il Li Pera, la prima volta il 13.03.1992, come teste nel carcere di Teramo, dove Li Pera è detenuto per ordine di Palermo. Li Pera dice a verbale di essere imputato per 416-bis a Palermo e afferma di essere un capro espiatorio. Rende una serie di dichiarazioni nel merito dell’inchiesta palermitana e non risulta presente un difensore. Li Pera sostiene che i magistrati di Palermo non sono interessati a sentirlo; Lima lo sente altre due volte, il 14 e il 15 giugno, sempre come testimone, persona informata sui fatti.
Una volta lo sente De Donno delegato da Lima. Frattanto interviene, purtroppo, la strage di via d’Amelio del 19 luglio. Lima sente Li Pera sempre come teste anche il 27 agosto.
Finalmente il 14 ottobre, nel carcere dell’Asinara, Li Pera viene sentito come indiziato, senza specificare l’imputazione e con un difensore d’ufficio presente. Il dottor Lima non dice mai niente a Palermo, pur essendoci totale identità dell’oggetto di indagine.
C’è un invito iniziale del dottor Lima a Li Pera di parlare di argomenti diversi da quelli di competenza di Palermo, ma è un invito, ovviamente, surreale, del tutto privo di contenuto.
Nell’informativa del ROS a Catania non si menziona neppure il lungo interrogatorio di Palermo cui De Donno aveva assistito. Il 28.10.1992, finalmente, il procuratore capo di Catania trasferisce il fascicolo da Catania a Palermo per competenza.
La procura di Palermo è spiazzata. Testi fondamentali per l’accusa sono diventati indagati, elementi raccolti a Catania avrebbero impedito, almeno in parte, l’archiviazione del luglio 1992. Soprattutto c’è un gravissimo pericolo di sviamento delle indagini mafia-appalti. La linea di Catania basata sulle dichiarazioni catanesi di Li Pera comporta una sostanziale fuoruscita dal mondo degli appalti di cosa nostra, che assume un ruolo marginale con esclusione del 416-bis e potenziale scarcerazione di tutti gli imputati.
Questa linea riduttiva di Catania è sostenuta anche dal ROS, in conflitto con se stesso, perché la linea sostenuta a Palermo è ben diversa. Dunque, un doppio gioco inquietante. Anzi, De Donno (ROS) interviene per quanto riguarda gli appalti su tre tavoli: Catania, Palermo e Paolo Borsellino (riunione del 26 giugno).
Nella relazione dell’avvocato Trizzino alla Commissione si legge, se non sbaglio, che Lima ha sostenuto che non aveva detto niente a Palermo perché in tal senso lo ha consigliato Borsellino. Stento, francamente, a crederlo per il grande rispetto dovuto e che porto a Paolo Borsellino.
In realtà, nella vicenda di Li Pera si intuisce una regia astuta che duplica e manipola dossier riguardanti le stesse notizie di reato, poi sottoposti a differenti uffici giudiziari.
Sono evidenti violazioni gravi e inammissibili delle regole sulla competenza dei PM e sul coordinamento delle indagini. Lima deve trasferirsi al Civile per non subire una altrimenti inevitabile sanzione disciplinare del CSM.
Quanto al ROS, è un giallo, almeno per me.
De Donno mi accusa di aver firmato una denunzia/segnalazione contro di lui. Il procedimento in Cassazione – di cui non sappiamo assolutamente niente – avrebbe avuto per De Donno esito favorevole.
Ora, io non ricordo, non mi risulta assolutamente di aver mai firmato nulla del genere. Del resto, il fascicolo Li Pera-De Donno-Lima arriva a Palermo da Catania nell’ottobre 1992, mentre io prendo possesso della procura di Palermo il 15 gennaio 1993. Ma è pensabile che si possa mentire su una circostanza del genere, soprattutto se si è un ufficiale dell’Arma? Poi, se De Donno è stato prosciolto, ne sono lieto per lui, ma della sua inaffidabilità abbiamo già parlato.
Per completare il quadro, depositerà Antonio Di Pietro. Un capitano del ROS (De Donno, sempre lui) comunica a Di Pietro che tale Li Pera (sempre lui) vorrebbe parlargli con riferimento alle indagini che sta facendo su Ferruzzi, De Eccher, Buscemi, perché a Palermo non gli credono dopo un anno di detenzione per gli stessi fatti.
Qualche giorno dopo, Di Pietro, con un altro capitano dei carabinieri, va a Rebibbia a sentire Li Pera, che gli racconta quel che aveva detto a Catania e cioè che a Palermo non gli davano retta. Generoso e impulsivo come nel suo carattere, Di Pietro teorizzava un lavoro in comune tra Milano e Palermo, ma la connessione dei processi ha regole precise.
Comunque, ci fu una riunione a Milano, la mattina nell’ufficio di Francesco Saverio Borrelli, capo di quella procura, e la sera in casa di Borrelli, presenti, oltre a Di Pietro, gli altri del pool di Milano: Davigo e Colombo; forse d’Ambrosio, ma non ne sono certo. Con me c’erano Lo Forte, Ingroia, Patronaggio e forse Scarpinato, ma non ne sono sicuro.
Alla fine tutti d’accordo, compreso Di Pietro, avremmo scambiato informazioni utili, ma non oltre.
Ora la doppia informativa.
A partire da giugno 1991, prima ancora della richiesta al GIP delle misure cautelari per mafia-appalti, si scatena una furibonda campagna di stampa nazionale contro la procura di Palermo.
L’accusa, fatta filtrare, secondo la stampa, dai carabinieri del ROS, è di avere insabbiato la posizione di importanti personalità politiche, anche con incarichi di governo. Non risultano smentite dal ROS. Le violazioni di segreto, intercettazioni e parte dell’informativa del ROS, sembrano clamorose.
Il fatto è che la procura non ha mai né visto né avuto quel che viene pubblicato dai giornali. I nomi di alcuni politici di rilevanza nazionale, già noti alla stampa fino all’estate 1991, vengono portati a conoscenza della procura soltanto dopo: parte nel novembre 1991 (esempio, De Michelis) e parte addirittura a settembre 1992 (esempio, Lima).
Il maresciallo Carmine Iannotta rivelerà di aver avuto dai vertici delle ROS disposizioni di omettere le intercettazioni sui politici perché ritenute non rilevanti.
Ancora una sorpresa. Viene consegnata l’indagine Sirap (settembre 1992) e per la prima volta vengono comunicate alla procura numerose intercettazioni risalenti addirittura al 1990, con riferimento a importanti uomini politici nazionali e regionali.
Neanche dopo l’omicidio Lima era stata depositata un’interpretazione del maggio 1990 in cui Lima raccomandava Cataldo Farinella, colpito da misura cautelare nel processo mafia-appalti.
In sostanza, alla fine emerge che dell’informativa mafia-appalti sono esistite due versioni: una ufficiale, quella consegnata a Falcone, senza alcun riferimento a esponenti politici, e una ufficiosa, usata per le fughe di notizie e per il battage giornalistico contro la procura, con riferimenti politici come Lima, Mannino e Nicolosi.
Nella relazione del 1999 si spiega che le fughe di notizie erano a favore di vari indagati e soprattutto di Angelo Siino. A domanda, in ambito processuale, se avesse avuto conoscenza dell’informativa mafia-appalti prima del suo arresto, Siino risponde che questo rapporto era per così dire a «cor di popolo» per citare le sue parole precise; nel senso che il contenuto lo sapevano tutti nei minimi particolari. Siino era stato informato «da giornalisti, carabinieri, avvocati tutti personaggi addetti ai lavori che gli dicevano di stare attento che lo stavano consumando, stavano per arrestarlo».
A Siino il rapporto fu materialmente consegnato da Lima, suo referente per i grandi appalti (Sirap e provincia di Palermo).
Nella caserma di Cinisi il maresciallo Lombardo disse a Siino che poteva fargli leggere il rapporto ed eventualmente intervenire per cercare di mitigare la cosa, ma non poteva parlare con De Donno che, secondo me il maresciallo Lombardo, era un «pazzo scatenato». Siino afferma che il rapporto ce l’aveva anche mastro Ciccio (Messina di cognome) capo del mandamento di Mazara del Vallo, in contatto con il maresciallo Canale.
Anche Pino Lipari aveva il rapporto e lo fece leggere a Siino.
In sostanza, dice Siino, tutti sapevano meno lui. Quanto al rapporto in sé, Siino lo definisce «il figlio investigativo del capitano De Donno» dandone nel contempo un giudizio stizzoso, negativo: «ben poca cosa, non aveva attinenza con quella che poteva essere la situazione, era una influenza contro un tumore».
Siino conferma, inoltre, l’esistenza di due versioni dell’informativa mafia-appalti. Sei mesi prima del suo arresto del luglio 1991 a Siino fu fatta leggere una versione che conteneva il nome di Mannino in quanto gestore di alcuni appalti irregolari ben specificati. Nella versione depositata dal ROS scompaiono Mannino e i nomi di altri uomini politici.
Siino, inoltre, racconta che Mannino era andato da Mori e De Donno a chiedere la sua testa (di Siino) perché Mannino diceva che «Io» Siino «ero un delinquente, che vessavo le imprese locali, che ero un personaggio poco raccomandabile, e forse in effetti lo ero, ma lui» Mannino «non era da meno. Da che pulpito veniva la predica».
A Siino, inoltre, venne detto che Mannino voleva che si stabilisse chi era il vero «ministro degli affari pubblici», se lui o Siino. Mannino e Subranni, dice ancora Siino, erano di fatto «compari» (fonte Guazzelli).
Tornando alla fuga di notizie, da alcuni giornali esce un ritratto devastante della procura di Palermo. Una manica di principianti irresponsabili, messa in stridente contrapposizione con gli impeccabili ufficiali del ROS. Vale a dire, i PM si occupano soltanto di manovalanza criminale e non anche degli uomini politici coinvolti. Mani invisibili suggeriscono, tagliano, aggiustano, seminano zizzania e confondono le acque. Una bufera mediatica contro la procura Palermo. Per dirla come un mio grande amico, Andrea Camilleri «una strumentale farfantaria».
Permettetemi una conclusione provvisoria molto personale. Vi sono fatti e circostanze che determinano una sensazione fastidiosa. Dopo l’incredibile vicenda del «trasloco» ad opera del ROS da Palermo a Catania dell’inchiesta Li Pera e dopo l’altrettanto incredibile vicenda del doppio fascicolo al tempo di Giammanco, a volte sembrano riemergere vecchie pulsioni ostili indirizzate, questa volta, contro la procura da me diretta, colpendone alcuni magistrati simbolo, in prima linea nell’indagine sulle strategie politiche dei corleonesi.
Sono qui, e vi ringrazio tutti, anche per contrastare dialetticamente l’eventuale profilarsi di iniziative leggibili in tal senso.
C’è un capitolo dedicato alle cooperative rosse. Questo a dimostrazione che la procura di Palermo si è occupata di tutto, anche delle cooperative rosse. Lo salto. Chi vuole, lo può trovare nella relazione, così da risparmiare un po’ di tempo. Sta di fatto che ci sono state due sentenze, la sentenza «Salamone» e la sentenza «Trash», che hanno avallato quanto ricostruito dalla procura in ordine alle cointeressenze della mafia con le strutture economiche inizialmente concepite per fini sociali e cooperative, strumentalizzate da cosa nostra per influenzare il sistema di appalti.
C’è un capitolo che ho intitolato «Siino e i ROS». Mori lamenta che, quando la procura da me diretta prese in carico Siino, quando l’ho fatto arrestare nel luglio del 1997, affidai le indagini alla Guardia di finanza e non a lui. Ma si dà il caso che Siino fosse stato arrestato dalla Guardia di finanza, per cui era la cosa giusta.
Per provare a dimostrarlo produco due documenti, che lei, presidente, ha già, se non sbaglio, che non esito a definire – mi scuso per l’enfasi, per la retorica – una sorta di museo degli orrori.
Si tratta della relazione 235/97, riservato, che avevo mandato al PG di Palermo l’8 giugno 1998, e della nota di contenuto analogo 79/98, riservato, che avevo inviato al Procuratore nazionale Vigna il 9 aprile 1998. Produco anche queste due note. In sintesi, in queste due note si dice quanto segue.
La procura di Palermo riceve da quella di Caltanissetta parte delle trascrizioni delle registrazioni di colloqui confidenziali fra Angelo Siino e il colonnello dei carabinieri Giovanni Carlo Meli, in procinto di trasferirsi al ROS nella primavera-estate 1997.
Meli registrava le conversazioni all’insaputa di Siino, che non era ancora un collaboratore di giustizia, ma un informatore confidenziale dei carabinieri.
La procura di Palermo stava indagando il pentito Balduccio Di Maggio, che si sospettava fosse tornato a delinquere. In effetti era così, purtroppo.
La procura di Palermo, all’esito di una difficile indagine condotta dal dottor Lo Forte, ordinava il suo arresto. Nel conseguente processo, Di Maggio veniva condannato a una pena grave, con revoca di tutti i benefìci precedentemente concessi per la sua collaborazione.
Nel contesto di tali indagini si verificarono fatti di speciale gravità, che mi permetto ora di esporre.
Già il 27 maggio 1997 il colonnello Meli apprende da Siino l’esistenza di un’organizzazione criminale ricostituita da Di Maggio, la responsabilità di questa associazione per vari omicidi già commessi, il progetto di commettere nuovi omicidi, in particolare l’omicidio contro Francesco Costanza, l’esistenza di un piano diretto a indurre Di Maggio a ritrattare le sue accuse nel processo Andreotti e accusare la procura, piano di cui lo stesso Meli ha ulteriore conferma in un colloquio del 3 giugno 1997.
Di tutto ciò Meli informava non il suo superiore gerarchico, il comandante provinciale dei carabinieri di Palermo Borruso, ma soltanto Mori, comandante del ROS, ufficio al quale Meli – lo ripeto – stava per transitare. Sia Meli sia Mori non riferiscono nulla alla procura di Palermo, né quando apprendono le notizie in questione, né dopo l’11 luglio 1997, quando, avendo Siino iniziato a collaborare con la procura di Palermo, era venuta meno ogni ipotetica esigenza di tenere celato un rapporto confidenziale con lui, né dopo il 7 agosto 1997, quando si è verificato il tentato omicidio di Francesco Costanza, ovvero proprio il delitto preannunciato da Siino a Meli il 27 maggio. È superfluo aggiungere altro, se non invitare i commissari, permettetemi, a leggere per intero le due relazioni prodotte, qualora la mia sintesi non fosse sembrata sufficiente. È una lettura che varrà la pena di fare.
Siino, poi, ha scritto una autobiografia con il suo difensore, Alfredo Galasso, che ho già citato. Il capitolo ventisette del libro si intitola «Il caso De Donno-Lo Forte».
Vi si racconta il groviglio di stranezze e falsità che aveva portato a un conflitto di notevole asprezza ed effetti imprevedibili tra la procura di Palermo e il ROS, in particolare Mori e De Donno, effetti che, secondo il noto giornalista Giuseppe D’Avanzo, avrebbero potuto essere devastanti per la procura.
Carmela Bertolino, moglie di Siino, parla di tre tentativi di De Donno per avere da lei elementi contro Lo Forte. Anche Siino parla di pressioni su di lui da parte di De Donno perché incolpassero Lo Forte.
Poi, c’è una registrazione farlocca fatta da Meli, ufficiale – lo ripeto – ormai collegato al ROS, dove prima si sostiene che Siino parla male di Pignatone e Lo Forte, ma poi si accerta che Pignatone non parla per niente e Lo Forte parla, ma dicendone bene di nuovo. Invece di arrestare i delinquenti, si delegittima la procura di Palermo.
Consentitemi una digressione, non troppo breve ma contenuta, riguardante i miei rapporti con i carabinieri durante tutta la mia esperienza di magistrato.
Con l’Arma io ho sempre avuto un ottimo rapporto di stima e fiducia, testimoniato, fra l’altro, dalle tante cose che ho scritto.
A Torino l’inchiesta ai capi storici delle Brigate Rosse e poi l’inchiesta basata sull’elaborazione del capo colonna Patrizio Peci, che è l’avvio della definitiva sconfitta delle BR, le ho condotte – ero giudice istruttore – avendo, passo dopo passo, accanto a me a indirizzarmi e a sostenermi gli uomini del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Rientrato a Torino dopo Palermo, ancora con i carabinieri, questa volta territoriali, che ho coordinato come procuratore capo, nell’inchiesta Minotauro sugli insediamenti della ‘ndrangheta a Torino e in Piemonte. Un centinaio di arrestati, praticamente tutti condannati in Cassazione. Questo per citare soltanto i più importanti processi.
Anche a Palermo ho avuto un ottimo rapporto con i carabinieri territoriali. Per fare un esempio, è merito loro l’arresto dei fratelli Graviano. È solo con il ROS che ci sono stati problemi, che non spetta a me giudicare. Ricordo solo che, quando ero ancora a Torino, praticamente alla vigilia della mia partenza per Palermo, fui avvertito dal comandante dei carabinieri di Piemonte e Valle d’Aosta, generale Delfino, che non conoscevo, dell’arresto di tal Baldassare Di Maggio, inteso «Galluccio», che avrebbe potuto dare indicazioni per l’arresto di Riina.
Gli chiesi subito di far venire nel suo ufficio Mori, che sapevo essere a Torino proprio per un primo abboccamento con me. Non sapevo che fra Mori e Delfino non correva buon sangue. Comunque, chiesi dall’ufficio di Delfino al Capo della polizia di apprestare un trasporto aereo in sicurezza del Di Maggio a Palermo e informai Vittorio Aliquò, procuratore aggiunto di Palermo, perché potesse raccordarsi con il ROS. Fu così che gli uomini del ROS, guidati dal capitano Ultimo, Sergio De Caprio, che già erano avanti, molto avanti nell’operazione, grazie anche al tassello fornito da Di Maggio, arrestarono Riina, il capo dei capi di cosa nostra, latitante da molti anni. Un successo enorme, una radicale inversione di tendenza in favore dello Stato, purtroppo con alcune ombre per quanto successe dopo.
La procura era pronta per la perquisizione del covo, il collega Patronaggio, per così dire, praticamente era con un piede sull’auto, poi, però, tutti d’accordo, magistrati e ROS, si decise di rinviare la perquisizione. A sostenere il rinvio fu in modo particolare Ultimo, proprio colui che aveva messo le manette ai polsi di Riina. L’intesa era che vi sarebbe stata una sorveglianza attenta e continua della zona. Così invece non fu e la procura non venne informata. E quando finalmente entrammo nel covo, lo trovammo, purtroppo, completamente spogliato.
Fra la procura e il ROS ci fu un carteggio.
I carabinieri confermarono di aver sostenuto il rinvio della perquisizione in quanto necessario per evitare ogni intervento immediato o, comunque, affrettato che avrebbero potuto pregiudicare ulteriori importanti acquisizioni che dovevano consentire di disarticolare la struttura economica e operativa facente capo a Riina. Quanto alla mancata comunicazione della sospensione della sorveglianza – sono atti scritti, virgolettati – secondo il ROS «chi ha operato ha sicuramente inteso di potersi muovere in uno spazio di autonomia decisionale consentito». In altre parole, i carabinieri del ROS avevano deciso senza dirci niente, convinti di poterlo fare in forza della loro presunta autonomia.
Un brutto episodio, un colpo che avrebbe potuto far crollare la procura. Invece, la procura non si è fermata. Anzi, potrei persino dire che la mazzata ci è servita per essere sempre più compatti, così da poter superare anche questo ostacolo del tutto inaspettato.
La nostra collaborazione con Mori e i suoi uomini continuò. Segnalo, per esempio, che quando si costituì spontaneamente Salvatore Cancemi, avendo egli manifestato l’intenzione di collaborare, decisi – potevo farlo – di non mandarlo in carcere e lo affidai proprio alla gestione del ROS. Il resto è storia di processi, di accadimenti, anche oggetto di queste memorie, con un interrogativo sullo sfondo: condividere o meno la tesi che Luigi Patronaggio, oggi procuratore generale di Cagliari, ha sostenuto formulando la requisitoria in un processo d’appello a Palermo, nella quale ha ravvisato un «metodo Mori», espressione di una serialità nell’agire autonomamente, al di fuori di «fastidiosi» controlli e autorizzazioni dell’autorità giudiziaria.
Vorrei citare, a questo punto, alcune parole cupe, tristi che Paolo Borsellino pronunciava frequentemente, specie dopo la morte di Falcone: «Siamo cadaveri che camminano». Lo diceva perché sapeva bene di essere stato condannato da cosa nostra a morire, con Falcone, nell’ambito di una strategia di annientamento dei suoi peggiori nemici. Tutta una vita spesa al servizio dello Stato, nell’eroica consapevolezza di correre un rischio mortale, non si può comprimere nel perimetro angusto dell’inchiesta mafia e appalti, con una tesi indimostrabile e indimostrata, ma soprattutto ingiusta, in quanto non rispettosa della grandezza e degli straordinari meriti di Borsellino.
Nel capitolo quattro dello scorso 31 luglio abbiamo visto come l’avvocato Fabio Repici sappia «pescare» verbali importanti, quasi perle giudiziarie, ancorché sepolti e dimenticati in qualche archivio. Dopo un verbale del maresciallo Canale, dopo un verbale di De Donno, ecco ora un verbale sul sito di Radio Radicale nel quale Vittorio Teresi, sostituto della procura di Palermo, deponendo, dichiara di essere quasi certo – lo ripeto, per quel rapporto che aveva negli ultimi tempi con Borsellino – che, se lui avesse avuto, mediante questi rapporti con Lo Cicero, notizie della cosiddetta «pista nera» per la strage di Capaci, forse era proprio per questo che voleva riferire a Caltanissetta quanto con tanta insistenza voleva che lo chiamassero. Teresi riferisce di una relazione di servizio che aveva redatto il 1° giugno 1992, una settimana dopo Capaci, che attesta un suo incontro con l’allora confidente dei carabinieri Alberto Lo Cicero, accompagnato da Teresi e dal brigadiere Walter Giustini.
La relazione contiene dati molto interessanti. Alberto Lo Cicero era diventato confidente dei carabinieri dopo aver patito il 20 dicembre 1991 un tentato omicidio. Grazie alla collaborazione, sempre in via confidenziale, della sua compagna, Romeo Maria, Lo Cicero consentiva a incontrare Teresi. Lo Cicero non avrebbe sottoscritto nessun verbale per timore di ritorsioni da parte dei mafiosi, sui quali poteva fornire rilevanti informazioni.
Lo Cicero aveva frequentato da vicino il capomafia Mariano Tullio Troia e nella casa di lui aveva incontrato altri mafiosi importanti, nonché l’onorevole Lo Porto, con il quale si era anche intrattenuto a cena più volte, apprendendo che aveva un nipote o un cugino proprietario di una villa nello stesso complesso. Mediante una società intestata alla moglie, il boss Troia controllava il movimento a terra, i trasporti e i lavori stradali in una vasta zona di Palermo e Capaci. Per la gestione delle ditte operanti in Capaci, Troia si avvaleva di un certo Sensale, anch’egli mafioso di cosa nostra.
Va sottolineato che all’epoca Teresi lavorava in stretto contatto con Borsellino, al quale, pertanto, riferiva ogni cosa, avuto contezza della quale l’avvocato Repici riesce a procurarsi un’altra perla: il verbale di una riunione alla procura di Palermo del 15 giugno 1992, cui partecipano per Palermo Giammanco, Aliquò, Borsellino e Teresi e per Caltanissetta Pietro Maria Vaccara, sostituto, riunione nella quale ci si scambia l’impegno reciproco di fornirsi ogni informazione, in particolare di comunicare immediatamente a Caltanissetta quanto fosse emerso circa l’omicidio di Falcone.
Il verbale è firmato da tutti i magistrati presenti, compreso Borsellino. Ed è sconvolgente aver reperito, a trentatré anni di distanza dalla strage di via D’Amelio, un documento sull’omicidio del dottor Falcone nel quale compare la firma di Borsellino.
Ma c’è un altro dato ancor più rilevante: un’informativa del 10 giugno 1992 dei carabinieri di Palermo, delegati da Teresi, rivolta alla procura di Caltanissetta, avente come oggetto l’omicidio in pregiudizio del dottor Giovanni Falcone, della moglie Morvillo Francesca e di tre agenti di scorta. Nell’informativa si faceva riferimento a un rapporto giudiziario del maggiore dei carabinieri Obinu, del ROS, riguardante Sensale e Troia, con l’indicazione del ruolo assegnato a costui proprio dalle dichiarazioni confidenziali di Lo Cicero. All’informativa del 10 giugno ne seguì un’altra, in data 12 giugno, firmata dal maggiore Minicucci della territoriale, ancora rivolta alla procura di Caltanissetta. In essa si dava atto dell’importanza assunta dalle conversazioni con Alberto Lo Cicero e Maria Romeo e si sollecitava la procura di Caltanissetta a emettere provvedimenti di fermo per la strage di Capaci nei confronti di tutti i soggetti indicati nella precedente informativa del 10 giugno, compreso Sensale, fatta eccezione per Troia, perché ritenuto ai vertici dell’organizzazione, per cui arrestarlo in quel momento avrebbe potuto danneggiare le investigazioni.
Nel frattempo, quando Borsellino era ancora in vita, Lo Cicero si era determinato a una formale collaborazione con la giustizia, con molta probabilità anche grazie all’influenza di Borsellino, come si può desumere da una informativa del 14 settembre 1992 di Minicucci indirizzata ad Aliquò, procura di Palermo, e per conoscenza a Tinebra, procura di Caltanissetta, nella quale, ricordata l’intesa raggiunta anche con Borsellino, si sosteneva l’inopportunità che il collaboratore Lo Cicero, al momento interrogato dalla procura di Palermo…
PRESIDENTE. Le chiedo scusa, dottor Caselli, se la interrompo. Ci sono problemi audio? Era qualcuno collegato.
Con i tempi come siamo messi, dottor Caselli?
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Abbastanza bene.
PRESIDENTE. Noi abbastanza male.
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Ho praticamente concluso.
PRESIDENTE. Va bene.
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Quindi, si può affermare che Borsellino era intervenuto in modo perentorio sull’avvio della collaborazione con la giustizia di Lo Cicero, imponendo addirittura che nella prima fase avrebbe dovuto riferire esclusivamente alla procura di Palermo. Ecco perché qualcuno ipotizza che, fino alla mattina del 19 luglio 1992, Borsellino rimase in attesa della delega del procuratore Giammanco ad occuparsi degli affari criminali della città di Palermo, delega necessaria perché Borsellino potesse raccogliere le dichiarazioni di Lo Cicero.
Con un corollario, nella relazione Teresi del 1° giugno 1992 si parla dell’onorevole Lo Porto come di personaggio conosciuto da Lo Cicero nella villa di Troia. L’onorevole Lo Porto, arrestato nel 1968 insieme al killer Pierluigi Concutelli, nel 1992 era in rapporti con Borsellino. Se ne trova traccia nel dispaccio ANSA del 20 maggio 1992, quando Borsellino esplicitò il suo dissenso sull’iniziativa del Movimento Sociale Italiano di votarlo in Parlamento, in seduta comune, per la Presidenza della Repubblica. In quel caso Borsellino definì l’onorevole Lo Porto «il mio vecchio compagno di scuola, nonché amico».
L’avvocato Repici – sono atti pubblici, ma credo facciano parte anche dell’archivio della vostra Commissione – fa notare che la riunione del 15 giugno, nella quale Caltanissetta e Palermo…
PRESIDENTE. Il senatore Gasparri dice che c’era quando è avvenuto questo fatto.
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Potrà confermarlo, allora.
Dicevo, la riunione del 15 giugno, nella quale Caltanissetta e Palermo parlarono di Lo Cicero e delle sue rivelazioni, logicamente comprese quelle su Lo Porto, fu di pochissimo precedente all’incontro di Borsellino con i colleghi Camassa e Russo, parlando con i quali Paolo Borsellino si lasciò andare allo sfogo su «un amico dal quale si era sentito tradito». Tutti loro meglio di me sapranno che per individuare questo amico l’avvocato Repici ha chiesto all’autorità giudiziaria di sentire Salvatore Borsellino, ma non mi pare che fin qui questa istanza abbia avuto esecuzione.
Concludo con un capitolo destinato ad Agnese Borsellino. Pochi giorni prima di morire, Borsellino dice alla moglie Agnese di aver scoperto che era in atto una trattativa tra mafia e pezzi infedeli dello Stato. Qualcuno aveva detto a Borsellino che Subranni, capo del ROS, era colluso con cosa nostra e addirittura «punciutu». Subranni reagì accusando la moglie di Paolo Borsellino di essere affetta da Alzheimer.
Paolo Borsellino pretendeva che le finestre di casa restassero chiuse, di modo che dall’esterno non si potesse vedere dentro. Temeva che qualcuno lo spiasse dal Castello Utveggio, che aveva fama di essere sede dei Servizi.
Vi è un’ultima cosa che vorrei leggere: i rapporti tra Gioè e Bellini. Gioè, morto suicida in carcere, ha fornito a Bellini un biglietto con cinque nomi di importanti mafiosi detenuti, chiedendo per loro gli arresti domiciliari od ospedalieri per buona condotta. Il maresciallo dei carabinieri Tempesta diede questo biglietto a Mori, che commentò: «I cinque nomi sono il Gotha della mafia e la questione non è praticabile, ma manderò qualcuno a valutare il personaggio (Bellini)». Ricordiamo che Bellini è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione, dopo le condanne della corte d’assise di Bologna, per la strage del 2 agosto. Tempesta non si era rivolto al suo comandante, al comandante del nucleo patrimonio artistico, ma a Mori, perché lo considerava il top dell’investigazione contro la mafia in quel momento.
Vi ringrazio per l’ascolto che mi avete dato e sono a vostra disposizione.
PRESIDENTE. Grazie. Ho visto diverse mani alzate. Abbiamo una trentina di minuti a disposizione, quindi cerchiamo anche noi di essere sintetici, per evitare al dottor Caselli di dover tornare.
Per adesso ho sette colleghi iscritti a parlare, ma non penso che in mezz’ora si possa concludere.
Prima di passare alle domande, per evitare di doverci tornare in un’altra occasione, ritengo necessario precisare che sulla questione Li Pera e Lima, a cui ha fatto riferimento il dottor Caselli, vi è stata un’indagine, sostenuta dalla procura di Palermo, poi definita con l’assoluzione del dottor Lima da questa incolpazione, ossia del presunto «scippo», e con il rigetto del ricorso promosso sul punto dalla procura.
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Se posso permettermi, i dati che ho portato sono dati obiettivi.
PRESIDENTE. Certamente. Però, devo anche dare conto di quanto risulta dai dati obiettivi che abbiamo qui.
ROBERTO MARIA FERDINANDO SCARPINATO. Presidente, non risulta questo che sta dicendo. È stata applicata la censura. C’è la sentenza…
PRESIDENTE. Intanto, senatore Scarpinato, fino a prova contraria, la parola la do io, non se la prende lei. Nessuno può prendere la parola senza che io gliela dia. Dopodiché, la condotta del dottor Lima è stata oggetto di un articolato giudizio disciplinare e, dopo una prima pronuncia sul integralmente assolutoria, il Consiglio superiore della magistratura gli ha inflitto una sanzione non per aver proceduto all’interrogatorio di Li Pera, né per averlo sentito senza difensore, né tantomeno per aver svolto un’attività di indagine di competenza della procura di Palermo. Anzi – ve la leggo tutta, così almeno nessuno può dare interpretazioni – tale ultima ipotesi, quella che è stata definita uno «scippo» della procura di Palermo, «è oggetto di uno specifico caso di incolpazione disciplinare. Per essa il dottor Lima è stato assolto».
Così è più chiaro. Va bene?
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Se posso permettermi, non assolto, ma è passato al civile per non essere condannato. È cosa diversa. Non assolto.
PRESIDENTE. Però deve restare agli atti perché c’è stato un lungo procedimento e non è giusto continuare a parlare di persone assenti, che non si possono difendere.
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. I magistrati hanno la facoltà di interrompere il procedimento disciplinare passando ad altro incarico.
PRESIDENTE. Però non si è trattato di «scippo», almeno secondo quanto risulta dal procedimento disciplinare. Questo lo devo dire perché ho gli atti qui, altrimenti non faccio il mio dovere.
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Cambierò parola.
PRESIDENTE. Lo devo dire, l’ho letta precisa, quindi non si tratta di un’interpretazione.
Dopodiché, io le volevo porre alcune domande.
A seguito della sua prima audizione qui sono arrivati diversi video in cui si metteva in risalto come lei prima avesse parlato, in più occasioni, anche in un ultimo video del primo agosto del 2022, del «nido di vipere», invece nell’audizione precedente lei ha detto «semmai ci fu un “nido di vipere”, se ne era dispersa la traccia».
Allora, per evitare che qualcuno metta in discussione quello che ha detto, e sicuramente era un modo di dire il suo, le chiedo in modo secco: nella procura di Palermo del ’91-’92, quella in cui avevano lavorato Falcone e Borsellino, c’era o no un «nido di vipere»?
Le pongo un’altra domanda, proprio perché la sua esperienza ci può dare un quadro più ampio. Lei ha fatto più volte riferimento al fatto che mafia-appalti sarebbe poco come motivo della strage. Perché, allora, è scritto nelle sentenze Borsellino ter, quater e quinquies che mafia-appalti è certamente una concausa, se secondo lei non può esserne il motivo? E soprattutto, dottor Caselli, proprio per la sua esperienza, come mai non fu incriminato Scarantino? Noi arriviamo al Borsellino ter, quater e quinquies dopo quello che in sentenza è definito «il più grande depistaggio della storia», cioè Scarantino, e qualcuno lo fece quel processo. Non il presidente Colosimo, non la Commissione antimafia, ma qualcuno fece il Borsellino 1 e 2. Quello fu o no un depistaggio? Effettivamente per anni si portò in giro una persona che gli stessi magistrati ritenevano non credibile.
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. L’espressione «nido di vipere» ricorre in questa seconda mia relazione come frase di Borsellino a Camassa e all’altro collega quella volta che scoppia in pianto. Quindi, «nido di vipere» è una frase di Borsellino. È facile da decifrare: i rapporti del procuratore Giammanco prima con Falcone e poi con Borsellino erano tutt’altro che normali; erano punitivi nei confronti di Falcone, costretto ad emigrare a Roma ,al Ministero, perché è un dato di fatto – a Palermo queste cose pesano moltissimo, può sembrare una banalità – che Giammanco faceva fare ore di anticamera a Falcone davanti al suo ufficio, in un corridoio frequentato da tutti, perché tutti vedessero che Falcone non meritava di essere ricevuto subito. Questa è una «tagliata di faccia» in Sicilia, figuriamoci in procura, e Falcone alla fine se ne va perché non può più lavorare lì. L’antimafia la vuole continuare, però al Ministero, eccome se la continua, facendo il monitoraggio sulle sentenze del cosiddetto «ammazza sentenze» e preparando l’antimafia moderna, Direzione distrettuale antimafia e direzioni distrettuali antimafia.
«Nido di vipere» è espressione che oggi ho riportato come di Borsellino.
Francamente di queste sentenze ho sentito parlare, ho letto sintesi, ma non so come possano essere queste convinzioni di mafia-appalti che personalmente non condivido per niente. Potrei cavarmela con una battuta: tot capita tot sententiae.
I magistrati quando sono in vena di scherzi traducono questo brocardo in termini un po’ maccheronici: «tutto capita nelle sentenze», anziché «tante teste tante idee». Io sono assolutamente convinto che la chiave di lettura è il discorso di Casa Professa. Più ci penso e più me ne convinco. Mi sembra di tutta evidenza che era una bomba, loro stessi dicono: «Chi gliel’ha fatto fare di dire quelle cose?»; e quelle cose erano una bomba, per i mafiosi che ascoltavano, pronta a scoppiare, la dovevano disinnescare. Ecco l’accelerazione, ecco l’ordine di Riina «non uccidere, caro Brusca, Mannino, ma passa a Borsellino». A me sembra molto evidente.
Dunque, Scarantino. Io di Scarantino non so niente, se non che Scarantino la procura di Palermo non l’ha mai usato.
Quando i colleghi di Palermo, in particolare il collega Sabella, che potete chiamare, andarono a sentirlo, subito avvertirono che era un bluff, quindi Palermo non l’ha mai usato.
Caltanissetta ha la sua competenza e conseguentemente quello che riguarda Scarantino riguarda soltanto Caltanissetta, non Palermo. Perché non fu inquisito? Mi pare che poi fu inquisito e accusato di calunnia, ma non vorrei sbagliarmi. Del resto, siccome è roba di Caltanissetta non lo so. Io so che Scarantino fu ascoltato da Sabella perché sembrava un pentito, ma Sabella ne giudicò la totale inaffidabilità e conseguentemente ci disse: «Non ne parliamo neanche, questo noi non lo sentiamo».
PRESIDENTE. Assolutamente. Disse il dottor Sabella che non sapeva nulla di mafia.
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Mi pare che Sabella menzioni questo fatto nel suo libro intitolato Cacciatore di mafiosi, dove racconta come ugualmente ha catturato o ha contribuito a catturare più mafiosi lui di qualunque altro magistrato. In questo libro parla di questo.
PRESIDENTE. Abbiamo un quarto d’ora. Alle 14 alla Camera si vota e non posso cambiare gli orari della Camera.
Do la parola al senatore Gasparri.
MAURIZIO GASPARRI. Chiedo la parola sull’ordine dei lavori, perché le questioni poste sono varie e di tale importanza per cui io delle domande vorrei porle. Prima il dottor Caselli, ad esempio, ha citato Guido Lo Porto, dicendo che Borsellino lo definiva amico. Io ho fatto un’interruzione perché io c’ero, ieri l’ho raccontato in un’intervista sulla Verità, perché nel 1992 ero stato appena eletto e decidemmo di votare simbolicamente Borsellino Presidente della Repubblica. Era maggio e Lo Porto, che era deputato, ci venne a dire che aveva parlato con il suo amico Borsellino che, schivo, giustamente non voleva essere coinvolto, per un atteggiamento che capisco. Noi lo votammo lo stesso, perché a volte si fanno delle votazioni simboliche nel Parlamento.
Questo dimostra l’amicizia – lei ha usato la parola «amico» – tra Lo Porto e Borsellino che durava nel maggio del ’92 e quindi fa giustizia di qualsiasi altra affermazione – lei prima ha citato Lo Porto in merito ad altre cose – per quanto riguarda Guido Lo Porto. La mia non è quindi una domanda, è un’affermazione perché lei ha usato la parola «amico» e io, siccome c’ero, ricordo che Lo Porto venne a dirci: «Mi sta telefonando Paolo». Quindi erano amici. Parliamo del maggio ’92, poche settimane prima della morte di Borsellino.
Questa però è una testimonianza storica che ha attinenza perché ogni tanto Lo Porto viene impropriamente evocato e quindi anche lei ha contezza che fosse amico di Borsellino nel maggio del ’92. Io, siccome c’ero, rendo una testimonianza che coincide una volta tanto con quello che dice lei.
Le domande sarebbero infinite, presidente. Ad esempio, riguardo alla informativa mafia-appalti, c’è una sentenza di Gilda Lo Forti di Caltanissetta che dà ragione all’investigazione del ROS e smentisce quello che io ho sentito poco fa. Per quanto riguarda la perquisizione del covo c’è una sentenza, che smentisce quello che ho sentito poco fa, che ha visto assolti Mori, De Donno e altri, perché – si dice nella sentenza – il rinvio della perquisizione fu concordato con la procura.
Quindi, più che delle domande ho una serie di osservazioni di natura storica, che dicono che la doppia informativa è falsa. E poi c’è l’altra questione, la questione delle questioni. Lo Forti dice, non so quanti anni dopo, che il 14 luglio del 1992 Borsellino viene informato della parziale archiviazione (qui definita quasi irrilevante, gli investigatori non l’hanno considerata tale) di mafia-appalti. Ma Borsellino incontra alla caserma Carini il 25 maggio del ’92 Mori e De Donno e li incoraggia a proseguire in questa inchiesta. E Paolo Borsellino, il 18 luglio – il 18 luglio, ripeto – del 1992, il giorno prima della strage di via D’Amelio, si reca nell’archivio, lasciandone traccia, la notizia è stata pubblicata da tutti, dove ha prelevato materiale di personaggi riguardanti la vicenda mafia-appalti. Come vede, se vogliamo liquidare queste cose in un quarto d’ora, facciamolo, ma io non lo ritengo serio. Questa è una serie di questioni; io non cito sentenze che qui vengono confutate.
Sono vere le sentenze o altro? Potrei continuare a lungo con questioni rilevanti. Non voglio monopolizzare il quarto d’ora, ma sarebbe irrispettoso anche nei confronti del dottor Caselli, di cui conosco la storia e l’impegno, liquidare queste questioni in un quarto d’ora, anche perché lui avrebbe altre cose da dire e anche noi. Io ho fatto un inventario: le parlo dell’informativa, le ho parlato di Lo Porto, le parlo di Gilda Lo Forti. Molte volte la gente fa anche confusione: quando io parlo all’esterno non tutti sanno che c’è un Lima magistrato e un Lima che era un’altra roba; unche stava a Palermo e una Lo Forti. A volte è anche complicato il racconto di queste vicende, lo dico in maniera serena.
Io non voglio adesso fare polemica. Io su queste cose potrei argomentare, ma poi tra un quarto d’ora ce ne andiamo e lasciamo la storia d’Italia appesa? È una domanda a me stesso: che dobbiamo fare?
PRESIDENTE. Do la parola al senatore Verini.
WALTER VERINI. Noi ringraziamo ancora il dottor Caselli per essere nuovamente venuto qui di persona per completare, sia pure sinteticamente, e consegnando il resto, la sua audizione. Lo ringraziamo davvero e ringraziamo anche lei, presidente, per aver accolto la richiesta. Tuttavia, adesso il senatore Gasparri pone un problema. Io credo che, se potessimo, oggi si potrebbe tranquillamente andare avanti, ma ci sono i lavori d’Aula che lo impediscono, quindi mi rendo conto che in otto minuti sarebbe difficile completare. Dunque, mi affiderei anche al dottor Caselli e alla sua disponibilità di continuare, magari anche da remoto, non necessariamente fisicamente qui, a rispondere, nei prossimi giorni. È evidente che le domande, sia dei commissari di maggioranza che di quelli di opposizione potranno essere diverse.
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Ho già detto alla presidente che sono a vostra disposizione.
WALTER VERINI. Quindi, nulla osta a chiudere, perché sono le 14 e voi avete Aula, però è chiaro che si deve e si può continuare.
PRESIDENTE. Prendo atto degli intendimenti dei gruppi e valutiamo la tempistica del prosieguo. Potrei anche provare per domani, ma so che questa settimana è impegnativa per tutti, quindi valutiamo il calendario e poi, ringraziando della disponibilità il dottor Caselli, ci aggiorniamo.
La seduta termina alle 13.50.
- “Entrambi, sia Falcone che Borsellino, sono stati uccisi per una vendetta postuma di Cosa nostra che li riteneva i suoi peggiori nemici.
In più Borsellino fu fermato per impedire che riferisse ai magistrati di Caltanissetta, qualora mai l’avessero convocato, quanto a sua conoscenza sull’attentato a Falcone”. - “la strage potrebbe essere stata compiuta per ribadire, raddoppiando l’efficacia offensiva, le stesse ragioni per le quali era stato ucciso Falcone, ovvero un tentativo di soffocare nel sangue il metodo del pool antimafia”.
Colosimo Chiara , Presidente .
Audizione di Gian Carlo Caselli, già procuratore della Repubblica, nell’ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D’Amelio:
La seduta comincia alle 14.20.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di Gian Carlo Caselli, già procuratore della Repubblica, nell’ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell’audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell’audito o dei colleghi e in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web-tv. Prima di dare la parola al dottor Caselli, che voglio ringraziare per la sua cortesia e per la sua disponibilità, ricordo a tutti che noi siamo convocati in deroga grazie a una concessione dei Presidenti della Camera e del Senato durante il voto del CSM, ma che comunque alle 16 dovremmo interrompere perché la Camera riprende il voto.
A seconda dei tempi dell’audizione del procuratore Caselli, ci regoleremo con l’andamento dei lavori, evidentemente per permettere all’audito di svolgere la sua relazione e a tutti i membri di fare le domande.
Dottor Caselli, la ringrazio ancora per essere qui e le do la parola per la sua relazione.
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Buongiorno a tutti. Signor presidente, signori commissari, grazie per l’attenzione che vorrete prestare al mio intervento. Scusate la mia voce che è quella che è.
I lavori ufficiali di questa Commissione, che è uno snodo importantissimo del nostro sistema democratico, sono iniziati con l’audizione dell’avvocato Trizzino, legale dei figli di Paolo Borsellino.
A Lucia, Manfredi, Fiammetta, sicuramente non soltanto da ora, va tutto l’affetto che meritano. È un affetto sincero, profondo, legato ad eventi che hanno cambiato l’Italia e le nostre vite. Un saluto affettuoso anche a Salvatore Borsellino, fratello di Paolo.
L’avvocato Trizzino ha potuto diffusamente illustrare fin da subito le conclusioni, a suo avviso, da raggiungere.
La presenza di vipere nella procura di Palermo nel 1992, la configurabilità di un collegamento tra via D’Amelio e l’inchiesta mafia-appalti.
Ho letto anche alcune critiche rivolte alla procura nel dopo strage, procura che ho diretto per quasi sette anni, dal 1992 al 1999, e non posso esimermi da alcune osservazioni preliminari.
Dopo le stragi del 1992, quando – e sono parole che tutti ricorderete di Nino Caponnetto – «sembrava che non ci fosse più niente da fare», la procura e la magistratura tutta di Palermo, ovviamente nei limiti delle rispettive competenze, furono in prima linea – in cima la politica, magicamente unita, le forze dell’ordine, i soldati dell’operazione Vespri siciliani e la società civile a Palermo delle lenzuola bianche alle finestre per fare resistenza e impedire che il nostro Stato diventasse uno Stato-mafia capace di stravolgere la democrazia.
I risultati arrivarono. Al riguardo produrrò – lo faccio fin da subito – un allegato dove sono analiticamente esposti i risultati raggiunti dalla procura di Palermo, che ho diretto dal 1993 al 1999. Io mi limito ad evidenziare alcuni, pochi punti. Un dato vincente è stato il numero davvero impressionante di mafiosi che, dopo le stragi, si pentirono e decisero di collaborare con la giustizia. In pochi anni si passa da un numero esiguo di pentiti sotto protezione a numeri molto elevati. Era il segno di un cambio di egemonia politica e sociale, perché, ce l’ha insegnato Falcone, il mafioso si pente e collabora con la giustizia nel preciso momento in cui comincia a fidarsi dello Stato.
Anche in virtù delle confessioni rese dai pentiti, riusciamo a catturare un numero altissimo, alto, di mafiosi latitanti di ogni ordine e grado criminale. Agli arresti seguono i processi basati sempre su prove consistenti.
L’ala militare di cosa nostra finisce alla sbarra e subisce dei colpi che non posso che definire duri: 650 ergastoli, oltre a centinaia di condanne da trent’anni in giù, ovvero il più alto numero di condanne nella storia di Palermo.
È possibile inoltre impostare una nuova strategia d’attacco al lato oscuro del sistema mafia, iniziando ad indagare anche sulle sue relazioni esterne con settori e pezzi della società civile e dello Stato, così da affrontare, in presenza dei presupposti di legge, anche la cosiddetta «criminalità dei potenti».
Una speciale menzione – lasciatemela fare – merita la spinta sociale e culturale che i successi giudiziarie producono. Anche dalla letteratura sociologica si studia la combinazione del trauma con la speranza. Nel caso nostro la combinazione di questo trauma con la speranza fa sì che nasca un poderoso risveglio della scuola.
In quegli anni la maggior parte delle regioni in tutta Italia vara leggi per l’educazione antimafia e Pag. 5comunque per la legalità. Fu una cosa che si può tranquillamente, senza timore di esagerare, definire grandiosa per le dimensioni e per i suoi effetti.
Nessuno pretende che i pubblici ministeri di Palermo siano pensati come dei salvatori della patria, per carità, ma di sicuro hanno diritto a un rispetto autentico non di facciata e mettere in funzione macchine che spargono dubbi o peggio non è certamente compito della Commissione parlamentare.
Volevo ricordare, infine, il primo incontro che ebbi con i nuovi colleghi, dopo la nomina a capo della procura di Palermo. Le mie parole furono queste, molto semplici: «Dobbiamo lavorare in squadra, tutti insieme. Non si guarda indietro. Altrimenti, andiamo a sbattere. Il programma è condiviso e attuato da tutti, senza riserve mentali». Nessuno remò contro.
La procura ha operato come un blocco coeso, raccogliendo il testimone di Falcone, Borsellino, Scaglione, Costa, Chinnici, Terranova, cercando di ispirarsi al loro esempio. Se mai ci fu un «nido di vipere», se ne era dispersa la traccia.
Questo mio intervento si ripropone sostanzialmente tre finalità.
La prima, valutare la consistenza, aggiustata dagli atti, degli elementi in base ai quali la strage di via D’Amelio può essere o potrebbe essere ricollegata in via esclusiva o quasi alla questione mafia-appalti. La mia risposta è – lo vedremo insieme – che non abbiamo elementi sufficienti.
Il secondo punto è dimostrare che negli anni 1992-1999, anni che precedono la mia gestione e si completano con la mia gestione – quella della procura di Palermo non è stata una mala gestio della materia mafia-appalti.
Il terzo punto è, più in generale, controbattere alcune critiche pregiudiziali ingenerose, che talora vengono mosse alla procura di Palermo o a me direttamente.
Oltre alle finalità che si possono definire tecniche, questa mia memoria si propone anche una finalità più alta.
Falcone e Borsellino sono stati due eroi moderni di epica grandezza, veri e propri giganti della storia non soltanto giudiziaria e non soltanto italiana. Sostenere che sono stati uccisi esclusivamente perché volevano occuparsi di mafia-appalti, secondo me, equivale a farne dei funzionari onesti, solerti, capaci, ma ben al di sotto del loro valore storico.
Per intenderci, nella celebre scuola dell’FBI di Quantico ad essere onorato ogni mattina al momento dell’alzabandiera è il busto di Giovanni Falcone nella sua completezza di eccezionale operatore contro il crimine organizzato nazionale e internazionale, non solo un bravo funzionario. E non per caso Andrea Camilleri ha equiparato l’omicidio del campione dell’antimafia all’abbattimento delle Twin Towers di New York. Non è un caso che Salvatore Lupo definisca le vittime di mafia, a partire da Falcone e Borsellino, come rivoluzionari in quanto straordinari creatori di credibilità e rispettabilità mediante l’affermazione della legalità.
A questo punto, se invece si sostiene che Borsellino e forse anche Falcone sono stati uccisi esclusivamente perché volevano occuparsi di mafia-appalti, con tutto il rispetto per l’opinione di tutti, è ovvio, in questo modo però si finisce per rimpicciolire queste due figure, trasformando gli artefici di un indiscusso capolavoro in un sistema giudiziario com’è stato il maxiprocesso, dimostrazione pratica che la mafia si può sconfiggere, che non è invincibile.
Se li trasformiamo in esperti di società, bilanci, offerte, gare, truffe, intrallazzi vari, se ne facciamo dei «Siino della legalità» contro i cattivi, depotenziamo le loro figure. In questo modo, Falcone e Borsellino, campioni indiscussi dell’antimafia, vengono svalutati, retrocessi a bravi funzionari, a professionisti delle gare regolari e dei conti in ordine.
Sarebbe un’operazione in perdita per l’immagine dei due magistrati, per il nostro Paese e per i giovani che perdono e perderebbero un riferimento e un esempio quando non vogliono adagiarsi nella indifferenza, nel disimpegno e nella rassegnazione, ma operare per risultati ritenuti socialmente o politicamente utili. Così si dice che abbia funzionato Borsellino per quanto riguarda la nostra Premier Giorgia Meloni.
Oltretutto, questa operazione sarebbe compiuta su un presupposto fragile, essendo a mio avviso sufficienti, lo ripeto, gli elementi che dovrebbero e potrebbero ricollegare via D’Amelio esclusivamente all’interesse di Borsellino per la questione mafia-appalti.
Mentre la verità di base per Capaci e via D’Amelio resta una vendetta postuma di cosa nostra contro i suoi più acerrimi nemici, Falcone e Borsellino, e nello stesso tempo un tentativo di seppellire nel sangue il loro metodo di lavoro vincente in mezzo al lavoro del pool, senza che tale verità si esaurisca nel significato della tremenda campagna stragista che, rispondendo a un disegno criminale unitario, a mio avviso, dispiegherà i propri effetti terroristici fino al 1994.
L’allegato l’ho prodotto. Sono essenzialmente questi i punti principali della mia relazione, anche se forse non farò in tempo a svolgerla tutta, ma mi rimetto alla presidenza.
La questione mafia-appalti come causa della morte di Borsellino la ritengo indimostrata.
Il rapporto mafia-appalti insabbiato è un falso. , La gestione processuale di Ciancimino scorretta è un altro falso. C’è poi il caso Li Pera, trasferito a Catania, che considero uno scippo scandaloso ai danni della procura di Palermo, quando io non c’ero.
Poi, c’è il problema difficile e complesso della cosiddetta «doppia informativa» mafia-appalti che, secondo me, quando viene rifiutata, smentita, trattata tamquam non esset rappresenta un altro scandalo contro la procura di Palermo.
Il secondo capitolo è dedicato a varie questioni pregiudiziali. Ne tratto una soltanto, quella che chiamo anch’io un pessimo affare secondo il libro di Bianconi che molti di voi, se non tutti, conoscono. È una circostanza assolutamente pacifica, ma con risvolti oscuri di decisiva rilevanza.
Il 41-bis, me lo insegnate, varato con decreto-legge subito dopo la caduta di Capaci, stentava ad essere convertito in legge ed era di fatto accantonato. Dopo la strage di via D’Amelio fu immediatamente recuperato e convertito.
Se qualcuno avesse anche solo accennato al fatto che Riina potesse non sfruttare l’opportunità di sbarazzarsi del 41-bis, in cosa nostra, e magari non soltanto, tutti lo avrebbero preso per un pazzo furioso.
Per contro, Riina, come stregato da una pulsione suicida, anziché aspettare il 7 agosto, giorno in cui sarebbe scaduto il termine utile per la conversione in legge del 41-bis, decise che l’attentato contro Borsellino si doveva fare il 19 luglio.
Nell’ottica di qualunque mafioso non demente, era una scelta illogica, insensata, che neanche il peggior cupio dissolvi avrebbe potuto giustificare; un vero e proprio mantra di Riina, secondo i pentiti, che si sarebbe giocato i denti, cioè una delle cose più preziose, pur di eliminare la legge sui pentiti e il 41-bis.
Se Borsellino si è voluto uccidere prima, facendo un pessimo affare, copyright di Giovanni Bianconi, è comunque molto difficile trovare, senza un salto logico, un qualche collegamento razionale con la questione mafia-appalti, se non altro perché, non anticipando l’attentato, a Borsellino sarebbe stata concessa una manciata di giorni, troppo poco anche per un magistrato eccellente, bravissimo, come lui, per combinare qualcosa.
Senza scomodare il rasoio di Occam, resta che Borsellino fosse stato ucciso per ribadire, raddoppiando l’efficacia offensiva, le stesse identiche ragioni per le quali era stato ucciso Falcone, vale a dire una vendetta postuma e un tentativo di soffocare nel sangue il metodo vincente del pool.
Nello specifico, che Borsellino magari, anche, per impedirgli di comunicare alla procura nissena, di Caltanissetta, quando Tinebra lo avesse convocato, il prezioso materiale raccolto di cui non faceva mistero. È l’intervento pubblico a Casa Professa il 25 giugno, data di cui parleremo anche per altri motivi.
Dice a Casa Professa in un intervento pubblico: «Avendo raccolto, come amico di Falcone, tante sue confidenze, anche delle convinzioni che io mi sono fatto raccogliendo tali confidenze, questi elementi che io porto dentro di me debbo per prima cosa assemblarli e riferirli all’autorità giudiziaria». Aveva dentro delle cose utili, ma non è mai stato sentito prima dell’assassinio.
Non dobbiamo dimenticare l’intervista che Borsellino due giorni prima di Capaci rilascia a una tv francese, il relatore si chiamava Calvi, intervista a lungo tenuta nascosta dalla nostra tv di Stato, perché riguardava fatti imbarazzanti riferibili a personaggi eccellenti, ma nulla, proprio nulla, che possa consentire di concentrarsi esclusivamente sulla pista mafia-appalti che invece era la scelta operata, mi sembra di aver capito leggendo e informandomi, con una sorta di presunzione dogmatica, dal generale Mori, dal colonnello De Donno e dall’avvocato Trizzino, così – permettetemi di dirlo – sradicando la strage di via D’Amelio dalla sequenza complessiva degli atti terroristico-mafiosi, sequenza nella quale Filippo Graviano, arrestato all’inizio del 1994, ha un ruolo centrale che va tenuto ben presente. Qui avrei alcune considerazioni sulla identità mafiosa. Gli uomini d’onore si considerano gli unici individui degni di essere riconosciuti come persona, e non per niente
PRESIDENTE. Intanto invito i colleghi che vogliono intervenire a segnalarlo.
- GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Due note sulla identità mafiosa. Se gli uomini d’onore si considerano tali e quindi gli unici individui degni di essere uomini d’onore e non semplici persone, figuriamoci Riina, capo dei capi, responsabile della guerra di mafia che ha causato migliaia, fra morti e scappati, per affermare il suo dominio, responsabile della decapitazione sistematica feroce di tutti i vertici istituzionali della Sicilia, cosa mai successa in nessun’altra parte del mondo, latitante per anni e quindi forte di complicità ad ogni livello. Se gli uomini d’onore si sentivano non persone qualunque, Riina almeno un semidio doveva sentirsi.
Ritengo che, facendo leva su questa sua esaltazione, un consigliori, anche esterno all’organizzazione, abbia potuto convincerlo che a lui sarebbe riuscito tutto bene, anche rinunciando con apparenti harakiri al suo conclamato e inossidabile impegno contro il 41-bis.
La logica impone, comunque, in ogni caso, di concludere che nella testa di Riina, vuoi perché qualcuno glielo avrà insufflato, vuoi perché lo avrà lui stesso elaborato, si era fissato un obiettivo non rinunciabile, di importanza tale da compensare i rischi che correva resuscitando l’odiatissimo 41-bis ormai moribondo. In cambio di che cosa? Questo è il punto decisivo da scoprire o altrimenti si gira a vuoto. Una risposta potrebbe venire dal pentito Salvatore Cancemi, che, nella sentenza di primo grado del Borsellino ter, ha dichiarato: «Per agevolare la creazione di nuovi contatti politici occorreva eliminare chi come Borsellino avrebbe scoraggiato qualsiasi tentativo di approccio con cosa nostra. Riina era stato accompagnato per la manina nella organizzazione della strage. Infine, egli aveva assicurato agli altri boss della cupola che la strage di Borsellino sarebbe stata alla lunga un bene per tutta cosa nostra». Nel medesimo contesto Cancemi fa anche il nome di Berlusconi e di Dell’Utri, indicandoli come soggetti da appoggiare ora e nel futuro. Era molto interessante, ma per quanti sforzi si possano fare non è dato scorgere un qualche possibile collegamento con mafia-appalti se non lavorando di fantasia.
Sta di fatto che il 41-bis poteva sparire e invece restò in piedi senza che e cosa nostra fossero in qualche modo compensati. Francamente, la scelta di concentrarsi esclusivamente sugli appalti, secondo me, che già di per sé stessa era debole, si indebolisce ancora di più. Anche perché l’attività della procura di Palermo in materia di appalti in quel periodo è stata intensa e con risultati positivi. Rinvio alla relazione di cui diremo tra poco che riguarda proprio mafia-appalti nell’arco di un decennio fino al 1999.
Comunque sia, ovviamente, la vicenda di Falcone e quella di Borsellino sono vicende molto complesse che non si possono semplificare per amore di una tesi o peggio ancora per la strumentazione di una tesi, quella di mafia-appalti, contro tutte le altre.
Non dimentichiamo il pensiero di Falcone che Giovanni Bianconi usa come esergo del suo libro: «Non pretendo» – dice Falcone – «di avventurarmi in analisi politiche, ma non mi si vorrà far credere che alcuni gruppi politici non si siano alleati a cosa nostra per una evidente convenienza di interessi nel tentativo di condizionare la nostra democrazia ancora immatura, eliminando personaggi scomodi per entrambi». Salto per cercare di rubare tutto il tempo che posso e vado a pagina 25, a un capitolo che ha un titolo molto impegnativo, forse troppo: perché è stato ucciso Paolo Borsellino? Dobbiamo fissare, a mio avviso, alcuni punti.
Primo punto: la fonte sono il generale Mori e il colonnello De Donno, che d’ora in poi chiamerò Mori e De Donno per velocizzare.
Il 25 giugno del 1992, nella caserma dei Carabinieri di Carini, Palermo, in tutta segretezza viene organizzato e si svolge un incontro con Paolo Borsellino, richiesto da Paolo Borsellino, che voleva conoscere De Donno, secondo alcuni pubblici ministeri di Palermo, autore del cosiddetto «anonimo Corvo 2».
Paolo Borsellino in questo incontro collega mafia-appalti a Capaci. La fonte sono Mori e De Donno. Considera mafia-appalti prioritaria, la vuole riprendere, ottiene la disponibilità di Mori e De Donno e propone tempi di sviluppo con inizio alla metà del mese successivo al suo rientro da una rogatoria tedesca.
Ci si accorda perché le indagini siano riservate ed esclusivamente dirette da Paolo Borsellino.
Per anni su questa riunione del 25 giugno è calato un totale silenzio, un silenzio incomprensibile, si legge in una ordinanza di archiviazione del 1998 del GIP di Caltanissetta Gilda Loforti a pagina 189. Dice la GIP: «Sorprende che Mori e De Donno abbiano riferito di questo singolare incontro presso la caserma di Carini soltanto a distanza di anni, tra la fine del 1997 e gli inizi del 1998, secondo quando riferito da De Donno davanti alla corte di assise di Caltanisetta» – sto leggendo l’ordinanza di Li Pera – «e non con immediata tempestività, come avrebbe dovuto, al contrario, suggerire la loro veste istituzionale, tenuto conto che ad appena qualche settimana da quell’incontro, il 25 giugno, era stata consumata in Italia, a meno di due mesi di distanza da quella di Capaci, la seconda tra le stragi più efferate, quella di via D’Amelio, e tutti gli organi investigativi erano alla ricerca di uno spunto qualsiasi per individuare esecutori e mandanti, esterni e interni» Il colonnello De Donno sostiene di aver parlato di questo incontro a Caltanissetta. Esiste, in effetti, un verbale di De Donno davanti ai pubblici ministeri di Caltanissetta Boccassini e Cardella, in data 11 dicembre 1992. In questo verbale De Donno dichiara: «Circa un mese dopo la consegna a Falcone del dossier mafia-appalti, quindi circa un mese dopo il febbraio 1991, Paolo Borsellino, allora procuratore di Marsala, chiese di incontrarmi per conoscere, con tutti i limiti del caso, i risultati dell’indagine che il ROS stava svolgendo. Borsellino, infatti, aveva già avviato un’indagine nel circondario di Marsala, in particolare su Pantelleria, concernente gli appalti e voleva verificare se tra le due indagini – la sua e quella del ROS – ci fossero punti di contatto. In particolare, Paolo Borsellino nella sua indagine si era dovuto interessare di Siino Angelo, che era già stato oggetto di indagine da parte del ROS». De Donno dice di non avere avuto molti contatti con Paolo Borsellino, ma pochi giorni prima di via D’Amelio fu Borsellino a volerlo incontrare nell’ufficio del ROS di Palermo. Borsellino chiese notizie sulle indagini di De Donno, il quale disse che cosa ne pensava della vicenda oggetto dell’informativa di cui sopra, quella consegnata nel 1992. In particolare, parlò del ruolo – De Donno – di Angelo Siino, sottolineando che, a suo parere, era il punto nodale di raccordo tra mafia e sistema economico imprenditoriale, persona – dice De Donno – non soltanto importante, ma addirittura insostituibile per la difficoltà di riallacciare la rete di collegamento che aveva saputo crearsi.
Paolo Borsellino chiese, poi, notizie di un fatto raccontato da il Sole24Ore circa un appunto dato da Falcone a un giornalista, che riguardava le critiche di Falcone verso Giammanco.
Questo lo salterei, non è essenziale.
È importante, invece, notare che l’incontro a tre, di cui ho parlato in precedenza, in questo verbale di De Donno davanti a Boccassini e Cardella svanisce, quindi mette anche in ombra il collegamento causale tra la morte di Paolo Borsellino e il dossier. Non è più un incontro a tre nella caserma, ma è un dialogo a due, sempre che non ci siano altri verbali che io non conosco.
L’avvocato Fabio Repici, legale di Salvatore Borsellino, ha scovato un verbale di Caltanissetta del maresciallo Carmelo Canale davanti al pubblico ministero Gozzo, all’aggiunto e ai pubblici ministeri Di Leo e Paci del 13 dicembre 1992, siamo avanti negli anni.
Comunque, su richiesta di Borsellino, Canale organizzò un incontro, al quale partecipò anche Mori, nella caserma Carini. Paolo Borsellino e Canale si recarono all’incontro in incognito, cioè uscendo dai sotterranei del Palazzo di giustizia, e Paolo Borsellino senza la scorta. Prima di allora Borsellino non aveva mai manifestato interesse – dice Canale – né a vedere De Donno né riguardo l’indagine mafia-appalti, anche se De Donno lo aveva già conosciuto quando De Donno era andato a Marsala proprio a portargli il rapporto mafia-appalti, ma non se lo ricordava – dice Canale – a dimostrazione della sua assoluta mancanza di interesse per l’argomento. Dopo questo, Canale accompagnò Borsellino all’aeroporto.Pag. 15
A parte il lunghissimo inspiegabile silenzio, il quadro – in base agli elementi che ho esposto fino ad ora, gli elementi fin qui disponibili – appare piuttosto incerto e confuso.
Ragioniamo come se ancora la versione di partenza, l’incontro del 26 giugno, non fosse in discussione. Emerge un dato indubbiamente di grande interesse: l’interesse di Borsellino verso mafia-appalti, che lo porta ad avviare concretamente un programma di lavoro, fissando i tempi di inizio. È necessario, però, secondo me, imprescindibile, per dare un senso logico al collegamento di mafia-appalti con l’eliminazione di Borsellino, sapere che cosa nostra conosceva questo interesse di Borsellino.
L’incontro del 25 giugno 1991 avviene in condizioni di assoluta segretezza, e per come è stato organizzato e per come si è svolto. Canale – lo abbiamo visto – ci va in incognito, uscendo dai sotterranei. L’avvocato Trizzino, con un’immagine molto efficace, ha evocato le riunioni dei Carbonari. Questo modus operandi è scarsamente compatibile, per non dire del tutto incompatibile, con la conoscenza da parte di cosa nostra da parte di un soggetto estraneo alla riunione, della riunione stessa. Se questa conoscenza fuori dalla riunione, oltre la cerchia dei partecipanti alla riunione, è molto difficile per le modalità stesse di assoluta segretezza della riunione, il collegamento dell’omicidio di Borsellino con mafia-appalti si sfilaccia un po’ o va in crisi.
Possiamo accantonare o non affrontare funditus alcuni interrogativi, che altrimenti dovremmo porre a tutto tondo.
Non risulta che Borsellino, procuratore aggiunto, quindi legittimato a farlo, abbia mai parlato della riunione del 26 giugno o di quanto in essa concordato con il ROS sul piano investigativo a Lo Forte e Scarpinato, suoi sostituti, che pure stavano lavorando su mafia-appalti. Perché? Per me rimane un interrogativo. Per parte loro, non sembra che Mori e De Donno abbiano detto nulla a Borsellino di Ciancimino e dell’inizio della cosiddetta «trattativa» né di quanto stava accadendo a Catania con Li Pera, da Palermo forzosamente trasferito a Catania. Perché tutto questo riserbo?
PRESIDENTE. Vogliamo fare una pausa? No, va bene.
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. C’è ancora un capitolo da scrivere. In un lasso di tempo, che non riesce meglio a precisare, orientativamente tra Capaci e i primi giorni di luglio, Giovanni Brusca riceve da Riina un ordine: «Sospendi la preparazione dell’omicidio Mannino» di cui aveva incaricato Brusca «perché ci sono esigenze più immediate da affrontare». Secondo Brusca, Riina, per una serie di notizie e valutazioni connesse, riteneva prioritaria l’eliminazione di Borsellino.
Dopo Brusca possiamo ricordare Cancemi, che parla di eliminazione di Paolo Borsellino per agevolare la creazione di nuovi contatti politici. Comunque sia, c’è un dato obiettivo di base: Riina Paolo Borsellino lo vuole morto più presto di quanto dovesse avvenire.
Anticipo che Brusca motiva parlando di notizie e valutazioni di Riina e Cangemi di nuove alleanze. Nessuno dei due parla di mafia-appalti. Quindi, di nuovo, se ci si ferma a questi dati, che però sono dati importanti, è un collegamento difficilmente proponibile, se non del tutto improponibile.
Attenzione, però. Facciamo anche un ragionamento che potrà sembrare persino un po’ provocatorio, ma che vuole essere soltanto un esercizio di logica. Gli ufficiali del ROS, Mori e De Donno, e l’avvocato Trizzino seguono due tesi. Prima tesi: mafia-appalti è la causa della morte di Paolo Borsellino. Seconda tesi: mafia-appalti muore a sua volta sabotata per l’archiviazione indebita e compiacente richiesta da pubblici ministeri considerati felloni, o quasi, in piena estate 1992, quando tutti pensano solo alle vacanze, allo svago, al divertimento e nessuno si interessa di archiviazioni e cose simili.
Queste due tesi, se ci pensiamo un attimo, sono come un cane che si morde la coda, innescano un cortocircuito: neanche il sanguinario Riina avrebbe mai fatto uccidere qualcuno perché non si occupi di una cosa che sta già morendo, scomparendo da sola. Invece, pur di denigrare la procura di Palermo del 1992, si prospettano due tesi contraddittorie, che si annullano vicendevolmente, perché conta soprattutto accusare la procura di qualcosa. Il famoso detto: calunniate, calunniate, qualcosa resterà.
In questa brutta storia, di certo potrebbe esserci soltanto il pessimo affare, cioè l’harakiri di Riina sul 41-bis, di cui ho già parlato, un rebus che rimane irrisolto e che avvolge la vicenda con una fitta coltre di nebbia, che non è dipanata. Prima conclusione: non vi sono, secondo me, allo stato degli atti, elementi sufficienti perché nella ricerca della verità in ordine alle cause della morte di Borsellino si possa puntare, secondo logica e buonsenso, sul collegamento mafia-appalti, men che mai esclusivamente. Fondamentale al riguardo è una testimonianza di un magistrato, collega e amico di Borsellino, di nome Davide Monti.
Depone al «Borsellino bis» di un incontro con Paolo Borsellino a Palermo intorno alle ore 20 del giorno prima della strage, neanche 24 ore. Borsellino dice a Davide Monti che c’era una spaccatura nella procura di Palermo, forse il «nido di vipere».è responsabile di una mala gestione dell’ufficio, ha perseguitato Falcone costringendolo ad andarsene.
Anche Borsellino non andava d’accordo con lui e non lo apprezzava, ma invece dello scontro, Borsellino dice a Monti: «Preferisco il tentativo di arrivare a risultati utili». Borsellino dice a Davide Monti: «La cosa che mi preme di più in questo momento è cercare elementi di ricostruzione della strage di Capaci». Non c’è nessun accenno a mafia-appalti.
Tirando le fila, ho cercato di fare un discorso fondato su un andamento storico-fattuale e la conclusione mia è che il collegamento con mafia-appalti non ci sta. Poi sono passato al piano della logica delle due tesi, che fanno a pugni, e anche sul piano della logica mafia-appalti non ci sta.
Poi c’è questa testimonianza di Davide Monti, che è come Borsellino che parlasse per la voce del collega. Il verdetto su questa vexata quaestio è come se fosse in qualche modo – scusate la retorica, ma è così – pronunziato proprio da Borsellino.
Allora, mi direte, rimane un problema: perché Borsellino è stato ucciso? Paolo Borsellino è stato ucciso per un motivo, a mio avviso, ben preciso, ma anche molto semplice: è stato ucciso perché era Paolo Borsellino, il nemico più odiato, insieme a Falcone, da cosa nostra perché responsabile di una formidabile tagliata di faccia dell’organizzazione criminale con il maxiprocesso che ha decretato la fine del mito dell’impunità di cosa nostra.
Quando il 30 gennaio 1992 le condanne diventano definitive, cosa nostra è costretta a reagire per recuperare quello che può: da un lato, colpisce i traditori, perché chi deve capire capisca e rientri o rimanga nei ranghi;
Naturalmente, oltre alla pista mafia-appalti ce ne sono altre che dovrebbero essere percorse o possono essere percorse, ma questo è un compito della Commissione e non mi permetto di insegnare niente a nessuno, anche se ho un elenco di possibilità.
PRESIDENTE. Ovviamente può farle.
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Lo faccio. Grazie.
La tesi che punta esclusivamente sul collegamento tra Paolo Borsellino e mafia-appalti porta la Commissione – ho osato scrivere – in un vicolo cieco, perciò secondo me è necessario trovare altre strade.
Ne ho elencate, a titolo meramente esemplificativo, sicuramente non esaustivo, alcune.
La paura che, alla lunga, in procura avrebbe finito per comandare più Borsellino che Giammanco. Questo, per un’organizzazione criminale come cosa nostra, era decisamente una perdita.
La preoccupazione per quello che Mutolo – o altri – poteva in quel momento rivelare a Paolo Borsellino.
La paura che altri potessero pentirsi, attratti dall’indiscutibile carisma professionale di Paolo Borsellino, e uno ce l’abbiamo: Lo Cicero.
La paura per un’intervista a Canal Plus fatta da quel Calvi prima di Capaci.
La paura che Signorino potesse aver ricevuto da Borsellino qualche confidenza di troppo.
La pista nera, che indicherà Lo Cicero, che si stava pentendo. Un amico traditore, di cui ha parlato recentemente una AGI che riferisce il pensiero dell’avvocato Repici. Le piste segnalate a questa Commissione da Roberto Scarpinato, magari – ho letto – affidandole alle cure di un Comitato ristretto suggerito da Luciano Violante ad Atreju il 16 dicembre 2024.
Questo per quanto mi riguarda.
Proseguendo nella esposizione della mia memoria, voglio passare al capitolo che s’intitola «Ciancimino». Su richiesta di Vito Ciancimino, veicolata dagli ufficiali del ROS, Mori e De Donno, la procura di Palermo, a partire dal 27 gennaio 1993 – io ero arrivato il 15 gennaio –, ha aperto una lunga serie di interrogatori nel carcere di Rebibbia. Questi interrogatori li ho condotti personalmente con uno degli allievi prediletti di Borsellino che era il magistrato Antonio Ingroia. I carabinieri del ROS hanno assistito a tutti questi interrogatori, ora in coppia Mori e De Donno, più spesso soltanto De Donno. Gli ultimi interrogatori furono affidati al sostituto Luigi Patronaggio, in un caso – li continuò anche quando io me ne andai da Palermo – con la partecipazione del nuovo procuratore capo di Palermo, Pietro Grasso. Ad alcuni interrogatori presenziò anche il difensore di fiducia di Ciancimino. Mori e De Donno non ebbero mai niente da eccepire, mai niente da chiedere, e neppure ci si è avvalsi di quello spazio di autonomia decisionale consentito che è stato rivendicato per la mancata sorveglianza del covo di Riina dopo il suo arresto.
Soltanto una trentina di anni dopo questi due ufficiali del ROS, Mori e De Donno, decidono all’improvviso di accusare Caselli e Ingroia con una tesi che ai due malcapitati appare francamente sbagliata e lesiva nei nostri confronti. La tesi di Mori e De Donno è questa: non avremmo adeguatamente sfruttato per le indagini l’ex sindaco mafioso di Palermo, Vito Ciancimino, con il rammarico – dicono i due ufficiali – che «il treno passa una sola volta nella vita». In verità, a noi Ciancimino è sembrato più che altro uno che si muoveva secondo un copione preciso, finalizzato, che fosse lui a sfruttare gli inquirenti, senza nessun ritorno in termini di fattiva collaborazione. Comunque sia, per propagandare la loro tesi, Mori e De Donno hanno scritto un corposo saggio, che molti di voi sicuramente conoscono, L’altra verità, uscito nel 2024, che hanno riproposto in molte sedi, credo anche in questa Commissione.
Nel libro, Mori e De Donno utilizzano amplissimamente un dattiloscritto di Ciancimino intitolato Le mafie. Ciancimino in questo dattiloscritto, che è corposo, si auto-elogia come persona leale, dal comportamento sempre ineccepibile, mentre era spietato nei confronti di Falcone: lo deride chiamandolo ripetutamente «il nostro» o «il magnifico nostro» e lo copre di insulti, un diluvio di insulti volgari, tipo «bugiardo e scorretto», «delirante», «cialtrone», «imbecille in malafede». Non meno vergognose le parole che don Vito riserva a Borsellino: «È inconcepibile che una persona dotata di tale testa possa continuare a fare il magistrato». Nessuna pietà per i due magistrati uccisi dalla mafia, soltanto un odio feroce. Un comportamento totalmente in distonia rispetto ai requisiti occorrenti per riconoscere un potenziale pentito affidabile. A maggior ragione se, come fa Ciancimino, si pretende con arroganza, con iattanza, preliminarmente e a prescindere, la patente di collaborante, con i benefici connessi, basata su un atto di fede o giù di lì.
Non è vero, mi spiace dirlo, quanto sostenuto dal generale Mori, che avremmo, noi pubblici ministeri precedenti, preteso che Ciancimino ammettesse di essere un uomo di fede.
Non risulta dai verbali, non so da dove possano aver preso questa cosa, che non mi risulta.
Sta di fatto che, dopo una prima serie di infruttuosi interrogatori, abbiamo contestato Ciancimino, e i due ufficiali del ROS lo ricordano nel loro libro a pagina 190: «Nella convinzione che le sue dichiarazioni non palesino una reale volontà di collaborare, ma soltanto l’intenzione di diminuire la portata Pag. 22delle sue responsabilità, lo abbiamo invitato a fornire dichiarazioni che vadano realmente nel senso di una effettiva collaborazione». Ciancimino, per superare questa impasse, ha chiesto di essere scarcerato per poter operare come infiltrato dei carabinieri. Un coup de théâtre che, ovviamente, non ha funzionato.
Abbiamo fatto fatica – faccio fatica ancora oggi – a capire come possano Mori e De Donno, che sostengono di aver avuto un unico scopo, vendicare Falcone e Borsellino, sponsorizzare Ciancimino, dandogli un credito postumo, quasi incondizionato, e scorgendone una straordinaria opportunità di lotta alla mafia, invece di una inaffidabilità e ambiguità, che sono i tratti caratteristici, a mio avviso, di Ciancimino, corleonese nelle mani di corleonesi, come è stato altre volte definito.
Eppure, secondo Mori e De Donno, nuove indagini si sarebbero potute o dovute fare utilizzando gli spunti offerti da Ciancimino. Se non fosse che Ciancimino non va oltre un impasto, talora surreale, di suggestioni, illazioni, deduzioni, sensazioni, cose dette a metà o semplicemente pensate, in sostanza chiacchiere, senza fondamento o significato, prive di prospettive concrete, processualmente parlando.
Un esempio per tutti: nelle pagine 212 e 213 del loro libro – ne parlano Mori e De Donno – Ciancimino tira in ballo il cosiddetto «architetto», cioè il possibile autore del genio politico che portò a eleggere un Capo dello Stato diverso da Andreotti. Sostiene Ciancimino: «Io ho in testa il nome del possibile architetto, ma non ne ho le prove» e poi precisa: «le notizie al riguardo le ho raccolte nel corso delle passeggiate lungo le vie di Roma, salotto dove ho orecchiato parole che mi hanno indotto a parlare dell’architetto». Tutto qua. Nondimeno, i due ufficiali nel loro libro escono con una teoria singolare: premettono che forse sarebbe stato impossibile andarePag. 23a dibattimento – pagina 200 del loro libro – e, nonostante ciò, loro stavano per sbaragliare ciò che non poteva essere sbaragliato, perché Ciancimino avrebbe potuto portare le indagini a livelli mai toccati prima – pagina 118 del libro –, beninteso, dibattimento escluso, quindi girando a vuoto, senza sbocchi di una qualche utilità, avendo gli stessi Mori e De Donno ammesso poco prima che il dibattimento era di fatto inarrivabile.
Perché tutto questo? Una risposta, a mio avviso, la possiamo trovare nelle pagine 199 e 200 del libro di Mori e De Donno, dove si legge: «Torna alla mente di Mori e De Donno sempre la stessa ossessiva domanda: e se ci fosse stato il dottor Falcone o il dottor Borsellino? Non sappiamo cosa sarebbe potuto succedere, ma di una cosa siamo sicuri: non ci sarebbe stato il processo trattativa Stato-mafia». Una tesi che ritroviamo poche pagine oltre – pagina 218 – quando Mori e De Donno parlano di una terribile aggravante, appunto la presunta trattativa Stato-mafia.
In altre parole, a parte il malvezzo di interpellare i morti come fosse una seduta spiritica, usurpando competenze psicosociali che non mi appartengono, provo ad azzardare l’ipotesi che il libro su Ciancimino sia una risposta maturata in un contesto di recriminazioni rancorose all’inchiesta Trattativa.
Questa delle recriminazioni rancorose, che spesso tracimano in livore, è la chiave di lettura, secondo me, e di comprensione di molte delle analisi che ho fatto. Che questa sia una chiave di lettura, le recriminazioni rancorose, vien fuori – è antipatico, ma necessario – da una lunga intervista televisiva a Gaia Tortora su La7e poi a vari quotidiani, in cui il generale Mori dichiara di voler vivere a lungo per vedere morti i suoi nemici. Frase che, anche a non volerla interpretare come una specie di anatema o di fatwā, è comunque sintomatica di un risentimento Pag. 24rancoroso, di certo non compatibile con obiettività e serenità di giudizio.
Quanto a De Donno, interfaccia di Mori anche per il risentimento suddetto, non si possono non ricordare alcuni precedenti rilevanti sul piano della attendibilità. Cito il primo, il principale: a margine della conferenza stampa sull’arresto di Riina, in un primo momento De Donno ebbe a rivelare a tre giornalisti – Cavallaro del Corriere della Sera, Bolzoni di la Repubblica e Rosato di L’Unità – che qualcuno per la vergogna avrebbe dovuto andarsene da Palermo, per poi precipitosamente smentire, con relative contestazioni e polemiche di quanto aveva dichiarato.
Poi ci sono anche dichiarazioni del 2013 all’università di Chieti, secondo cui il covo di via Bernini di Riina era stato filmato numerose volte prima del suo arresto, cosa che non risultava mai successa. Talché De Donno farà una clamorosa retromarcia, dichiarando di aver fatto confusione con la sorveglianza di un altro covo.
Un altro riscontro di quello che ho detto prima, del clima di livoroso rancore, seguendo i lavori di questa Commissione, è quando, su domanda di uno dei componenti della Commissione che legge due intercettazioni telefoniche, conversazioni tra De Donno e Dell’Utri e tra Dell’Utri e Mori, risponde in maniera abbastanza seccata: «Io faccio indagini e sono anche bravo. Di politica non mi occupo». Queste conversazioni le avete sentite, le ricorderete, sono indubbiamente interessanti. Mori e De Donno sono entusiasti per l’annullamento con rinvio. Ci sarà una sentenza definitiva di condanna a sette anni. De Donno ribadisce la sua imperitura stima nei confronti di Dell’Utri. Sarà condannato – ripeto – a sette anni. E Mori ci mette del suo dicendo che per la magistratura di Palermo egli ha una totale disistima.
È da ricordare che per Dell’Utri ci sarà non soltanto la condanna a sette anni. C’era già stato un processo con arresto e condanna nel 1995 a Torino per reati fiscali e frode.
Se vogliamo completare il quadro, la deposizione di Virginio Rognoni, 11 giugno 1981, contenuta nella sentenza ordinanza del 1991 che riguarda gli omicidi politico-mafiosi della città, in particolare quello di Piersanti Mattarella. Rognoni depone che Piersanti Mattarella lo va a trovare a Roma e gli esprime il suo dissenso e la sua grande preoccupazione per le notizie sulle pressioni che l’ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, uomo di discussa, ambigua e dubbia personalità – virgolettato – stava mettendo in atto per ottenere un reinserimento a un livello di piena utilizzazione politica all’interno del partito della Democrazia Cristiana. Questo dato lo potete trovare, se volete, nel volume di Giuliano Turone Crimini inconfessabili, a pagina 133.
PRESIDENTE. Abbiamo concordato con il dottore che lui, in realtà, ha altre parti, però possiamo dividere il lavoro, tenendo sempre conto che sono le ore 15.25 e che alle ore 16 sarà necessario interrompere la seduta. Se ritenete, possiamo fare delle domande su questa prima parte, fermo restando che il dottore ha già dato disponibilità, magari non in presenza, ma da remoto, come deciderà lui stesso, per continuare.
Se siete d’accordo, sospendiamo i lavori per qualche minuto.
(La seduta, sospesa alle ore 15.20, riprende alle ore 15.25)
PRESIDENTE. Prima di chiudere per permettere ai colleghi di andare in Aula a votare, do la parola al dottor Caselli per indicarci i punti sui quali ancora dovrà intervenire nella prossima seduta.
GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Io avevo preparato – ho qui davanti a me – una memoria di circa Pag. 26ottanta pagine che tratta vari argomenti.
Il primo, l’introduzione, l’ho svolto, il «Pessimo affare» l’ho svolto, «Perché via D’Amelio» l’ho svolto, di Ciancimino ho parlato.
I capitoli successivi sono intitolati uno alla questione Siino, uno alla questione mafia-appalti in generale, uno alla questione Li Pera in particolare e uno alla cosiddetta «doppia informativa».
C’è poi un capitolo sulle «cooperative rosse» e uno sulle «recenti scoperte», chiamiamole così, dell’avvocato Repici, che sono di pubblico dominio perché ne hanno parlato i giornali.
Poi avevo preparato alcune schede su Agnese Borsellino, su Gioè e sugli attentati agli oggetti artistici e infine alcune considerazioni en passant.
Se vogliamo andare avanti, potrei parlare di Li Pera.
PRESIDENTE. Mi sembra troppa carne al fuoco per trattarla in mezz’ora.
Intanto la ringrazio per questa prima parte di audizione e le chiedo, quando sarà pronto, di girarci comunque anche il documento, in modo che i commissari possano leggerlo, e alla fine di questa seduta di indicarci delle date in cui è disponibile. Grazie.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 15.30.
31.7.2025 Caselli, dietro morte Borsellino non c’è indagine mafia-appalti – ANSA
“Non ci sono elementi per dire che la strage via D’Amelio sia collegata all’indagine mafia-appalti e, inoltre, nè prima del mio arrivo alla procura di Palermo nè dopo c’è stata una cattiva gestione di quell’indagine.
Ridurre la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, eroi moderni di epica grandezza, al tentativo di fermare l’inchiesta mafia-appalti significa ridimensionare il loro valore storico.
Entrambi, sia Falcone che Borsellino, sono stati uccisi per una vendetta postuma di Cosa nostra che li riteneva i suoi peggiori nemici.
In più Borsellino fu fermato per impedire che riferisse ai magistrati di Caltanissetta, qualora mai l’avessero convocato, quanto a sua conoscenza sull’attentato a Falcone”.
Lo ha detto l’ex procuratore di Palermo Giancarlo Caselli nel corso della sua audizione davanti alla commissione nazionale antimafia nell’ambito delle attività d’indagine svolte sulla strage costata la vita al giudice Borsellino e alla sua scorta.
“Trovo ingiusto strumentalizzare una tesi a discapito di altre”, ha aggiunto.
Caselli, che ha retto al Pocura di Palermo dopo le stragi mafiose del ’92 (dal 1993 al 1999), ha anche ricordato i successi dell’azione della magistratura di quegli anni. “Dopo la reazione dello Stato seguita agli attentati del ’92 c’è stato il più alto numero di collaborazioni con la giustizia, segno di un cambio di egemonia politica e sociale perché il mafioso si pente quando si fida dello Stato – non dimentichiamo poi i successi contro l’ala militare di cosa nostra, che ha subito colpi durissimi (come le condanne a 650 ergastoli e centinaia di anni di carcere), e le indagini sul lato oscuro dei rapporti tra pezzi Stato e boss”. Caselli ha rivendicato dunque i meriti e i successi della sua Procura. “Quei magistrati – ha spiegato – hanno diritto a rispetto autentico e spargere fango non è compito della commissione Antimafia”.
L’ex procuratore capo di Palermo Caselli in Commissione antimafia: «Le stragi del ’92 sono una vendetta postuma, non c’entra mafia-appalti»
«Non esistono elementi sufficienti a collegare la strage di via D’Amelio al dossier su mafia e appalti». Lo ha affermato Gian Carlo Caselli, già procuratore di Palermo, nell’audizione in corso davanti alla Commissione antimafia. «Falcone e Borsellino – ha ricordato Caselli – sono due eroi moderni, di epica grandezza, veri e propri giganti della storia non solo giudiziaria e non solo italiana. Dire che sono stati uccisi solo per i collegamenti con la vicenda mafia e appalti equivale a farne funzionari solerti, onesti, capaci, ma ben al di sotto di quello che fu il loro reale valore». «Il mio affetto per i familiari di Borsellino è sincero e profondo, legato a eventi che hanno cambiato l’Italia e le nostre vite: l’avvocato Trizzino ha potuto illustrare fin da subito le conclusioni che a mio avviso vanno raggiunte, ovvero la presenza di vipere nella Procura di Palermo nel 1992 e la configurabilità di un collegamento tra via d’Amelio e l’inchiesta mafia-appalti», ha proseguito l’ex procuratore capo di Palermo.
«Di fronte alle critiche rispetto al mio operato da procuratore non posso che formulare alcune osservazioni – continua Caselli, – Procura e magistratura di Palermo sono state in prima linea insieme a politica, Forze dell’Ordine, esercito e società civile per impedire che il nostro Stato diventasse assoggettato alla mafia e la nostra democrazia venisse travolta: un dato importante è il numero di mafiosi che dopo le stragi si sono pentiti e hanno collaborato con la giustizia, in pochi anni siamo passati da un numero esiguo a uno molto elevato. Come ci ha insegnato Falcone, il mafioso si pente e collabora con la giustizia quando comincia a fidarsi dello Stato: anche in virtù delle confessioni rese dai pentiti siamo riusciti a catturare un numero importante di mafiosi latitanti».
«Agli arresti sono seguiti i processi, basati sempre su prove consistenti: l’ala militare di Cosa nostra è finita alla sbarra, con 650 ergastoli e centinaia di condanne da trent’anni in giù; mai ce ne sono state così tante nella storia di Palermo. Si è inoltre impostata una nuova strategia d’attacco al lato oscuro del sistema mafia, indagando le relazioni esterne con settori della società civile e dello Stato, così da affrontare anche la cosiddetta criminalità dei potenti. Nessuno pretende che i pm di Palermo vengano pensati come salvatori della patria, ma di sicuro hanno diritto a un rispetto autentico: mettere in funzione macchine che spargano dubbi non è certo compito di una commissione parlamentare».
«Le stragi di Capaci e di via d’Amelio sono una vendetta postuma di Cosa nostra contro Falcone e Borsellino, acerrimi nemici, e il tentativo di seppellire nel sangue un metodo di lavoro vincente, quello del pool. Il presunto legame con l’inchiesta mafia appalti è allo stato del tutto indimostrato». conclude Caselli.
Omicidio di Paolo Borsellino, Caselli: “Fu ucciso perché era il nemico più odiato di Cosa nostra”
Queste le parole di Giancarlo Caselli, ex Procuratore di Palermo davanti alla Commissione nazionale antimafia. Paolo Borsellino “fu ucciso per un motivo semplice: Perché era Paolo Borsellino, il nemico più odiato di Cosa nostra. Responsabile del maxiprocesso che ha decreto la fine dell’impunità di Cosa nostra e quando le condanne divennero definitive Cosa nostra fu costretta ad agire”. Sono le parole di Giancarlo Caselli, ex Procuratore di Palermo davanti alla Commissione nazionale antimafia. Caselli: “Non dimentichiamo poi i successi contro l’ala militare di cosa nostra, che ha subito colpi durissimi” “Dopo la reazione dello Stato seguita agli attentati del ’92 c’è stato il più alto numero di collaborazioni con la giustizia, segno di un cambio di egemonia politica e sociale perché il mafioso si pente quando si fida dello Stato. Non dimentichiamo poi i successi contro l’ala militare di cosa nostra, che ha subito colpi durissimi e le indagini sul lato oscuro dei rapporti tra pezzi Stato e boss”. Così l’ex Procuratore di Palermo, Giancarlo Caselli davanti alla Commissione nazionale . “Trovo ingiusto strumentalizzare una tesi a discapito di altre. Non ci sono elementi per dire che la strage via D’Amelio sia collegata all’indagine mafia-appalti e, inoltre, né prima del mio arrivo alla procura di Palermo né dopo c’è stata una cattiva gestione di quell’indagine. Entrambi, sia Falcone che Borsellino, sono stati uccisi per una vendetta postuma di Cosa nostra che li riteneva i suoi peggiori nemici. In più Borsellino fu fermato per impedire che riferisse ai magistrati di Caltanissetta, qualora mai l’avessero convocato, quanto a sua conoscenza sull’attentato a Falcone”. Così, l’ex procuratore di Palermo Giancarlo Caselli proseguendo la sua audizione davanti alla commissione nazionale antimafia nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Federico Rosa QdS 31.7.2025
Falso! Falso! Falso! Caselli ha spazzato via la coltre di bugie che sta avvolgendo l’Antimafia
Gian Carlo Caselli, intervenendo oggi in Commissione parlamentare antimafia, ha spazzato via la coltre di falsità con la quale Mori, De Donno, Trizzino hanno fin qui avviluppato la Commissione Antimafia, scandendo ripetutamente e per titoli precisi: Falso! Falso! Falso!
Grazie a questo “sgombero” democratico sarebbe ora finalmente possibile guardare oltre ed intravedere le figure-negate dalla narrazione mainstream, quelle cioè sulle quali per nulla al mondo doveva cadere l’attenzione degli onorevoli commissari e dell’opinione pubblica. Figure-negate come Giuseppe Graviano, Paolo Bellini, Marcello Dell’Utri, Guido Lo Porto. Ovvero alcuni dei protagonisti, noti e meno noti, della transizione tra prima e seconda Repubblica. Personalità dalle traiettorie che intrecciano pericolosamente quelle degli attuali attori di governo. Di Giuseppe Graviano, cioè il collegamento ineludibile tra tutti i fatti stragisti del ’92-’93, mai preso in considerazione dalle ricostruzioni Mori-Colosimo, Caselli pare chiedersi: ma come diavolo è stato possibile? Forse, rispondo io, la totale scomparsa di Giuseppe Graviano dalla scena del crimine dipende dalle domande che Graviano avrebbe trascinato sulla ribalta, domande impertinenti ed insopportabili: dal bar Doney a Spatuzza, dall’arresto a Milano, alle “esternazioni” durante il processo “‘ndrangheta stragista”, fino al misterioso e spettacolare ruolo dello storico fiancheggiatore, il gelataio di Omegna, nella rocambolesca vicenda mediatico-investigativa che ha quasi rovinato la festa (al ROS) per la cattura di Matteo Messina Denaro e la carriera all’incauto Giletti, cui sarebbe stata fatta intravedere la foto maledetta della merenda sul lago di Berlusconi, Graviano, Delfino. Paolo Bellini cioè una delle fonti adoperate dagli uomini di Mori per tenere aperto il dialogo con Cosa Nostra, che a Mori avrebbe recapitato tramite il capitano Tempesta prova documentale delle richieste dei boss di Cosa Nostra, prova che Mori avrebbe distrutto come se niente fosse, forse ritenendo che negoziare è governare, non punire. Quel Paolo Bellini che è stato definitivamente condannato per la strage di Bologna del 2 Agosto del 1980, diventa così il secondo collegamento ineludibile tra eversione neo fascista, P2, apparati infedeli, Cosa Nostra e stragi. Con Bellini per Bologna è stato condannato, serve ricordarlo incidentalmente, anche Luigi Ciavardini, quello dell’abbraccio garrulo ed imperdonabile con la presidente Colosimo. Marcello Dell’Utri… be’, è Marcello Dell’Utri, quello che merita l’imperitura stima da parte di De Donno, in sintonia con lo stesso Mori (che invece disprezza i magistrati di Palermo), manifestata platealmente, col silenzio (assenso?) della presidente Colosimo, il 19 giugno scorso in Parlamento (nella sua articolazione sammacutiana). Nonostante le condanne prima per truffe societarie e fiscali, poi per mafia, nonostante l’informativa Grande Oriente, nonostante l’allarme lanciato dallo stesso, stimatissimo Borsellino,nella sepolta intervista alla tv francese Canal Plus due giorni prima della strage di Capaci, che illumina i rapporti tra Vittorio Mangano, Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi. Guido Lo Porto, dal 1972 parlamentare per nove legislature prima con la casacca del MSI poi AN, quindi presidente dell’ARS negli anni gloriosi di Berlusconi a Palazzo Chigi e di Cuffaro in quello dei Normanni. Compagno di scuola ed amico personale di Paolo Borsellino, come ricorderà egli stesso quando nel Maggio del 1992 prese pubblicamente le distanze dalla iniziativa del MSI che lo volle candidare alla Presidenza della Repubblica. Arrestato con il fascio-mafioso Pierluigi Concutelli già nel 1968, attovagliato con mafiosi di primordine coinvolti nella organizzazione della strage di Capaci secondo le confidenze di Alberto Lo Cicero. Confidenze, quelle di Lo Cicero, delle quali Borsellino era informato ed alle quali aveva attribuito grande rilevanza, tanto da volersene occupare personalmente: ma venne ucciso il giorno stesso in cui Giammanco gli diede la delega su Palermo (telefonandogli sorprendentemente alle 7:30 del mattino della domenica 19 luglio 1992… Come se non avesse proprio potuto attendere l’indomani). Giuseppe Graviano e Paolo Bellini, insomma, sembrerebbero circoscrivere la “base”, Marcello Dell’Utri e Guido Lo Porto “l’altezza” di un solido geometricamente incistato nel cuore della Repubblica italiana. Un solido dalle radici profonde negli apparati illegali posti a difesa dello status quo e che, tutt’altro che passato, continua a produrre i suoi mefitici frutti avvelenati, carichi di disprezzo per la Costituzione. Di questa solida cisti continueremo ad occuparci, ma oggi resti agli atti che quel “Falso! Falso! Falso!” ripetuto in Antimafia da Gian Carlo Caselli mi è parso una specie di acconto sul riscatto atteso fin da quel: “Assolto! Assolto! Assolto!”. FQ. DAVIDE MATIELLO 31.7.2025
L’affondo di Caselli: “Borsellino non morì per mafia&appalti”
Caselli contesta Borsellino: “Nella Procura di Palermo non c’era un nido di vipere”
L’inchiesta mafia e appalti non può essere collegata alla morte di Paolo Borsellino, la Procura di Palermo non ha avuto una cattiva gestione, da parte del generale Mario Mori c’è un risentimento rancoroso. Cosi ha parlato ieri Giancarlo Caselli, ex procuratore di Palermo, chiamato in audizione davanti alla Commissione antimafia che sta indagando sullestragi del 1992-93. In pratica quella di ieri (l’audizione proseguirà dopo l’estate, ndr) è stata una difesa a tutto campo da “critiche pregiudiziali e ingenerose” degli ex colleghi, ad iniziare da Roberto Scarpinato, il primo ad affermare che la strage di via D’Amelio non era legata all’indagine dei carabinieri del Ros. “Il mio affetto per i familiari di Borsellino è sincero e profondo, legato a eventi che hanno cambiato l’Italia e le nostre vite”, ha esordito Caselli, ma “di fronte alle critiche rispetto al mio operato da procuratore non posso che formulare alcune osservazioni”.
Caselli ha quindi iniziato il suo intervento ripercorrendo quanto accaduto in quegli anni, dove la magistratura di Palermo era in prima linea per impedire che il “nostro Stato diventasse assoggettato alla mafia e la nostra democrazia venisse travolta”. A riprova di ciò il magistrato ha elencato il grande numero di mafiosi che dopo le stragi si erano pentiti ed avevano iniziato a collaborare con la giustizia. “Come ci ha insegnato Falcone, il mafioso si pente e collabora con la giustizia quando comincia a fidarsi dello Stato: anche in virtù delle confessioni rese dai pentiti siamo riusciti a catturare un numero importante di mafiosi latitanti”, ha ricordato Caselli. “Agli arresti sono seguiti i processi, basati sempre su prove consistenti: l’ala militare di Cosa nostra è finita alla sbarra, con 650 ergastoli e centinaia di condanne da trent’anni in giù; mai ce ne sono state così tante nella storia di Palermo. Si è inoltre impostata una nuova strategia d’attacco al lato oscuro del sistema mafia, indagando le relazioni esterne con settori della società civile e dello Stato, così da affrontare anche la cosiddetta criminalità dei potenti”, ha aggiunto. “Nessuno pretende – ha precisato – che i pm di Palermo vengano pensati come salvatori della patria, ma di sicuro hanno diritto a un rispetto autentico: mettere in funzione macchine che spargano dubbi non è certo compito di una commissione parlamentare”.
Il clima in procura non era dunque quello velenoso e pericoloso descritto da Borsellino: “Nessuno ha remato contro di me, ma abbiamo tutti lavorato come un blocco coeso raccogliendo il testimone di Falcone, Borsellino, Scaglione, Costa, Chinnici e Terranova cercando di ispirarsi al loro esempio” e “se mai ci fu un nido di vipere se n’è dispersa la traccia”. Per il Caselli pensiero, Falcone e Borsellino furono due eroi moderni della storia non solo giudiziaria e non solo italiana. “Sostenere – ha quindi affermato –che sono stati uccisi esclusivamente perché volevano occuparsi di mafia e appalti equivale a farne dei funzionari onesti, ma ben al di sotto del loro valore storico”. Sul punto il magistrato ha ricordato che “il Maxiprocesso è un capolavoro giudiziario e la dimostrazione pratica che la mafia non è invincibile: se trasformiamo Falcone e Borsellino in esperti di bilanci depotenziamo le loro figure e togliamo un riferimento a quei giovani che non vogliono adagiarsi nell’indifferenza, nel disimpegno e nella rassegnazione, ma vogliono piuttosto operare per ottenere risultati socialmente utili”.
Ma allora perché sono morti Falcone e Borsellino? Alla domanda che nessuno ha fatto, Caselli ha così risposto: “La verità di base per Capaci e via d’Amelio resta una vendetta postuma di Cosa nostra contro i suoi più acerrimi nemici e un tentativo di seppellire nel sangue i loro metodi di lavoro vincenti”. “Il 41-Bis stentava a essere convertito in legge ed era di fatto accantonato, ma dopo la strage di via d’Amelio fu immediatamente recuperato. Se qualcuno avesse anche solo accennato al fatto che Riina poteva non sfruttare l’opportunità di sbarazzarsi del 41-Bis tutti lo avrebbero preso per pazzo”, ha precisato Caselli, fornendo così una ricostruzione diversa da quella fornita dai carabinieri del Ros e dai familiari di Borsellino.
Riina, ha continuato Caselli, “forse per una pulsione suicida anziché aspettare il 7 agosto, giorno in cui sarebbe scaduto il termine per la riconversione in legge, decise che l’attentato a Borsellino si dovesse fare il 19 luglio. La strage potrebbe essere stata compiuta per ribadire, raddoppiando l’efficacia offensiva, le stesse ragioni per le quali era stato ucciso Falcone, ovvero un tentativo di soffocare nel sangue il metodo del pool antimafia”. Paolo Comi L’UNITÁ 1.8.2025
31.7.2025 VERINI (PD) Caselli ha confermato quanto non sia possibile e quanto DEPISTANTE sia ridurre le cause della strage di Via D’Amelio al solo filone mafia e appalti
GIANCARLO CASELLI