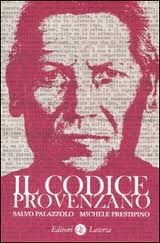
Il codice Provenzano Ed.Laterza
Il mistero dei pizzini «Non sapete quello che state facendo», sussurrò Bernardo Provenzano ai poliziotti che l’ammanettavano dentro il suo covo di Corleone, a Montagna dei Cavalli, dopo 43 anni di latitanza.L’11 aprile 2006. Erano le 11.21 di una mattina che il capo di Cosa Nostra aveva dedicato interamente alla scrittura dei pizzini, l’unico strumento che utilizzava per comunicare con il mondo al di fuori della sua casa bunker in mezzo alle campagne della provincia palermitana. Bernardo Provenzano aveva comandato da sempre così, battendo i tasti delle sue macchine per scrivere.
Dovunque si trovasse. Poi affidava quei messaggi, ripiegati sino all’inverosimile e avvolti dallo scotch trasparente, nelle mani di fidati mafiosi. Mai il capo di Cosa Nostra aveva utilizzato un telefono o un cellulare, mai aveva ceduto alle lusinghe e alle scorciatoie di quella tecnologia che pure fa della sicurezza nelle comunicazioni un baluardo imprescindibile. La centrale di comando su cui si era fondato il trono di Bernardo Provenzano stava per intero su un tavolino. Quella mattina dell’11 aprile apparve in tutta la sua chiarezza ai poliziotti che avevano indagato per otto lunghi anni.[…]La cartella dei pizzini in partenza fu l’ultima cosa che Bernardo Provenzano fissò prima di abbandonare per sempre l’ultimo nascondiglio.
L’espressione sbigottita dei primi momenti aveva già lasciato il posto a quell’enigmatico sorriso che avrebbe fatto presto il giro del mondo, immortalato dai fotografi e dalle telecamere davanti alla squadra mobile di Palermo. Solo per un momento, il padrino fu distratto dal servizio del telegiornale di Rai 2 che annunciava il suo arresto, poi rilanciò lo sguardo verso la macchina per scrivere dove aveva lasciato un segreto a metà. Per la prima volta, si separava dai pizzini, simbolo del suo comando.
Che era terminato alle 11.21 di quel giorno di inizio aprile, ma non era stato ancora svelato.Ecco perché fu l’archivio dei pizzini il mistero che si manifestò subito a chi aveva trovato la strada per Montagna dei Cavalli. Perché al capo di Cosa Nostra i poliziotti del gruppo ribattezzato «Duomo», dal nome del vecchio commissariato nel cuore della Palermo antica dove avevano sistemato il loro quartier generale, erano arrivati seguendo i fedeli messaggeri dei pizzini del capo. Partivano da casa della compagna e dei figli di Bernardo Provenzano, all’ingresso di Corleone, e si immergevano nella città dove il padrino era cresciuto settant’anni fa ed era diventato un killer spietato. Uno, due, tre postini fidati avevano il compito di proteggere i misteri che restavano dopo otto anni di indagini e arresti fra i manager, i picciotti e i favoreggiatori del capo di Cosa Nostra, finalmente costretto all’angolo dall’azione dello Stato.
I misteri che restavano apparvero presto in tutta la loro asfissiante presenza agli uomini che si aggiravano dentro il covo di Montagna dei Cavalli. Senza la decifrazione del codice segreto, le parole dei pizzini, scritte a macchina o a penna, apparivano frasi senza senso e senza tempo. Appesantite dalle continue sgrammaticature di un capomafia che da bambino non aveva terminato la seconda elementare.
Eppure, una ragione doveva esserci in quel codice. Un metodo criminale doveva legare ogni pedina del mistero grande che era l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra dopo le stragi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, così come Bernardo Provenzano l’aveva riformata per farla sopravvivere allo sconquasso dei pentimenti e della reazione dello Stato.
Ai poliziotti fu subito chiaro che dietro ogni numero che scandiva i pizzini c’erano misteriose strade, tanti altri postini ancora, luoghi discreti per ogni scambio, un destinatario o un autore che quasi sempre avevano una doppia vita. Perché nessuno fa il mafioso e basta.
Ma cerca di rimodellare la società in cui vive secondo il proprio personale verbo. Il verbo di Provenzano, il mafioso per eccellenza.Dietro quella sequenza di numeri c’erano i nomi dei favoreggiatori e dei capi, degli insospettabili di tutte le risme e dei nuovi adepti a Cosa Nostra. L’euforia del momento per un arresto tanto importante lasciò presto il posto alla riflessione.
Perché per bloccare davvero Bernardo Provenzano e la sua organizzazione sarebbe stato necessario individuare subito il codice che nascondeva la sequenza dei suoi ordini, degli esecutori e dei gregari, dei consiglieri e degli insospettabili. Gli unici indizi per riuscirci erano altri misteri, quelli rappresentati dai pizzini già scoperti: fra il luglio 1994 e il dicembre 1995, Luigi Ilardo, vicerappresentante della famiglia di Caltanissetta e confidente dei carabinieri, ne aveva consegnati nove al colonnello dei carabinieri Michele Riccio; un pizzino era stato scoperto dalla squadra mobile di Palermo nel covo di Giovanni Brusca, a Cannatello, nell’Agrigentino, al momento del suo arresto, il 20 maggio 1996; un altro era nel casolare di San Giuseppe Jato dove nell’ottobre 1997 si nascondeva Giuseppe Maniscalco, anche lui autorevole interlocutore di Provenzano, che come Brusca è oggi collaboratore di giustizia. Nel marsupio di Antonino Giuffrè, componente della Cupola mafiosa arrestato dai carabinieri il 16 aprile 2002 in un casolare della provincia palermitana, c’erano cinque pizzini di Provenzano fra molti altri scritti da diversi capi e uomini d’onore. Altri 31 biglietti erano stati ritrovati qualche mese dopo grazie alle indicazioni di Giuffrè, ormai collaboratore di giustizia, nascosti dentro un barattolo di vetro custodito in un casolare fra le montagne di Vicari.
Era l’archivio del capomafia Giuffrè, un tempo insegnante di educazione tecnica, che aveva accumulato grande esperienza all’interno dell’organizzazione: lui era il padrino a cui Provenzano aveva affidato la più delicata delle riforme mafiose, quella di mutare il linguaggio di Cosa Nostra e persino il nome. Perché ormai «picciotto», «famiglia», «capodecina», «capomandamento», «commissione provinciale» venivano ritenuti termini antiquati e soprattutto pericolosi, considerato il peso delle intercettazioni ambientali negli arresti degli ultimi anni.
A Giuffrè il padrino aveva anche chiesto di studiare un nuovo cifrario alfanumerico da utilizzare per le comunicazioni riservate. Lui si era applicato, aveva fatto per iscritto la sua proposta, ritrovata anche questa. Ma fu bocciata da Provenzano, perché ritenuta «troppo semplice». Qualche anno dopo, da collaboratore di giustizia, Giuffrè ha contribuito a svelare molti segreti della Cosa Nostra voluta da Provenzano, però il capo dei capi aveva già provveduto a cambiare il codice. Così da rendere impossibile l’individuazione dei nuovi ordini e degli esecutori.
Ma c’era molto di più dietro il mistero. Che non era fatto solo di numeri. Persino Giuffrè, vicinissimo al capo e ai suoi segreti, non ha saputo spiegare il vero significato di alcune espressioni di Bernardo Provenzano. Più che concetti, erano altre enigmatiche presenze. Sintetizzate dal padrino nei «ringraziamenti» a «Nostro Signore Gesù Cristo». Lo ha fatto per ben due volte.Inizialmente, erano sembrati i soliti riferimenti pseudo religiosi di cui sono pieni i pizzini. Ma presto quei brani avevano fatto ipotizzare la vera essenza del mistero Provenzano: le complicità inconfessabili di cui il padrino ha goduto e i nomi di chi gli ha consentito di regnare per 43 anni di delitti, affari e collusioni nei palazzi che decidono.