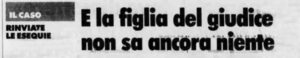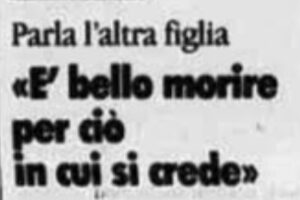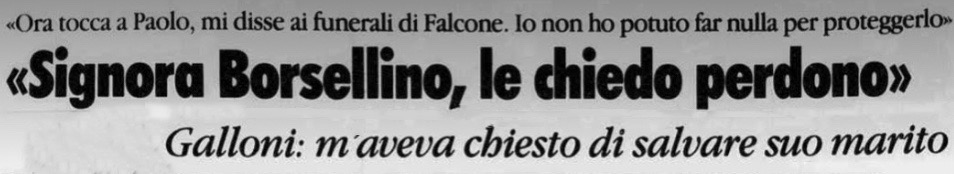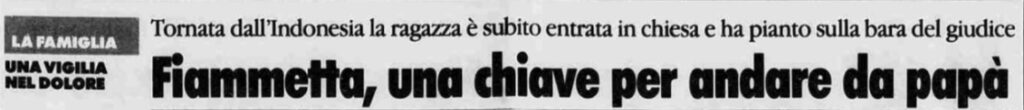Fiammetta, la figlia più giovane del giudice Borsellino, non sa ancora che il padre è stato assassinato.
La ragazza è in vacanza in Indonesia e ogni mezz’ora le radio e le tv lanciano un appello perché chiami l’Italia. Appena giunta in Indonesia, aveva chiamato casa e parlato con il padre. A lui aveva detto che stava partendo per un’escursione in una zona vulcanica dall’isola di Bali. Per trovarla si è mobilitata l’ambasciata e il console onorario.
Finora senza esito. La cosa ha aggiunto una ragione di dolore in più per la famiglia Borsellino. Ha detto la vedova: «Anche da questo si vede l’efficienza dello Stato, non riescono nemmeno a trovare la mia Fiammetta».
Finché non tornerà, non si faranno i funerali del giudice. Lo hanno deciso la madre con gli altri due figli, Manfredi e Lucia.
Una famiglia molto unita, non soltanto nell’orgoglioso rifiuto ai funerali di Stato.
D’altra parte la famiglia del giudice Bosellino aveva accompagnato ed assecondato il magistrato in tutti i momenti della sua vita, patendo le sue stesse ansie e le sue stesse paure.
Il figlio di Borsellino, Manfredi, studente di Giurisprudenza, ha scelto di intraprendere la carriera di magistrato, come il padre e come il nonno.
Angelo Piraino Leto, padre della mamma.
L’altra figlia del giudice assassinato, Lucia, laureanda in farmacia, per lunghi anni ha sofferto di una gravissima forma di anoressia che si era manifestata per la prima volta nell’estate dell’85 quando Borsellino e Giovanni Falcone furono costretti a rifugiarsi insieme alle famiglie nell isola-carcere dell’Asinara per scrivere la sentenza-ordinanza del maxiprocesso, il primo grande atto di accusa contro i capi di Cosa Nostra.
Borsellino aveva confidato di sperare di non dover fare il super-procuratore: «Sono sicuro, Lucia ne morirebbe».
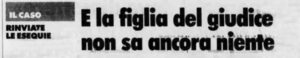
Segue dalla prima pagina FIAMMETTA ancora non lo sa. E’ l’ultima figlia di Paolo Borsellino, la più giovane. In Indonesia ogni mezz’ora radio e televisione ripetono l’appello, in inglese e in italiano, perché telefoni all’ambasciata italiana di Giakarta, o al console onorario di Bali. Ma lei non s’è ancora fatta viva.
Povera Fiammetta, due giorni fa è arrivata in Indonesia con il volo 336 della Garuda, ha subito telefonato a casa, ha parlato con il padre. Era notte, le quattro del mattino di sabato.
Ha detto che il viaggio era andato bene, che l’indomani sarebbe partita per un’escursione in una zona vulcanica dell’isola di Bali.
«Ci sentiamo tra qualche giorno». Non si sentiranno più.
Agnese Borsellino, vedova del giudice assassinato, ieri mattina, anche per questo piangeva: «La cercano da diciotto ore e ancora non l’hanno trovata. Anche da questo si nota l’efficienza dello Stato: non riescono nemmeno a trovare la mia Fiammetta».
Insieme agli altri due figli, Lucia e Manfredi, in un consulto di famiglia, la vedova di Paolo Borsellino aveva deciso che non si sarebbe fatto il funerale finché non tornava Fiammetta.
Molto unita, la famiglia Borsellino, non solo nell’orgoglioso rifiuto ai funerali di Stato.
Moglie e i tre figli hanno accompagnato il giudice, assecondato i suoi passi, gioito e sofferto insieme con lui. Dalle sue paure e dal suo lavoro sono rimasti marchiati. Manfredi sta studiando legge e – fino a ieri • diceva di voler tare il magistrato.
Lucia studia farmacia, ma per lunghi anni ha sofferto di una terribile malattia nervosa. Borsellino lo aveva dichiarato agli amici più intimi in questa ultime settimane, dopo la morte di Falcone, quando si pensava a lui proprio per il ruolo di super-procuratore cui era destinato l’amico ucciso: «Sono combattuto.
Da una parte so che quel posto è l’unico che possa assicurarmi di poter svolgere indagini sull’assassinio di Giovanni e Francesca; dall’altra parte sono sicuro che mia figlia ne morirebbe».
Il dramma di Lucia comincia all’Asinara, in quei terribili cinquanta giorni dell’estate 1985, quando Paolo Borsellino e Giovanni Falcone devono trasferire carte, bagagli, ricordi, memoria, paure e persino le famiglie.
Via da Palermo, via dai veleni, dall’aria inquinata, dai sorrìsi, dagli ammicchi. Via dai sospetti, da occhi e orecchie indiscrete per l’ultimo atto del maxi processo.
E’ all’Asinara, nell’isola-carcere (dove con una battuta che non è mai diventata proposta Giulio Andreotti voleva «confinare» i boss) che Borsellino e Falcone, si auto-recludono per scrivere testo-finale del maxi-processo, il primo grande rinvio a giudizio per i vertici di Cosa Nostra.
E’ all’Asinara che Lucia comincia a stare male. Paolo Borsellino lo aveva raccontato anche in qualche intervista, non solo agli amici. «Proprio in quel perìodo Lucia era diventata donna.
Per lei quelli furono giorni difficilissimi, un’estate senza amici, solo noi della famiglia, Giovanni Falcone, sua moglie, il direttore del carcere e qualche detenuto peraltro libero di circolare all’interno dell’isola».
Quando gli chiedevano cosa gli avesse pesato di più nella vita, Borsellino rispondeva l’altissimo prezzo pagato dalla famiglia più che la paura personale. Lucia è diventata donna in un clima tremendo, lontano dalla sua città dai suoi amici, dalle sue cose, proprio nel perìodo in cui la paura per papà si era materializzata nella paura di tutti: la famiglia era isolata perché tutti erano minacciati.
E Borsellino ricordava che solo Falcone rimase ininterrottamente cinquanta giorni sull’Asinara: «Giovanni non aveva figli, e quando io non c’ero faceva da papà ai miei ragazzi».
A Falcone si affezionò Lucia, ma soprattutto Manfredi, il ragazzo che anche per scelta, non solo per destino di successione, sapeva di dover fare il magistrato. Giudice il nonno, Angelo Piraino Leto, il padre della mamma, per lunghi anni presidente del tribunale di Palermo; giudice il padre; giudice quella specie di zio che era Giovanni Falcone.
Il giorno dopo la strage di Capaci, Manfredi era vicino al padre. Li hanno visti, i due Borsellino, con le mani appoggiate sulla bara. Sono passati appena due mesi e domenica pomerìggio, in via D’Amelio, Manfredi Borsellino è stato uno dei primi ad arrivare.
Lo hanno visto barcollare, con le braccia larghe, come se cercasse qualcuno da abbracciare.
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 21.7.1992

Per due giorni hanno messo a soqquadro l’isola per cercarla ma non è servito a niente.
Fiammetta Borsellino, in vacanza a Bali, ha saputo della morte del padre nel peggiore dei modi. Telefonando casualmente a casa, ignara di tutto, ieri pomeriggio. «Bali è un posto meraviglioso, ci divertiamo moltissimo.
Papà e mamma come stanno?», ha chiesto alla persona che ha risposto per prima al telefono, non si sa se il fratello Manfredi, o la sorella Lucia. Dall’altro capo un silenzio agghiacciante. Poi la voce commossa, rotta dal pianto, ha raccontato alla figlia allibita cos’era successo.
L’attentato al padre e alla scorta, la morte tragica due giorni fa, domenica sera. Le ha detto che da quel momento lo stavano cercando disperatamente su tutta l’isola, con l’aiuto della polizia e dei mass media indonesiani.
Le ha consigliato di mettersi subito in contatto con l’ambasciata italiana a Giacarta, o con il console onorario a Bali.
Non si se se a quel punto la sorella, o il fratello abbiano passato il telefono alla madre.
Se la signora Agnese abbia pianto con la figlia lungo le onde che collegano, in telesoluzione ormai, Palermo con quel villaggio di Ruta Beach, la spiaggia bianchissima aperta sull’oceano all’estrema punta Ovest dell’isola dove i turisti vanno a veder tramontare il sole. A casa c’erano tutti. Tutti aspettavano spasmodicamente quella telefonata che avrebbe ricongiunto, almeno per una attimo, quella famiglia unita. Quel che ne resta.
Il funerale del giudice ucciso si sarebbe fatto solo con lei. Si sa che invece che Fiammetta, la figlia più piccola, diciannovenne, del dramma che si era abbattuto sui suoi cari non sapeva niente.
Tutto immaginava tranne che una cosa del genere. Era tranquilla Proprio domenica mattina, le quattro di mattina, per i sette fusi orari che separano l’Italia dall’Indonesia, aveva chiamato casa per dire che era arrivata bene.
Aveva parlato col padre. Olila aveva detto che sarebbe partita per una gita in una zona vulcanica. Che avrebbe ritelefonato dopo qualche giorno. Era in vacanza, quasi dall’altra parte del mondo, Fiammetta, con amici di famiglia.
Era andata a divertirsi, per la prima volta da sola, cosi lontano, e non aveva letto i giornali stranieri, né visto la tv. Tanto meno aveva ascoltato i notiziari radiofonici locali che hanno trasmesso la notizia dell’attentato di Palermo e poi gli appelli, lanciati in continuazione dall’ambasciata d’Italia.
Forse è stato per colpa di quella gita non la trovavano. «Non riescono nemmeno a trovarla la mia Fiammetta • si era lasciata andare a dire la madre Agnese, accasciata su un divano lunedi sera -. Anche in questo lo Stato è inefficiente La cercano da diciotto ore e non sono capaci di trovarla». E non l’hanno trovata.
Dopo quasi quarantott’ore si è fatta viva lei, per caso. A dire il vero ci avevano provato. Lo stesso presidente della Repubblica Scalfaro aveva sollecitato le autorità.
La Farnesina si era mobilitata. Due funzionari dell’ambasciata italiana a Giacarta erano subito volati a Bau’ e si erano messi in contatto col console onorario sull’isola.
Adesso i funzionari ammettono malvolentieri di essere arrivati tardi. «Fiammetta è stata rintracciata, è in un alberghetto vicino a Bali» ha dichiarato al Grl il viceconsole Rinardo Macchiano, raggiunto per telefono a metà pomeriggio. «Abbiamo invaso l’isola di annunci per radio e tv, messo in azione la polizia e l’abbiamo trovata – ha raccontato -.
Abbiamo parlato con gli amici di famiglia con cui la ragazza viaggiava. Tra mezz’ora andremo a incontrarli». «So che hanno chiamato subito Palermo», ha aggiunto. Ma poi ha spiegato: «Ho parlato con il capofamiglia e no confermato la cosa. Meno male che non viaggiava sola ma con amici di famiglia. Rientrano domani (oggi, ndr) e arriveranno probabilmente dopodomani.
Alla ragazza sono stati dati dei tranquillanti ed è stata mandata a letto».
La vacanza di Fiammetta si interrompe qui. Avrebbe dovuto tornare il 31 luglio. Invece sarà di nuovo a Palermo stanotte, al più tardi domani. Potrà abbracciare per l’ultima volta il padre dilaniato dalla bomba. E il giudice assassinato potrà finalmente trovare riposo. La famiglia aveva detto subito che per le esequie si sarebbe dovuto aspettare l’arrivo della seconda figlia, quella che non si trovava.
Adesso, ha fatto sapere che i funerali si celebreranno nella chiesa di Santa Maria Marillac dove Paolo Borsellino andava ogni domenica.
In forma strettamente privata, ha confermato.
Unica eccezione il Capo dello Stato.
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 22.7.1992
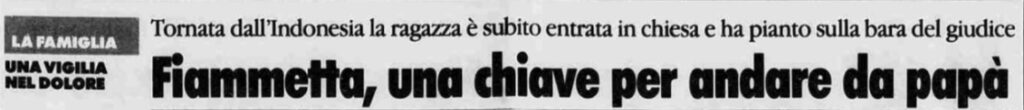
Con lei c’era Caponnetto: «Questa adesso è la mia casa»
Una chiave. Una piccola semplice chiave che passa di mano in mano, apre la stanza della chiesa in cui nella torrida calura della polvere e del cemento sta la bara del magistrato Paolo Borsellino. E’ una stanza piccola, di penombra. E non è una stanza qualsiasi, non è la sagrestia. E’ la stanza in cui il magistrato della Repubblica Paolo Borsellino andava a confessarsi.
Era un uomo religioso, e non per banale tradizionalismo. Era religioso perché era un credente cattolico, ma ci sembra che i ragazzi, figli e loro amici, abbiano sempre goduto di libertà di pensiero.
Paolo Borsellino era un uomo all’antica, ma nel senso che non ammetteva deroghe, disordini insensati, spese pazze. E per lui la giustizia era il compito che Iddio gli aveva dato: lo ha svolto come un soldato, anche se i magistrati dovrebbero fare i magistrati, e non i soldati.
Ma visto che gli era stato chiesto anche, per soprammercato, indebitamente, anzi criminalmente, di vivere anche da soldato oltre che da giudice, lui aveva fatto un breve inchino, da servitore dello Stato, e quando gli hanno chiesto, per cortesia, di morire senza fare troppe storie, di morire senza tanti cavilli sulle auto in sosta, sui modi nuovi che la mafia usa per uccidere, be’: lui è morto, anche se non ha fatte in tempo a vedere per l’ultima volta la mamma e a salutare Fiammetta una volta in più.
Con lui, non dimentichiamolo, sono morti cinque poliziotti – una donna per la prima e speriamo ultima volta che invece erano chiamati proprio a fare un mestiere soldatesco: nel loro contratto di lavoro, diversamente da quello dei magistrati, è inclusa, prevista, sicuramente malpagata e tuttavia accettata e sottoscrìtta la clausola della morto possibile e prevedibile in servizio.
Certo, morire in modo idiota, inutile, mostruoso, beffardo, è molto più che morire: è essere espropriati della dignità.
Ma che dire del fatto che anche i vigili urbani, chiamati per istituto a multare e far rimuovere le macchine in sosta vietata persino quando non sono stare rubate, caricate di trìtolo e sistemate sotto la casa in cui abita la mamma di un uomo da difendere, non hanno fatto, né detto nulla? Nulla di nuovo sul fronte palermitano.
Immondizie a tonnellate sui marciapiedi, la gente nauseata, zone crescenti di scortesia, – tanto noi meridionali siamo fatti così -, disservizi e al tempo stesso una infinita gentilezza umana, una delicatezza di sentimenti che non può non commuoverti, distruggerti.
Palermo è una città che ti afferra alla gola e non sai mai se è per amarti o strozzarti, ma la sua fisicità, insieme alla sua impassibile compostezza, sono devastanti e meravigliose. E in questa città, non dimentichiamolo, vivono protetti dalle loro vaste famiglie, nelle loro nicchie ecologi- che, i capi mafia, gli assassini. E in questa città, ci ha detto un finanziere, nessuno della guardia di finanza osa tentare di aprire un container che arriva nel porto, perché questo compito è geloso privilegio della dogana, dunque ognuno si faccia 1 fatti suoi, non s impicci.
La gente scherza alla maniera mafiosa: «Ti vedo pallido, non stai bene, vedi che occhiaie. Secondo me tu sei malato: perché non ti fai una bella vacanza, eh?». Questa è Palermo, anche. Oltre alla Palermo dei salotti buonissimi, raffinatissimi, estenuati dalla sapienza, dove tutto si sperde, si smemorizza, si disfa, ma poi si ricompone nei forti interessi superiori, supremi.
Anche questa è Palermo. E oggi Palermo, tutte le Palermo buone (ma certamente anche qualche emissario degli assassini andrà a godersi lo spettacolo, e piangerà magari, e farà la comunione, meschino), andrà ai funerali in forma privata di Paolo Borsellino.
La chiesa, Santa Luisa di Marillac, è una bruttissima chiesa moderna delle periferìe degli Anni Sessanta, quando si immaginava «il moderno» come una squilibratura di piani di cemento, e le chiese moderne dei luoghi di tortura diafani e inutilmente spaziosi.
La chiesa è al di là di un piazzale di polvere che sta davanti all’ingresso della palazzina: otto piani per quattro condominii, balconate con sbarre bianche, caseggiati anonimi, torridi d’estate, gelidi d’inverno.
La chiave. La piccola chiave è Sella che apre la stanza in cui tre giorni è depositata la bara. Il consigliere Antonino Caponnetto mi ha chiesto se desideravo vedere questo luogo d’angoscia. E’ un luogo di terribile spartana freddezza, sia pure nella temperatura desertica. Lì, con quella chiave in mano, poco dopo l’alba si è presentata Fiammetta, la figlia che è tornata dall’Oriente, la figlia amata alla quale papà Borsellino diceva: «Ricordati, Fiammetta: sempre il numero di telefono, mi devi lasciare. Così, se mi ammazzano, almeno ti telefono per dirti che sono morto».
Era questo lo scherzo. Atroce e profetico, anzi consapevole. Ieri sono tornato sotto quella casa, mentre un ghibli libico sollevava polveri e fumi, e caligini. Oltre quelle polveri la chiesa delle esequie. Là, con la sua chiave, la mano ferma, l’occhio serrato per un attimo, è stata per un attimo immobile Fiammetta. Poi ha aperto.
Quel che è accaduto poi non è materia di racconto. Nessuno può narrare, o interpretare o riferire il suo orrore, la sua paralisi, il suo pianto liberatorio, irrefrenabile, e poi trattenuto, e poi ancora stremato, infinito. Ci tornava alla mente, in questo deserto di Saragoza che è la periferìa palermitana, la triste cantilena di Ombretta sdegnosa del Mississippi. Lì era Ombretta che moriva annegata.
Qui è Fiammetta che soffoca nelle sue lacrime, trafitta dagli ingiusti ma inevitabili sensi di colpa per essere stata lontana mentre papà moriva, di aver seguitato a godere la vacanza quando già tutta l’Italia era travolta e sconvolta, di aver saputo per ultima, e di trovarsi adesso davanti a papà: muto, chiuso in quella scatola orrìbile, offeso nel suo corpo, che dall’interno di quella sua condizione di morto certamente le parlava, le parlava attraverso il dialogo deliamente, quando la voce di chi ci è morto seguita a nascere nuova e spontanea: «Fiammetta, amore mio, figlia mia diletta: tu lo sai che io ti volevo chiamare, quando mi hanno fatto saltare in aria con tutta la scorta, sotto la casa della nonna, sai, avrei voluto.
Ma tu non mi avevi lasciato il numero, e così ho dovuto fare tutto da solo. Ma tu sapevi come Lucia e Manfredi che papà inseguiva la verità, inseguito dalla morte. E adesso hanno vinto loro». Fiammetta ha riattraversato la strada composta, silenziosa, la mano per un attimo sulla fronte, con quella terribile, sconcertante compostezza di questa gente, ha varcato la linea degli agenti e dei carabinieri, ha salito i quattro ?redini, ha superato il libro delle iirne, ed è salita al quarto piano, con quell’ascensore piccino, su cui già si va stretti in tre.
Cari ragazzi Borsellino, credo che neanche voi, come il vostro papà, sarete mai dimenticati. Non sarete dimenticati per quel che siete oggi, con la vostra mamma che e così fiera, nel suo matriarcalismo patriarcale, del fatto che il vostro papà vi abbia «graffiati nella sua roccia»: è l’espressione più sconvolgente e bella che abbia mai udito da un genitore per dire che quel figlio è suo figlio, anzi, figlio del suo sposo.
La grandezza di questo dramma e, al di là delie immagini, e non sappiamo dire se oggi anche questo rito sarà dato in pasto alle belve, ma speriamo di no.
Bartolo, il ragazzo di Lucia, una delle due figlie del magistrato assassinato, mi accoglie con la consueta gentilezza e quando gli chiedo come si svolgeranno le esequie: «La famiglia avrà dei posti suoi, poi ci saranno dei posti per le autorità, e infine dietro entrerà la gente che vuol venire».
Verrà il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, l’uomo al quale non sono state risparmiate umiliazioni che sono le umiliazioni dello Stato stesso.
E verrà Claudio Martelli, il ministro di Grazia e Giustizia che in questi mesi si è blindato, ha abbassato sempre più il tono della voce alzando la fermezza, ha stretto le file sulle questioni di principio, ha mostrato le unghie, ha dato segnali che qui a Palermo sono stati colti, anche se con Sesta primordiale diffidenza fe è riservata a tutto dò Che viene da fuori, da Roma, e dal governo, dai partiti e dal Parlaménto. E anche Parisi, il capo della polizia.
Tre nomi – ha rivelato ieri Manfredi – che papà Borsellino aveva compreso ne Ila lista delle persone che avrebbe voluto ai suoi funerali.
Quell’elenco comprendeva «solo uomini di cui si fidava». «Vogliamo che siano presenti tutti coloro che si vogliono stringere intomo a noi e partecipare al nostro dolore», mi ha detto Agnese Borsellino. «Verrà chi vuole, purché non speculi sulla morte di nostro padre», mi ha detto Lucia.
«Non voglio sciacalli, non voglio profittatori del nostro dolore», mi ha detto Manfredi – ormai l’uomo di casa – e il giudice Antonino Caponnetto sussurra: «Io sono vicino a loro come se fosse la mia famiglia, perché è la mia famiglia. Io vorrei che tutte le persone buone che hanno creduto nell’operato di Paolo fossero vicine a noi». Borsellino, questo è un fatto ormai accertato, stava sulle piste di materiali concretissimi, realissimi, nuovi e sconvolgenti.
Non è stato ammazzato a scopo dimostrativo, anche perché la mafia non ha mai ammazzato nessuno a scopo dimostrativo, fino a prova del contrario e per quante libere applicazioni si possano fare all’uso del fantasticomafioso, un genere letterario vicino a quello omerico. E con uomini come Paolo Borsellino che, proprio per amor omerico potrebbe stare forse nella parte di Ettore, ucciso e trascinato sotto le mura davanti agli occhi della sua gente e della sua famiglia, davanti alle mura d’Ilio dell’Italia assediata dal prepotere mafioso. Sì, forse Paolo Borsellino – cari Fiammetta, Manfredi e Lucia – era un Ettore che aveva intuito il punto in cui Achille, l’onnipotente macchina da guerra della mafia, aveva il suo tallone vulnerabile, ma non gli hanno dato il tempo di scoccare il suo dardo. E’ morto lì, forse senza avere il tempo di coagulare un’idea, senza aver per fortuna il tempo di capire.
La mafia, mostruosa nell’effetto scenico, e un boia più misericordioso di quello di San Quintino o di Alcatraz. La sua devastazione è feroce e spettacolare, ma immediata. Questi ragazzi hanno forse il conforto nel fatto che il loro papà è morto all’istante, con quelle altre povere cinque creature che gli erano accanto. Non sarà un grande conforto. Per lui forse fu più dura vedersi morire fra le braccia Giovanni Falcone in ospedale: «Lo tenevo io, mentre moriva». E Falcone, paradossalmente (ce lo racconto Claudio Martelli durante le elezioni presidenziali) non sarebbe morto se avesse avuto la cintura di sicurezza e se non fosse stato alla guida: la sua macchina andò a sfracellarsi dentro la voragine provocata sotto la prima auto che era già passata. Fu un errore dei killer, che si perfezionarono.
Per Borsellino non ci sono stati sbagli. Un pulsante sul citofono, una esplosione nucleare. Ora siamo all’epilogo, siamo alle esequie.
Domani racconteremo quel che sarà accaduto in via Cilea, e saranno nuove scene di dignità e strazio, sgommate di alfette e polvere, spintoni e pianti, ci saranno forse slogan e urla, ma speriamo di no. Dio mio, ragazzi figli di Paolo, impedite che anche un centesimo di quanto accadde nell’orrore della cattedrale possa ripetersi al funerale del vostro papà.
Ricordatelo, specialmente durante il momento supremo dell’addio, mentre si rammarica di non avere neppure il telefono per potervi dire come sta, specialmente Fiammetta, che ha tutti i motivi di pensare al suo papà trovato nella stanzetta chiusa con la piccola chiave.
Giovanni, Paolo, Peppino, Antonino Caponnetto loro nuovo genitore, erano e restano anche dei campioni quel sorriso siciliano triste e obliquo, una strizzata d’occhi, la faccia di chi dice: non ci credo, ma se ti fa piacere lo penso.
Tanto, ragazzi, questo vostro padre e tutti ì giudici eroi di Palermo, non li dimenticherà mai più nessuno. Insieme, non li faremo mai dimenticare.
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 24.7.1992
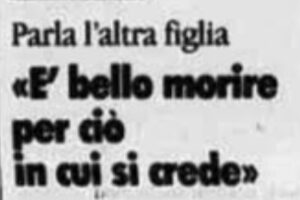
«E’ bello morire per ciò in cui si crede» Parla l’altra figlia «Questa frase me l’ha insegnata mio padre e voglio farla mia, ricordandolo: E’ bello morire per ciò in cui su crede”».
Lucia Borsellino, l’altra figlia del giudice ucciso, ha raccontato ai microfoni del Tg5 il suo dramma, i suoi giorni di dolore. «Mio padre – ha detto ad Enrico Mentana – non ha mai perso la fiducia.
E’ morto per questo, perché credeva troppo in quello che stava facendo».
«Quella domenica – ha aggiunto – voleva che andassi al mare. Ma io gli ho risposto che dovevo studiare, nei prossimi giorni avrei dovuto sostenere un esame. Cosi gli ho risposto di no. Lui quasi si è offeso, c’è rimasto male.
Nel pomeriggio una mia amica mi ha ospitato. E poco dopo le diciotto ho saputo, piano piano, la verità». Lucia Borsellino ha concluso: «Mio padre era un uomo buono, generoso.
Era di una bontà infinita. Io ho cominciato a stare male, ad entrare in crisi ai tempi del maxiprocesso a Cosa Nostra.
Allora mi sentivo privata di una vita normale e tranquilla».
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 21.7.1992
Anche questa parte del lugubre copione è stata replicata con una puntualità quasi ossessiva. La camera mortuaria è stata allestita alle 18 nel grande atrio del palazzo di Giustizia che molti dai tempi del contrasto Falcone-Meli e delle lettere del «Corvo» chiamano «Palazzo dei veleni». Fiori, lacrime, invettive, cori con slogan pieni di rabbia e applausi, tanti applausi mentre le bare provenienti dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università dove sono state eseguite le autopsie, inutile in questo caso ma indispensabile formalità voluta dalla legge, sono state portate su furgoni mortuari all’ingresso dell’edificio marmoreo. Per prima è stata portata a spalle la cassa con i resti martonati di Paolo Borsellino.
Se ne sono incaricati alcuni magistrati che nell’ Ufficio istruzione del tribunale avevano lavorato per molto tempo al fianco di Borsellino e Giovanni Falcone e, primo fra loro, Antonino Caponnetto ora in pensione che in mattinata aveva mormorato, provato dall’emozione, «è finito tutto» e che fu il capo dell’Ufficio subito dopo Rocco Chinnici, assassinato con un’altra autobomba nel 1983. «Caponnetto resisti, siamo con te», gli grida la folla, mentre il magistrato è in preda alla commozione. Accanto a Caponnetto, altri due giudici dell’indimenticabile esperienza del «pool» antimafia di Palermo, Giovanni Ilarda e Gioacchino Natoli.
I volti tirati, labbra serrate, occhi umidi di pianto. E gli agenti di polizia addetti alle scorte, gli stessi che dopo la strage di Capaci il 23 maggio si definirono «I morti», hanno sorretto le bare con i corpi dei cinque loro colleghi, nuove vittime dell’incessante sfida dei boss.
Anche fra i poliziotti grande commozione e pianti di rabbia mentre la folla applaudiva le casse in mogano lucido con i resti mutilati e carbonizzati. Pochi minuti prima che giungesse il furgone mortuario con la salma di Borsellino, l’edificio è stato raggiunto dalla moglie Agnese con i figli Manfredi di 20 anni e Lucia di 22.
La signora, figlia dell’ex primo presiderà del tribunale, era andata moltissime volte nel palazzo di Giustizia dove in qualche modo era di casa. Stavolta però non è riuscita a camminare con il suo consueto passo spedito e per salire la scalinata e guadagnare la porta metallica con i vetri blindati del- l’ingresso ha dovuto essar sorretta da agenti che quasi l’hanno sollevata per renderle più agevole il penoso tragitto.
E dentro la signora Borsellino e i congiunti dei cinque poliziotti, appena riconosciuti dalla folla oltre le transenne, sono stati applauditi lungamente mentre sui catafalchi venivano lanciati fiori.
Un gruppo di giovani aderenti alla «Rete» ha esibito striscioni e cartelli, proseguendo una protesta durata sin da domenica sera, do- Ela strage, accanto alla magnosotto casa di Giovanni e Francesca Falcone, in via Notarbartolo, che tutti ormai chiamano «albero Falcone» e che è diventato uno dei sempre più numerosi e questi sì invincibili simboli della lotta alla mafia.
Alle sei bare rendono omaggio picchetti di magistrati e poliziotti, mentre la gente di Palermo sfila silenziosamente nel corridoio formato dalle transenne su una stuoia in velluto rosso. [a. r.) Antonino Caponnetto, magistrato In pensione, è stato acclamato dalla folla.
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 21.7.1992

Con i Borsellino nella casa del dolore QUANDO sono uscito dalla vostra casa, caro Manfredi Borsellino, ho visto quelle guardie e quei carabinieri sotto il sole a picco, il registro delle firme nell’androne e tutto il magone che avevo dentro al cuore si è tumefatto. Lei ha 19 anni e la sua mamma Agnese, quando è uscito un attimo dal piccolo salotto in cui ci siamo incontrati, mi ha detto: «Manfredi è la fotocopia del padre.
Identico. Identico fisicamente, identico mentalmente, lo stesso carattere, la stessa forza interna». E allora, quando poi lei è rientrato, l’ho guardata con maggiore e, se mi consente, più affettuosa curiosità.
Diciannove anni sono un’età terribile per sopportare il peso di una tale morte di un tale padre. E quella sorta di vostro secondo padre che è il grande le pc I conc magistrato e padre del pool antimafia, padre di Falcone, di Ayala, del suo stesso papà, Antonino Caponnetto, quei trepido signore che è tornato in trincea dallo stato di pensionato, mi spiegava rannicchiato su quella sedia di velluto beige: «Manfredi è dovuto diventare un uomo in una settimana. E che uomo.
Lo guardi. Guardi la forza con cui ha preso il comando della sua vita». Ed è stato allora, poco do- S, che fra me e lei, giovane e te uomo di diciannove anni, fotocopia vivente di un uomo che aveva lo sfrontato e suicida orgoglio di ringhiare al mondo la sua condizione aristocratica di «servitore dello Stato», si è svolta la parte più penosa e amara della nostra conversazione.
SEGUE DALLA PRIMA Lei mi ha parlato dello sciacallaggio dei giornalisti, delle centinaia di giornalisti che si sono improvvisamente spacciati per amici di suo padre, di quelli che sono riusciti ad infiltrarsi in casa Tino a violare il sancta sanctorum della tenda oltre la quale suo padre furiosamente lavorava. Ricorda come descriveva i giornalisti, vii razza dannata? «Hanno l’attrezzatura tipica, lei li riconosce subito: taccuino e telefonino, fanno finta di volerti bene, si infiltrano, ti fanno parlare e scrivono ogni parola, ogni lacrima di mia madre. Da allora li abbiamo sbattuti fuori, da allora non vogliamo più saperne di questi ladri di parole con il telefonino e il taccuino».
Che dire? Io sono e resto un giornalista, e ho sempre carta e penna. Ma quello che voi Borsellino mi avete detto, acco- f;liendomi come un amico, ‘andavo registrando su quella banda magnetica che corre fra mente e cuore.
E mi chiedevo se avessi o no il diritto di render conto ai lettori di quel che voi siete e rappresentate, famiglia del giudice ucciso, e di chi era – raccontato dal vostro amore – Paolo Borsellino, l’uomo contro il quale gente senza ; onore, ma con molta dinamite, ha scatenato quell’inferno, assassinando Paolo e devastando la dignità di tutti noi cittadini e sconvolgendo l’anima di quelle centinaia di palermitani con cui ho passato la notte fumando e camminando, litigando e urlando, e durante i mostruosi funerali di martedì, quando la mafia avrà gioito vedendo lo Stato seppellito nelle bare, schiaffeggiato negli uomini e nei simboli, teleripreso come un premio di Formula Uno, con quella chiesa piena di uniformi militari, persino quelle bianche della marina, e vuota del popolo di Palermo. E allora ho deciso di scrivere questo articolo, dedicato alla gente del Nord, oltre che a voi e ai palermitani, perché molto c’è da spiegare e capire e pian- Sere e riflettere e agire, prima i sparare sentenze.
La vostra casa, innanzitutto.
E’ la casa di periferia di un professionista borghese che vive nel decoro non povero e neppure sfarzoso. Posso dirlo? Con le tante piccole cose di pessimo gusto di Gozzano, che però sono, apparivano e appaiono come i segni della virtù: le coppe sportive, i mobili in stile, la casa lustra e viva, mentre invece la morte si respira nell’afa della strada, su quella spianata di terra davanti alle vostre finestre, dove stanno ad arroventarsi le Alfette dei carabinieri. E poi voi. Il giudice Antonino Caponnetto, prima di tutto.
O forse dovrei dire prima di tutto la moglie di Paolo Borsellino, Agnese.
Chi non ha radici in Sicilia, chi non ha un sentimento, un risentimento, un filo di memoria legato alla Sicilia, non può valutare la fermezza composta e minuta di una grande compagna di vita di un grande uomo di legge. Agnese, questa signora così discreta, così piccina e così alta nella dirittura, ha la mano ferma. A Palermo ci si stringono le mani.
Non si dà la mano. Si trattiene. E intanto ci si guarda negli occhi, e si valuta, si soppesa l’umanità che si ha di fronte. La prima cosa che mamma Borsellino mi racconta è terribile e buffa al tempo stesso, e spero di non violare l’intimità della famiglia se la racconto con le parole che ho registrato nel nastro della mente: «Paolo è un uomo fortissimo, lei non immagina la sua forza, il suo carattere».
Si usa il presente vivente, perché la casa di Paolo Borsellino è piena di lui. «E così, scherzando con Fiammetta tutte le volte che lei partiva, con quel suo tono secco e carico d’affetto, le diceva ridendo: Fiammetta, appena arrivi non ti scordare di chiamare e darmi subito il tuo numero di telefono: sennò, quando mi ammazzano come faccio a telefonarti per avvertirti?».
Fiammetta arriva dalla sua lontana vacanza in Oriente mentre questo giornale va in edicola. Arriva in compagnia di un amico del suo papà, che anche lui è come un secondo papà. Fiammetta, anche lei, è forte. Forte come Paolo Borsellino, il giudice che, dice la moglie, «più siciliano di così non poteva essere, siciliano fino ai capelli, siciliano nel profondo del cuore».
Infatti era talmente siciliano che l’italiano gli era una lingua vagamente ostile e in compenso capiva ogni sfumatura dei mille dialetti, con cui afferrava negli interrogatori tutto quello che c’era da capire. Manfredi è un bel ragazzo, asciutto, bruno, sportivo, interista, maglietta blu, fermo e sorridente.
La sua fermezza, la sua virilità sono la continua¬ zione paterna: «Il padre, questi figli li ha fatti graffiati nella sua stessa roccia. Manfredi prima di tutto. E poi Lucia, passione della sua vita. E Fiammetta, passione a parte: tre figli, tre passioni distinte e grandiose». E il figlio: «Noi siamo una vera, autentica famiglia siciliana. Alla sera ci mettiamo a tavola per mangiare, sì, ma per parlare prima di tutto. Le cene siciliane sono lunghe. Sono fatte di parole, di silenzi, di comunicazioni.
Mio padre comunicava». Qui si toccherebbe un punto delicatissimo: se e quanto Paolo Borsellino sapesse di essere un condannato a morte. E’ il punto più delicato.
La moglie mi dice: «Aveva perso la voglia di vivere, aveva perso il suo buonumore, aveva carte, carte, carte. Lavorava sempre, indagava, lavorava. Era preso da una frenesia senza tregua».
Capisco, anche se nessuno me lo dice, che Paolo Borsellino inseguito dalla morte, consapevole di essere già nel braccio delle esecuzioni, già temendo di non poter forse rivedere più Fiammetta che partiva per una lunga vacanza («Ricorda di lasciarmi il tuo numero, sennò come ti telefono se mi ammazzano?»), trasmetteva al figlio semplicemente le sue sensazioni. Ricorda, Manfredi: «Papà non ci dava mai notizie sul suo lavoro, ferreo e preciso come sempre. Ma sussurrava i nomi delle persone di cui ci si può fidare, la gente che considerava sicura. Non moltissima». E capisco che Paolo Borsellino non si fidava quasi di nessuno, e la sera a tavola negli ultimi tempi diceva discretamente quali fossero le poche persone meritevoli di fiducia. E le altre? La mia è una visita di condoglianze.
Non ho il cuore di chiedere della pista tedesca, quella del pentito che sta in Germania e che Borsellino andava a interrogare. Ma Manfredi me ne parla indirettamente confidandomi che troppa gente sapeva e scriveva quello che non doveva sapere e scrivere: «Chi le ha date queste notizie ai giornali? Come sono uscite? Chi è stato?», chiedeva a tavola, durante le lunghe cene dell’addio il servitore dello Stato Paolo Borsellino, l’ultimo del pool antimafia, l’ultimo generoso moschettiere della Repubblica, lui che era di sentimenti conservatori, un po’ missino e un po’ monarchico, ma in quella maniera tipicamente siciliana, che consiste nel sentirsi funzionari di un potere lontanissimo, regale, assoluto, che sta a Madrid, a Napoli, a Torino, a Roma, ma che comunque è lo Stato, di cui con orgoglio sprezzante si dichiarano servitori, pronti prima di tutto a morire, e quanto al resto si vedrà.
Ed ecco, l’uomo più trepido e caro di questa Palermo triste e terribile. Ecco Antonino Caponnetto, il siciliano che parla fiorentino perché dalla Sicilia emigrò a Firenze che aveva dieci anni, e a Firenze è voluto tornare nell’83 quando ammazzarono Rocco Chinnici: «E C’è molta forza nella sofferenza e il magistrato per tutti è ancora vivo La moglie Agnese «Sapeva che era arrivato alla fine e voleva lavorare senza tregua» Paolo Borsellino e Giovanni Falcone (nella foto a fianco) sono sempre stati uniti nel lavoro e nella vita
La mafia li ha uccisi sterminando anche gli uomini delle scorte.
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 23.7.1992

I fasci di fiorì deposti da ignoti palermitani sulla soglia del portone sono visibili da molto lontano. E’ una landa desolata la via Cilea, all’ora di pranzo. I palazzi della nuova zona residenziale sembrano piegarsi sotto il sole impietoso della prima vera estate ’92. La casa del giudice Paolo Borsellino è all’ottavo piano dell’edificio contrassegnato col n. 21.
Uno sbarramento di poliziotti in divisa impedisce accesso ai fotoreporter. E’ stato un pellegrinaggio, per tutta la mattinata di ieri ed anche la sera di domenica. Decine di giovani, commossi, arrivano, sostano, posano un fiore o semplicemente pregano.
Salgono soltanto gli amici di famiglia. Più che i curiosi, si ha l’impressione che la famiglia Borsellino non gradisca ingerenze di carattere, diciamo, «politico». No, non vogliono proprio che si speculi su questa ennesima tragedia.
Lo Stato, nei funerali del procuratore aggiunto Paolo Borsellino, sarà assente.
La famiglia, almeno per ora, sembra irremovibile e resiste ad ogni pressione: nessuna auto blu, nessuna scorta, nessuna autorità. Non si riempirà, stavolta, la basilica di San Domenico.
Non ci sarà la diretta Tv. E il governo non sarà costretto, come avvenne per i funerali di Giovanni Falcone, ad imboccare la porta secondaria della sacrestia per sfuggire alla contestazione della piazza.
Il dolore dei Borsellino sarà solo loro. E dei loro amici. Di quelli che saranno invitati: perché il lutto autentico non venga mischiato alle frasi di circostanza, alla ipocrisia delle falso cordoglio. Eppure non è stata una decisione presa a cuor leggero.
Non si tratta di reazione rabbiosa: è lucida consapevolezza. In casa Borsellino ne hanno discusso, stamattina.
Il giovane Manfredi ha trascorso in piedi il pomeriggio, la serata e la nottata di domenica. Prima ha voluto vedere: è andato nell’inferno di via D’Amelio, lo hanno visto aggirarsi tra le macerie come il figlio che cerca le spoglie del padre in un campo di battaglia.
L’hanno visto barcollare.
Anche Lucia barcolla, adesso. La ragazza, ancora convalescente dopo un periodo lunghissimo e terribile in cui ha rifiutato il cibo per il terrore di perdere il padre, adesso sta immobile.
Entrambi hanno parlato con mamma Agnese. Madre-disperazione appare devastata: è irriconoscibile questa donna che per tanti anni è stata la compagna discreta e insostituibile di un uomo che il suo vero matrimonio l’aveva contratto con l’aspirazione ad amministrare giustizia. Non hanno dovuto dibattere troppo, per convenire che «non c’era alcuna necessità di funerali di Stato». Il resto della famiglia ha convenuto, anche il vecchio Angelo Piraino Leto, ax presidente del Tribunale di Palermo e padre della signora Agnese. Alla consultazione è mancata Fiammetta, l’altra figlia. E’ in viaggio, in Indonesia. I funerali si faranno solo quando la ragazza rientrerà a Palermo.
Mamma Agnese comunali che saranno «strettamente privati» e si celebreranno nella chiesa di Santa Maria Marinai;, dove Paolo Borsellino andava ogni domenica. Il parroco è già stato messo al corrente, tramite don Cesare Battoballi, il giovane prete cugino di Antonio Schifani uno dei poliziotti della scorta di Falcone, morto nella strage di Capaci.
II sacerdote è stato in via Cilea, ieri mattina. L’accompagnava Rosaria Costa, la vedova di Schifani, la ragazza che ha commosso l’Italia intervenendo in diretta Tv ai funerali del marito per dire: «Mafiosi, inginocchiatevi».
E’ stato l’incontro di due donne affrante, quella di Rosaria e mamma Agnese. Un abbraccio stretto e commovente. Ci sarà -olo una deroga alla decisione dei Borsellino: riguarda il Capo delio Stato. Ieri mattina Scalfaro ha telefonato alla famiglia: un colloquio privato. Il Presidente ha assicurato il suo intervento per accelerare le ricerche di Fiammetta.
Non si sa altro del contenuto della telefonata, si sa, però, che Scalfaro è stato invitato ai funerali. Sarà la sola eccezione. Anche Martelli ha telefonato alla signora Borsellino.
Il ministro si è intrattenuto a lungo con la vedova. Il colloquio è rimasto riservato ma non sembra aver provocato ripensamenti nella determinazione di «fare a meno dei rappresentanti del governo». C’è anche Antonio Caponnetto, nel salotto, insieme coi parenti. E’ stato in piedi tutta la notte. Abbraccia la signora Agnese.
Lei piange, guarda una foto di Paolo e sussurra: «Gioia mia… gioia… me lo hanno preso. E’ tutto finito». E’ un susseguirsi di emozioni. Arriva la madre di Francesca Morvillo, la moglie di Giovanni Falcone morta nella strage di Capaci, stringe ìe mani della signora Agnese e singhiozza: «Paolo è andato a trovare Giovanni e Francesca».
Poi una frecciata rivolta allo Stato: «Non meritavano uomini così». Ma è ancora di Caponnetto il commento più amaro: «Non vado a palazzo di giustizia.
Non voglio incontrare alcune persone, non voglio vedere certe facce.
Troppi farisei a Palermo, troppi amici dell’ultima ora».
La tensione sale, il silenzio sostituisce le parole. Arriva un vecchio amico di Paolo Borsellino, il maresciallo Canale. Lucia va con lui. Vuole presenziare alla ricognizione nell’ufficio del padre.
Vuole gli oggetti personali. E’ coraggiosa Lucia. Manfredi sta seduta su una poltroncina accanto ad una porta chiusa.
Sembra abbia montato la guardia, al di là di quella porta c’è lo studio del padre. Francesco La Licata «Fiammetta è a Bali E questo governo non è neppure capace di trovarla» In alto: il corpo del giudice Borsellino
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 21.7.1992
I funerali di Paolo Borsellino, si svolgeranno nella chiesa di Santa Maria Luisa di Marillac.
Lo ha reso noto la famiglia, la cerimonia si svolgerà in forma strettamente privata.
Tra gli intimi che parteciperanno alla cerimonia funebre del magistrato, il maresciallo dei carabinieri Carmelo Canale, stretto collaboratore del giudice. «Lo seppelliremo in silenzio – ha detto il maresciallo Canale – con i pochi ìntimi, con quelli che gli vplevano bene. Lo seppelliremo in silenzio perché così lui avrebbe voluto, perchè il dottor Borsellino non gradiva la confusione e le proteste in chiesa. Lui era un cristiano praticante». Fiammetta, la figlia minore, provieni? dall’Indonesia dove si trovava in vacanza, sarà accompagnata a Palermo nella giornata di oggf con un aereo messo a disposizione dal presidente del Consiglio.
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 23.7.1992
Il giudice Sarà sepolto domani
Salvo imprevisti dell’ultima ora si svolgeranno domani i funerali, in forma privata, del giudice Paolo Borsellino, che erano stati rimandati in attesa di rintracciare la figlia Fiammetta in vacanza a Bali.
Anche in quell’occasione ci dovrebbe esser la presenza del presidente Scalfaro, l’unico personaggio dello Stato che i familiari hanno invitato per le esequie.
Intanto la salma di Borsellino è stata trasferita dalla camera ardente allestita a palazzo di giustizia nella parrocchia di Santa Maria Luisa di Marillac. Nella chiesa è vegliata esclusivamente dai familiari.
In questo tempio – ha ricordato il parroco Alessandro Manzone – il procuratore aggiunto si recava ogni domenica per assistere alla messa.
«Era un uomo – dice il sacerdote – che riusciva ad abbinare fede e professione, testimoniando il suo essere cristiano e i valori in cui credeva anche nel lavoro».
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 22.7.1992
In chiesa il presidente recita una preghiera e chiede aiuto alle persone giuste e pulite Da Scalfaro, l’ultimo applauso a Borsellino Una enorme folla ha ascoltato l’omelia in strada, sotto il sole Alla cerimonia anche Galloni, un parente: lui non era invitato .
Se i funerali di martedì nella cattedrale si ricorderanno come un incubo, quelli di Paolo Borsellino, ieri, lasceranno tutt’altra memoria: una folla straripante, ma contenuta; il presidente della Repubblica che non sa dove sedersi, e che poi si sistema fra la propria figlia e la signora Agnese, vedova del giudice ucciso. E poi, dietro, come una crostimi arruffata e angelicata, in discretissimo incognito, Francesco Cossiga, Cossiga il Tremendo, se ricordate, commosso, silenzioso. La televisione ha ripreso dall’esterno e avrete visto tutti quella grande piazza terrosa che separa i caseggiati di via Cilea dalla chiesa. Noi eravamo dentro, e siamo stati abbastanza vicini alla famiglia, ai ragazzi commossi, ai compagni d università. E sulla bara era distesa la toga rossa del magistrato. Caponnetto, come si legge nel testo del suo discorso, ha ricordato il biglietto del cittadino che ha lasciato un lilium per Borsellino, con su scritto: «Un solo grande fiore per un grande uomo solo».
Ripetere che Borsellino non era solo, che viveva in tutti, sarebbe retorico, ormai. Paolo Borsellino è morto. Lo abbiamo in foto e nella mente, ci sono i suoi figli e i suoi allievi. Esistono videocassette e testi di discorsi, scritti e conferenze. Ma è morto. E quella era la sua bara. Per ora la mafia ha vinto. C’era il prefetto Parisi, capo della polizia, che stava seduto sulla stessa panca del ministro Martelli e del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Galloni. A proposito di Galloni un parente dei Borsellino mi dice esplicitamente che la sua presenza è stata subita dalla famiglia, che non lo aveva invitato ma che non ha neppure potuto dire di no. C’era. Ce n’erano tanti. Troppi. Borsellino, quando seppe che stava per morire, dettò ai suoi un elenco delle persone che avrebbe desiderato vedere in prima fila al proprio funerale.
Quelle e non altre. La famiglia però non è riuscita, né ha potuto né saputo resistere a tutte le pressioni. E cosi sono entrati nelle prime file uomini che Borsellino, dall’interno della sua prigione corporale, non avrebbe voluto sentirsi accanto. Quanto a Galloni non esisteva alcun divieto, ma nessun motivo di simpatia, né riconoscenza. La cerimonia.
E’ stata molto cristiana, molto moderna, talmente moderna da sembrare, ai nostri occhi viziati da un’infanzia di controriforma barocca e latina, quasi una bella messa protestante: con una figura femminile vestita da diacona, con un coro di voci che cantavano canzoni sacre moderne, tutto molto suggestivo. Un signore gentilissimo mi avvicina e si presenta come il consuocero del povero giudice. Non sapevo che Borsellino avesse figli sposati, e in effetti non ne aveva. Ma il signor Francesco Gabrielli è il papà di Federica, fidanzata di Manfredi. E mi racconta un episodio, un frammento di vita, che da solo illustra una società e una cultura: «Mia figlia mi ha raccontato, proprio pochi giorni fa, di avere scoperto che Paolo Borsellino aveva aperto una grappetta, cioè un fascicolo, a suo nome.
Dentro c’era tutto quello che la riguardava, compresi i nomi degli amici, i numeri di telefono… Esattamente come faceva con i suoi tre figli. Aprendo una cartella con il suo nome, di fatto l’aveva dichiarata sua quarta figlia».
Questo minimo dettaglio, al di là della psicologia, assume un valore ulteriore se si considera quel che ci ha detto ieri il consigliere Caponnetto a proposito dell’inseparabile agenda di Borsellino, volatilizzata il giorno della sua morte, anche se la borsa che la conteneva è rimasta intatta. La sorella di Federica, Francesca, mi racconta un altro episodio del rapporto padre-figli. Prima di morire Borsellino aveva deciso di regalare al figlio Manfredi gli sci d’acqua. Ma aveva anche deciso di tenere nascosto il fatto che fosse lui a comprarli: voleva che fosse Federica, la futura nuora, a darglieli come un dono suo. E così ieri l’altro Federica è entrata in un negozio d’articoli sportivi ed ha comperato quegli sci d’acqua che facevano parte delle promesse di Paolo Borsellino, e ha consegnato a Manfredi soltanto il buono d’acquisto. Il giorno che se la sentirà, andrà a ritirarli. Mi rendo conto che tutti que- sti ragazzi, questi giovani che ho intomo, tutti sui vent’anni, già formano coppie stabili e definitive, sono legati dall’infanzia, sono legati dagli studi, dal vicinato, dall’amicizia dei padri. Sono amorì «in casa», benedetti dalla parentela, e tuttavia di libera scelta. E si vede in filigrana il tessuto della società siciliana e palermitana, la fratellanza e la sorellanza, il senso dell’onore e della famiglia, Federica che è fidanzata di Manfredi, ma che studia insieme con Lucia Borsellino, sorella di Manfredi, gli ultimi esami di laurea in farmacia: «Laboratorio 3» fra pochi giorni. Mancano ormai soltanto Tecnica di laboratorio e Farmacologia. E intanto Manfredi, ovviamente, studia Legge seguendo le orme paterne: è al secondo anno, in regola con gli esami, anche se il primo lo amareggiò perchè prese soltanto 21. La messa prosegue. Si alternano al podio, o forse si dovrebbe dire ancora pulpito, le persone care e comunque quelle invitate a «dire parole» sull’ucciso. E’ un dramma nel dramma perché, l’abbiamo visto altre volte, l’emozione moltiplicata dall’elettronica, elevata alla potenza del dolore, produce creature spettacolari e terribili, o anche qualche episodio di insopportabile trombonismo. Ma come dimenticare la sorella dei]’ucciso, Rita, leggere il suo testo che contiene le inevitabili parole del sangue, del perdono, dei veleni, con la voce infranta, il tremore trattenuto in un vestitino scuro a righine e da un volto terreo? I parlanti si alternano alle voci cantanti e al microfono sale una ragazza bruna molto bella e severa che intona un inno di alleluia che somiglia ai canti celtici irlandesi di «Enya», inse¬ guita da un coro che invoca «non abbandonerai l’anima mia». Dalla lettera di San Paolo agli apostoli, legge un giovanotto in grigio, vibrante di emozione, un nipote. E subito viene ricordato che sull’Arca di Noè soltanto 8 si salvarono, otto giusti e non di più. Si guarda intorno. Non sono giusto 8 i sostituti procuratori che si sono dimessi, come se volessero a modo loro ridar vita al pool antimafia? Dal Vangelo secondo Matteo: vedendole falde deìmonte Gesù salì la montagna circondato dai suoi discepoli e disse: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia perché avranno giustizia. Quando, si chiedono nel brusio della preghiera? Da chi? Ecco la Schifarli in prima fila, la vedova in nero che lesse straziata e corretta (dal sacerdote) un testo di rifiuto del perdono. Le siamo accanto, è fragile, è tremante, è ferita a morte. L’officiante prende il microfono: «Guai – dice – a chi accumula ciò che non è suo». Applausi, applausi dentro e fuori la chiesa, dove è radunata la folla, e dai palazzi dai balconi gremiti. Parole gravi che frustano un’aria pesante, non più mitigata dai condizionatori: «Borsellino si era accorto di essere odiato da chi ha ostacolato in ogni modo la sua azione, di essere stato perseguitato. Abbiamo il dovere sacrosanto di continuare questa lotta. Oscar Luigi Scalfaro parla per pochi minuti, e il suo tono è sommesso e forte allo stesso tempo. E’ lui il capo del Consiglio superiore della magistratura, è da lui che i giudici di Palermo si aspettano decisione e tutela. Il presidente della Repubblica usa parole sobrie e appropriate, anche se esordisce in nome della madre di tutti noi, come se fosse obbligatorio e scontato che o si è cattolici apostolici romani o non si è. Il Presidente assicura fermezza, assicura il éiiò interesse”atffWo, ricorda con molta passione le qualità del servo dello Stato che lo Stato, distrattamente imprevidente, sempre un passo indietro rispetto alle necessità di oggi, ha lasciato o ha consentito che si uccidesse. Usa parole emotivamente e moralmente efficaci in nome e per conto delle persone giuste, oneste, pulite, che vogliono la pace, le persone per le quali vale la pena pregare affinché le persone responsabili «mai siano motivo di vergogna e odio». Ma il presidente della Repubblica si impegna: e dalla sua dichiarazione di impegno prende poi slancio la forte allocuzione di Antonino Caponnetto, il padre del pool antimafia, il pensionato tornato in servizio, in militanza attiva, stremato da un collasso che lo ha fatto vacillare, seguito da una moglie trepida e con un grande bicchier d’acqua a portata di mano perché ha bisogno di reidratarsi, bere e volontà. Del discorso straordinario e teso di Antonino Caponnetto diamo conto per intero in prima pagina. Ma quel discorso è stato applaudito per ottantadue secondi, e se provate a vedere quanto sono lunghi guardando 1 orologio, potete, possiamo capire il senso di quell’applauso. Il telegramma del cardinale Pappalardo che gelidamente si scusa di non esserci, riceve quattro battute di mani. Forsemeno ancora. La funzione va avanti nella sua impeccabile regìa, il prefetto Parisi si alza dalla sua panca e comincia ad arretrare, in piedi, avviandosi verso l’uscita. Anche qui, in questa chiesa, dovrà subire un’amarezza: un cognato dell’ucciso lo affronta con parole aspre e aggressive, e il prefetto è costretto a subire. Il vecchio Angelo Piraino Leto, magistrato anche lui, è il suocero di Borsellino, padre di Agnese. Ed è un uomo all’antica che ricorre a tutto il bagaglio della retorica tradizionale. E’ l’unico che, dicendo «siamo in presenza del presidente Scalfaro e del suo predecessore», dà atto della presenza di Francesco Cossiga. Quanto al resto, l’anziano uomo di legge reclama il ritorno all’ordine, rimpiange, così dice, i tempi in cui «delitto e castigo erano un binomio indissolubile». La triste cerimonia è alla fine. Corre voce che qualcuno sia stato colto da malore e portato via, ma il fatto non ha interferito con il rito. La bara viene alzata a spalla e vediamo Bartolo, il ragazzo di Lucia, Manfredi naturalmente, tutti i parenti 0 gli uomini della famiglia sollevare il feretro mentre si leva un primo lungo applauso, e poi l’applauso prosegue, dilaga quando la bara esce all’esterno, e’ sale la confusione, scoppiano minimi alterchi da nervosismo e da «lei non sa chi sono io», ci sono i soliti ordini cretini che ingiungono di sbarrare un’uscita lasciando che la gente si insulti e soffochi, finché il presidente della Regione, con lodevole buonsenso, interviene intimando alle forze dell’ordine, e in nome dei suoi poteri, di riaprire il passaggio. Partono le auto delle scorte, rombano, si accendono le lampade, applausi per il presidente della Repubblica, per il ministro Martelli, anche per il povero Parisi, ovazioni per Caponnetto, applausi per Giuseppe Ayala e la chiesa si svuota, lentamente ma con qualche convulsione. Il furgone parte per «I Rotoli» cimitero antico di Palermo, dove il padre di Paolo volle improvvisamente comperare una tomba con una piccola cappella, presentendo la morte. E’ un cimitero marino, come quello amato da Paul Valéry, e lì riposerà l’ultimo giusto giustiziato dalla mafia. Paolo Suzzanti Il suocero del magistrato «Rimpiango i tempi nei quali delitto e castigo erano un binomio indissolubile» A sinistra, portata a spalle, cori sopra la toga rossa eia giudice, la bara del giudice Paolo Borsellino esce dalla chiesa di Santa Luisa di Marillac Il presidente della Repubblica Scalfirò e il capo della polizia Parisi applaudono la salma del giudice all’uscita dalla chiesa Circondato dagli uomini della scorta, ai funerali c’era anche l’ex sindaco Leoluca Orlando.
UN FIORE PER UN UOMO SOLO
Questa è la «preghiera laica» che Antonino Caponnetto, ex capo del pool antimafia delta procura di Palermo, ha recitato leti mattina, tra la commozione generale, ai funerali di Paolo Borsellino. SONO le parole di un vecchio ex magistrato che e venuto nello spazio di due mesi due volte a Palermo col cuore in pezzi perché ho perso Giovanni, Francesca e Paolo che per me erano figli, fratelli e amici con i quali ho condiviso il lavoro, la gioia e le amarezze di questi anni. Soltanto poche parole per una preghiera laica e fervente. Per il fratello Paolo, per la sua umanità, per il coraggio con cui ha affrontato la vita e con cui è andato incontro ad una morte annunciata, con il suo amore immenso dedicato alla famiglia e agli amici tutti. Ognuno di noi è debitore verso di lui perché conserviamo qualcosa di lui in fondo al cuore. A me mancheranno le sue telefonate che si chiudevano con l’immancabile frase «ti voglio bene Antonio» alla quale io rispondevo «anch’io te ne voglio Paolo». Un ricordo ancora per il suo appassionato e incessante lavoro divenuto frenetico negli ultimi tempi quasi che egli sentisse avvicinarsi la fine. Ad ognuno di noi aveva donato qualcosa di prezioso che tutti conserveremo in fondo al cuore. Ho rimorso per quell’attimo di sconforto e di debolezza in cui sono stato colto dopo avere posato l’ultimo bacio sul viso ormai gelido di Paolo. Avevo detto «è finita». Ma nessuno di noi può dire che ormai tutto è finito. Nessuno di noi, io meno degli altri, ha il diritto di dirlo. Pensavo in quel momento di desistere dalla lotta contro la delinquenza mafiosa, sembrava che Antonino Caponnetto con la morte dell’amico fraterno tutto fosse finito, ma in un momento simile, in un momento come questo coltivare un pensiero del genere, me ne sono subito convinto, equivale a tradire la memoria di Paolo, come pure quella di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Ho sentito la volontà della popolazione di liberarsi da questa barbara e sanguinosa oppressione che ne vanifica la speranza che nasce. E da qui nasce la mia preghiera, la rivolgo a te presidente Scalfari che da tanto tempo ormai mi onori della tua amicizia •he sa di essere ricambiata i un’ammirazione infinita, j’ente di Palermo e delira Sicilia ti ama Presi. ti rispetta, ha fiducia tua saggezza e nella iczza. ‘ morto servendo lo Stai uale credeva, cosi con di lui Giovanni e Francesca, ma ora questo stesso Stato che è stato servito fino al sacrificio deve veramente dimostrare di essere presente in tutte le sue articolazioni sia con la sua forza sia coi suoi servizi. E’ giunto il tempo, mi sembra, delle grandi decisioni e delle scelte di fondo che le vicende impongono: dovranno essere uomini credibili e onesti, dai politici ai magistrati con le tue illuminate direttive a gestire questa fase necessaria di rinascita morale. Solo attraverso questa rigenerazione collettiva, il sacrificio di Paolo non sarà vanificalo. Non è più tempo della gente che vive delle collusioni, degli attendismi, dei compromessi, delle furberie. Io ho apprezzato le tue parole, noi tutti le abbiamo apprezzate, le tue parole dirette al Consiglio Superiore dove hai parlato di una nuova rinascita, è quella che tutti aspettiamo. E con la fermezza che ti conosco hai giustamente condannato, censurato quegli errori che hanno condotto martedì pomeriggio a disordini che altrimen¬ ti non sarebbero accaduti. Non resteranno inutili i sacrifici di Giovanni, di Francesca, di Paolo e di otto agenti di scorta. Agli agenti che hanno seguito i loro protetti fino alla morte va il nostro pensiero, la nostra riconoscenza, il nostro tributo di ammirazione. Fra i tanti fiori che ho visto in questi giorni lasciati da persone anonime ho visto un bellissimo lilium, uno splendido fiore di ìilium e sotto c’erano queste poche parole senza firma: Un solo grande fiore per uri grande uomo solo. Io vorrei dire a questo grande diletto amico che non è solo, perché accanto a lui batte il cuore di tutta Palermo, batte il cuore dei familiari, attorno a lui batte il cuore dell’Italia. Caro Paolo, la lotta che hai sostenuto fino al sacrificio dovrà diventare e diventerà la lotta di ciascuno di noi, questa è una promessa che ti faccio solenne, come un fratello. Questa è la promessa che io ti faccio, solenne come un giuramento. Antonino Caponnetto
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 25.7.1992
Il giudice ucciso fu processato
Quattro anni fa, proprio di questi giorni, nell’aula del Csm intitolata a Vittorio Bachelet, cominciava quello che fu anche un processo a Paolo Borsellino, «colpevole» di aver denunciato sui giornali che a Palermo era stato smantellato il pool antimafia, che non si facevano più indagini su Cosa Nostra, che non si sapeva più quanto stava ..scadendo nelle cosche. Ieri, dopo che la mafia ha fatto a pezzi anche Paolo Borsellino con 30 o 50 chili di esplosivo, quel giudice è stato commemorato in quella stessa aula, per i suoi meriti di magistrato che, insieme a Chinnici e Falcone, aveva inventato il pool antimafia. «Fu una scuola destinata a rimanere come una pietra miliare nella storia della magistratura italiana e della secolare lotta per la giustizia contro il fenomeno mafioso», ha detto con grande solennità il vice-presidente del Csm Giovanni Galloni. I componenti dell’organo di autogoverno dei giudici oggi sono diversi da quelli di quattro anni fa, ma era stato proprio Borsellino, dopo la morte del suo amico Giovanni Falcone, a ricordare il procedimento che dovette subire davanti al «tribunale dei giudici». Per evitare che l’allora procuratore di Marsala finisse per fare le spese della sua denuncia, Falcone scrisse una lettera in cui faceva proprie le accuse di Bosellino, e si dimise lui stesso da membro del pool antimafia. igio. bla.]
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 23.7.1992
Il Csm, tempio di battaglie e veleni
Negli uffici di Roma dovrebbe essere decisa la strategia antimafia, ma si pensa alle carriere. L’aria condizionata soffia a temperature polari nelle stanze vuo| te di Palazzo dei Marescialli quando sono le 9 di sera e anche il penultimo consigliere se ne va con la maglietta del week-end e il telefonino in mano. Resta il prò fessor Lombardi, abito scuro e sguardo risorgimentale, con una bellissima stampa della Divina Commedia alle spalle e una bottiglia di minerale sul tavolo. Fuori di qui Roma ribolle di caldo e di indifferenza. In piazza di Spagna c’è il defilé di moda e già la capitale impazzisce di traffico e di tassì introvabili. Eccoci al Consiglio superiore della magistratura, nei corridoi del vero palazzo dei veleni, il palazzo delle lacrime di coccodrillo, il ring della giustizia italiana, il tribunale di autoassoluzione e autopromozione di tutti i magi strati. E’ qui che si decidono le carriere, gli incarichi, i trasferimenti, i destini, la vita dei giudici.
Qui sono caduti sotto i colpi dei veti incrociati, degli scambi di favore, degli equilibri politici, delle invidie personali e professionali Giovanni Falcone e Giuseppe Ayala.
Qui, giusto quattro anni fa, si apriva un procedimento contro Paolo Borsellino, colpevole di aver detto quello che lutti sapevano: che grazie alle scelle del Csm le indagini sulla mafia erano morte e sepolte. In queste stanze, attraverso questi corridoi adesso deserti le tragedie palermitane di questi f»iomi sono state tutte puntualmente annunciate Anche l’ultima di via D’Amelio: un consigliere ci ha rivelato che proprio di fronte alla bara di Giovanni Falcone, la moglie di Paolo borsellino ha afferrato il braccio di Giovanni Galloni, vicepresidente del Csm. e grosso modo gli ha detto. «Portatelo via da Palermo perché qui me lo ammazzano*.
Ma non c’è bisogno di confidenze sussurrate in questi tempi in cui i cadaveri sono caldi e nessuno parla e chi lo fa chiede l’anonimato: il copione di questa follia è scritto, punto per punto, negli atti del Csm Basta prendere i verbali della seduta del 19 gennaio 1988: era previsto, annunciato e denunciato che scegliendo l’anziano Meli e bocciando il giovane Falcone per il ruolo di capo dell’ufficio Istruzione il pool antimafia sarebbe stalo sciolto.
Lo aveva detto, per esempio, Giancarlo Caselli; ma anche Pietro Calogero (il pubblico mini stero padovano del «7 aprile» padovano), con un intervento molto breve e molto chiaro: la scelta di Meli «va contro il buon senso». Meli, invece, vinse per un solo voto di di l’I cn-il/,!: «Buona ani ministrazione – disse per esem pio un consigliere di Magistrato ra democratica, che con due voti su tre si pronunciò contro Falcone – è anzitutto quella che osserva le regole, che non si chiude in un’ottica di puro risultato».
Bisognava rispettare l’anzianità di Meli, non proporsi di battere la mafia. Abbiamo chiesto a consiglieri passati e presenti del Csm se questo significhi fiancheggiamentj della mafia, se aver deliberatamente escluso l’uomo più adatto per il posto più difficile sia slato una consapevole opera di appoggio a Cosa nostra. Ma tutti hanno risposto di no. Non c’è malafede, c’è la burocrazia al potere, c’è l’inerzia delle «regole», c’è il dominio della difesa del corpo: c’è un governo della magistratura – ci ha spiegalo un consigliere della commissione nomine – tendente innanzitutto a garantire tutti, anche i pigri, eliminando le «punte» come Falcone.
Il Csm è un ingranaggio governalo da due Ionizzazioni sovrapposte, non da una sola come le usi o la Rai: i membri togati sono espressi dalle quattro «correnti» della magistratura, i membri laici sono spartiti tra i diversi partiti politici. I togati sono sospettosi nei confronti dei laici, spesso visti come portatori di interessi politici. Un conflitto continuo, un litigio dietro l’altro: ogni decisione richiede infinite mediazioni che si risolvono quasi sempre nella scelta meno impegnativa. Falcone è isolato e bocciato nell’88; nel ’90. quando si presenta candidalo al Csm, raccoglie appena 50 voti e non viene eletto; nel ’92 quando si propone per dirigere la superprocura antimafia, e cioè l’estensione della pratica del pool a tutto il Paese, incontra un fuoco di sbarramento totale a Palazzo dei Marescialli.
Eppure erano passati quattro anni dalla sua bocciatura che provocò polemiche e ripensamenti infiniti: e i coccodrilli, anche qui, avevano già versato le loro lacrime. Per capire meglio questa logica bisogna leggere cosa dice il consigliere Umberto Marconi nella re- lazione in cui sostiene la candidatura Meli e boccia quella di Falcone: è ai giudici umili, ai non protagonisti che «noi dobbiamo rispello… garantendo legalità ed equilibrio nelle procedure… anche in quelle di nomina per posti direttivi… perchè si possa dire che senza sussulti… noi assicuriamo a ciascuno il suo».
A Palermo la mafia bombardava Palazzo di giustizia e il consigliere Cariti cosi motivava la sua scelta: «Mentre mi accingo a votare per Meli… non posso non constatare che in astratto il dottor Falcone, per la professionalità e l’eccezionale impegno, potrebbe essere l’uomo giusto al posto giusto, ma in concreto…». E’ cambiato qualcosa dall’88 a oggi? No. Qualche mese fa è stato nominato il Procuratore della Repubblica di Roma, In corsa c’erano due pubblici ministeri di esperienza e di prestigio come \ Coiro e Volpali-il più titolato sarebbe stato probabilmente Coirò, ma essendo di Md, di sinistra, era improponibile per una poltrona tradizionalmente assegnata a un moderato.
Volpari avrebbe spaccato il Csm in senso opposto. Si è scelto un terzo candidato, il dottor Mele, cottimo magistrato di Cassa/ione», ma che ha fatto il pubblico ministero per soli quattro anni, all’inizio della carriera Ouilche mesi fa si è deciso di non prendere nessun provvedi¬ mento contro Pasquale Barreca, il presidente di sezione della corte d’appello di Palermo che con decisione legittima, ma assai discutibile, aveva consentito il ricovero in ospedale (da dove è poi evaso Pietro Vemengo, il «killer dei cento delitti») di parecchi boss reclusi.
Ci ha detto un altro consigliere del Csm: «Una decisione che mi ripugna: se avessi seguito l’impulso avrei votato perché fosse caccialo dalla magistratura. Ma noi non possiamo sindacare sulle sentenze. Su Barreca si doveva solo decidere se era incompatibile con l’ambiente: non lo era e allora ho votato anch’io per lui». E cosi qualche giorno fa Barreca ha .annullato una sentenza di condanna del super-boss Nitto Sanlapaola. Eccoci dunque davanti al professor Giorgio Lombardi, uno dei membri laici del Csm, cioè un non magistrato. Lombardi insegna diritto costituzionale all’università di Torino. Professore, come può succedere tutto questo? Lombardi non vuole fare dichiarazioni, ma si fa capire benissimo scandendo queste parole: «La verità è che al Csm è affidata la garanzia dei percorsi professionali del magistrato, non il controllo dell’operato della magistratura.
La Costituzione dice che i giudici sono sottoposti unicamente alla legge.
Tra la volontà astratta del legislatore e la traduzione concreta negli atti c’è solo l’intelligenza del giudice, gli unici spazi di controllo sono quelli dei diversi gradi di giudizio». Insomma, il Csm è un gigantesco ufficio del personale, che deve occuparsi anche dei permessi per l’allattamento delle giovani uditrici madri, ma non di come si fa giustizia.
Al Csm i 7 mila e 500 giudici chiedono la garanzia che la loro carriera, dai 26 ai 70 anni, si svolga naturalmente, secondo la giusta progressione di grado. Come diceva Marcone perché ciascuno ottenga «il suo». Ed essendo composto da membri eletti, che non possono essere rieletti, ma devono garantire alla corrente il mantenimento del seggio, si favoriscono tutti e non si punisce nessuno.
Il paradosso però è che il Csm scegliendo i capi degli uffici (come nel caso Meli-Falcone) determina la politica giudiziaria di cui è responsabile il governo. Per questo il ministro Martelli ha chiesto alla Corte Costituzionale di risolvere il conflitto sostenendo che la valutazione delle capacità organizzative e direttive di capo spettano a lui e non soltanto – per via burocratica – al Csm. E alla Corte ha vinto il primo round. Andiamo dal professor Massimo Brutti, ora senatore del pds, fino al ’90 membro laico targato pei. Fu uno dei sostenitori di Falcone, e conferma che il Csm è un organismo collegiale, complesso, all’interno del quale si svolge una lotta politica dura.
Nella bocciatura di Falcone, dice Brutti, «prevalsero miopia e corporativismi. Non voglio dire altro». E poi aggiunge: «Mi dà l’angoscia pensare che in quei giorni sarebbe bastato convincere due persone in più per nominare Falcone. Sarebbe cambiato tutto». Questa angoscia ora pesa come un macigno sulla coscienza collettiva del Csm. Eppure, solo qualche settimana fa, dopo la strage di Capaci, sono volati insulti feroci tra i socialisti (favorevoli a Falcone per la superprocura) e i pds, contrari.
Ora i pds rinfacciano ai socialisti di bocciare la candidatura di Agostino Cordova, procuratore di Palmi, perché ha messo sotto accusa i nessi calabresi tra alcune cosche mafiose e alcuni socialisti. Volano gli stracci, il superprocuratore non c’è e la mafia fa le stragi. Siccome i membri del Csm non vogliono parlare chiediamo al professor Giuseppe Di Federico, bolognese, docente di organizzazione giuridica, studioso del Consiglio, di farci una sintesi dei problemi: «Il Csm è nato per proteggere l’indipendenza della magistratura e garantire i cittadini sulla professionalità dei magistrati. E invece ha garantito tutti i giudici, non ne ha mai vagliato le capacità professionali, ò venuto meno ai compiti che gli erano stati assegnati dalla Costituzione». Un esempio? I curricula di ciascun giudice vengono compilati dagli altri giudici dello stesso distretto.
Ne ahhiamn visti alcuni, nessun magistrato vi appare mai meno che «integerrimo», tottimo». Dice Di Federico: «Quando si dice che tutti “sono bravi” diventa difficile scegliere, il criterio dominante diventa l’anzianità, lo scambio di favori tra le correnti domina tutto, ognuno viene accontentato nei suoi desideri». Ciascuno, come auspicava Marcone, ottiene «il suo». Martedì il Csm riapre il caso Palermo: chi sarà la sua prossima vittima? ma* inietti I consiglieri in difesa «Dobbiamo rispettare le regole dei partiti e della burocrazia»
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 26.7.1992
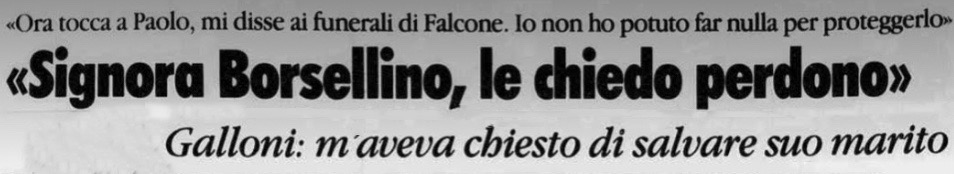
Non direste mai che Giovanni Galloni è siciliano di Paterno. Non ne ha l’accento, no il tratto. Ma quando pronuncia la parola vergogna ha come un guizzo di sicilianità. «Sulla bara di Falcone – racconta con quella sua voce chioccia che suona commossa sempre Agnese Borsellino mi abbracciò e mi sussurrò: “Protegga mio marito, perché il prossimo sarà lui”.
Quando l’ho ritrovata china sulla bara di Paolo non ho provato soltanto pietà e disagio, mi sono vergognato perché non ho potuto far nulla per esaudire l’invocazione di quella donna».
Alla vigilia di un’altra estate di veleni, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, per molti ormai luogo simbolo dei cavilli corporativi che hanno favorito la vittoria della mafia, si presenta all’appuntamento nel torrido e deserto pomeriggio festivo alla guida di una «Uno». E la scorta? «Cerco sempre di evitarla perché sono convinto che sia il modo migliore per salvare la vita mia e degli agenti. Io a sedici anni ero già nella Resistenza, ho imparato presto a rischiare la vita.
Quando nel 1979 le Brigate rosse avevano deciso di ammazzarmi, fecero un attentato sotto casa mia e un agente della scorta fu colpito in faccia. Salvò la vita per miracolo. Non vorrei mai che questo si ripetesse». Onorevole Galloni, lei si è vergognato davanti ad Agnese Borsellino anche perché l’organismo che presiede non ha mai dimostrato di amare molto suo marito né Giovanni Falcone? Questa e una visione falsa delle cose. Per Borsellino e Falcone il Consiglio ha fatto i salti mortali.
Ma si deve capire che noi, per legge, dobbiamo gestire le carriere dei magistrati in base ai titoli formali. Non possiamo nominare capo di stato maggiore un sergente, anche se si è distinto sul campo di battaglia. Se questi criteri non vanno più bene, i politici li modifichino per legge, ma non pretendano di imporci la nomina di magistrati che noi non possiamo nominare. Lei è un politico da quarant’anni, onorevole Galloni, deve capire che le stiamo chiedendo com’è potuto accadere che il Csm sia stato di fatto complice di scelte che hanno provocato la sconfìtta dello Stato contro Cosa nostra. Personalmente sono convinto che a suo tempo la nomina di Antonino Meli a capo della Procura di Palermo sia stata un errore, ma nessuno può negare che egli avesse più titoli formali di Falcone. E qui è la chiave di quella che è stala chiamata la stagione dei veleni: c’è un conflitto profondo nella magistratura tra chi pensa che siano più efficaci i metodi tradizionali e chi invece ritiene che l’unico metodo per combattere la mafia sia quello del pool di magistrati inventato da Rocco Chinnici. Ma la gente ha l’impressione che i cavilli e il corporativismo selvaggio del Csm servano alla fine a proteggere magistrati mafiosi. Non ho prove; di connivenze tra giudici e mafia. Se qualcuno ne ha ce lo dica e noi applicheremo le sanzioni 11 ministro Martelli eserciti il suo diritto, chieda sanzioni, corno ha latto per Bar reca e per Di Pisa Quanto ai corporativismo, so poi corporativismo s’intende la difesa dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura dalla politica, allora evviva il corporativismo. Difendere Barreca o Carnevale significa proteggere l’autonomia dei giudici? «Non sono d’accordo su quel che dici, ma darei la vita perché tu possa continuale a dirlo»: con questo motto rispondo su Barreca e Carnevale, di cui non condì vido le decisioni troppo formalistiche, ma dei quali devo difendere i diritti. Martelli dove capi re che in nessun Paese; demoera tico al mondo si può colpire un giudice por il merito delle sue sentenze. A Los Angeles nessuno ha toccato neanche i giudici che hanno mandato assolti i poliziotti filmati mentre picchiava no a sangue un negro Perciò ci terremo Carnevale l’ammazzasentenze? oro che per evitare che si ripe •io che e accaduto ci siano modi diversi dalla sanzione disciplinare o dall’incompatibilità ambientale. E intanto la mafia vince. Vincerebbe di più se non si capisse che sopra ai giudici c’è soltanto la legge. Per la superprocura antimafia il governo non chiede soltanto che a guidarla sia un magistrato esperto e capace? Lo vogliamo tutti, ma noi abbiamo eccepito la potestà del ministro di indicare il candidato. Però, in qualche modo, la Corte Costituzionale ha dato ragione a Martelli. Siamo in attesa della sentenza, ma non mi risulta che la Corte abbia buttato all’aria niente. Raccomanda di raggiungere il «concerto» con il ministro e aggiunge che se non c’è accordo ha ragione il Csm. Certo, con il ministro Vassalli problemi di questa natura non esistevano. Come mai? Vassalli veniva a discutere con la commissione del Consiglio e, la volta successiva, per un dovuto riguardo, la commissione andava da lui Martelli, invece, ha comunicato che in commissione non sarebbe venuto lui, ma il suo capo di gabinetto o un altro collaboratore. Il Consiglio si è ribellato anche per questa lesione alla sua dignità. Ma spero che tutto si possa appianare. Ho apprezzato mollo che, a differenza di altri, Martelli ha rifiutato di fare nomi por la superprocura. Chi e che ne ha fatti? 11 ministro Scotti, commettendo una gaffe terribile. Mi auguro proprio che finalmente cessi questa furia dell’esecutivo nel tentare d’imporre nomi per i vertici della magistratura. Scotti era per Borsellino. Io non credo nella superprocura, penso sia difficile un coordinamento nazionale antimafia Borsellino la pensava come me, ma io ero convinto e glielo dissi che la sua candidatura sarebbe stata meglio di quella di Falcone, proprio perché lui ora mono legato all’esecutivo e la sua nomina non sarobbo stata interpretata come un’intrusione del governo. Ma non volle faro la domanda e prefori andare prò- j curatore aggiunto a Palermo Con a capo Giammanco, contestato adesso da otto magistrati della procura. Borsellino ora un missino tiepi- I do, ma un cattolico molto fervi- ‘ do e un grande uomo di media zionc. Senza di lui Giammanco avrà difficolta. Da domani il 1 Consiglio esaminerà il problo ma. Da quel che ci sta raccon- tando, onorevole Galloni, sembra che tutti gli altri Eoteri dello Stato siano moilitati per conculcare l’autonomia della magistratura. Anche il suo scontro con Cossiga derivava da questo? Cossiga aveva alcuni motivi di doglianza verso il vecchio Consiglio: un trasferimento di Ayala per incompatibilità ambientale e l’applicazione assai severa delle norme nei confronti dei giudici risultali iscritti alla P2. E nei confronti del nuovo Consiglio da lei presieduto? C’è stato il problema dei giudici iscritti alla massoneria. Io riconosco il diritto d’opinione e credo che la massoneria sia un’associazione libera, ma la sua se- frelezza va a detrimento deiautonomia e dell’indipendenza del giudice massone. Le sembra il problema più grave rispetto a un corporativismo che tende a salvare anche i giudici incapa¬ ci? Questo è un luogo comune. Noi non siamo più corporativi dei prefetti o degli avvocati e non è vero che lasciamo gli errori senza sanzione per difendere una casta chiusa. Sui giudici incapaci siamo molto rigidi: nella passata gestione su 100 processi c’erano state 27 condanne, ora le condanne sono salite a 62. Certo, non tutti i magistrati hanno capacità eccezionali e per le carriere di quelli meno capaci avviene un po’ come per i professori universitari, ciascuno difende il suo allievo. Non le sembra un paradosso rivendicare così fortemente l’autonomia dal governo, quando poi il Consiglio superiore della magistratura è una delle sedi più irriducibili della partitocrazia? E’ vero, l’elezione dei membri del Csm avviene su liste di corrente. Ma chi potrebbe mai dire che, ad esempio, tutti gli aderenti a Magistratura democratica fanno parte dello stesso partito politico? Le nomine del Parlamento avvengono con criterio lottizzatorio, ma sicuramente il Consiglio non risponde a direttive dei partiti. Glielo dice uno che sulla perversione del sistema dei partiti ha idee ben chiare da oltre un decennio. Perché da oltre un decennio? Perche fino al 1980 partecipai all’ultimo tentativo di rinnovamento del mio partito, la de. Con il rovesciamento di Zaccagnini, quel tentativo è definitivamente fallito. Nel decennio successivo la politica e i partiti sono rimasti avviluppati nella loro perversio ne di potere. Il potere e il denaro hanno travolto la classe politica italiana, cui è venuto meno ogni punto ideale di riferimento. Veramente, la tesi prevalente sulla questione morale dice che ne è responsabile proprio il consociativismo che voi avete propugnato ed esercitato. Anche Moro vedeva il consocia tivismo come una fase transitoria, cui doveva seguire l’alternanza di maggioranza e opposizione. Il nostro riferimento ideale era la Costituzione, una Costituzione attualissima e modernissima. Per questo dissento da Cossiga e da tutti quelli che vogliono fare la seconda Repubblica.
Il problema non è istituzionale, è politico. L’esasperazione del potere per il potere ha sostituito il concetto del potere per servizio. I partiti hanno deviato, hanno tradito la loro ragion d’essere e disperso il valore fondamentale della Costituzione. O saranno capaci di recuperare i valori dell’articolo 49 o il Paese andrà incontro alla tragedia della distruzione dello Stato democratico. Su questo si salda no Milano e Palermo. Intende dire che la corruzione politica su cui indaga il giudice Di Pietro e la lotta alla mafia dei giudici palermitani sono due aspetti di una stessa realtà? La mafia è votata al potere, un potere terribile che non ha altra sanzione che la morte. I partiti, abbandonando la Costituzione, hanno subito una mutazione malvagia che ha eletto il potere a loro oggetto sociale. Il loro punto d’incontro è negli affari. Insomma, la politica si fa mafia? Attenzione: la ricerca del potere ha una natura analoga, ma ciò non vuol dire, come qualcuno sostiene teorizzando sul terzo livello, che i capi siano gli stessi. I capi mafia sono ‘.api mafia e i capi politici capi politici. Il problema è un altro. Quale? Che il cittadino comune da una parte ha la mafia, il racket, la criminalità organizzata; dall’ altra le tangenti, le ruberie istituzionalizzate, i politici che si fanno ricchi. Come fa più a distinguere? Mafia e Stato non gli appariranno come la stessa cosa? Certo, fa impressione un Paese in cui a Palermo vince la mafia e a Milano il governo dei giudici E ha colto nel segno: il Consiglio superiore viene attaccato perché i giudici ti Palermo fanno poco e a Milano troppo.
Questo la dice lunga sulle critiche che vengono dalla politica. In una crisi morale del Paese come quella che stiamo vivendo dev’essere ben chiaro che la magistratura non prende direttive dal governo. L’inchiesta di Di Pietro a Milano è inattaccabile? Si è detto che i giudici hanno usato i servizi segreti e non la polizia, ma nessuno l’ha dimostrato. Io capisco che il capo di un partito soffra quando vede portar via i suoi ammanettati, ma il Consiglio non ha alcun elemento per interferire. Se degli eccessi ci son stati, saranno corretti. Non c’è l’uso della prigione come deterrente per chi non parla? Formalmente sull’inchiesta di Milano non c’è nulla da dire, la detenzione viene applicata contro il rischio d’inquinamento delle prove. Una cosa ho raccomandato fraternamente a Di Pietro: di non esprimere mai opinioni sul merito del procedimento in corso. Il giudice Colombo non l’ha fatto, proponendo un condono? Se ci saranno denunce le quali proveranno che i giudici hanno violato la riservatezza sul merito del procedimento, chiederò l’applicazione delle sanzioni.
Craxi sostiene che il finanziamento occulto dei partiti non può essere considerato alla stregua degli arricchimenti personali. A parte il fatto che la stragrande maggioranza delle tangenti non va ai partiti, ma, nel migliore dei casi, alle correnti e, nel peggiore, ai troppi uomini con funzioni pubbliche che abbiamo visto diventare ricchi, la legge c’è e va rispettata. Si aumenti, se si vuole, il finanziamento pubblico dei partiti e si applichino controlli più rigorosi, ma per il passato non si pensi a colpi di spugna, i cittadini non capirebbero se non si applicasse la legge esistente. Perché i Di Pietro sono così rari in altre regioni? Ce ne sono di Di Pietro.
Lui è stato bravo ma anche fortunato. Onorevole Galloni, non ha l’impressione che la gente rinuncerebbe volentieri a un po’ di garantismo se vedesse qualche risultato contro la mafia? Tra leggi eccezionali che sospendono la Costituzione e leggi che non la urtino, lo spazio c’è. Ma son convinto che si debbano rispettare i diritti di qualsiasi uomo, anche se quell’uomo è un mafioso. Il terrorismo l’abbiamo sconfitto senza leggi eccezionali, ma con l’invenzione del pentitismo.
Altri Paesi ricorsero perfino alla tortura. Spero che nessuno da noi voglia imitarli. Alberto Staterà «Il Csm non ha mai dato aiuti alla mafia Per Falcone abbiamo fatto i salti mortali ma non si può nominare un sergente a capo dello Stato Maggiore. Le carriere vanno gestite sulla base dei titoli formali» «Non credo alla superprocura Tangentopoli? Ci criticano perché Di Pietro si dà troppo da fare, ma i giudici non obbediscono ai partiti» Da sinistra Borsellino. Falcone, Giovanni Galloni, Bettino Craxi e l’ex consigliere istruttore di Palermo, Antonino Meli Agnese, la moglie del giudice assassinato da una autobomba in via D’Amelio, a Palermo durante i funerali. La donna ha detto: «Paolo è ancora con noi, la sua forza non va dispersa» Sopra l’ex presidente della Repubblica. Francesco Cossiga, e a destra il deputato del pri, Giuseppe Ayala, pm del maxiprocesso.
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 27.7.1992

Dopo i giorni della polemica di Palermo, da domani i veleni si spostano a Roma, Cominciano infatti lo audizioni di tutti i magistrati della procura, davanti al Comitato antimafia del Csm. Tocca subito a Pietro Giammanco, procuratore capo, Bruno Siclari, procuratore generale, e al sostituto Roberto Scarpinato
L’accertamento, si sa, dovrà trovare una soluzione al problema posto dagli otto sostituti che si sono dimessi, con un documento, dalla Dda. Nella nota sono riportate anche valutazioni critiche sulla direzione dell’ufficio, che non garantirebbe una «guida autorevole».
I magistrati dimissionari osservano, nel documento ora all’esame del Csm, che «divergenze e spaccature erano divenute ormai di pubbli co dominio dopo la strage di Capaci» e che la situazione, anziché migliorare, è peggiorata: do po la strage di via D’Amelio, le tensioni sono di veniate ancora più acute. Ma gli otto giudici che hanno presentato le dimissioni dalla procura distrettuale antimafia hanno annunciato anche che chiederanno un incontro con il Capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, e con il ministro del l’Interno, Nicola Mancino.
«Al Presidente vogliamo spiegare le condizioni oggettive nelle quali lavorano i magistrati di Palermo – ha detto il sostituto Roberto Scarpinato -. La situazione è diventata estremamente critica, per le minacce, i pericoli, ma soprattutto per le inefficienze dimostrate dal sistema di sicurezza. Per continuare nel nostro lavoro dobbiamo avere la certezza, dettata dai fatti, che lo Stato ci è vicino».
Agli otto scissionisti sono pervenute numerose attestazioni di solidarietà da parte di col leghi di varie sedi, ma soprattutto da parte dei cittadini. Anche «Magistratura democratica», la corrente interna alla quale aderiscono alcuni dei dimissionari, ha diffuso una nota in cui si sottolinea che gli otto «non hanno affatto abbandonato il campo» e che il loro «è stato un gesto di denuncia e non di resa».
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 27.7.1992
Ucciso l’ultimo simbolo dell’antimafia
Hanno fatto terra bruciata. C’era Paolo Borsellino, era l’eredità lasciata da Giovanni Falcone. Naturalmente non esiste nessun testamento scritto, ma non v’è palermitano saggio che disconosca questa verità: era Borsellino, da poco procuratore aggiunto di Palermo, l’unico in grado di raccogliere il pesante fardello lasciato da Falcone sull’asfalto di Capaci. Non c’è più neppure lui, adesso. E’ morto come il suo amico. L’hanno disintegrato con una bomba simile a quella di maggio. Morti i ragazzi che lo scortavano, come quegli altri che proteggevano Falcone e la moglie. Un’altra strage. Uguale alla prima: sembrano pensate in serie, eseguite da automi che rispondono ad input inviati da un solo cervello. Anche Borsellino. Le agenzie raccontano di corpi straziati, arti letteralmente strappati dal busto. Palermo come Beirut. Lo avevamo già sentito, questo slogan, quando era toccato al giudice Rocco Chinnici, «padre» di questa schiera di giudici sacrificati, falcidiati, a volte anche vilipesi dopo morti. Anche Borsellino se n’è andato. Per liberarsene non hanno esitato a minare un intero quartiere. Adesso si sentiranno più al sicuro, i signori di Cosa nostra. Centomila in piazza, dopo Falcone? Ed allora spariamo di più, e coinvolgendo sempre più la gente comune. Perché se ne stia tranquilla, perché non alzi la testa. Non c’è più nessuno a Palermo che possa guidare la riscossa. Lui era davvero l’ultimo. Come sono uguali, la sua storia e quella del suo amico e. «fratello» Giovanni. Il destino aveva voluto che fosse proprio Borsellino a raccogliere «l’ultimo respiro» di Falcone. Era uscito distrutto da quel pomeriggio. Pianse come un bambino. Rimase di pietra quando il cuore del suo amico si fermò. Per interminabili attimi aveva sperato che Giovanni ce la facesse. «Non era cosciente raccontò qualche giorno dopo la strage di Capaci – ma soffriva. Non è riusicto a dirmi nulla. Francesca, invece, ebbe il tempo di chiedermi: “Giovanni…come sta? Dov’è Giovanni?”». Paolo Borsellino era palermitano. Forse ha pagato pure per questo: Cosa nostra odia in modo particolare i concittadini che si schierano dall’altra parte della barricata. La sua origine, inoltre, gli consentiva di capire molto di più degli altri. Anche Falcone era palermitano, e, per sua ammissione, da ciò si sentiva avvantaggiato. Era nato a piazza Magione, Paolo Borsellino. Nel cuore della città vecchia, all’ombra delle vestigia normanne, splendido fondale messo a paravento di una delle più antiche e rassegnate povertà. Da bambino, era il dopo guerra, tirava calci alla palla nel Campetto dell’oratorio. Conosceva già Falcone, giocavano insieme, in un quartiere popolare dove poteva accadere, così raccontava Falcone, di dover disputare incontri di ping-pong con altri ragazzi, come Tommaso Spada- ro, che sarebbero divenuti capi di Cosa nostra. Eppure, malgrado la pericolosa «palestra», l’ideale della giustizia doveva avere la meglio. Divenne giudice quasi contemporaneamente con Falcone. Concòrsi diversi, ma stessi «maestri». Quali? Uno fu certamente il consigliere Morvillo, del tribunale di Palermo. Aveva due figli, il magistrato: Alfredo e Francesca. Borsellino e Falcone, giudici di primo pelo, li conobbero che erano poco più che ragazzini. Se li sarebbero ritrovati, dopo, giovani colleghi: Alfredo sostituto procuratore, Francesca alla Procura dei minorenni e, successivamente, moglie di Giovanni Falcone. Borsellino, invece, avrebbe sposato la figlia di Angelo Piraino Leto, presidente del Tribunale di Palermo. Era sanguigno, Paolo Borsellino. Ed era di destra. Non ha mai nascosto la sua ideologia: sin da quando, studente universitario, militò nel Fuan e strinse amicizia con quelli che sarebbero divenuti i leader missini della Sicilia occidentale. Ma non ha mai fatto politica con le sentenze. Il suo impegno lo ha sempre riversato nell’attività associazionistica della «corporazione», come ogni tanto amava ironizzare. Tutto alla luce del sole: i suoi colleghi sapevano esattamente come la pensava, ma erano anche certi che l’ideologia o la militanza in nessun modo avrebbe mai insidiato la sua autonomia di giudizio. Era, insomma, autorevole. E per questo piaceva a Falcone. «Di Borsellino ci si può fidare – assicurava l’amico – ed è anche un lavoratore instanca¬ bile. Già, instancabile. Il maxiprocesso ne fu la prova più evidente. Il pool aveva il «capo», Falcone, e il «numero due», Paolo Borsellino. Poi c’erano i preziosissimi Guarnotta e Di Lello, poi si aggiunse Giacomo Conte, il più giovane. Lavoravano tutti a ritmo continuo. Non erano colleghi, erano prima di tutto amici. In particolare Paolo^e Giovanni: avevano la stessa visione di Cosa nostra e delle strategia da op¬ porre alla «Piovra». A loro bastava uno scambio di occhiate per dirsi tutto, erano in perfetta sintonia. Una macchina perfetta, il pool, messa in pista da quella figura eccezionale che è Antonino Caponnetto, l’uomo che più di tutti ha lavorato nell’ombra per facilitare il lavoro dei giudici di Palermo. Che esperienza, quella del maxiprocesso. I magistrati chiusi a scrivere pagine su pagine, la villa di Mondello di Giuseppe Aya- la, che sarebbe stato poi uno dei due pubblici ministeri, utilizzata come «covo» del pool antimafia. E i mandati di cattura scritti sul tavolo da ping-pong del giardino, mentre dall’esterno un autoblindo scoraggiava i malintenzionati. Quello fu un momento in cui tutti, ma tutti davvero, gli uomini del pool antimafia dimenticarono persino di avere una famjglia. Già, la famiglia, 1″figli. Borsellino ne aveva tre, un maschio e due ragazze: Manfredi, Lucia e Fiammetta. Quanta apprensione per Lucia. Accadde quando lui e Falcone furono costretti a rifugiarsi con le famiglie all’Asinara. Sì, proprio nel carcere dell’isola. I servizi di sicurezza avevano avuto una soffiata che la mafia preparava qualcosa contro i due. Restarono più di un mese «al confino». Fu in quell’occasione che Lucia si ammalò: divenne anoressica.* Una malattia della quale non si è mai liberata completamente e che si riacutizzava ógni volta oìfe Lucia sentiva il padre in pericolo. Era a Lucia che Borsellino pensava ogni volta che gli veniva offerto un incarico nuovo. Era la salute della figlia l’insopportabile contrappeso alle sue scelte.
Opponeva resistenze all’ipotesi di di. untare Superprocuratore al posto del suo amico morto a Capaci. Lo spiegò, una mattina, qual era il tarlo che gli arrovellava il cervello. «Sono combattuto. Da una parte so che quel posto è il solo che possa assicurarmi di poter svolgere indagini sull’assassinio di Giovanni e Francesca. Dall’altra parte sono sicuro che mia figlia ne morirebbe». E si macerava, interpretando i suoi tentennamenti come una sorta di diserzione ad un dovere che sentiva impellente. Sì, perché Paolo Borsellino era un uomo onesto fino in fondo. E leale. Tanto franco da riuscire ad esprimere tutte le sue perplessità senza incrinare i rapporti di amicizia. Così avvenne con Giovanni Falcone. Borsellino non era d’accordo con l’idea di istituire la Procura nazionale.
Come tanti altri giudici, temeva che un simile organismo potesse servire ad imbrigliare politicamente le iniziative della magistratura. Spiegò a Falcone tutte le sue perplessità. J L’amico non riuscì a convincerlo completamente, ma quando la legge passò e la Dna fu istituita, Borsellino non ebbe dubbi ad indicare Falcone come l’unico che potesse far funzionare un simile organismo. Non c’era divergenza di vedute che potesse far venire meno il rispetto e la stima. Difficile pensare a Borsellino e Falcone come a possibili «nemici». Fu Paolo, per primo, a dimostrare all’altro tutta la sua amicizia. Era il 1988, cominciava il sistematico smantellamento del pool antimafia di Palermo e Borsellino, anche per rassicurare la figlia convalescente, si era già trasferito alla procura della Repubblica di Marsala. La lontananza da Palermo non gli impedì, tuttavia, di intervenire in aiuto dei vecchi amici del pool. Sanguigno come sempre, lanciò la sfida: si fece intervistare per dire che lo Stato stava abbassando la guardia.
Fu «processato» dal Consiglio superiore: uno scontro durissimo nel quale anche Falcone gettò tutto il suo prestigio, arrivando a minacciare le dimissioni se il Csm avesse punito Paolo Borsellino. Anche dopo la morte di Falcone non si tirò indietro. Fu implacabile con quanti tentavano di offuscarne la memoria, vigile con gli amici dell’ultima ora. Confermò l’esistenza degli appunti che il suo amico aveva annotato all’epoca della difficile convivenza col palazzo di giustizia e, in particolare, col procuratore capo Piero Giammanco. Perònon si. lasciò prendere,,dalla smania presenziahstica. Era cosciente che il polverone non serve. Si era convinto che l’unico modo per «onorare» la memoria di Giovanni Falcone era quello di scovare gli assassini. Senza clamori, in silenzio. Passo dopo passo. Si era mosso parecchio, era andato all’estero.
Domani sarebbe andato in Germania, dove, sembra, c’è parecchio da indagare su Cosa nostra. Continuava a tenere i contatti coi «suoi» pentiti. Uno di questi, Rosario Spatola, alla notizia di quest’altra strage ha dichiarato di essere «rimasto orfano». Un’altra, Giacoma Filippello, ricorda di averlo visto di recente e rimpiange di non poter più consegnargli, come avevano convenuto, una poesia da lei composta in ricordo di Giovanni Falcone. No, non aveva mollato. Aveva superato lo smarrimento di maggio, quando, tenendo la mano appoggiata sulla bara del suo amico Giovanni aveva detto ai colleghi: «Chi vuole andarsene se ne vada. Questo è il nostro futuro». Ma lui era rimasto. Francesco La Licata I clan lo odiavano particolarmente perché era palermitano ma aveva scelto la giustizia Sanguigno, con simpatie di destra sempre schierato in prima linea I giudice Paolo Borsellino (a fianco) e sotto assieme all’ex ministro Vassalli e al giudice Falcone Borsellino con i colleghi Ayala ‘ e Falcone (a fianco) e (sopra) il giudice Giammanco
«Ero con lui un’ora prima della morte» Il racconto dell’amico Tricoli, ex deputato regionale siciliano, che ha pranzato con Borsellino
«Sì, Paolo ha trascorso le ultime ore della sua vita a casa mia». Un timbro di autentica angoscia nella voce, Giuseppe Tricoli riesce a stento a non lasciarsi sopraffare dall’emozione per l’assassinio di un amico fraterno, il giudice Paolo Borsellino. Tricoli, ex deputato regionale del msi, docente di diritto nell’Università palermitana, rappresenta, assieme a Guido Lo Porto e allo scomparso Angelo Nicosia, l’anima antica del movimento sociale siciliano. Come ogni estate, anche quest’anno Tricoli passa i mesi più caldi a Villagrazia di Carini, distante una decina di chilometri da Palermo. Anche Borsellino possedeva un villino a Villagrazia, e proprio nello stesso complesso condominiale di Tricoli. Fatalità: Villagrazia confina con Capaci, il paese nei cui paraggi hanno fatto esplodere il 23 maggio scorso l’automobile del giudice Falcone. «In tarda mattinata Paolo aveva voluto fare un’improvvicata a casa mia», racconta Tricoli al telefono, mettendo fine a una lunga pausa. Può sembrare strano che anche dopo le minacce, i controlli di una vita blindata, l’obbligata cautela su ogni spostamento, Borsellino potesse ancora permettersi qualche «improvvisata». «Ma è andata proprio così», prosegue Tricoli, «saranno state più o meno le tredici quando Paolo, la moglie Agnese e il figlio Manfredi sono venuti a farci visita. Non lo vedevo da qualche tempo, ho invitato lui e i suoi familiari a pranzare da noi. Hanno accettato. Abbiamo chiacchierato a lungo, perlomeno fino alle sedici e trenta». «Paolo era sereno», continua Tricoli, «e ho avuto l’impressione che le minacce degli ultimi tempi e il dolore per la morte di Falcone non avessero inciso così tanto sul suo buon umore». Villagrazia era per Borsellino, oramai da vent’anni, il luogo della «spensieratezza», dice Tricopli. Eppure, pranzando con gli amici, il giudice che sarebbe stnto ucciso di lì a poche ore, non ha eluso l’argomento mafia. «Ha parlato a lungo del giudice Livatino. Ha spiegato della particolare ferocia della mafia di Palma di Montechiaro. Gli ho chiesto che cosa ne pensasse della Superprocura. Ha avuto un attimo di esitazione e sulla sua faccia si è dipinta come un’espressione di sconsolato scetticismo. “Intanto bisogna vedere se faranno passare il decreto Martelli”, mi ha risposto. E poi ha accennato alle “opposizioni” che qualcuno aveva fatto sul suo nome come candidato alla direzione della Superprocura. Ha avuto anche la forza di sorridere con un commento ironico: “Certo che in giro ci sono dei signori che assumono atteggiamenti molto incoraggianti per noi che facciamo la lotta alla mafia”». Tricoli va avanti con qualche difficoltà nel suo raccónto. Conosceva Paolo Borsellino dai tempi dell’Università: «Io ero il presidente del Fuan di Palermo, l’organizzazione universitaria del msi, e lui ne faceva parte con molta convinzione e partecipazione». Si frequentavano da tanto tempo, si scambiavano confidenze: «Eravamo due amici veri, di un’amicizia cementata nel tempo anche per le comuni idee politiche». «Quando Paolo ha avvisato gli uomini della scorta che era giunto il momento di prepararsi non gli ho chiesto dove fosse diretto», ricorda adesso Tricoli, mentre in tv scorrono le immagini della carneficina di Palermo. «Stavo guardando un film, in televisione e d’improvviso annunciano un’edizione straordinaria del telegiornale. “Un’esplosione a Palermo”, dicono. Mi si gela il sangue. Vorrei avvertire Agnese, rimasta a Villagrazia assieme al figlio. Ma non lo faccio per non metterla in apprensione. Poi una ragazza dal giardino di una casa vicina grida a squarciagola che un giudice ha perso la vita in un attentato. Mi precipito da Agnese, sconvolta, terrea in volto, e lei chiede a mia moglie di accompagnarla a casa della suocera. Aveva capito tutto». Giuseppe Tricoli attende con ansia il ritorno della moglie, che ora, mentre lui è al telefono, sta ancora vicino ad Agnese. Ricorda con sgomento di aver chiesto all’amico Paolo come facesse a non avere paura: «Mi ha risposto: “Sono cattolico, credere nell’umanità per me è un dovere”. Ma poi ha aggiunto, sconsolato: “Questa è la Sicilia”». «”Ma ne parliamo quando tornerò dalla Germania”. Sono state le sue parole di arrivederci. Ci siamo abbracciati. Per l’ultima volta». Pierluigi Battista «Abbiamo parlato della Superprocura, era scettico: troppi i miei oppositori».
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 20.7.1992
«Adesso il tritolo è pronto per me»
Caponnetto gli disse: «Stai attento, evita gli spostamenti abituali. Non andare da tua madre»
Una partita a scacchi. E la vita come posta in palio. Quanto devono essere stati penosi, per lui, i suoi figli, la povera moglie, gli amici, gli ultimi giorni di vita di Paolo Borsellino. Consapevole di essere segnato, in lotta contro il tempo, preoccupato di non scoprire le carte, muoveva le sue pedine per ribaltare la sorte. Ma, puntualmente un nuovo indizio, un segnale allarmante lo ricacciava indietro. Fino a chiuderlo in un vicolo cieco: la certezza di «dover morire». Dove, quando? Solo su questo Borsellino ne sapeva poco. Ma che fosse ormai un morto che camminava l’aveva capito. Gliel’avevano detto, anche. Con tanto di relazione di ser- ‘ vizio controfirmata dai servizi di sicurezza. Eppure nessuno lo ha potuto salvare. Borsellino si è avvicinato, giorno dopo giorno, alla sua fine. Spettatore impotente, l’ha sentita arrivare, fino a cederle nella tragica domenica di via D’Amelio. Sabato ne aveva parlato con il confessore, solo qualche ora prima della sua morte annunciata, aveva confidato all’amico Pippo Tricoli: «Lunedì scorso il tritolo è arrivato anche per me». Avevano trascorso gran parte della mattinata insieme, Borsellino e Tricoli. Proprio quella domenica le due famiglie avevano ripreso la consuetudine del pranzo a Villagrazia di Carini, nella casa della villeggiatura estiva. Una consuetudine che si era allentata per le vicende umane e personali del giù• j dice, sempre più coinvolto nelle indagini e sempre più demoralizzato, specialmente dopo la strage di Capaci e la morte di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. L’allarme per l’incolumità del procuratore giunse sotto forma di «notizie attendibili» raccolte dai servizi di sicurezza. Ce voci parlavano di qualcosa che si preparava e indicavano una serie di «possibili bersagli», si dico fossero cinque, naturalmente tenendo conto delle maggiori o minori probabilità. All’esame degli esperti i più esposti risultarono Paolo Borsellino e l’ex sindaco Orlando: «Cosa Nostra li vuole morti». Non fu una sorpresa, per Borsellino. Della sentenza di morte emessa nei suoi confronti aveva già avuto un drammatica conferma, interrogando il pentito Vincenzo Calcara. Ad un certo punto il mafioso si alzò, chiese di interrompere l’interrogatorio, volle abbracciare e baciare il giudice, dicendogli: «La mafia lo ha condannato a morte. Io stesso dovevo eseguire la sentenza, uccidendola con una fucile di precisione». Ma quella segnalazione, accompagnata da un’altra dei carabinieri del Kos (Reparto operazioni speciali) dello stesso tenore, significava qualcosa di più. Significava che da «soggetto a rischio». Borsellino si trasformava in «soggetto in pericolo». E lui sapeva cogliere la differenza. Con chi confidarsi? Non c’è più Giovanni Falcone, ma c’è sempre il «padre» dei giudici palermitani, il vecchio Antonino Caponnetto. Borsellino lo chiama al telefono e gli racconta. Da Firenze l’ex consigliere istruttore cerca di dargli consigli. «Stai attento, evita gli spostamenti abituali». Borsellino, che proprio in quel momento si accinge ad intraprendere i contatti con Leonardo Messina, un nuovo pentito, sa di non poter restare immobile. E va ripetendo: «Devo far presto, la mia è una lotta contro il tempo». Spiega a Caponnetto che diffìcilmente potrà evitare l’impatto che è in arrivo. Dall’altro capo del filo una raccomandazione: «Paolo, almeno evita di andare da tua madre, per il momento». Borsellino si schernisce e bisbiglia: «Per quello che può servire!». Già, la casa della madre. Un posto «a rischio», tanto da meritarsi la «zona rimozione», un piccolo accorgimento antibomba sperimentato dopo l’attentato a Rocco Chinnici. C’erano state parecchie segnalazioni d’allarme in via D’Amelio. A parte il «covo» dove il boss Antonino Madonia teneva il «libro mastro» delle estorsioni, proprio di fronte al portone dell’abitazione della signora Borsellino, più d’una volta erano stati notati strani movimenti. E un pentito aveva raccontato di cunicoli che collegavano la via D’Amelio con alcune strade molto distanti. Borsellino sente sul collo il fiato della mafia. Raccoglie la testimonianza dell’ultimo pentito in un clima da «Fort Al amo»: con tre funzionari della questura di Caltanisetta nascosti di fretta per sottrarli ai killer e tra una certa indifferenza per il fiume di notizie che Leonardo Messina comincia a riversare sui verbali. Indifferenza? Si, come se dalle parole del pentito, la cui attendibilità e conoscenza della mafia non sarebbero proprio da sottovalutare, potesse giungere qualche «grossa grana», dal momento che il giovanotto dimostra di sapere molto di mafia e politica e troppo di collusioni tra criminali e apparati giudiziari. Va in Germania, Borsellino. I primi di luglio, come conferma ufficialmente la polizia di Mannheim. La pista gliela «regala» Messina, parlando degli assassini! dei giudici Livatino e Saetta e del maresciallo Guazzetti. E il pentito gli «regala» anche un’altra notizia: un mafioso originario di Palma di Montechiaro, che vive in Germania, è disposto a collaborare. Borsellino rientra dalla Germania, convinto di tornarci presto: cosa che avrebbe dovuto fare lunedì, se non lo avessero ucciso. Va a Roma, a parlare con l’Alto commissario, Finocchiaro. Incontra i «suoi» pentiti: Spatola e Giacoma Filippello. Forse proprio a Roma riceve i particolari che lo convincono di essere quasi alla fine della partita. E’ inquieto, il giudice. La signora Agnese, adesso, lo ricorda «assente» e «irrequieto». Borsellino non vuole allarmare la famiglia, ma non può fare a meno di parlare del pericolo che sta correndo. E’ ancora la testimonian- L’allarme era stato lanciato da un rapporto dei servizi di sicurezza Nel mirino anche Orlando za di Pippo Tricoli a chiarire: «Me lo hanno detto i figli. Sabato scorso, Paolo aveva confessato che la sua posizione era diventata davvero pericolosa». E domenica pomeriggio, trenta minuti prima di andare a morire, saluta l’amico abbracciandolo. «Ci siamo stretti – ricorda Tricoli – e ci siamo scambiati uno sguardo intenso che voleva dire tutto». Poi lo scoppio, la strage. Francesco La Licata Caponnetto porta la bara di Borsellino. Sono a sinistra il giudice ucciso e Pippo Tricoli.
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 20.7.1992
«Noi giudici non siamo al sicuro»
Così accusava dopo la strage di Capaci Questa è l’intervista che Borsellino rilasciò al nostro inviato dopo la morte di Falcone; le riflessioni su quella strage possono servire a spiegare anche quella di cui è stato vittima.
«C’è un’osservazione elementare che non posso ignorare: la coincidenza temporale tra l’attentato e la improvvisa ed imprevista sensazione generale che Falcone avesse ormai raggiunto al Csm la maggioranza per essere designato procuratore nazionale antimafia». Ma nessuno lo sapeva ancora. Lo avevo detto a Giovanni, che queste condizioni ormai c’erano. Avevo capito che, malgrado la fortissima opposizione di una parte della magistratura, la candidatura di Falcone poteva passare. C’è una seconda circostanza da non sottovalutare: ad un certo momento si era fatta strada la convinzione che Giovanni, in un eventuale nuovo governo, potesse diventare ministro dell’Interno. Ne ha mai parlato con Falcone? Con lui direttamente no. Ma ci sono colleghi che lo hanno fatto e possono testimoniare che l’ipotesi era meno fantasiosa di quanto potesse sembrare. So inoltre, e questa è una terza circostanza che osservo, che la sua reiterata abitudine di venire a Palermo pressoché ogni settimana, sempre durante il weekend, si sarebbe interrotta perché Francesca, la moglie, aveva finalmente ottenuto di stare a Roma per un lungo periodo. Questo avrebbe diradato le visite di Giovanni nella sua città. Non so quanto la circostanza fosse conosciuta, fuori. Qui dentro la conoscevano tutti e se ne parlava. Non so se in queste osservazioni, e vi prego prendetele come tali e niente altro, vi sia il perché della morte di Giovanni. Ma sono le uniche cose che sono riuscito a pensare. Le sembrano trascurabili? Confesso di non aver avuto molto tempo per riflettere. Ciò che è avvenuto mi tocca personalmente. Conoscevo Giovanni da quando avevamo entrambi i pantaloni corti, siamo entrati insieme in magistratura ed abbiamo lavorato sempre gomito a gomito. Conoscevo Francesca Morvillo che era una ragazzina, Ho imparato a fare il magistrato nell’ufficio del padre. Ricordo che insieme andavamo a prenderla a scuola, dopo il lavoro. E’ comprensibile che, seppure con un semplice ragionamento, met- ta a disposizione le poche -cose che so. Ho un solo cruccio: quello di non poter partecipare alle indagini. Avevo chiesto di essere applicato a Caltanissetta, sede dell’inchiesta, ma in quella procura, purtroppo, non è previsto il ruolo dell’aggiunto. Dico purtroppo perché se avessi potuto occuparmi dell’indagine avrei trovato una ragione. Altre volte ho dovuto superare momenti difficili aggrappandomi al lavoro. Accadde dopo l’omicidio del capitano Emanuele Basile. La morte dell’ufficiale incise parecchio sulla mia personalità, la responsabilità delle indagini mi ha aiutato a superare l’enorme paura e a vincere il blocco emotivo. Mi ha consentito di riprendere a svolgere il mio lavoro di magistrato. Che ne farà di queste sue «sensazioni»: le terrà per sé? Andrò a Caltanissetta per raccontarle al procuratore Celesti. Feci lo stesso per la morte del consigliere istruttore Rocco Chinnici. Servì a chiarire una polemica che riguardava i rapporti con un uomo politico. Ma a Celesti non farò un ragionamen¬ to: i ragionamenti non fanno parte di una testimonianza, possono esserne il retroterra, tutt’al più materiale per un’intervista. Ma perché Falcone l’hanno ucciso a Palermo e non, per esempio, a Roma? Sarebbe stato più facile altrove, visto che le sue condizioni di protezione erano migliori a Palermo. Invece hanno agito qui. Mi sono dato una spiegazione semplice: hanno colpito a Palermo perché l’assassinio di Falcone è un omicidio di mafia e tutti i delitti eccellenti sono stati compiuti a Palermo. Questo non perché sia proibito eseguire attentati fuori, ma per il semplice fatto che la mafia uccide dove comanda e controlla il territorio. Una regola fissa? Guardi che il problema non è se un omicidio si possa fare o no. Tutti i delitti sono possibili. E’ relativamente facile, per questa gente, uccidere anche un capo di Stato. Per killer e mandanti di mafia il problema essenziale è un altro: assicurarsi l’ùnpunità. Nessun mafioso è disposto a rischiare un solo giorno di carcere per un delitto. Questa certezza, Cosa Nostra ritiene di raggiun- ,geria solq.se opera ,in,Sicjlia e in luoghi dove il controllo del territorio è pressoché totale. Eppure sono stati sollevati tanti dubbi sulla matrice mafiosa dell’agguato. Si è parlato di congegni sofisticati… Per le notizie che ho non si è trattato di un attentato compiuto con tecniche raffinatissime. Per quanto ne so non si è trattato di nulla di complicato. Bestiale sì, perché pensato senza nessuna considerazione per la vita di innocenti. Si poteva fare di più per prevenire la strage? Non mi sento di recriminare sulla protezione offerta a Giovanni Falcone. I magistrati lavorano in condizioni di sicurezza carenti, quasi che la scorta sia una cosa che si debba fare solo per scrupolo. Lo stesso non si può dire per Giovanni. Sì, non c’era l’elicottero e mancava la macchina «cerca-esplosivo». Ma mi chiedo come sarebbe stato possibile scoprire la bomba a tre metri sotto il manto stradale. Il problema è semmai cercar di capire perché la mafia sia così potente. Già, perché? a»™ ‘ Lascio da parte tutte le questioni sociologiche, politiche e dico: si può affrontare la superpotenza mafiosa se le si fa un regalo come quello di adottare strumenti processuali buoni per un Paese che non è l’Italia e meno che mai può essere la Sicilia? Ogni volta dobbiamo dimostrare che la mafia esiste, che Uccide, che corrompe. Falcone, però, difendeva questo codice. Peccava di ottimismo. Aveva un modello di magistrato che era se stesso, una capacità di lavoro incredibile, un incrollabile spirito di sacrificio. Un uomo che ci aveva cambiati tutti, che dalla struttura giuridica pigra ed evanescente degli Anni 80 era riuscito a tirar fuori quel monumento di indagine che fu il maxiprocesso. Aveva torto: la media delle capacità di impegno dei magistrati non è quella di Giovanni. La media è rappresentata anche da me, che mi scoraggio, che non so se domani riuscirò a fare la stessa quantità di lavoro che ho fatto oggi. Francesco La Licata Il giudice Borsellino mentre esce dalla procura di Marsala.
«Diceva: so che sarò il prossimo»
«Le sue paure confidate al giornalista Luca Rossi «Un uomo spezzato in due, trasformato persino fisicamente, nel modo di muoversi. Era sparito il magistrato un po’ guascone e pieno di entusiasmo che avevo conosciuto cinque anni prima. Era un uomo sconvolto per la morte del suo amico Falcone, e soprattutto cosciente di essere lui il prossimo bersaglio della mafia». Così Luca Rossi ricorda il suo ultimo incontro con Paolo Borsellino, una settimana fa nella sua casa di Palermo, «sembrava trasformata in una caserma, con davanti un camion e tre auto blindate cariche di poliziotti». Erano amici da tempo, da quando il giornalista milanese era diventato familiare in Sicilia per il suo libro «Arrivederci Mafia». Un’amicizia rinnovata recentemente, per l’ultimo libro di Luca Rossi «I disarmati» (edito da Mondadori, come il precedente). Un titolo terribilmente profetico per i personaggi: i protagonisti e i sopravvissuti della battaglia antimafia degli Anni Ottanta, i poliziotti di Pa- lermo, e loro, i magistrati superblindati, ma in realtà disarmati di fronte a una mafia capace di metterli fuori gioco. Sono rivelazioni forti quelle di Borsellino all’amico giornalista, a pochi giorni dalla sua morte. «Mi confidò che non avrebbe accettato di dirigere la superprocura antimafia. A differenza di Falcone era un giudice sul campo, che credeva poco ai grandi disegni. Mi disse: “se vado via da Palermo qui non resta più nessuno a seguire le inchieste contro la mafia. Qui si arena tutto. Era furioso con il procuratore capo di Palermo Giammanco, lo giudicava un “insabbiatore”, di essere lui la causa della fuga di Falcone a Roma. Diceva di non riuscire più a fare nulla a Palermo, per cui si era ritagliato un suo spazio, seguendo le piste mafiose ad Agrigento e a Trapani. Ma era dispiaciuto che proprio nel momento d’oro del pentitismo mafioso, con ben trenta persone disposte a spifferare tutto sulla piovra attuale, perché stufi dei metodi dittatoriali del grande capo Riina, non ci fosse in realtà nessuno in grado di svolgere queste indagini». Borsellino, l’uomo che confida in mezzo alla sua disperazione anche i progetti per il futuro: «mi confessò che dopo dieci anni di indagini contro la mafia, ora cercava di sopravvivere per altri due anni, standosene buono e defilato nella speranza di diventare poi lui procuratore capo di Palermo, al posto di Giammanco». Nel suo libro, Luca Rossi descrive una tazzina rovesciata, appoggiata sulla scrivania, nello studio del magistrato, ritrovata nella stessa posizione dopo un anno. «Incuriosito, gli chiesi se aveva un qualche significato, ma per tutta risposta mi disse che alla moglie piaceva così. Ho capito la morale della tazzina, la morale di Borsellino: non esiste dietrologia, le cose sono molto più semplici di quanto si crede». Borsellino aveva dovuto rinunciare quest’anno alle vacanze, costretto a rimanere rinchiuso in casa, superprotetto, lui che amava passare ogni minuto libero con i figli o le piccole gioie, come mettersi al barbecue a cuocere le bistecche per gli amici. Si divideva tra lavoro e casa e le puntate a Roma, per interrogare un pentito. «Un uomo franco e aperto, molto coraggioso». Riaffiorano anche i ricordi del passato che stridono con quelli del presente. Un episodio di qualche anno fa. E’ l’una di notte e non si trova un taxi, allora Borsellino accompagna l’amico giornalista con la sua auto blindata e senza scorta, fermandosi pure a comprare le sigarette: «io avevo paura, ma lui era tranquillo: “la mafia non spara quando è impreparata”, mi disse. Invece ora aveva paura, ma aveva di fronte alla morte lo stesso atteggiamento di Falcone». Luca Rossi gli chiede una settimana fa: «perché non metti alle finestre vetri antiproiettile: da uno di questi palazzi chiunque può spararti. Mi rispose solo con un sorriso, come per dirmi, ma non ti rendi conto che non servirebbe a nulla, che sono già un uomo morto». Stefanella Campana «Temeva di essere emarginato e che a Palermo tutto fosse insabbiato» Il giornalista-scrittore Luca Rossi e la copertina del suo libro dedicato alle vittime eccellenti della mafia siciliana.
Con Falcone, amici nel rischio
Con Falcone, amici nel rischio Con Falcone, amici nel rischio 7/ libro «Cose di Cosa Nostra» svelò la loro fuga all’Asinara ROMA. Paolo Borsellino compare due volte in Cose di Cosa Nostra, il libro-testamento di Giovanni Falcone (a cura di Marcelle Padovani, da alcune settimane in testa alle classifiche di vendita). Una prima citazione nel passaggio relativo alle cautele quotidiane dei giudici che compongono il pool antimafia: «E’ stato scritto – ricordava Falcone – che mi spostavo da un bunker a un altro, dal palazzo di giustizia alle carceri e dalle carceri alla mia prigione personale: la mia casa. Qualcuno ha pensato forse che attribuissi troppa importanza a questi problemi. Non sono d’ accordo. Conosco i rischi che corro facendo il mestiere che faccio e non credo di dover fare un regalo alla mafia offrendomi come facile bersaglio. Noi del pool antimafia abbiamo vissuto come forzati: sveglia all’alba per studiare i dossier prima di andare in tribunale, ritorno a casa tardi la sera. Nel 1985 io e Paolo Bor¬ sellino siamo andati in “vacanza” in una prigione, all’Asinara, in Sardegna per stendere il provvedimento conclusivo dell’istruttoria del maxiprocesso. Non rimpiango niente – commentava Giovanni Falcone anche se a volte percepisco nei miei colleghi un comprensibile desiderio di tornare alla normalità: meno scorte, meno protezioni, meno rigore negli spostamenti». Falcone ricorda Paolo Borsellino anche là dove riflette sulla morte: “Il pensiero della morte mi accompagna ovunque. Ma si acquista anche una buona dose di fatalismo”. E con il fatalismo, a temperare là paura, è l’ironia. Falcone evoca alcune battute al tempo del maxiprocesso: «Mi viene a trovare a casa il collega Paolo Borsellino. “Giovanni – mi dice -, devi darmi immediatamente la combinazione della cassaforte del tuo ufficio”. E perché?. “Sennò quando ti ammazzano come l’apriamo?”».
Indagava su collusioni tra mafia e magistrati, la bomba gli ha tranciato gambe e braccia Ammazzato a un passo dalla verità Borsellino doveva andare in Germania da un pentito
«Devo faro in fretta. La mia è una lotta contro il tempo». Paolo Borsellino si era buttato a capofìtto nel lavoro. Aveva superato il brutto momento del dopo-Falconc ed era riuscito ad afferrare nuovamente il filo «giusto» delle indagini. Ma perché tanta fretta? A cosa si riferiva la sua «lotta contro il tempo?». Gli amici fidati che hanno ricevuto la confidenza non ne sanno di più. ma ora, dopo la strage di via D’Amelio gli investigatori sembrano in grado di ricomporre lo scenario. Borsellino teneva i contatti con due pentiti molto importanti. Uno sta in Italia, l’altro in Germania. Sapeva che Cosa Nostra non ignorava la notizia. 1 colloqui coi collaboratori rivelavano particolari sempre più inquietanti, raccontavano di preparativi di stragi e il bersaglio più probabile era sempre lui,Te rede di Falcone. Sapeva, il procuratore aggiunto di Palermo, che avrebbero cercato di impedirgli in ogni modo di concludere l’inchiesta Per questo aveva fretta: era convinto che una voi ta raccolte tutte le dichiarazioni dei pentiti, sarebbero diminuite le probabilità di morire. Cosa Nostra può uccidere anche soltanto per vendetta, ma ò l’omicidio «preventivo» la sua vera «specialità». Ieri Borsellino sarebbe andato in Germania per incontrare un «emigrato» agrigentino, un uomo che vive da qualche tempo in «esilio volontario», il pentito numero 2. Era stato l’altro collaboratore, un mafioso originario della provincia di Caltanissetta, a metterli in contatto. Chissà cosa sarebbe venuto fuori. Si parla di collusioni tra palazzi di giustizia e mafia. Ma nessuno è in grado di firmare una simile ipotesi. Qualcosa, invece, si sa dell’ai tro pentito. E’ un superkiller nato a San Cataldo (Caltanissetta), si chiama Leonardo Messina, e da sempre è al servizio deile cosche mafiose cosiddette del «Vallone». Ne sa, di storie l’ultimo confidente di Paolo Borsellino. Sa, per esempio, che la decisione di uccidere il giudice era stata presa dal «governo» di Cosa Nostra. E dice che la «sentenza» era irrevocabile. Il giovane si è arreso allo Stato intorno all’inizio di maggio. Si dice che non lo avessero convinto certi tentennamenti della «cupola* mafiosa, di fronte alle sue richieste di entrare a far parte dei quadri dirigenti, naturalmente dietro ufficiale assegna zione di una fetta di territorio. Che dà in cambio il giovane superkiller? Dirige l’apparato logistico-militare. Una prova? Cosa Nostra decide di far fuori tre funzionari della questura di Caltanissetta. Il «contratto» viene affidato a Messina. Vengono mobilitati due killer che arrivano da Como con tanto di pistola e silenziatore. L’agguato è stabilito per il venerdì Santo, durante la processione. Ma qualcosa non funziona: il giorno prima una soffiata manda all’aria il piano. Vengono arrestati Messina e i due killer venuti dal Nord. Chi ha parlato? La domanda si agita nella mente di Messina. Il giovanotto è malpensante e sospetta che a metterlo nei guai potrebbero essere stati i suoi ex amici, allarmati per le eccessive pretese del giovane «rampante». Così Messina parla. Chiede il contatto con Falcone, ma il direttore degli affari penali non può ascoltarlo, il suo nuovo ruolo non glielo consente: lo «passa» all’amico Borsellino. Si apre così il libro di alcuni omicidi eccellenti: Messina parla dell’assassinio dei giudici Saetta e Livatino, dell’agguato mortale teso ad Agrigento al maresciallo Guazzili. Al procuratore si apre un orizzonte nuovo. Confida di aver capito improvvisamente una serie di cose che erano rimaste oscure. E per saperne di più, viene invitato dal pentito a contattare un «amico che vive in Germania». Da qui la decisione di partire. Una ventina di giorni fa un altro colpo di scena: i servizi segreti «captano» la notizia che la mafia ripeterà il tentativo andanto in fumo il venerdì Santo. I funzionari in pericolo vengono presi di notte, con le famiglie e portati in posti sicuri. E’ il primo campanello d’allarme per Borsellino. Cominciano anche ad arrivare minacce e telefonate anonime: Borsellino ripete che «deve far presto». Il massacro di Capaci rallenta definitivamente la marcia del procuratore verso la verità, mentre il tam-tam della mafia mette in circolo la notizia che ci sono due nuovi pentiti. Un vecchio trucco per «bruciare» il lavoro dei magistrati. Paolo Borsellino ci credeva in questi pentiti. A qualcuno aveva confidato di aver fatto un buon lavoro. Per un periodo a Palazzo di Giustizia circolò la voce che si preparavano provvedimenti giudiziari. Invece non accadde nulla. Il clima negli uffici della Procura della Repubblica non è mai stato dei più sereni, ma mai tumultuoso come in queste ultime settimane. La riunione di ieri mattina ne e testimonianza: ore ed ore di dibattito per concludere con una spaccatura che si presenta insanabile. E ad aggravare la tensione contribuisce l’ultimo sospetto: qualcuno sapeva che Borsellino, a quell’ora (alle 17), sarebbe andato dalla madre. La carica di esplosivo, infatti, era già stata collocata sotto una «Seat», quando è arrivato il corteo delle blindate, una carica che. nella deflagrazione (come ha dimostrato l’autopsia) ha tranciato di netto a Borsellino gambe e braccia. Chi poteva saperlo? Una cosa è certa: il giudice a mezzogiorno telefonò alla madre per dirle: «Mamma, alle cinque sarò da te». Telefonata intercettata? Possibile. Ma resta ancora un dubbio: telefonò dal suo cellulare o da un apparecchio di casa sua? Il «telefonino» è facile da intercettare, ma un telefono normale no. Francesco La Licata Un’immagine del luogo dove è avvenuta la strage voluta dalla mafia
La pentita
«Ora posso dire che veramente sono rimasta sola». La pentita Giacoma Filippello, ex convivente del capomafia Natale D’Ala, così ha sintetizzato al tg3 i suoi sentimenti all’indomani dell’uccisione di Borsellino: «C’eravamo sentiti una settimana dopo la morte di Falcone e gli avevo detto che avevo scritto una poesia per l’amico. Lui mi ha detto: “Sono felice che lei lo abbia ricordato nella maniera che solo lei sa fare, dedicandogli la poesia che mi sta leggendo’.
Poi, con un nodo alla gola, per rianimarmi disse: “Speriamo che non debba scriverne una anche per me”».
La Filippello ha aggiunto: «Borsellino mi diceva sempre che le cose che dicevo io si verificavano puntualmente; che come dicevo io, la mafia è come la matematica, precisa». «Ecco – ha concluso – ho un ricordo bellissimo di lui, sempre sorridente, in cerca sempre della verità e della giustizia». ARCHIVIO ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 21.7.1992
La mafia dichiara guerra allo Stato
. E’ guerra allo Stato. Dopo Falcone, Borsellino. A nemmeno due mesi di distanza dall’attentato sull’autostrada, la mafia ha assassinato un altro giudice di prima linea. Ed è stata una strage: sei morti (il giudice e cinque agenti della sua scorta, fra cui una donna), diciotto feriti, palazzi sventrati, decine di auto distrutte. L’agguato è stato compiuto in via Mariano d’Amelio, in un quartiere nuovo di Palermo, a pochi passi dalla casa della madre del magistrato. Mancavano cinque minuti alle 17 quando è scoppiato l’inferno: una «Seat Ibiza» con 40 chili almeno di tritolo è stata fatta saltare in aria con un telecomando a distanza. Il giudice, che stava percorrendo il giardino di casa della madre, e gli uomini della scorta sono stati colpiti in pieno. Sul luogo dell’attentato, tra i primi ad accorrere, anche l’ex giudice Ayala, compagno di Borsellino e Falcone nel pool antimafia. servizi da pag. 2 a pag. 5 Ali di folla sgomenta intorno alle auto investite dallo scoppio che, alle 16,55 di ieri, ha ucciso il giudice Borsellino e cinque agenti della scorta.
Inferno a Palermo, assassinato Borsellino
Hanno ucciso anche lui, Paolo Borsellino, un altro giudice-simbolo della lotta alla mafia, compagno di studi e amico d’infanzia di Giovanni Falcone e, morto lui, il più autorevole candidato alla direzione della “Superprocura”. L’hanno atteso al varco mentre andava a far visita alla madre e alla sorella in un edificio di via Mariano D’Amelio, in centro, una strada stretta, in tutto un centinaio di metri senza sbocco, a poca distanza dalla Fiera del Mediterraneo e dal mercato ortofrutticolo all’ingrosso. Con Borsellino i boss hanno assassinato, facendoli a pezzi, cinque poliziotti della scorta, fra i quali una ragazza, Emanuela Loi. Le altre quattro vittime, giovani che lavoravano per un modesto compenso, coscienti di giocare una terribile partita con la morte sempre in agguato, sono Walter Cusina, Vincenzo Limuli, Claudio Traina e Agostino Catalano.
Fra passanti e abitanti nella zona vi sono 18 feriti. Il nuovo massacro è stato realizzato dalla mafia con una “Seat Ibiza” lasciata in sosta piena di tritolo e dinamite (almeno 40 chili), fatta saltare con un congegno radiocomandato azionato a distanza alle 16,55 di ieri.
E’ una torrida domenica di luglio nella città semideserta.
Borsellino, 52 anni, tre figli, sposato con Agnese, una figlia dell’ex presidente del tribunale Angelo Piraino Leto, era appena sceso dalla Croma blindata preceduta e seguita da due vetture gemelle e aveva imboccato un breve corridoio fra un giardinetto per raggiungere l’ingresso del palazzo. Era seguito dagli sguardi vigili degli agenti che, come sempre, impugnavano le pistole mitragliatrici, pronti a far fuoco in caso di necessità.
Chi ha premuto il congegno causando la devastante deflagrazione era sicuramente nei pressi, appostato in una casa vicina o in una vettura in sosta nei pressi.
Il boato è stato avvertito in tutta Palermo in un raggio di oltre 10 chilometri sino a Mondello, la principale zona balneare della città con la spiaggia chiusa per inquinamento, uno dei tanti esempi dello sfascio di Palermo nel dramma dell’aggressione mafiosa, quotidianamente costretta a fare i conti con storie incredibili.
E nella zona attorno a via Autonomia Siciliana, in cui converge via D’Amelio, in pochi minuti si sono riversate centinaia di persone che presto son diventate migliaia, fra l’accorrere di decine di ambulanze fatte giungere da tutti gli ospedali, mezzi dei vigili del fuoco, autoradio di polizia, carabinieri; guardie di finanza, vigili urbani.
Per oltre un’ora si è camminato fra pezzi dei corpi delle vittime mutilate e carbonizzate dallo scoppio e fra i rottami delle vetture investite dalla spaventosa onda d’urto. Una delle “Croma” è stata catapultata a una cinquantina di metri.
Una scena terribile: l’asfalto divelto, come quello nell’autostrada di Capaci il 23 maggio per l’uccisione di Giovanni Falcone, della moglie Fran- cesca Morvillo e degli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro; i lamenti dei feriti in attesa dei soccorsi e portati quindi in vari ospedali (tre sono in rianimazione); le imprecazioni della gente, specialmente dei residenti nei 96 alloggi del vicinato più o meno gravemente danneggiati con gli infissi divelti, i vetri in frantumi, le pareti annerite.
Sono stati disposti urgenti sopralluoghi per verificare la stabilità degli edifici investiti dall’esplosione. C’è stato anche chi si è inginocchiato a pregare e chi ha urlato invocando la pena di morte.
Agnese Borsellino è stata accompagnata in via D’Amelio quando già si era avuta la certezza che la mafia aveva ancora una volta colpito una vittima «eccellente», appunto suo marito. La signora ha chiesto all’amica Mirella Falzone, moglie dell’ex deputato regionale missino Giuseppe Tricoli, di condurla sul posto. «Ti prego non dirmi di no e poi adesso voglio stare accanto a mia suocera», ha insistito.
E in via D’Amelio, poco dopo, ha avvertito un malessere, ma l’ha vinto e si è fatta forza fino a quando ha abbracciato l’anziana suocera tremante. «Sì, è lui», ha mormorato il procuratore della Repubblica Pietro Giammanco, pallido e teso chino sui cadavere martoriato del suo «aggiunto» coperto da un lenzuolo, uno dei lenzuoli di Palermo stesi nei balconi e nelle finestre per protesta contro i boss. «Mio Dio, mio Dio!», ha esclamato Giammanco, coprendosi il volto per evitare di finire «in pasto» ai giornali e alle Tv così stravolto.
E tra tanta distruzione, angosciato, l’anziano suocero s’è fatto largo a fatica tra la folla: «Voglio vederlo, lasciatemelo vedere», ha implorato. Manfredi, il figlio di 20 anni di Borsellino, s’è tenuto a lungo in disparte, quasi a non voler credere in ciò che realmente era accaduto, e si è aggirato tra la folla prima di abbandonarsi a un pianto disperato.
Fra i primi ad accorrere un altro personaggio di spicco nella guerra alle cosche, Giuseppe Ayala, neo eletto per il Pri a Montecitorio e pm nel primo maxiprocesso alla sanguinaria struttura siciliana di Cosa nostra che con il collega Domenico Signorino, andato via in lacrime cinque anni fa chiese 19 condanne all’ergastolo e oltre 2500 anni di carcere per i membri della Cupola e oltre 400 loro affiliati. Ayala abita nel residence «Marbela», a poco più di 100 metri dal luogo della nuova strage e si è precipitato in strada, certo che fosse accaduto qualcosa di veramente grave.
Quando è arrivato il sostituto procuratore Guido Lo Forte, l’ha abbracciato.
E un altro giudice-politico, il neo sindaco Aldo Rizzo, segretario della commissione parlamentare Antimafia quando fu deputato, non ha potuto nascondere il suo profondo turbamento: «Siamo in guerra», ha urlato con la voce che gli era rimasta, aggiungendo: «Sì, mettiamocelo in testa, è una guerra senza esclusione di colpi e dobbiamo prepararci a resistere perché non possiamo e non dobbiamo ammettere che questa debba essere la fine». «Ora vengono i ministri e faremo un altro grande funerale», ha sibilato un giovane agente delle scorte, uno dei 600 «angeli con la pistola» di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza che attualmente assicurano a Palermo la sorveglianza dei cosiddetti obiettivi a rischio, come appunto vengono chiamati gli uomini che sono il costante bersaglio dei boss.
E monetine lanciate sprezzantemente da un gruppo di agenti delle scorte contro il ministro degli Interni Nicola Mancino e il capo della Polizia Vincenzo Parisi al loro arrivo a Palermo danno la misura di quale e quanta sia la loro esasperazione.
Parecchi militari hanno continuato a essere assegnati a ondate a Palermo fin dall’indomani del delitto Dalla Chiesa, il 3 settembre del 1982, che segnò un altro eccezionale momento della spavalda sfida dei mafiosi allo Stato e alla società e al quale seguì una straordinaria mobilitazione con l’istituzione dell’Alto commissariato antimafia, un organismo sulla cui utilità effettiva molti sono dubbiosi.
La reazione degli agenti delle scorte fu già composta ma fermissima dopo il 23 maggio e Oscar Luigi Scalfaro volle personalmente rassicurare una. loro delegazione durante la sua breve visita a Palermo, primo atto sostanziale del suo settennato .
Fra le richieste principali avanzate dopo la strage di Capaci, gli agenti delle scorte e gli autisti giudiziari che con loro rischiano la vita, inclusero quella di una consistente copertura assicurativa: «Sappiamo che al mattino usciamo da casa, ma non se la sera vi torneremo», dissero a Scalfaro. Ora altri cinque di loro sono caduti in questa interminabile e furiosa guerra scatenata dai boss e quasi certamente dal «cervello», dal vero «braccio operativo» di Cosa Nostra in Sicilia, il capo del clan dei corleonesi Salvatore Riina.
Nei giorni scorsi il difensore di Riina, l’avvocato Nino Fileccia, di solito schivo e nient’affatt.o loquace con i giornalisti, ha dichiarato che il suo cliente ricercato da oltre 25 anni è in Sicilia.
Un’ammissione interpretata come un messaggio perché tutti fossero certi che il «boss dei boss» non se n’è andato, ma è più che mai attivo in Sicilia facendosi beffe delle forze di polizia e dei magistrati che tanto possono essere uccisi in ogni momento. Antonio Ravidà L’asfalto divelto come a Capaci, decine di vetture distrutte, j palazzi sventrati dallo scoppio Il pm Giammanco ha riconosciuto | il cadavere del suo «vice» j| Nel disegno la scena dell’attentato al giudice Borsellino. Sopra, il cardinale Pappalardo accorso sul luogo della tragedia che ha descritto come «uno scenario di guerra» Il palazzo dove abitava la madre di Borsellino, sventrato dalla tremenda esplosione che ha divelto duecento metri d’asfalto
Autobomba
Non Palermo come Beirut, semmai Beirut come Palermo dove infatti morte e terrore sono stati sparsi già tre decenni fa, il 30 giugno del 1963 con la strage nella borgata Ciaculli dove nell’esplosione di una «Giulietta» imbottita di tritolo morirono sette tutori dell’ordine richiamati sul posto da una telefonata anonima. Era una trappola.
Seguì un’estate d’inferno, come tante altre dopo, mentre Beirut non ancora sconvolta da un’altra spietata guerriglia scatenata principalmente dai trafficanti di droga era una pacifica capitale mediterranea per vacanze milionarie. Anche a Palermo, come a Beirut, il massimo potenziale di violenza sin da allora si è accompagnato alla maggiore diffusione degli stupefacenti.
I terroristi libanesi perfezionarono poi la tecnica e utilizzarono i radiocomandi per provocare gli scoppi da una certa distanza, facendo saltare in aria nell’attimo voluto auto lasciate in sosta nel punto esatto dal quale sarebbe dovuta passare la vittima designata.
Questo sistema, ormai chiamato «libanese», non potè essere sfruttato nella strage di Capaci il 23 maggio scorso perché una vettura abbandonata in sosta nell’autostrada probabilmente avrebbe suscitato sospetti, richiamato l’attenzione: i mafiosi, allora, a Capaci preferirono piazzare il tritolo seppellendolo per farlo esplodere ugualmente con un radiocomando azionato a un centinaio di metri di distanza. Paolo. Boreellino è il terzo alto magistrato di Palermo assassinato dalla mafia in un agguato con l’esplosivo.
Prima di lui il 29 luglio del 1983 il capo suo e di Giovanni Falcone, Rocco Chinnici, il consigliere istruttore del Tribunale a capo del «pool» dei giudici istruttori antimafia (morirono anche i tre carabinieri della scorta e il portinaio dello stabile dove la vittima designata abitava in via Pipitone Federico, nel centro della città); quindi il 23 maggio scorso Falcone, la moglie e tre agenti della scorta (altri cinque rimasero feriti).
E nel 1985 un altro giudice scomodo, ora parlamentare della «Rete», Carlo Palermo, sfuggì per poco alla morte sul litorale di Pizzolungo, a Trapani, rimanendo ferito con cinque guardie di Finanza della scorta, ma trovarono un’orribile morte uria giovane madre, Barbara Rizzo Asta, e i suoi due figli gemelli, Giuseppe e Salvatore, di sei anni diretti a scuola: la loro «Golf» fu dilaniata da un’autobomba che danneggiò soltanto le due vetture blindate con il giudice e i militari.
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 21.7.1992
Il plastico, 80 chili, era in una 126
Gli esperti del gabinetto della polizia scientifica e quelli del Centro Investigativo Speciale dei carabinieri continuano a setacciare via D’Amelio, ed hanno rinvenuto altri reperti utili alle indagini.
Gli investigatori, contrariamente a quanto ipotizzato subito dopo la strage, hanno stabilito che gli attentatori hanno collocato l’esplosivo, circa 80 chili di plastico, dentro una Fiat 126 che hanno parcheggiato davanti al 19 di via D’Amelio, e non sotto la Seat Ibiza di proprietà di uno degli abitanti della strada. La 126 era stata rubata a Palermo una decina di giorni prima dell’agguato, e questa circostanza conferma che il «via» all’operazione per uccidere il giudice Borsellino, era stato dato almeno un mese prima.
Un primo rapporto sulla ricostruzione dell’agguato è stato consegnato al procuratore della Repubblica di Caltanisetta, Giovanni Tinebra. Intanto da ieri anche l’Fbi affianca gli investigatori italiani: sette agenti americani cercano in via D’Amelio una traccia, un’impronta, un errore dei killer della mafia. Gli specialisti Usa sono tornati a Palermo due mesi dopo la strage di Capaci: anche in autostrada avevano svolto la stessa rilevazione.
Intanto, sul fronte delle indagini, le indiscrzioni provenienti dal tribunale segnalano che i nuovi pentiti starebbero per la prima volta affrontando temi connessi ai rapporti tra mafia e politica, ma anche quelli relativi a presunte infiltrazioni di Cosa Nostra in istituzioni ed apparati importanti dello Stato ed anche nell’ordine forense.
ARCHIVIO STORICO LA STAMPA EDIZ. 23.7.1992
PAOLO BORSELLINO – La sua famiglia