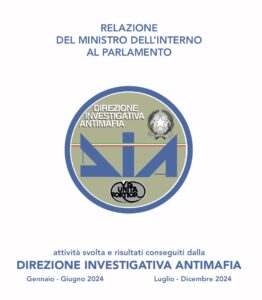Criminalità organizzata sempre più digitale: le nuove rotte delle mafie in Europa
Negli ultimi anni le organizzazioni mafiose tradizionali, dalla Cosa Nostra alla’Ndrangheta fino alla Camorra, hanno profondamente trasformato i loro modelli operativi, orientandosi sempre più verso il controllo dell’economia legale e attività digitali.
Le relazioni della Dia e di altre agenzie europee evidenziano che il loro modus operandi “è sempre meno legato a eclatanti manifestazioni di violenza ed è, invece, rivolto verso l’infiltrazione economico-finanziaria”.
Oggi il riciclaggio è “la strategia dominante delle mafie evolute”: i clan investono nei paradisi fiscali, anche digitali, e nelle piattaforme finanziarie globali. La pandemia da COVID‑19 ha aggravato le opportunità per i mafiosi: procedure di gara semplificate e imprese in difficoltà hanno rappresentato “una grande opportunità” per le cosche, che puntano a rilevare imprese in difficoltà finanziaria e a drenare fondi pubblici per il rilancio economico.
In questo contesto, i clan agiscono sempre più “silenziosamente”, senza ricorrere a violenze plateali, utilizzando al contempo sistemi di riciclaggio sempre più sofisticati e nascosti.
Cybercrime e truffe online: la nuova frontiera mafiosa
Le mafie hanno rapidamente assorbito le modalità del crimine informatico. Operazioni di polizia europee hanno arrestato centinaia di persone legate ai clan tradizionali per frodi e attacchi digitali.
Ad esempio, una maxi-operazione congiunta di Spagna, Italia ed Europol ha portato all’arresto di oltre 100 sospetti legati a organizzazioni mafiose che impiegavano hacker: phishing, SIM swapping, malware e attacchi ai sistemi bancari sono stati usati per appropriarsi di fondi. Come spiega una dirigente della Polizia spagnola: “Ora (i mafiosi, ndr) si stanno trasformando governando l’era digitale. Stanno usando hacker all’interno delle loro organizzazioni”.
Oggi è necessario contrastare reati di nuovo tipo. Phishing e frodi bancarie: clan inseriscono specialisti informatici nei loro organici per portare attacchi via mail ingannevoli o siti falsi e prosciugare conti correnti.
Mercato dei dati rubati: Europol segnala che credenziali di accesso, informazioni personali sottratte e strumenti di hacking circolano come commodity sui mercati criminali del dark web.
Compromettere sistemi aziendali o account privati è diventato un business: dati personali vengono comprati all’ingrosso per alimentare ransomware, frodi finanziarie e persino ricatti sessuali.
Attack as a service: Le reti cybercriminali offrono servizi “chiavi in mano” (da server per phishing a tutorial per frodi), abbattendo le barriere tecniche d’ingresso.
Ad esempio, l’operazione Jackal III (2024) di INTERPOL ha denunciato una grande gang nigeriana, la “Black Axe”, considerata una “mafia violenta” nigeriana, coinvolta in cyber-frode, estorsioni informatiche, traffico di droga e sfruttamento sessuale online.
Nicola Gratteri, Procuratore di Napoli, ha descritto una criminalità «camaleontica» sempre più esperta di digitale. Ha raccontato di aver scoperto «una banca online con sedi anche in Lituania e Lettonia che riciclava miliardi di dollari» gestita da clan campani, trovando «tecnologie che la nostra Polizia giudiziaria nemmeno si sogna».
Secondo Gratteri, l’‘ndrangheta e gli altri clan «sono molto evoluti sul dark web», con transazioni in bitcoin e nuove droghe sintetiche, mentre per le forze di polizia servono urgenti «giovani ingegneri informatici» che colmino il ritardo tecnologico italiano.
Giuseppe Lombardo, Procuratore della DDA di Reggio Calabria, Ha lanciato l’allarme sul sorpasso tecnologico delle mafie: «Le mafie sono avanti – ha detto Lombardo – perché sanno bene che le nuove tecnologie sono applicate ormai alle transazioni finanziarie, soprattutto su scala internazionale (…) Sono molto interessate alle comunicazioni crittografate, sanno quali sono i rischi e mettono in campo una serie di accorgimenti per eludere le indagini».
Queste attività informatiche non sono più “eccezioni”: rapporti di Europol (IOCTA 2024) confermano che phishing, investimenti truffaldini e altri schemi di frode digitale hanno colpito milioni di vittime nell’UE.
In parallelo, crescono richieste investigative per tracciare transazioni di criptovalute legate a reati informatici, segno della stretta connessione tra cybercrime e riciclaggio digitale.
Criptovalute e riciclaggio nell’economia globale
Le valute virtuali sono diventate il nuovo “paradiso fiscale” delle mafie. Nonostante la loro volatilità, criptomonete e stablecoin consentono trasferimenti istantanei di grandi capitali senza lasciare tracce bancarie tradizionali.
La Guardia di Finanza italiana segnala che, fra il 2024 e il 2025, sono stati sequestrati in Italia circa 73 milioni di euro in valute digitali, un segnale dell’intensità delle indagini. A livello globale, un report di Chainalysis documenta che nel 2024 oltre 40 miliardi di dollari in criptovalute sono finiti nei portafogli elettronici delle organizzazioni criminali dei quali il 60% in stablecoin, che mimano le monete tradizionali e rendono le transazioni apparentemente più “pulite”.
Exchange anonimi e mixer: i clan usano piattaforme senza obbligo di identificazione (KYC), mixer per “mescolare” i bitcoin e blockchain privacy (es. Monero, Zcash) per riciclare i proventi illeciti. Questi strumenti creano un flusso difficile da seguire con metodi tradizionali.
Società di comodo e strutture offshore:le aziende “cartiere” in Europa (ad es. società estoni o mediorientali) veicolano fondi sporchi in criptovalute e contanti nei mercati legali. Ad esempio, mafie siciliane sono state collegate a transazioni sospette verso wallet esteri di anonimizzazione.
Riciclaggio invisibile: le unità di intelligence finanziaria (UIF) italiane segnalano cicli tipici di trasferimento di denaro contante in conto societario, convertito in crypto, e re-immissione nell’economia reale. La Dia osserva che le mafie italiane mantengono ramificazioni operative in Lituania, Lettonia, Germania, Spagna e persino Canada per far transitare i narcotrafficati.
Il risultato è che l’”economia sommersa” mafiosa si è in buona parte spostata online: è sufficiente un clic per movimentare somme enormi. Come spiega il generale Luigi Vinciguerra della GdF, “non si tratta più di eccezioni”. Oggi forme digitali di riciclaggio convivono con metodi tradizionali, e la parola chiave è la velocità, per rendere la tracciabilità «decisamente difficile».
Infiltrazioni nell’economia legale
La crisi economica post-pandemia ha creato terreno fertile per le mafie, che hanno progressivamente rilevato o fatto fallire imprese indebitate e mirano ai piani di rilancio pubblici (PNRR e fondi UE).
La Dia parla apertamente di “infiltrazione dell’economia legale” come strategia privilegiata durante l’emergenza sanitaria.
Secondo il rapporto semestrale 2021 della Dia, la liberalizzazione di appalti e servizi pubblici ha moltiplicato i rischi di penetrazione mafiosa, soprattutto nel settore sanitario e negli appalti per le grandi opere. I clan hanno sfruttato il lockdown per agire sottotraccia: è diminuito il traffico di droga di strada, mentre sono aumentati i casi di riciclaggio al Nord e di favori elettorali e corruzione al Sud.
Tra i metrodi usati dalla consorterie mafiose troviamo l’usura e “welfare” mafioso. Le mafie si presentano come finanziatori di ultima istanza per imprenditori e cittadini in difficoltà: prestano denaro a tassi usurai ma con apparente rapidità, creando dipendenza. A loro volta, le cosche offrono forme di assistenza (cibo, sanità privata, favori economici) per ottenere consenso sociale.
Il Rapporto semestrale evidenzia che la Camorra usa i propri capitali «lo strumento ideale per proporre un ‘intervento’ (assistenziale, ndr)» su piccole e medie imprese indebitate, entrando nel tessuto produttivo locale. Altro fenomeno è quello delle acquisizioni mirate di imprese in settori vitali (ristorazione, edilizia, logistica, trasporti, sanità) che sono entrate nel mirino mafioso.
Ad esempio, indagini in Lombardia e Calabria documentano l’acquisto di ristoranti, palestre e centri ricreativi in difficoltà finanziaria, utilizzati per riciclare denaro contante e nascondere movimenti illeciti. In Campania il prefetto Michele Di Bari segnala un boom di interdittive antimafia nei settori edile e della ristorazione: nei primi 9 mesi del 2025 sono scattati 21 divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione nel comparto edilizio e 16 nel food.
Questi settori sono particolarmente vulnerabili per l’alto uso di contante e manodopera irregolare, che facilitano le operazioni mafiose. Inoltre esistono le c.d. “imprese cartiere” a vita breve. Le mafie creano società schermo che durano pochi mesi, trasferiscono fondi attraverso di esse e le chiudono («scatole vuote»). In Sicilia la Dia ha individuato 56 di queste società “cartiere” usate solo per far transitare fondi di clan di Palermo e Trapani. Tale modello di impresa effimera è oggi considerato un indice chiave del riciclaggio organizzato.
La pandemia ha dunque accentuato un fenomeno iniziato da tempo: le mafie non aspettano più solo di partecipare alla ripresa economica, ma di direzionarla. Come sottolinea la Dia, da Nord a Sud il denominatore comune delle strategie mafiose è oggi la capacità di operare da imprenditori silenti, usando prestanome o società pulite per acquisire commesse pubbliche e competere sul mercato legale.
Mafie italiane e reti criminali straniere
Nel nuovo contesto europeo convivono mafie storiche italiane e potenti network internazionali. Le organizzazioni mafiose italiane, oggi più “burocrate” che boss violenti, continuano a generare liquidità attraverso traffici tradizionali (droga, usura, gioco d’azzardo) ma reinvestono questi proventi nel settore digitale: algoritmi, criptovalute e giurisdizioni offshore fanno parte del loro arsenale. Per esempio, le inchieste “Paper Wall” (tra Catania e Malta) e “Tornado” (in Lombardia) hanno svelato reti italo-albanesi di riciclaggio basate su fatture false e società fittizie.
Accanto alle mafie italiane, l’Europa è attraversata da reti transnazionaliagguerrite. Tra queste la mafia albanese. Negli ultimi anni i gruppi criminali albanesi sono diventati “international wholesalers” della cocaina europea. Uno studio della Global Initiative spiega che, grazie a connessioni dirette in Sudamerica e porti come Antwerpen e Amburgo, gli albanesi hanno gestito spedizioni record di droga (fino a 12 tonnellate) verso l’UE. Europol indica gli albanesi tra le nazionalità maggiormente coinvolte nel traffico di cocaina. Le loro strutture sono orizzontali e flessibili: un capo finanzia ed è collegato a clan in vari Paesi (Paesi Bassi, UK, Italia), usano sistemi di trasferimento come l’hawala per muovere centinaia di milioni e investono i profitti in immobili e infrastrutture globali. Alktra realtà oggi estremamente diffusa è quella dei gruppi nigeriani.
Le criminalità nigeriana europea è caratterizzata da organizzazioni confraternali gerarchiche, spesso armate, che offrono “protezione” in cambio di fedeltà. Oltre al tradizionale traffico di droga, sono attivi nel traffico di esseri umani (tratta sessuale e lavoro forzato) e in frodi online (romance scam, BEC, carte clonate). Ad esempio, l’operazione Jackal III di Interpol/Europol (2024) ha arrestato 300 persone legate al network “Black Axe”.
Questo gruppo, definito “mafioso-violento” dalle autorità, combinava furti di credenziali e malware con spaccio e tratta: in quelle indagini sono stati sequestrati milioni di dollari e liberate decine di vittime di schiavitù digitale. Esistono, inoltre le reti cinesi. Le triadi e altre organizzazioni criminali cinesi operano in tutta Europa, spesso nei business dell’immigrazione clandestina e della prostituzione forzata.
In quell’operazione sono state arrestate 30 persone e liberate 33 vittime. Le indagini hanno svelato complessi processi di riciclaggio tramite documenti falsi e ricettazione, confermando che le reti cinesi usano servizi di crime-as-a-service (conti anonimi, passaporti contraffatti) per gestire profitti su scala continentale. Esistono anche altri gruppi transnazionali.
Accanto a questi, anche formazioni etiopi, nigeriane (diverse da Black Axe), georgiane, rumene e russe esercitano attività criminali diffuse: dal traffico di anziani verso centri di riciclaggio in Europa dell’Est fino alle frodi con false imprese. Le forze dell’ordine segnalano continue connessioni tra mafie tradizionali e bande informatiche estere: ad esempio, professori di criminologia osservano che in molti casi esiste ancora una divisione dei ruoli tra “capo clan” e “coder” freelance, ma che l’integrazione crescerà in futuro. In ogni caso, i leader investigativi concordano sulla crescita del pericolo cyber: le cosche italiane stanno esternalizzando a hacking network est-europei o africani il compito di compiere truffe digitali e riciclaggio via criptovalute.
Italia ed Europa: strategie a confronto
Il contrasto a queste nuove minacce richiede cooperazione su scala continentale. In Italia il contrasto punta su inchieste patrimoniali e interdittive antimafia: la Dia intensifica l’azione patrimoniale per “arginare l’inquinamento dei mercati”, mentre prefetture e procure emettono interdittive per imprese sospettate di collusione. Esempi recenti sono le operazioni “Paper Wall” e “Tornado” che hanno colpito reti italo-albanesi di traffico e riciclaggio.
A livello europeo si sviluppano diversi approcci. Innanzitutto la cooperazione investigativa. Europol ed Eurojust coordinano operazioni congiunte (es. task force antitraffico cocaina, indagini cyber-su istituzioni finanziarie).
Un report europeo del 2024 sottolinea che la complessità transnazionale di queste reti impone “sforzi di intelligence condivisa e indagini finanziarie mirate”. Anche Interpol ed altri organismi internazionali hanno lanciato operazioni come Jackal III (Nigeria) e joint-investigations sul darknet, spesso con successo.
Normativa e controlli. In alcuni Paesi sono state approvate leggi ad hoc. Nel Regno Unito, ad esempio, la creazione di un registro nazionale delle imprese (Companies House) e la fusione di tutte le polizie locali in Police Scotland hanno migliorato il contrasto. Studi britannici evidenziano che fino al 2017 la Scozia era considerata un «eldorado nascosto» per i capitali mafiosi, grazie a società a responsabilità limitata controllate da partner offshore. Il 90% delle cosiddette SCottish Limited Partnerships è detenuto da compagnie madri nei paradisi fiscali, spesso collegate a criminali internazionali, rendendo possibile il riciclaggio di miliardi. Grazie alla centralizzazione investigativa e ai requisiti di trasparenza (2017), le indagini scozzesi hanno però oggi raggiunto alti livelli di sequestri patrimoniali e eradicazione di clan locali.
Molte banche europee collaborano con unità anti-riciclaggio nazionali per bloccare transazioni sospette. Ad esempio, a Malta e Lussemburgo (hub crypto e finanziari) si stanno restringendo i controlli sulle piattaforme di cambio valute digitali. L’Agenzia francese antiriciclaggio ha riconosciuto negli ultimi anni “una minaccia elevata” da parte di reti criminali cinesi e italiane sui propri mercati finanziari, rafforzando l’analisi di transazioni in valuta virtuale.
Confronti bilaterali. Italia e altri Stati collaborano su estradizioni e sequestri transfrontalieri. La cooperazione giudiziaria UE/Interpol ha permesso estradizioni di boss albanesi (il caso Çela-Çopja, nel 2025, è seguito in tribunale in Belgio) e l’intervento coordinato su reti cinesi in Spagna/Croazia. Il contrasto all’uso illecito di blockchain vede anche iniziative internazionali: task force per deanonimizzare transazioni e scovare broker informali, gli “underground money brokers” descritti dalle forze dell’ordine.
Oggi l’Italia e il resto d’Europa condividono una sfida comune: fermare mafie sempre più “senza volto” e tecnologiche. Se da un lato il nostro Paese si avvale delle storiche competenze di magistrati e investigatori (potenziando ad esempio il Nucleo Speciale Polizia Valutaria e le commissioni antimafia), dall’altro l’esperienza estera fornisce spunti di azione (ad es. controlli incisivi sulle giurisdizioni offshore e centralizzazione dei dati).
La partita rimane aperta, ma è un fatto che le mafie stanno riconfigurando i loro equilibri: come avverte Europol, “criminal networks are increasingly exploiting new technologies”, necessitando così una risposta altrettanto innovativa delle istituzioni. Roberto Greco L’ALTROPARLANTE 25.10.2025
- MAFIA E CRIPTOFONINI, BITCOIN E DARK WEB
- MAFIA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
- MAFIA E METAVERSO
- MAFIA E SOCIAL
- MAFIA E TIK TOK
- MAFIA E CIBER SECURITY
- MAFIA D CYBERSPAZIO