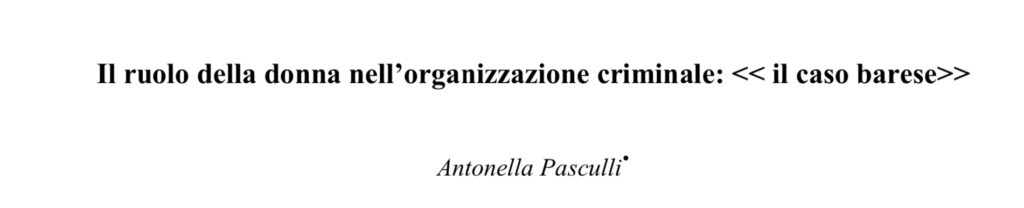TESTIMONI DI GIUSTIZIA
- DONNE E MAFIA : LA VOCE DI CHI HA SCELTO DA CHE PARTE STARE
- LA RIVOLUZIONE CHE PARTE DA UN RIFIUTO
- IL RUOLO DELLA DONNA NELL’ORGANIZZAZIONE
- LE DONNE D’ONORE E L’ONORE DELLE DONNE
- LE DONNE NELL’ORGANIZZAZIONE MAFIOSA
- L’ALTRA META’ DELLA CUPOLA
- DONNE E POTERE NELLA CAMORRA
- DONNE CONTRO LA MAFIA E DONNE DI MAFIA
- DONNE E GUERRE DI MAFIA
Testo
Le storie delle vittime della mafia sono tutte da ricordare. Un libro racconta anche quelle meno note di donne e persone comuni
Fra le vittime della mafia, ci sono nomi entrati nella storia e nelle cronache, come quello di Paolo Borsellino, la cui figlia Fiammetta è fra i protagonisti del numero 47 di Vanity Fair in edicola fino al 24 novembre. La maggior parte delle storie raccontate in Morire di Mafia, La memoria non si cancella, pubblicato da Sperling & Kupfer e scritto dai giovani dell’Associazione Cosa Vostra, sono però ignote ai più.
Sono le storie di uomini, donne e bambini, oltre 200 in totale, vittime della mafia in tempi e luoghi diversi. Dal secondo dopoguerra a oggi, dalla magistratura al mondo del lavoro, dai comuni cittadini alle forze dell’ordine. A raccontarle è un gruppo di giovani dell’Associazione Cosa Vostra. Solo il condirettore di questo gruppo è un uomo, le altre sono ragazze, studentesse e giovani professioniste. Alessia Pacini è una di loro.
«Non ci sono per noi vittime di serie A e vittime di serie B. Raccogliendo le storie dei familiari delle vittime di cui abbiamo raccontato le vite, c’è una grande ricerca umana». Prima di essere vittime sono state persone con una vita spesso semplice. Il denominatore comune delle storie è il morire di mafia, ma anche la necessità di ricordare. Il magistrato Sebastiano Ardita ha detto che «le storie delle vittime di mafia fanno stare male, ma fanno germogliare la passione e inducono alla serietà e al sacrificio. Parlarne è una struggente necessità, per il bene nostro e di chi verrà».
«In tante storie», spiega Alessia Pacini, «è evidente il grande senso di responsabilità a partire dagli imprenditori che si sono opposti al pizzo e alle leggi della criminalità organizzata. Ci sono madri coraggio come Matilde Sorrentino che ha denunciato gli abusi in una scuola di Torre Annunziata».
La figura femminile in ambito mafioso è doppia. «Da una parte le donne d’onore che imparano dalle loro madri un codice di comportamento. Si arriva anche a delitti commessi ad hoc perché una relazione extraconiugale è una macchia. Dall’altra parte ci sono donne che si sono ribellate a questi codici e lottano soprattutto per garantire un futuro diverso ai figli».
È proprio Alessia ad aver scritto la storia di Lia Pipitone. La firma, con lei, il figlio della donna, Alessio Cordaro. Nonostante avesse solo quattro anni quando è morta la ricorda per piccole cose, su tutte il suo amore per il mare. È stato lui, insieme al giornalista Salvo Palazzolo a far riaprire il caso della madre. Grazie alle testimonianze, ci sono state, nel 2018, le condanne di mandante ed esecutore dell’omicidio.
Sono vite che si intrecciano quelle delle vittime di mafia. Gianmatteo Sole è stato rapito e ucciso il 22 marzo 1995 solo perché la sorella era fidanzata con il figlio di boss e la mafia pensava che lui avesse informazioni sul possibile piano per il rapimento dei figli di Totò Riina. È suo fratello Massimo a raccontare la sua storia. «Andando nelle scuole», spiega Alessia Pacini, «ha incontrato Graziella Domino, mamma di un bimbo ucciso a 11 anni. Quando sua madre e la signora Domino si sono incontrate è nato un sentimento di sorellanza. In quell’abbraccio c’era tutto l’amore delle mamme delle vittime di mafia». VANITYFAIR 22.11.2020
l ruolo della donna nelle associazioni criminali di stampo mafioso è sempre stato caratterizzato da una certa ambiguità.
La presenza femminile nell’organizzazione si basa sia su un’esclusione formale che in una partecipazione sostanziale alla vita dell’organizzazione.
Donne e Cosa Nostra Anche sotto il profilo di genere, il fenomeno mafioso dimostra una grande capacità di adattamento: benché abbia sempre assunto la forma di organizzazione maschile, il suo maschilismo deriva da quello presente nel contesto sociale di riferimento. Del resto, come scrisse Giovanni Falcone, non è altro che «l’esasperazione dei valori siciliani»[1]. Non desta sorpresa quindi l’accresciuto ruolo della donna nelle organizzazioni criminali di stampo mafioso.
Donne mafiose Già ai tempi del processo alla mafia delle Madonie (1927-1928), tra i 153 imputati vi erano 7 donne, con imputazioni quali l’assistenza ai latitanti, la riscossione del pizzo e la custodia del denaro; tra queste, Giuseppa Salvo, definita dai giornali «la regina di Gangi» per il suo ruolo di spicco, che nel corso del processo mantenne un perfetto atteggiamento omertoso[2]. Nello stesso periodo cominciò la sua carriera di ricercata dalla giustizia Maria Grazia Genova, detta «Maragè», nata a Delia, in provincia di Caltanissetta nel 1909 e morta in ospedale, in miseria, il 15 dicembre 1990, dopo aver collezionato una cinquantina di denunce e ventidue arresti. Sorella di Diego, «uomo di rispetto» del paese, già nel 1927 venne arrestata per furto. Nel 1949 riuscì ad evadere dal carcere dove doveva scontare una pena in seguito alle indagini sulla faida in cui era coinvolta la sua famiglia e che finì quando non ci fu più nessuno da ammazzare[3]. Pare che quando qualcuno della sua famiglia si trovasse nei guai con la giustizia e fosse necessario pagare gli avvocati, questa si presentasse da professionisti e commercianti della città, chiedendo un contributo[4]. Mandata al confino agli inizi degli anni sessanta, nel ’79, quasi ottantenne, venne proposta di nuovo per il soggiorno obbligato.
Più recente l’attività di Angela Russo, arrestata il 13 febbraio 1982 assieme ad altre 27 persone, tra cui i figli e le nuore, all’età di 74 anni perché sospettata di essere stata corriera di droga tra Palermo, le Puglie e il Nord Italia. Si scoprì in seguito che la Russo, soprannominata «nonna eroina», era più che corriera: era stata l’organizzatrice del traffico di droga fatto dalla sua famiglia e all’atto dell’arresto, e poi durante il processo e nei confronti del figlio pentito, si comportò da perfetta mafiosa[5]. Ad esempio, chiamò il figlio «vigliacco e infame» e in un’intervista disse:
«Salvatore io l’ho perdonato, ma non so se Dio potrà mai perdonarlo. … Dicono che fra un anno esce. Lui lo sa che è condannato, lo sa che esce e lo ammazzano. Quelli non perdonano. … Lui prima spera di avere il tempo di vendicare suo fratello Mario, morto ammazzato per causa sua. Ma che pensa di poter fare? Prima ci doveva pensare a Mario. Ora non gli daranno il tempo. Ora, Salvino, quando esce muore»[6].
E ancora, non riconoscendosi nel ruolo subalterno che le veniva attribuito: «Quindi secondo loro io me ne andavo su e giù per l’Italia a portare pacchi e pacchetti per conto d’altri. … Dunque io che in vita mia ho sempre comandato gli altri, avrei fatto questo servizio di trasporto per comando e conto d’altri? Cose che solo questi giudici che non capiscono niente di legge e di vita possono sostenere».
Contestualmente espose una sua precisa idea di mafia, fatta di «veri uomini», come suo padre, di leggi severe che colpivano inesorabilmente chi «sbagliava» e risparmiavano i «figli di mamma», mentre ora:
«E vanno a dire mafioso a questo, mafioso a quello. Ma che scherzano? Siamo arrivati a un punto che un pinco pallino qualsiasi che ruba subito è «mafioso». Io in quel processo di mafiosi proprio non ne ho visti. Ma che scherzano, è modo di parlare di cose serie? Ma dove è più questa mafia, chi parla di mafia, cosa sanno loro di mafia? Certo, sissignora, io ne so parlare perché c’era nei tempi antichi a Palermo e c’era la legge. E questa legge non faceva ammazzare i figli di mamma innocenti. La mafia non ammazzava uno se prima non era sicurissima del fatto, sicurissima che così si doveva fare, sicurissima della giusta legge. Certo, chi peccava «avia a chianciri», chi sbaglia la paga, ma prima c’era la regola dell’avvertimento… Allora in Palermo c’era questa legge e questa mafia. C’erano veri uomini. Mio padre, don Peppino, era un vero uomo e davanti a lui tremava di rispetto tutta Torrelunga e Brancaccio e fino a Bagheria…»[7].
Un esempio degli ultimi anni è quello invece di Maria Filippa Messina, giovane moglie di Nino Cinturino, boss di Calatabiano, paese in provincia di Catania, in carcere dal 1992. Il suo è un esempio di donna «supplente», in assenza del marito capomafia, ma una supplente che dimostra di potere assumere essa stessa il ruolo di capomafia. Arrestata il 4 febbraio 1995 nella sua abitazione a Calatabiano, appunto perché sospettata di essere alla guida della famiglia del paese dopo l’arresto del marito, venne accusata di avere assoldato killer per vendicare l’omicidio di un mafioso della cosca, ucciso assieme alla madre. In alcune conversazioni, intercettate dalla polizia, la Messina disse che era venuto il momento «di pulire il paese», per ottenere il controllo del territorio occupato dalla cosca rivale dei «Laudani».
Con lei furono arrestati altri sette mafiosi, tra cui autori di alcuni delitti commissionati dalla donna[8]. In carcere le venne notificato un altro ordine di custodia cautelare, assieme al marito e ad altri presunti mafiosi, per i delitti avvenuti durante una guerra di mafia tra la cosca catanese di Turi Cappello e il suo alleato Nino Cinturino e quella dei Laudani avvenuta tra il 1990 e il 1995. Tra gli arrestati altre due donne, Vincenza Barbagallo e Domenica Blancato, e tra le persone a cui il provvedimento fu notificato in carcere vi era un’altra donna, Sebastiana Trovato.
Con una lettera al quotidiano «La Sicilia», pubblicata il 19 dicembre 1996, la Messina si lamentò di essere stata sottoposta al carcere duro, cioè all’isolamento secondo l’articolo 41 bis, prima donna nella storia[9].
Tipologia delle donne di mafia Tra le donne di famiglie mafiose sono stati riscontrati una varietà di comportamenti derivanti dalla personalità delle donne, che non si discosta molto dalla tipologia riscontrabile in altre famiglie, anche se la specificità della provenienza mafiosa non può non esercitare un forte condizionamento, ma non fino al punto da tradursi in standard uniformi.
Le fedeli compagne religiose Così vi sono donne nate in famiglie mafiose e sposate a mafiosi che obbediscono allo stereotipo delle «fedeli compagne», discrete e premurose, come Rosaria Castellana, moglie di Michele Greco soprannominato «il papa”. Quando il marito, latitante, venne accusato della strage in cui perse la vita Rocco Chinnici, dichiarò che si trattava di una «assurda macchinazione»: «Il papa? Ho letto questo appellativo sui giornali… Lui è un uomo così tranquillo, sapeste! Adora me e suo figlio. Il tempo lo trascorreva tutto in campagna a curare i suoi agrumeti. E poi è così religioso»[10].
La famiglia Castellana era una famiglia di grossi proprietari terrieri della zona di Ciaculli. L’educazione della signora Rosaria era stata quella che si dava alle ragazze destinate a fare un «buon matrimonio»: studiò musica e le lingue straniere, scriveva poesie, si interessava d’arte. «La mia vita trascorre tra casa e chiesa», disse. Una donna religiosa, insomma, come il marito.
E religiose dichiarano di essere numerose altre donne di famiglie mafiose che coniugano cristianesimo e convivenza con l’assassinio. Per fare qualche esempio recente, Antonietta Brusca, che dopo l’arresto dei figli dichiarò di averli educati nel timore di Dio, rimarcando come la moglie di Greco la sua vita tutta casa e chiesa[11]. Cosa che non le impedì di essere l’intestataria dei conti bancari dove i suoi figli, educati cristianamente, depositavano il denaro acquisito con il traffico di droga ed altri traffici illeciti.
Religiosissima è Filippa Inzerillo, autrice di un appello rivolto alle donne di mafia pubblicato dal «Giornale di Sicilia« il 2 novembre 1996. Vedova di Salvatore, il capo di una delle più importanti famiglie mafiose ucciso nel maggio 1981, due settimane dopo l’omicidio di Stefano Bontate, all’inizio della seconda guerra di mafia che portò al dominio assoluto dei Corleonesi in Cosa Nostra. Della famiglia Inzerillo furono uccisi anche due fratelli di Salvatore, due zii, un cugino e il figlio di sedici anni, Giuseppe, che aveva dichiarato di volere vendicare la morte dei congiunti. La signora Inzerillo, che ora fa parte di un cenacolo di carismatici scrisse: “Donne di mafia, ribellatevi. Rompete le catene, tornate alla vita. Sangue chiama sangue, vendetta chiama vendetta. Basta con questa spirale senza fine. Lasciate che Palermo rifiorisca sotto una nuova luce, nel segno dell’amore di Dio. Lasciate che i vostri figli crescano secondo principi sani, capaci di esaltare quanto di bello c’è nel mondo“. La villa dove abitava la Inzerillo, nella borgata Passo di Rigano, divenne un luogo di preghiera. Ma malgrado la sua religiosità, la mentalità mafiosa fece capolino nella risposta alla domanda se avesse perdonato anche Totò Riina: «È solo un figlio (di Dio) che ha sbagliato. Ha lo spirito malato e dovrebbe pentirsi, non dico davanti ai magistrati, ma davanti al Signore, prima che sia troppo tardi». Come dire: l’unica giustizia è quella divina, quella umana non conta nulla. Uno dei principi fondamentali del codice mafioso.
Le «madrine» e le «supplenti» Altre donne invece ricoprono un ruolo attivo negli affari della propria famiglia, svolgendo compiti criminali in prima persona (ad esempio, il traffico e lo spaccio di droga) e che si possono definire «madrine» a pieno titolo, anche in presenza di uomini, o «supplenti» in seguito all’arresto o alla latitanza degli uomini.
Numerose sono le donne che si limitano a favorire le attività delittuose dei congiunti, risultando prestanome, proprietarie di quote o addirittura intestatarie di società e imprese per lo più usate per il riciclaggio del denaro sporco, proprietarie di immobili acquistati con denaro illecito, proprietarie di esercizi commerciali al posto dei mafiosi che non possono comparire.
Ci sono poi le donne appartenenti a famiglie storiche di Cosa Nostra, cioè nate e cresciute in quell’ambiente e, come le ragazze dell’aristocrazia e dell’alta borghesia i cui matrimoni avvenivano e continuano ad avvenire prevalentemente nel loro ambiente, sposate con mafiosi di rango, per le quali è ragionevole pensare che siano coscientemente partecipi delle attività dei congiunti; e ci sono poi le mogli di piccoli mafiosi, provenienti da ambienti non mafiosi e trovatisi a fare da prestanome probabilmente senza avere piena coscienza dell’origine del denaro impiegato.
Un esempio interessante è quello di Francesca Citarda, non tanto per il caso in sé, quanto per l’atteggiamento del collegio che doveva giudicarla, frutto di una mentalità retriva – questa sì, rigidamente maschilista – e di giudizi stereotipi sulle donne meridionali ancora non del tutto scomparsi negli ambienti giudiziari. La Citarda, moglie di Giovanni Bontate e figlia di Matteo Citarda, entrambi appartenenti a famiglie mafiose storiche, venne proposta per il soggiorno obbligato nel marzo 1983, in applicazione della disposizione della legge La Torre che estendeva ai familiari e ai prestanome dei mafiosi le indagini patrimoniali, finalizzate alla confisca dei beni di cui non venga provata la legittima provenienza. Con lo stesso provvedimento venne richiesto il soggiorno obbligato per altre donne di famiglie mafiose: Rosa Bontate, sorella di Giovanni e Stefano e moglie di Giacomo Vitale, coinvolto nel falso sequestro Sindona; Epifania Letizia Lo Presti e Francesca Battaglia, rispettivamente sorella e moglie di Francesco Lo Presti, mafioso di Bagheria; Anna Maria Di Bartolo, moglie del mafioso Domenico Federico; Anna Vitale, cognata di Gerlando Alberti, proprietaria di una villa a Trabia trasformata in una raffineria di eroina e latitante da quando il laboratorio era stato scoperto.
Queste donne sarebbero, secondo gli inquirenti, «organicamente collegate alla mafia ed inserite in quella fitta rete di legamenti col tessuto sociale e con l’apparato della cosa pubblica” rivelata dalle indagini patrimoniali[12].
Il matrimonio tra Francesca Citarda e Giovanni Bontate venne richiamato nel rapporto della questura come un evidente patto tra famiglie mafiose. Per il pubblico ministero che fa la richiesta di soggiorno obbligato per Giovanni Bontate e per la moglie, il patrimonio dei due sarebbe in larga parte di origine illecita, costituito con il denaro del traffico di droga e il successivo riciclaggio[13]. Il Tribunale di Palermo, presieduto dal giudice Michele Mezzatesta, accolse però la richiesta soltanto per Giovanni Bontate, sostenendo che troppo lontane per ideologia, mentalità e costumanza sono le cosiddette «donne di mafia” dalle «terroriste” che purtroppo hanno avuto un ruolo di attiva partecipazione alle bande armate che tuttora attentano alla sicurezza dello Stato e all’ordine democratico.
Donne e pentitismo Donne collaboratrici di giustizia Donne e ‘ndrangheta Per quanto concerne l’organizzazione «flessibilità e fragilità interna hanno avuto un peso nella partecipazione delle donne alle attività delle ‘ndrine»[14] L’esclusione formale delle donne si sostanzia nella proibizione di partecipare all’organizzazione mafiosa mediante rito di iniziazione. Questa norma ha trovato però delle eccezioni nella storia di questa organizzazione criminale. Sono emersi degli atti di alcuni processi risalenti ai primi del Novecento in cui compaiono casi di donne affiliate all’organizzazione. Emerge così una strutturazione formale del coinvolgimento femminile.
Le donne venivano ammesse all’organizzazione indossando i panni di un uomo. Si riscontra un’apposita carica formale per le donne, la cosiddetta “sorella d’omertà”. Questo titolo viene riconosciuto a donne legate in qualche modo a uomini d’onore, ma ciò avviene molto raramente, nonostante il loro ruolo criminale sia risultato negli anni maggiormente definito e incisivo a livello giudiziario.
Le donne non fanno giuramento di fedeltà all’organizzazione perché il loro primo dovere è quello di essere fedeli ai propri uomini. Nei casi in cui alle donne venga riconosciuto tale titolo, queste hanno il compito di dare assistenza ai latitanti, di far circolare le ‘mbasciate e di mantenere i contatti, attraverso i colloqui, tra i detenuti e l’organizzazione esterna.
Un’ulteriore ruolo che una donna poteva ricoprire era la “santista”, la carica più elevata che una donna può avere all’interno della ‘ndrangheta. Le regole della ‘ndrangheta calabrese non contemplano la possibilità di affiliare delle donne ma se una di loro viene riconosciuta particolarmente meritevole può essere associata con il titolo di sorella d’omertà. La partecipazione femminile emerge maggiormente nei periodi di conflitto. Vuoti di potere portano allo scoperto le donne nell’organizzazione. Durante i periodi di conflitto si scatenano vendette e le donne ricoprono il ruolo da protagoniste in questo ambito. Quando gli uomini sono assenti per i più disparati motivi, sia che siano latitanti o in prigione, le donne sono indispensabili per dare continuità alle attività criminali.
Un altro ruolo importantissimo che può ricoprire una donna è quello di farsi messaggera tra il carcere e l’esterno. Il ruolo delle donne all’interno dell’organizzazione è ambivalente. Da un lato cercano di proteggere in tutti i modi i loro figli e mariti temendo per la loro incolumità, dall’altro sono loro stesse ad incitarli a combattere e a compiere vendette. I ruoli tipicamente riconducibili alle donne sono quelli di custodia e occultamento delle armi, di vigilanza esterna, di acquisizione di informazioni e di trasmissione di messaggi. Possono sembrare attività apparentemente semplici, ma sono in realtà di grandissimo rilievo ai fini dell’organizzazione. Si può dire in altre termini che le donne all’interno dell’organizzazione «vivono tra assenza formale, da una parte, e inserimento di fatto, dall’altro: il loro potere si gioca attorno ad una soglia»[15]
Sono cruciali nel sistema della vendetta e risultano indispensabili in uno dei momenti simbolici più importanti per l’organizzazione, i matrimoni. La donna non risulta inserita nella dimensione inter-organizzativa, ma svolge funzioni essenziali nella dimensione famigliare dell’unità di base. Le donne risultano in grado di svolgere i ruoli criminali richiesti ai membri dell’organizzazione proprio perché sono appartenenti alla famiglia biologica. Per questo le donne non necessitano di ulteriori riti simbolici: sono considerate già per nascita fedeli e leali all’organizzazione. Per secoli pregiudizi culturali e biologi hanno tenuto le donne lontane dalla sfera pubblica, rilegandole nella sfera privata e domestica. Il divieto per le donne di prendere parte al rito di iniziazione risiede nel pregiudizio maschile che le donne debbano limitarsi a fare figli e a prendersi cura della casa. Per anni si è così erroneamente pensato che le donne fossero all’oscuro di ciò che le circondava nell’organizzazione mafiosa.
Il ruolo tradizionale della donna Le donne all’interno delle organizzazioni mafiose hanno da sempre esercitato compiti tradizionali nella sfera del privato. Questi compiti riguardano l’educazione dei figli e delle figlie, l’incitamento alla vendetta, la garanzia della reputazione maschile e i matrimoni combinati. Oltre a questi compiti tradizionali le donne svolgono anche dei ruoli importanti nell’ambito criminale, che si concretizzano sempre prevalentemente in funzioni di supporto e di sostituzione agli uomini.
Funzioni Attive Tra le funzioni attive esercitate dalle donne all’interno dell’organizzazione mafiosa vi sono la trasmissione del codice culturale mafioso e l’incitamento alla vendetta. La trasmissione del codice culturale mafioso risulta essere di vitale importanza e un onere imprescindibile che spetta all’universo femminile. Nella ‘Ndrangheta come in Cosa Nostra si ricorre all’allegoria della famiglia per definire ruoli esterni al proprio nucleo biologico. Alle donne non sposate che aiutano l’organizzazione mafiosa viene dato il titolo di “sorelle d’omertà”. La trasmissione del codice culturale mafioso è delegata soprattutto alla madre. La figura materna ha una funzione centrale nel processo educativo dei figli. A lei spetta il compito di inculcare nei figli determinati disvalori indicati da lei come “giusti” , in contrasto con i principi diffusi nella società civile. I principali disvalori riguardano l’omertà, la vendetta, il disprezzo dell’autorità pubblica e la differenza di genere. L’oneroso compito di formare nuove personalità mafiose spetta proprio alla donna. Alla prole si insegna l’agire criminale sotto forma di apprendimento durante la fase della socializzazione primaria. Il bambino acquisisce il modello culturale mafioso attraverso l’osservazione e la partecipazione per poi arrivare ad interiorizzarlo. Le donne rispettate in quanto madri e generatrici di figli sono educatrici loro stesse della mentalità maschile. Le madri devono insegnare alle figlie femmine un modello di subordinazione della donna all’autorità maschile. La distinzione di genere all’interno dell’organizzazione mafiosa ricopre un ruolo centrale. Proprio ponendo enfasi sul ruolo materno viene dato alle donne la possibilità di essere riconosciute in un contesto dominato dalla presenza e dall’autorità maschile. La centralità della famiglia, luogo di incontro degli affetti ma anche degli affari mafiosi, amplifica l’importanza delle figure femminili. «Un ruolo che risulta comunque sempre caratterizzato da ambiguità e confusione, avvolto quasi in una ragnatela inestricabile di sentimenti ed emozioni»[16] Si tratta di una partecipazione ambigua poiché la violenza esterna non lascia spazio all’espressione della soggettività femminile. La seconda funzione attiva che spetta alle donne all’interno delle organizzazioni mafiose è l’incitamento alla vendetta. All’interno della ‘ndrangheta si può parlare di una “pedagogia della vendetta”, termine utilizzato dalla sociologa Renate Siebert per indicare il continuo incitamento nei confronti dei figli a vendicare l’onore del padre ucciso. La vendetta è un principio chiaro insegnato all’interno dell’organizzazione. Le donne sono le custodi dell’onore offeso dei propri uomini. Al concetto di vendetta sono legati quello di onore e di vergogna. La vendetta viene intesa come elemento cardine di un ordinamento giuridico alternativo allo Stato. Ci sono elementi simbolici che caratterizzano la vendetta. La calendarizzazione della vendetta è uno di questi. Un’altra pratica diffusa è quella di indirizzare la ritorsione contro i parenti della persona da colpire, la cosiddetta vendetta trasversale. La donna gioca un ruolo di primo piano nella “memoria della vendetta”, ossia nel ricordare costantemente ai propri figli o mariti il compito di non lasciare impuniti gli assassini del proprio caro. La strategia delle donne è quella di far leva sul sentimento della vergogna che una mancata vendetta susciterebbe nei propri compagni e nelle rispettive famiglie di appartenenza. La volontà della donna di compiere vendetta viene perciò ascoltata anche se quest’ultima non fa parte dell’organizzazione.
Funzioni Passive Tra le funzioni passive esercitate dalle donne nell’organizzazione mafiosa vi è quella di garante della reputazione maschile e quello di essere una merce di scambio nelle politiche matrimoniali. La donna deve salvaguardare la reputazione maschile (che garantisce agli uomini di essere formalmente affiliati alla mafia) attraverso la sua rispettabilità e onorabilità. Alle donne era perciò richiesto un comportamento sessuale “corretto”, ossia la verginità prima delle nozze e successivamente la castità. Per evitare la perdita dell’onore gli uomini dovevano così esercitare uno stretto controllo sulle proprie donne, un controllo che permaneva attraverso gli occhi del clan qualora l’uomo fosse stato incarcerato. Se l’uomo si dimostra capace di mantenere un controllo totale sulla propria donna, agli occhi degli altri sarà capace di mantenere un controllo anche sul proprio territorio. Il pudore femminile rappresentava la via per mantenere intatto l’onore maschile. L’uomo in sostanza deve mantenere una buona reputazione. La rettitudine femminile garantisce la reputazione maschile. Il comportamento sessuale di una donna condiziona sia l’entrata di un uomo all’interno dell’organizzazione che la propria carriera. Per la donna vige il divieto assoluto di commettere adulterio. Divieto che per l’uomo non sussiste dato che privatamente può mantenere una doppia vita. Anche le vedove sono obbligate a rimanere fedeli ai mariti o fidanzati defunti, per evitare un eventuale disonore familiare. Un’altra grande funzione passiva legata al ruolo tradizionale della figura femminile è quella di essere merce di scambio nelle politiche matrimoniali. La donna risulta ancora essere succube del volere familiare. I matrimoni combinati con obiettivi strategici servono ad allargare le alleanza o per riappacificarsi dopo anni di faide. Combinare i matrimoni contribuisce così a ridurre la possibilità di faide tra i clan. Agli uomini è tacitamente concesso di mantenere due vite parallele, una con la propria famiglia e l’altra con la propria amante. L’importante è mantenere la facciata di rispetto della propria famiglia soprattutto pubblicamente. Alla donna è invece severamente vietato avere una doppia vita. Nei matrimoni combinati le donne hanno il compito di riappacificare due famiglie rivali. Difatti: «il sangue della sposa durante la prima notte di nozze, rappresentando la giusta restituzione del sangue versato nel corso della guerra, sancisce la fine della faida.»[17]
Il ruolo criminale della donna Il ruolo criminale delle donne emerge nel corso degli anni Settanta e Ottanta a seguito di due importanti processi di trasformazione: uno endogeno alle associazioni mafiose, legato tanto alla tipologia di affari illeciti quanto alla struttura interna; l’altro esogeno, legato alle trasformazioni avvenute nella società in riferimento alle condizioni della donna rispetto all’educazione, al mondo del lavoro e ai costumi sociali. «La parziale uscita dalla zona d’ombra dentro cui erano state relegate è la conferma delle capacità adattive del fenomeno criminale rispetto alle sfide economiche, giudiziarie e sociali messe a punto negli ultimi anni»[18] Un grande fattore di cambiamento è stato l’entrata delle organizzazioni criminali nel narcotraffico. Siamo di fronte ad una nuova generazione di donne più giovani e più istruite che si sono adeguate alla domanda mafiosa in nome dell’offerta. Vi sono tre settori chiave in cui le donne si inseriscono all’interno della criminalità: il traffico di droga, il settore economico finanziario e le attività di collegamento e di gestione del potere. Nel settore del narcotraffico le donne venivano arruolate come corrieri e spacciatrici. Trasportare la droga è un mestiere particolarmente adatto ad una donna perché si possono facilmente nascondere quantitativi di droga simulando gravidanze o arrotondando fianchi e seni. Le donne sono anche considerate più fidate e meno controllate dalla polizia. Alcune delle attività legate allo spaccio della droga venivano svolte in casa e perciò considerate adatte alle mansioni femminili. Il fattore dell’insospettabilità è preminente nell’assoldare figure di sesso femminile. Le donne coinvolte nel narcotraffico sono donne che provengono da contesti di marginalizzazione sociale, che hanno un elevato numero di figli da mantenere e che faticano ad arrivare a fine mese. Queste donne accettano di entrare in traffici illeciti sia per provvedere alla propria famiglia che per soddisfare il desiderio di raggiungere mete consumistiche proposte dalla società. Un esempio di questo tipo di donne sono quelle che negli anni Ottanta collaboravano con i Serraino-Di Giovine, attivi a Milano nel settore del narcotraffico internazionale, al fine di comprare il motorino ai figli adolescenti. Le donne vengono anche coinvolte nell’organizzazione di traffici di droga: è questo il caso di Angela Russo, detta “nonna eroina”, arrestata nel 1982 con l’accusa di essere l’organizzatrice dell’ingente narcotraffico. Un’altra figura di spicco è quella di Maria Serraino, che attraverso il consorzio ‘ndranghetista esercitava un controllo capillare e militare nell’area circostante Piazza Prealpi ( nella zona nordovest di Milano ). Entrambe le donne Angela a Maria hanno un cognome “rispettabile” e condividono il proprio potere affiancate da una figura maschile, il figlio.
Il settore in cui si riscontra il maggior numero di donne è il settore economico finanziario. Quest’ambito risulta particolarmente adatto alle donne perché non richiede l’utilizzo della violenza fisica. Le donne vengono utilizzate come la faccia pulita dell’organizzazione, servono come presta nome ma amministrano anche società ed investono denaro. Le donne iniziano ad entrare nel vivo dei traffici dell’organizzazione anche grazie alla loro preparazione e ai loro studi. Molto spesso risultano più affidabili e competenti della controparte maschile. «Nell’analisi della presenza femminile nel settore economico finanziario della criminalità organizzata va sottolineato che essa è stata esclusivamente strumentale alle associazioni mafiose»[19] Le donne non hanno ricavato particolari vantaggi dalle proprie prestazioni nel settore economico finanziario ne tanto meno hanno guadagnato un’indipendenza economica dagli uomini della propria famiglia.
Infine, le donne possono venire coinvolte anche più direttamente nella gestione del potere mafioso. Questo si verifica soprattutto quando la figura maschile è assente perché è in carcere o perché risulta essere latitante. Nelle vesti di messaggera le donne trasportano, per conto dei membri del clan, le cosiddette ambasciate ( messaggi scritti o orali ) dal carcere all’esterno, oppure da un luogo di latitanza all’altro. Le donne acquistano posizioni di comando nella struttura militare quando il proprio uomo è assente ( agli arresti oppure latitante ). Alle donne si da così una delegazione del potere temporaneo e vengono usate in posizioni di comando solo perché servono agli uomini.
La pseudo-emancipazione della donna Per quanto riguarda le donne all’interno delle associazioni criminali di stampo mafioso non si può parlare di un vero percorso di emancipazione femminile, perché in realtà si tratta di un percorso di pseudo-emancipazione. «Parlare, quindi, in modo affermativo di emancipazione femminile nel contesto mafioso, come accade ogni volta che una donna viene scoperta in attività criminali di stampo mafioso, toglie validità euristica al concetto stesso di emancipazione »[20] Infatti, il potere affidato alle donne è sempre di natura delegato e temporaneo. Il potere femminile nella mafia è sempre di natura delegata e temporanea: la delega temporanea del potere avviene in assenza dell’uomo, senza intaccare il sistema fondato sul patriarcato. Infatti, le donne continuano a subire violenze fisiche e psicologiche dagli uomini della propria famiglia, da cui dipendono anche economicamente: si sfrutta il processo di emancipazione femminile in corso nella società legale, ma si rimane ancorati alle vecchie tradizioni.Il paternalismo giudiziario Per molti anni le donne hanno potuto agire quasi indisturbate ed essere utilizzate in molti settori. «Si può dunque sostenere che la donna “mafiosa” abbia goduto per molti anni di una sorta di impunità connaturata»[21]. I mafiosi hanno continuato a sottolineare l’estraneità femminile dalla struttura criminale per motivazioni di carattere economico e strutturale. Per quanto riguarda le condanne spesso si sono ricondotte le azioni a carico di donne coinvolte in affari illeciti riguardanti le organizzazioni mafiose al reato di favoreggiamento (articolo 378 c.p.). «La non punibilità della donna è stata influenzata dalla sua condizione di genere»[22]. A partire dagli anni novanta si è iniziato a considerare le donne coinvolte in reati mafiosi individualmente, invece che giudicarle in base a categorie di genere. La legge Rognoni-La Torre ha aiutato a svelare l’implicazione delle donne nei reati economici finanziari. Le donne non venivano accusate del reato di associazione mafiosa perché venivano formalmente escluse dall’organizzazione. Questa prassi nel corso degli anni è venuta meno in sede processuale. Attraverso la raccolta di testimonianze femminili ci si è allontanati dalla valutazione stereotipa della condizione femminile all’interno dell’organizzazione criminale mafiosa per valorizzarne invece la sua soggettività. Negli anni novanta il numero di donne imputate e poi condannate per associazione di stampo mafioso aumenta. Erroneamente si considerava la partecipazione femminile come temporanea e accidentale senza considerare che poter portare avanti efficacemente determinati traffici illeciti è indispensabile essere inseriti nel gruppo criminale. Risultava essere non più un elemento essenziale l’acquisizione della prova di una normale affiliazione per essere accusate di associazione di stampo mafioso. Le donne rimangono comunque dei soggetti atipici all’interno dell’organizzazione mafiosa. «L’espressione soggetti atipici è utilizzata per sottolineare l’anomalia della partecipazione delle donne con un ruolo attivo negli affari criminosi del sodalizio»[23]. Negli anni duemila si è iniziato anche a far ricorso all’applicazione dell’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario (carcere duro) anche alle detenute. Una recente sentenza della Cassazione sembra fare chiarezza su come debba essere giudicato il ruolo della donna all’interno dell’organizzazione in sede processuale: «La partecipazione della donna nell’associazione mafiosa non può ricavarsi da un’asserita massima di esperienza tratta dal dato sociologico o di costume che assume un ruolo di passività e di strumentalità della stessa, ma va ricostruita attraverso l’esame delle concrete e peculiari connotazioni della vicenda che forma oggetto del »[24]
Donne e pentitismo Attraverso il pentitismo le donne possono abbandonare l’ambiente malavitoso e affidarsi alla giustizia pubblica. Nel pentitismo femminile si possono individuare due linee di tendenza comuni: «Una si colloca in continuità con il contesto di provenienza, mentre l’altra è il prodotto di un processo di rottura»[25] Le donne si affidano dunque alla giustizia pubblica per denunciare gli assassini dei propri cari o per desiderio di riaffermare la propria individualità rispetto all’organizzazione mafiosa. Vi sono diverse modalità di reazione delle donne anche per quanto riguarda la scelta di un proprio parente di collaborare con la giustizia: quella di rinnegare la scelta di chi collabora e di rimanere conformi al sistema mafioso o al contrario seguire la scelta del congiunto ed applicare una spaccatura con l’universo di appartenenza. Il ruolo delle donne risulta essenziale nel supportare in termini pratici e psicologici il collaboratore. Giovanni Falcone fu il primo ad aver riconosciuto quanto la figura della donna fosse determinante nel percorso di collaborazione. Spesso le collaboratrici di giustizia si affidano alle forze dell’ordine per vendicare gli assassini dei propri cari. Nella volontà di collaborare predomina in questo caso un modello vendicativo. Quando non è la vendetta a spronare le donne alla collaborazione si parla invece di un modello emancipativo. La donna allontanandosi dall’organizzazione «opera una svolta che innesca dei meccanismi di profondo cambiamento»[26] Alla donna che collabora si prospetta la possibilità di crearsi una nuova vita per se e per i propri figli. La donna si affida allo Stato per lasciarsi alle spalle anni di soprusi e di cultura mafiosa. WIKIMAFIA
Note
- ↑ Falcone, Cose di Cosa Nostra, p.80-81
- ↑ Siragusa-Seminara, 1996, p. 110
- ↑ Cascio – Puglisi (a cura di), 1986, p. 16
- ↑ «L’Ora», 17 dicembre 1990
- ↑ Cascio – Puglisi (a cura di), 1986, pp. 83 s., 86 s., 96 s.
- ↑ Pino, 1988, p. 89
- ↑ Pino, 1988, pp. 79 s.
- ↑ «Giornale di Sicilia», 5, 6 e 7 febbraio 1995
- ↑ «Giornale di Sicilia», 11 gennaio e 19 dicembre 1996
- ↑ Madeo, 1992, p. 76
- ↑ «La Repubblica», 24 maggio 1996
- ↑ Cascio – Puglisi (a cura di), 1986, pp. 32 s.
- ↑ Ivi, p. 35
- ↑ Ingrascì O., Donne, ‘ndrangheta, ‘ndrine. Gli spazi femminili nelle fonti giudiziarie. Donne di mafia. Rivista Meridiana, p. 39
- ↑ Ingrascì O., Donne, ‘ndrangheta, ‘ndrine. Gli spazi femminili nelle fonti giudiziarie. Donne di mafia. Rivista Meridiana, p. 52
- ↑ Alessandra Dino, Un mondo in frantumi, Inchiesta: donne e’ndrangheta, Rivista Narcomafie marzo 2012, p.47
- ↑ Ingrascì O., Donne d’onore, storie di mafia al femminile,Bruno Mondadori, 2007, p.43
- ↑ Dino A., Un mondo in frantumi, Inchiesta: donne e ‘ndrangheta, Rivista Narcomafie, marzo 2012, p.45
- ↑ Ingrascì O.Donne d’onore, storie di mafia al femminile, Bruno Mondadori, 2007, p. 71.
- ↑ Siebert R., Donne di mafia, Rivista Meridiana, p. 27
- ↑ Renate Siebert, Donne di mafia, Rivista Meridiana, p.96
- ↑ Siebert R., Donne di mafia, Rivista Meridiana, p.105
- ↑ Siebert R., Donne di mafia, Rivista Meridiana, p.116
- ↑ Corte di Cassazione, Prima sezione penale, Sentenza n. 10953, 26 maggio 1999
- ↑ Siebert R., Donne di mafia, Rivista Meridiana, p.133
- ↑ Siebert R., Donne di mafia, Rivista Meridiana, p.152
Le donne che raccontano le vittime della mafia, per non perdere la memoria
Le storie delle vittime della mafia sono tutte da ricordare. Un libro racconta anche quelle meno note di donne e persone comuni
«Meglio morta che separata.» Questa è la frase che accompagna la morte di Rosalia Pipitone, ventiquattro anni. L’ha pronunciata suo padre, boss mafioso dell’Acquasanta, a Palermo. Impossibile accettare la separazione della figlia dal marito. Venne uccisa, con la messinscena di una rapina, il 23 settembre 1983.Lia è una vittima di mafia come Teresa Buonocore uccisa nel 2010 da due sicari assoldati da un uomo, un pedofilo, fatto condannare da Teresa per i suoi abusi sulla figlia minorenne.
Fra le vittime della mafia, ci sono nomi entrati nella storia e nelle cronache, come quello di Paolo Borsellino, la cui figlia Fiammetta è fra i protagonisti del numero 47 di Vanity Fair in edicola fino al 24 novembre. La maggior parte delle storie raccontate in Morire di Mafia, La memoria non si cancella, pubblicato da Sperling & Kupfer e scritto dai giovani dell’Associazione Cosa Vostra, sono però ignote ai più.
Sono le storie di uomini, donne e bambini, oltre 200 in totale, vittime della mafia in tempi e luoghi diversi. Dal secondo dopoguerra a oggi, dalla magistratura al mondo del lavoro, dai comuni cittadini alle forze dell’ordine. A raccontarle è un gruppo di giovani dell’Associazione Cosa Vostra. Solo il condirettore di questo gruppo è un uomo, le altre sono ragazze, studentesse e giovani professioniste. Alessia Pacini è una di loro.
«Non ci sono per noi vittime di serie A e vittime di serie B. Raccogliendo le storie dei familiari delle vittime di cui abbiamo raccontato le vite, c’è una grande ricerca umana». Prima di essere vittime sono state persone con una vita spesso semplice. Il denominatore comune delle storie è il morire di mafia, ma anche la necessità di ricordare. Il magistrato Sebastiano Ardita ha detto che «le storie delle vittime di mafia fanno stare male, ma fanno germogliare la passione e inducono alla serietà e al sacrificio. Parlarne è una struggente necessità, per il bene nostro e di chi verrà».
«In tante storie», spiega Alessia Pacini, «è evidente il grande senso di responsabilità a partire dagli imprenditori che si sono opposti al pizzo e alle leggi della criminalità organizzata. Ci sono madri coraggio come Matilde Sorrentino che ha denunciato gli abusi in una scuola di Torre Annunziata».
La figura femminile in ambito mafioso è doppia. «Da una parte le donne d’onore che imparano dalle loro madri un codice di comportamento. Si arriva anche a delitti commessi ad hoc perché una relazione extraconiugale è una macchia. Dall’altra parte ci sono donne che si sono ribellate a questi codici e lottano soprattutto per garantire un futuro diverso ai figli».
È proprio Alessia ad aver scritto la storia di Lia Pipitone. La firma, con lei, il figlio della donna, Alessio Cordaro. Nonostante avesse solo quattro anni quando è morta la ricorda per piccole cose, su tutte il suo amore per il mare. È stato lui, insieme al giornalista Salvo Palazzolo a far riaprire il caso della madre. Grazie alle testimonianze, ci sono state, nel 2018, le condanne di mandante ed esecutore dell’omicidio.
Sono vite che si intrecciano quelle delle vittime di mafia. Gianmatteo Sole è stato rapito e ucciso il 22 marzo 1995 solo perché la sorella era fidanzata con il figlio di boss e la mafia pensava che lui avesse informazioni sul possibile piano per il rapimento dei figli di Totò Riina. È suo fratello Massimo a raccontare la sua storia. «Andando nelle scuole», spiega Alessia Pacini, «ha incontrato Graziella Domino, mamma di un bimbo ucciso a 11 anni. Quando sua madre e la signora Domino si sono incontrate è nato un sentimento di sorellanza. In quell’abbraccio c’era tutto l’amore delle mamme delle vittime di mafia». di Chiara Pizzimenti 22 novembre 2020 VANITY FAIR
STUDIO CRIMINOLOGICO SUL RUOLO DELLA DONNA NELLA MAFIA
1. Introduzione “Le donne di mafia non sono protagoniste della violenza in prima persona, generalmente non uccidono, eppure oggi tutti gli addetti ai lavori, magistrati,poliziotti,studiosi, concordano che il ruolo dalle molteplici sfaccettature sia di grande rilevanza” (Renate Siebert)
Gli studi dedicati al ruolo della donna nella mafia accompagnati da esempi di storie vere ci rivela come la condizione delle donne all’interno del sistema mafioso oscilli tra complicità, responsabilità e vittimizzazione intesa come subordinazione e sfruttamento. Il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali di stampo mafioso è ancora poco studiato e conosciuto ed è sempre stato piuttosto ambiguo. Infatti la donna anche se formalmente esclusa tuttavia partecipa sostanzialmente alla vita dell’ organizzazione in quanto la figura femminile è centrale nella funzionalità del sistema socio-culturale e criminale mafioso. Sebbene ufficialmente le donne continuino a non far parte dell’organizzazione, a non poter essere formalmente affiliate e a non partecipare ai riti di iniziazione, sono state sempre presenti nelle dinamiche di potere delle organizzazioni mafiose e in molti casi si sono sostituite agli uomini incarnando i medesimi disvalori.
Per anni l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori ovvero poliziotti, magistrati, studiosi si erano assestati sul vecchio stereotipo, proposto dagli stessi mafiosi, della donna silente, defilata, che aveva soltanto un ruolo passivo di madre e moglie e sostanzialmente all’oscuro degli affari e degli atti criminali perpetrati dai propri congiunti, padre, marito, figli. Infatti il binomio donna-crimine era difficilmente accettato in quanto violava le aspettative sociali: dunque la donna di mafia ha goduto per molto tempo di una sorta di impunità connaturata in quanto la donna era considerata per natura conforme alle regole e l’importanza che la società ha attribuito al ruolo di madre ha contribuito a rappresentare le donne come lontane da un comportamento criminale di tipo mafioso. Le donne hanno usufruito della insospettabilità ed invisibilità, per operare, semplicemente, approfittando di una società che non voleva ammettere che le donne fossero capaci di un comportamento criminale. Inoltre i primi studi sulla criminalità femminile, risalenti alla Scuola Positivista e in particolare all’opera di Cesare Lombroso (“La donna criminale”,1893), partendo dal presupposto che i comportamenti criminali poco si addicono al ruolo e alla condizione sociale della donna, convengono che la vera natura della donna, l’essere madre, sia antitetica rispetto al crimine e che il conservatorismo che la caratterizza la porti a essere più rispettosa della legge e meno congenitamente incline dell’uomo a commettere reati.
Tale immagine è andata pian piano dissolvendosi a partire dalla fine degli anni 80 quando nuovi studi sul fenomeno mafioso e le testimonianze dei collaboratori e soprattutto delle collaboratrici di giustizia hanno svelato una realtà nascosta facendo emergere ruoli femminili più attivi e pregnanti rispetto agli stereotipi dominanti e un’immagine della donna di mafia assai differente, articolata e fortemente contrastante con l’icona precedente. Infatti nel corso degli anni le donne hanno assunto ruoli sempre più importanti all’interno delle organizzazioni criminali, tanto che alcune hanno ricoperto addirittura ruoli di primo piano, sono divenute vere e proprie boss.
L’aumento della partecipazione delle donne, favorito dall’espansione del traffico di stupefacenti e dalle crescente esigenza di riciclare denaro sporco, e la constatazione che le attività di alcune cosche mafiose proseguivano nonostante la detenzione del capo, hanno fatto si che la donna perdesse la caratteristica di “deviante segreta” (Becker: deviante segreto è chi infrange le regole sociali ma non viene etichettato come deviante perchè non viene scoperto) e gli addetti ai lavori superassero i tradizionali luoghi comuni e prendessero coscienza di una realtà nascosta che ha avvantaggiato le associazioni mafiose dal momento che le donne hanno potuto agire quasi indisturbate e quindi essere proficuamente utilizzate in vari settori. Infatti tale invisibilità ha garantito alla mafia una sostanziale impunità per le attività delittuose commesse dalle donne, attività che, di norma sono state ritenute non socialmente pericolose e non rilevanti ai fini della configurazione della fattispecie associativa. Significativa è la sentenza del 1983 con la quale il Tribunale di Palermo, pur attestando l’autenticità del legame tra Cosa nostra e le famiglie degli imputati, prosciolse l’ imputata di sesso femminile (Francesca Citarda, moglie del boss Giovanni Bontate e figlia del boss Matteo Citarda), specificando che le donna non poteva essere colpevole perchè, in quanto moglie di un mafioso, non aveva raggiunto un livello di emancipazione sufficiente per essere in grado di commettere il reato per cui era stata sottoposta a giudizio cioè non poteva aver rivestito un ruolo attivo negli affari della mafia perchè carente delle elementari cognizioni tecnico-finanziarie e per la naturale estraneità al difficile mondo degli affari. Per i giudici di Palermo la donna di mafia ancora non aveva un ruolo decisionale di autodeterminazione nell’ambito del sistema mafioso e quindi non procedettero al sequestro dei beni del marito.
Solo nell’ultimo ventennio le donne hanno acquisito una indubbia visibilità, rivelando un universo fluido e diversificato. Infatti le donne che troviamo nel raggio di influenza della mafia sono estremamente diverse tra di loro e la loro partecipazione alle attività criminali varia a seconda della provenienza familiare, delle condizioni ambientali e dell’indole personale. In particolare l’universo femminile mafioso comprende:
A) donne nate e cresciute nelle famiglie mafiose: esse, mogli, figlie e sorelle dei boss, agiscono da trait d’union fra gli uomini latitanti o in carcere e i membri dell’organizzazione che possono muoversi alla luce del sole. Sono perfettamente a conoscenza degli atti violenti perpetrati dai loro uomini e svolgono un ruolo fondamentale che va dal sostegno psicologico e materiale alla temporanea delega del potere attraverso attività di prestanome, gestioni patrimoniali e finanziarie, estorsioni e mediazioni;
B) un esercito di donne che vivono ai margini della società, in codizioni economiche disagiate che vengono utilizzate dalla mafia soprattutto nel settore del narcotraffico. Infatti le donne coinvolte nel traffico di stupefacenti sono estranee alle logiche dei gruppi criminali per i quali lavorano e di fronte all’opportunità di racimolare qualche spicciolo accettano le “proposte lavorative” della criminalità organizzata.
All’interno delle organizzazioni mafiose le donne hanno, da sempre, sia esercitato compiti tradizionali nella sfera privata quali l’educazione dei figli e l’incitamento alla vendetta; sia svolto anche dei ruoli importanti nell’ambito criminale soprattutto in funzioni di supporto e di sostituzione agli uomini al fine di garantire il buon andamento dei principali traffici illeciti in cui la famiglia è inserita. In entrambi i casi le donne hanno contribuito a rafforzare la struttura socioculturale del sistema mafioso, garantendone la sopravvivenza nonostante le condanne penali a carico degli uomini. In pratica la donna riveste all’interno dell’ organizzazione mafiosa due ruoli fondamentali: il ruolo culturale e il ruolo criminale.
Dopo questa introduzione passerò, nei prossimi capitoli, ad esaminare l’effettivo ruolo che le donne ricoprono nella mafia e le varie teorie criminologiche ad esso riferibili, partendo dal loro ruolo tradizionale, ai loro compiti di gregarie, supplenti e vere e proprie sostitute del boss, fino al loro sfruttamento da parte dei maschi del clan.
2. Il ruolo culturale della donna nella mafia “Molte disgrazie, molte tragedie del Sud sono venute dalle donne, soprattutto quando diventano madri. Quanti delitti d’onore sono stati provocati, istigati o incoraggiati dalle donne! Dalle donne madri, dalle donne suocere.” (Leonardo Sciascia, La Sicilia come metafora)
Quello culturale è il ruolo tradizionale nel quale la donna è responsabile del processo educativo e della trasmissione della cultura e del codice mafioso. Le donne hanno rivestito e rivestono tuttora un ruolo fondamentale nella socializzazione dei figli all’odio e alla vendetta e nella trasmissione di un certo modo di porsi. Infatti soprattutto la madre ha un ruolo centrale nel processo educativo dei figli e nella creazione della cd”psiche mafiosa”: la madre è educatrice, a lei spetta il compito di inculcare cioè radicare in maniera irreversibile nei figli l’ideologia mafiosa ovvero le consuetudini e i disvalori di cui si nutre la criminalità mafiosa quali omertà, vendetta, disprezzo dell’ autorità pubblica, indicati come “giusti” in contrasto con i principi diffusi nella società civile. La mafia si configura come una vera e propria subcultura criminale cioè come sottogruppo avente un’ esistenza e un ruolo storico in seno alla società e dotato di un autonomo patrimonio culturale (valori, idee, concetti, miti), di un proprio linguaggio e di una propria legislazione interna appresi e condivisi dai suoi membri e antiteci rispetto ai valori della cultura dominante. Infatti la mafia è un’ organizzazione criminale con una propria ideologia culturale, un sistema di valori alternativo e prevalente rispetto a quello proposto dalla società civile.
La mafia non è soltanto un sistema criminale ma coinvolge anche la psicologia di chi vi è coinvolto e sin dall’infanzia il sentire mafioso ha origine nella famiglia la quale si configura come luogo privilegiato di formazione dell’identità e della coscienza, come ambiente privilegiato per la trasmissione dei valori su cui si basa l’agire mafioso. Ai figli si insegna l’agire criminale sotto forma di apprendimento durante la fase della socializzazione primaria cioè quella che si realizza all’interno del gruppo familiare. Il bambino apprende, assimila il modello culturale mafioso attraverso l’ osservazione e la partecipazione per poi arrivare ad interiorizzarlo, si identifica con chi si prende cura di lui all’inizio della sua vita e gli mostra un modello di valori e principi su cui costruirà i propri punti di riferimento. Si tratta di un tipo di apprendimento cultural-criminale che ricorda quanto sostenuto da Sutherland nella Teoria delle associazioni differenziali: l’agire criminale, al pari del comportamento sociale, si impara, si apprende e quindi l’individuo sviluppa una condotta conforme oppure deviante a seconda dei modelli sociali favorevoli o contrari alla legalità con i quali viene a contatto. Il luogo ideale per l’apprendimento è costituito da un’attività intima e privata quale è la famiglia o il gruppo amicale. Nel caso degli esponenti mafiosi il comportamento criminale è un comportamento appreso percepito come vero e proprio valore trasmesso all’interno della famiglia; il mestiere di criminale si impara in casa. Inoltre la madre ha il potere di influenzare le scelte del figlio, è un elemento cruciale affinchè il figlio assimili il modello paterno.
Un modello di donna che ha cresciuto i figli secondo i valori dell’ideologia mafiosa è quello di Ninetta Bagarella: donna di lignaggio mafioso è sorella di Leoluca Bagarella e moglie di Totò Riina (capo dei capi di Cosa Nostra fino ai primi anni 90) condivide la latitanza con il marito e nel mentre si occupa dell’educazione dei figli; le imputazioni per associazione di stampo mafioso a cui entrambi i figli sono stati sottoposti e l’ergastolo per omicidio cui è stato condannato il maggiore testimoniano il risultato di questo progetto educativo.
Inoltre la donna è titolare anche della cd “pedagogia della vendetta” (termine coniato da Renate Siebert) cioè di quel modello educativo incentrato sul mito del sangue e dell’onore con il quale sono cresciute dalle madri intere generazioni di mafiosi. Le donne hanno il compito di incitare continuamente i figli a vendicare l’onore del padre ucciso, a riparare il torto subito, non lasciando impuniti i suoi assassini. La vendetta, strettamente legata al concetto di onore, è un principio chiaro insegnato all’interno dell’organizzazione mafiosa e l’ invocazione femminile alla vendetta è accompagnata da un codice linguistico simbolico che si rifà al sangue: “sangue lava sangue”; “l’offesa va lavata con il sangue”. L’ideologia dell’onore può essere interpretata come una specie di “tecnica di neutralizzazione”del comportamento criminale (teoria di Sykes e Matza): le motivazioni onorifiche offrono all’affiliato una sorta di giustificazione morale alle proprie azioni efferate.
E’ proprio il complesso di valori della subcultura mafiosa di appartenenza, trasfusi in modo martellante sin dall’infanzia, che spiega come il giovane possa neutralizzare i valori della società civile, favorevoli alla giustizia e al rispetto delle leggi, attraverso il richiamo ad una lealtà più alta, quella della propria comunità e della propria famiglia mafiosa.
La funzione di incitamento alla vendetta va intesa non come parte di un ruolo fisiologicamente tipico della donna, ma come una funzione culturale tradizionalmente attribuitale nella divisione sessuale dei compiti all’interno di una determinata comunità: infatti studi della criminologia di stampo femminista (tra cui la criminologa Sonia Ambroset) hanno decostruito i preconcetti della criminologia classica in base ai quali la donna è stata storicamente considerata, per natura, più incline ad istigare il delitto piuttosto che a compierlo.
3. Il ruolo criminale della donna nella mafia “Quando la mafia è davvero nei guai chiama a raccolta le sue donne” (sostituto procuratore Antonio Laudati). Anche se formalmente escluse dall’onorata società, in quanto non affiliate, le donne hanno assunto nel corso del tempo, accanto al ruolo tradizionale ricoperto nella sfera privata, un ruolo criminale. Infatti negli anni è emerso e si è affermato sempre di più un ruolo significativo delle donne non solo come trasmettitrici della cultura mafiosa in seno alla famiglia ma anche nella gestione delle attività delle cosche. Negli ultimi anni sono sempre di più le donne coinvolte in affari illeciti e l’intervento femminile nella sfera criminale da sporadico è diventato più sistematico. Le donne nel corso degli ultimi decenni hanno assunto il ruolo di gregarie e supplenti dei boss e talvolta sono giunte ad incarnare il ruolo di vero e proprio leader. Inoltre i numerosi casi di cronaca hanno smentito le convinzioni circa il ruolo esclusivamente pedagogico della donna all’interno della criminalità organizzata e l’immagine della moglie, della madre e della sorella del mafioso che per anni ci è stata tramandata come quella di una donna silenziosa, che non sa ciò che accade intorno a lei. Il coinvolgimento femminile nella sfera criminale conferma le capacità della mafia di adattarsi alle sfide economiche, giudiziarie e sociali: infatti il ruolo criminale delle donne è stato influenzato sia dalle esigenze di adattamento ai nuovi mercati illeciti sia dalla reazione alle attività di contrasto delle autorità pubbliche, che hanno portato a dei mutamenti interni al sistema mafioso. Per capire i cambiamenti interni alla mafia è utile rifarsi alla distinzione tra power syndicate (esso indica la struttura famiglia, con le rigide affiliazioni) e enterprise syndicate (esso rappresenta la molto più mobile rete degli affari cioè la dimensione economico-finanziaria) proposta dal criminologo Alan Block. Tale distinzione tra power e enterprise syndicate è fondamentale per inquadrare la posizione della donna la quale può prendere parte alla dimensione economico-finanziaria ma non le è concesso essere ammessa al power syndicate. Tuttavia tale schema proposto da Block è riduttivo perchè consente di spiegare la condizione di coloro che non possono essere ufficialmente membri del sodalizio criminale ma vengono assoldati per il solo fatto di soddisfare le nuove esigenze dell’organizzazione, come accade proprio nel caso delle donne; al contrario non permette di analizzare quei casi prevalenti di donne che sono già presenti nella struttura culturale della mafia e che, nonostante la loro ordinaria esclusione, possono prendere parte al power syndicate nei momenti di crisi del consorzio criminale.
A partire dagli anni 70 l’allargamento delle attività criminali in termini qualitativi, quantitativi e geografici, in particolare l’espansione del traffico internazionale di stupefacenti e la crescente necessità di riciclare i profitti illeciti hanno costretto i consorzi mafiosi a incrementare il personale impiegando in tali affari anche soggetti non affiliabili, secondo il codice mafioso, all’ “onorata società”, tra cui proprio le donne. Tale coinvolgimento si è consolidato nei periodi più critici per i consorzi mafiosi conseguenti alle guerre tra clan o alla repressione statale. A seguito della detenzione e della latitanza di numerosi esponenti anche di spicco dell’organizzazione mafiosa, come risulta dai fatti di cronaca nonchè da numerose sentenze, la donna ha assunto la direzione della cosca forte anche del fatto che alcune di esse si sono inserite nel tessuto sociale, nelle professioni e quindi possono aiutare la mafia con le loro attività parallele. Infatti quando i mariti si trovano in carcere sono le mogli, spesso aiutate dai parenti, ad assumere il controllo degli affari di famiglia. Dunque la mancata affiliazione non ha precluso alle donne un’effettiva partecipazione alle attività dell’organizzazione.
In particolare oggi le donne di mafia sono parte attiva nello svolgimento della criminalità mafiosa, la loro partecipazione è reale ed effettiva e sono tre i settori chiave in cui esse si inseriscono: traffico di droga, settore economico-finanziario e attività di gestione del potere.
Traffico di droga: l’espansione dei traffici ha posto la necessità di trovare manodopera fidata. Nel settore del narcotraffico le donne vengono assoldate, agiscono, come corrieri e spacciatrici. Infatti trasportare la droga è un mestiere particolartmente adatto alle donne sia perchè possono nascondere facilmente le confezioni di stupefacenti simulando una gravidanza o arrotondando fianchi e seno sia perchè più sicure in quanto insospettabili (proprio l’insospettabilità è preminente nell’assoldare figure femminili) e meno controllate dalla polizia (è altamente improbabile che vengano sottoposte a perquisizioni in aeroporto). Le donne coinvolte nel narcotraffico sono estranee alle logiche dei gruppi criminali per i quali lavorano: infatti si tratta di donne del poplo, soprattutto casalinghe madri di famiglia incensurate che vivono ai margini della società, hanno un numero elevato di figli da mantenere e faticano ad arrivare a fine mese. Queste donne accettano di entrare in traffici illeciti sia per provvedere alla propria famiglia sia per soddisfare il desiderio di raggiungere le mete consumistiche proposte dalla società.
Emblematica è la storia di un gruppo di casalinghe residenti a Torretta (paesino vicino Palermo) che nei primi anni 80 venivano sfruttate dalla mafia per trasportare ingenti quantità di droga da Palermo a New York (con indosso panciere riempite di eroina e ben profumate per non essere individuate dai cani antidroga, si imbarcavano all’aeroporto di Punta Raisi per New York dove consegnavano la merce ad altri affiliati dell’organizzazione. Dopo alcuni giorni ritornavano a Palermo con i dollari appiccicati sul corpo con il nastro adesivo). Le storie di vita delle donne di Torretta mettono bene in luce le condizioni di elevata marginalizzazione che connotano le criminali donne le quali sono spesso indotte al reato da situazioni di degrado e di miseria. Infatti di fronte all’opportunità di racimolare qualche spicciolo (infatti svolgono compiti comunque poco remunerativi anche se altamente rischiosi) accettano le “proposte lavorative” della criminalità organizzata che approfitta proprio di persone che versano in difficili condizioni economiche. Tuttavia a suscitare le condotte illegali non sono solo le necessità economiche di base, ma anche la mancanza di mezzi sufficienti per raggiungere le mete consumistiche proposte dalla società. Dunque il loro agire va letto attraverso la combinazione di due teorie sociologiche della devianza: la teoria della marginalizzazione e la teoria dell’anomia di Merton. Il sociologo struttural-funzionalista Merton mutua il concetto di anomia da Durkheim ma attribuisce ad esso un diverso significato: infatti utilizza il concetto di anomia per spiegare l’origine del delitto, intentendo il delitto come risposta a una società che ha le caratteristiche anomiche cioè la sua cultura propone delle mete senza che vengano forniti a tutti i mezzi per conseguirle. Infatti guadagnare soldi trasportando droga permetteva loro di colmare il gap prodotto da un’esperienza sociale condizionata da una situazione di anomia nel senso inteso da Merton. Questo risulta evidente sia dal modo in cui spendevano il denaro illecitamente guadagnato: lo spendevano per comprare prodotti superflui e consumistici; sia anche dalle osservazioni di una delle donne coinvolte la quale per giustificare la propria condotta sostiene di avere avuto bisogno di quei soldi per pagare le bollette e al contempo ammette di averli usati anche per abbellire la propria abitazione, una casa popolare (“ho fatto quello che ho fatto per il grande bisogno. La casa quando ce l’hanno data era bruttissima: porte, finestre, bagno, cucina, tutto era scarso come in tutte le case popolari; io l’ho trasformata perchè ho sempre sognato una casa bella come quella dei signori”). Dunque il denaro illecito risolveva talune strette necessità e contemporaneamente alleviava parte delle proprie frustrazioni. Infatti in contesti caratterizzati da un elevato livello di anomia cioè in cui vi è una forte disgregazione socio-economica la mafia trova facilmente lavoratori da assoldare perchè gli individui che vivono in condizioni di disagio vedono il mondo criminale come un’alternativa alla miseria economica, un’alternativa che oltre a fornire loro delle prospettive di vita, risulta allettante e garantisce anche un certo status sociale a cui altrimenti essi non potrebbero arrivare.
Nel settore del narcotraffico le donne vengono coinvolte anche nell’ organizzazione di traffici di droga: è il caso di Angela Russo, detta “Nonna Eroina”, arrestata nel 1982 per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Non ha avuto solo un semplice ruolo di corriera della droga ma è stata proprio lei a reggere anche le fila dell’ingente narcotraffico fatto dalla sua famiglia: infatti era lei che coordinava l’attività dei figli e delle nuore coinvolti nel traffico di droga, smistava le ordinazioni e a volte trasportava lei stessa la droga non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti. Nonna Eroina, nata e cresciuta in una famiglia mafiosa, può considerarsi una donna boss anche perchè aderisce totalmente e con convinzione al mondo mafioso: infatti sia al momento dell’arresto sia poi durante il processo e nei confronti del figlio pentito si comporta da perfetta mafiosa, presenta gli atteggiamenti tipici dei boss, mostrandosi forte e determinata, negando con convinzione l’esistenza della mafia e disprezzando la legge statale; ripudiando pubblicamente uno dei figli (Salvatore) quando decide di collaborare con la giustizia chiamandolo “infame” e “vigliacco” anche davanti ai giudici.
Altri esempi di donne che si sono comportate come vere e proprie boss sono rappresentati da: Ninetta Bagarella, moglie di Totò Riina, la quale in un’intervista affermò “la mafia non esiste è tutto un’invenzione dei giornali per vendere più copie”; e Serafina Buscetta, sorella di Tommaso (Masino), la quale rinnegò il fratello per la sua scelta di collaborare con la giustizia affermando in un’intervista “Non dite ancora che è mio fratello. Mi ha rovinato la vita”.
Settore economico-finanziario: l’esigenza di riciclare sempre più denaro sporco ha generato un lavoro criminale non necessariamente violento e compatibile con i tratti relazionali e culturali femminili. E’ il settore in cui si riscontra il maggior coinvolgimento femminile perchè questo ambito è particolarmente adatto alle donne sia perchè non richiede l’utilizzo delle violenza fisica che in generale, e nella mafia in particolare, è associata al sesso maschile sia perchè le donne anche grazie alla loro preparazione e ai loro studi molto spesso risultano più competenti e affidabili degli uomini. In tale settore le donne vengono utilizzate come la faccia pulita dell’organizzazione: infatti sono numerose le donne che favoriscono le attività delittuose dei congiunti, risultando prestanome, proprietarie di quote o addirittura intestatarie di società e imprese per lo più usate per il riciclaggio del denaro sporco, proprietarie di immobili acquistati con denaro illecito, proprietarie di esercizi commerciali, al posto dei mafiosi che non possono comparire.
Un esempio di donna particolarmente attiva in tale settore è quello di Nunzia Graviano: detta la “picciridda”, la sorella dei boss (Giuseppe e Filippo Graviano) del mandamento di Brancaccio (condannati per l’omicidio di padre Pino Puglisi e ritenuti responsabili dell’omicidio dei giudici Falcone e Borsellino), è stata caratterizzata da un certo spessore criminale e ha svolto efficacemente il ruolo di supplente durante la carcerazione dei fratelli reggendo le fila dei loro affari. Si è occupata soprattutto del settore finanziario, reinvestendo le ingenti risorse economiche della cosca, perchè ha tutte le potenzialità per occuparsi di investimenti in quanto è una donna sveglia, intelligente e acculturata: infatti la Graviano conosce le lingue straniere, sa usare il computer e legge il “Sole 24 ore” per tenersi aggiornata sulla Borsa e scegliere al meglio le azioni su cui investire i proventi illeciti.
La partecipazione delle donne nella sfera economico-finanziaria rimane nascosta, garantendo l’occultamento delle origini illegali dei beni accumulati dalla mafia, fino alla seconda metà degli anni 80 cioè fino a che non viene applicata la legge Rognoni-La Torre (approvata nel 1982): essa consente di emettere ordinanze di sequestro nei confronti di proprietà registrate sotto nomi “puliti”, ma sospettati di nascondere patrimoni mafiosi. Tale legge dunque estende ai familiari e ai prestanome dei mafiosi le indagini patrimoniali finalizzate alla confisca dei beni di cui non venga provata la legittima provenienza. Un esempio interessante al riguardo è quello di Francesca Citarda, moglie del boss Giovanni Bontate e figlia del boss Matteo Citarda entrambi appartenenti a famiglie mafiose storiche, la quale viene proposta per il soggiorno obbligato insieme al marito nel 1983 in applicazione della legge Rognoni-La Torre perchè il patrimonio dei due coniugi sarebbe in larga parte di origine illecita, costruito con il riciclaggio del denaro ricavato dal traffico di droga. Tuttavia il Tribunale di Palermo, pur attestando l’autenticità del legame tra Cosa Nostra e le famiglie degli imputati, respinge la richiesta di soggiorno obbligato solo per la donna sostenendo che non poteva essere colpevole perchè, in quanto moglie di un mafioso, non aveva raggiunto un livello di emancipazione sufficiente per essere in grado di commettere il reato per cui era stata sottoposta a giudizio cioè la donna non poteva aver rivestito un ruolo attivo negli affari della mafia per la naturale estraneità al difficile mondo degli affari. Infatti per lungo tempo i giudici hanno ritenuto le donne di mafia estranee alle imprese e agli affari di famiglia e la concezione mafiosa della donna incompatibile con la possibilità che essa assuma un ruolo attivo, rilevante penalmente o anche solo ai fini dell’applicabilità di una misura di prevenzione. Questo è uno dei casi più rappresentativi di trattamento preferenziale dei giudici nei confronti del genere femminile.
Attività di gestione del potere:le donne possono ricoprire anche ruoli più direttamente correlati alla gestione del potere mafioso e questo accade soprattutto quando la figura maschile è assente perchè è in carcere o perchè latitante. Nelle vesti di messaggere le donne trasportano, per conto dei membri del clan, le cd “ambasciate” (messaggi),dal carcere all’esterno oppure da un luogo di latitanza all’altro, attraverso le quali gli uomini possono supervisionare l’esercizio del potere temporaneamente delegato ad altri affiliati o, in certi casi, alle donne stesse. Le donne acquistano posizioni di comando quando il proprio uomo è assente (in carcere o latitante) ed il loro potere è meramente delegato, sostitutivo e temporaneo: infatti il potere delle donne scaturisce dallo stato detentivo o di latitanza del congiunto e dall’appartenenza familiare e gli uomini finchè sono in carcere concedono il potere a sorelle, mogli, figlie che lo esercitano fino a quando qualche uomo della famiglia riesce ad uscire dal carcere e a riprendere in mano la direzione del clan. Le donne boss sono accomunate dal fatto di essere temute e rispettate dai membri dell’organizzazione mafiosa sia per il loro cognome sia per la loro forte personalità.
In particolare nei momenti di crisi dell’organizzazione, dovuti all’assenza o alla collaborazione degli uomini del clan e al potenziamento dell’azione repressiva da parte delle Autorità competenti, la presenza femminile soprattutto nei ruoli di comando semplicemente si intensifica; infatti le donne sono presenti nella scena criminale anche nei momenti “di tranquillità”. La delega temporanea del potere costituisce un’intensificazione della presenza femminile soprattutto nelle posizioni di comando e non un semplice neoinserimento perchè le donne che da un giorno all’altro si rivelano così adatte all’attività criminale vera e propria sono già inserite in modo latente nel contesto criminale mafioso. Infatti le donne appena sono chiamate a ricoprire cariche elevate cioè si pongono alla guida del clan dimostrano immediatamente notevoli capacità di gestione delle attività grazie al know-how mafioso precedentemente acquisito perchè non è possibile improvvisare l’amministrazione di attività criminali che esige conoscenze e competenze specifiche. Le donne mostrano di avere una profonda conoscenza degli assetti mafiosi senza la quale non sarebbero in grado di sostituire il congiunto assente. Si tratta di un sapere costruito in passato, utile nelle situazioni di emergenza, segno che le donne sono in qualche modo coinvolte nel power syndicate già prima di comparire sulla scena criminale cioè fanno parte del gruppo mafioso già prima di rimpiazzre i loro congiunti. Infatti quasi tutte le mogli, le figlie e le sorelle degli uomini d’onore sono nate e cresiute in famiglie mafiose, hanno respirato aria di mafia fin dalla nascita e perciò conoscono benissimo il modo di fare e di pensare di un mafioso. Emblematico è il caso di Giusy Vitale la quale faceva parte del gruppo mafioso già prima di rimpiazzare i fratelli alla guida del sodalizio: infatti si permette addirittura di esprimere la propria opinione riguardo la scelta del nuovo capo mandamento, dopo aver visionato uno dei pizzini che i fratelli erano soliti consegnarle per comunicare tra di loro.
Giusy Vitale: è la prima donna condannata per associazione mafiosa (1998). Nota come “boss in gonnella”, ultima di quattro fratelli, è stata cresciuta per diventare una vera mafiosa. E’ l’unica donna nella storia di Cosa Nostra ad aver preso decisioni normalmente appannaggio degli uomini e dei boss, è l’unica ad aver veramente comandato: infatti quando i fratelli finiscono in carcere si ritrova ad essere la loro erede, prende il loro posto diventando capo mandamento di Partinico, e in questo ruolo fa eseguire sentenze di morte, omicidi, partecipa ai traffici di droga, ricicla il denaro sporco, ordina taglieggiamenti a commercianti e imprenditori, partecipa ai vertici mafiosi, si procura armi e ha contatti con importanti esponenti della cosca, da Bernardo Provenzano, a Matteo Messina Denaro e Giovanni Brusca. Altro esempio significativo è Maria Filippa Messina: è la prima donna ad essere stata sottoposta al 41 bis cioè al cd carcere duro (nel 1996). E’ la moglie del boss Nino Cinturino e fu arrestata nel 1995 per aver sostituito completamente il capomafia assente dal 1992. La sua storia mette bene in luce la presa di potere come concessione scaturita dallo stato detentivo del marito e avente carattere delegato e sostitutivo: infatti quando il marito viene arrestato insieme a numerosi affiliati del suo clan si apre per Maria Filippa l’opportunità di dimostrare le proprie doti criminali, dapprima fungendo come anello di congiunzione tra il carcere e il mondo esterno, e successivamente sostituendosi al marito alla testa del consorzio criminale, una volta che questi fu sottoposto alla detenzione speciale. Infatti dal momento dell’arresto del marito diventa lei la guida del clan mostrando un particolare spessore criminale: è il vero polmone dell’organizzazione, tiene a raccolta gli uomini di maggior prestigio del clan e organizza con essi le sorti dell’ organizzazione criminale di cui è a capo. Non si limita a riscuotere tangenti per conto del marito in galera ma assume il comando militare della cosca e progetta massacri contro le bande rivali, incitando i membri del sodalizio a fare fuori i nemici. Infatti viene accusata di aver assoldato un killer per vendicare l’omicidio di un associato del clan e al momento dell’arresto era in procinto di ultimare l’organizzazione di una strage per eliminare esponenti del clan rivale e ristabilire il dominio della cosca dei Cinturino.
4. Vittimizzazione delle donne di mafia Le vittime della mafia non sono solo quelle persone che vengono uccise ma anche quelle donne, sia estranee sia interne alla famiglia mafiosa, che vengono sfruttate dalle associazioni mafiose per soddisfare gli interessi dell’organizzazione stessa e quelle donne nate e cresciute in famiglie mafiose che, nonostante arrivino a ricoprire ruoli di comando, continuano comunque ad essere sottoposte ai maschi della famiglia (padri, mariti, fratelli) anche per quanto riguarda la sfera prettamente privata, la loro vita personale.
Infatti la condizione della donna nella mafia presenta anche aspetti di vittimizzazione cioè A) di sfruttamento perchè sia il diretto coinvolgimento negli affari criminali (come corrieri della droga, spacciatrici) sia l’attribuzione del potere di comando (cioè la donna si pone alla guida del clan, si configura come lady boss) rispondono alla logica secondo cui l’uomo utilizza le donne nel mercato criminale quando gli servono perchè sono indispensabili alle attività illecite maschili in quanto l’adempimento dei loro incarichi è unicamente funzionale agli interessi dell’organizzazione. Le donne fanno il loro ingresso in momenti di espansione delle attività criminali (cioè quando il mercato criminale richiede manodopera: esempio l’aumento della partecipazione delle donne è favorito dall’espansione del traffico internazionale di stupefacenti) e nei periodi di emergenza cioè nei periodi di conflitto tra fazioni rivali e di potenziamento dell’azione repressiva da parte delle Autorità competenti: infatti in tali situazioni le donne divengono pedine utili per accrescere le attività criminali, nei momenti di espansione, o per sopravvivere in tempi difficili. Significative sono al riguardo le storie delle donne di Torretta e di alcune lady boss quali Nunzia Graviano e Maria Filippa Messina.
B) di subordinazione al potere di controllo degli uomini della famiglia anche sul piano delle scelte che riguardano la sfera personale. Per esempio persino una donna, apparentemente emancipata come Nunzia Graviano, trattata dai fratelli al pari di un membro della cosca, si ritova a dover rinunciare alla propria individualità per sottostare alle regole maschili della famiglia. La sua libertà personale è limitata dalla volontà dei fratelli che, non gradendo la storia d’amore di Nunzia (aveva intrapreso una relazione con un medico siriano),tra l’uomo amato e la famiglia d’origine, la costringono a scegliere quest’ultima.
5. Conclusioni In base a quanto espresso nelle pagine precedenti possiamo arrivare alla conclusione che: 1) anche nella mafia come in ogni famiglia e in ogni società la figura femminile riveste e rivestirà sempre un ruolo fondamentale e indispensabile perchè le donne costituiscono l’architrave su cui poggiano le organizzazioni mafiose: esse hanno la funzione di procreare, mettere al mondo i figli e di educarli e formarli come figli d’onore garantendo così il futuro dell’organizzazione; di intervenire nelle situazioni di difficoltà dell’organizzazione assicurando la prosecuzione del comando, del potere dell’uomo in carcere o latitante e garantendo così la sopravvivenza dell’organizzazione. Alla mafia la donna serve: serve, in primo luogo, anzi è indispensabile nell’essere madre, poiché in tale veste è la principale, se non l’unica responsabile, della trasmissione ai figli del codice disvaloriale mafioso concorrendo a formare perfetti futuri Riina o Provenzano e perfette future Palazzolo o Bagarella; serve perché tra detenuti, latitanti e pentiti la donna rimane la persona più affidabile cui impartire importanti compiti che si traducono nella commissione di svariati illeciti; ed ancora serve ed è necessaria se grazie ad una certa miopia del mondo giuridico e degli altri addetti ai lavori, che ha creduto alla sua marginalità, ha goduto di maggiori sconti di pena se non addirittura dell’impunità, garantendole, per più di 20 anni, un indisturbato sviluppo.
2) nonostante nel tempo il coinvolgimento femminile nella sfera criminale da sporadico sia diventato più sistematico e sia aumentato il numero di casi di supplenza e di donne capo è sbagliato pensare che le organizzazioni mafiose abbiano avviato una politica di pari opportunità per le donne perchè le storie delle donne di mafia rivelano che la condizione femminile nella mafia è mutata tanto quanto è rimasta intatta in quanto la mafia continua a conservare il suo carattere maschilista e a ricorrere alle donne per i suoi affari criminali solo in caso di necessità. Infatti il mondo mafioso continua ad essere caratterizzato nei confronti delle donne da: relazioni di genere di tipo patriarcale, dipendenza economica, controllo degli uomoni sulla loro vita, assunzione di lavori poco remunerativi e altamente rischiosi, concessione del potere meramente temporanea; tutti elementi che testimoniano sia come l’inclusione della donna si configuri quale sfruttamento femminile strumentale alle attività criminali dell’organizzazione stessa sia come la mafia non riconosca il valore della libertà femminile intesa come presa di coscienza della propria autonomia individuale.Infatti l’inserimento sempre più organico e stabile, non è emancipazione, ma una gentile “concessione” dell’Onorata Società rispondente solo all’egoistica necessità di preservare se stessa. La mafia ha consentito l’accesso alle attività criminali ad una nuova generazione di donne, più istruite e libere di muoversi rispetto al passato ma allo stesso tempo, però, ha negato loro la completa indipendenza fisica, psicologica ed emotiva. Le donne sembrano aver raggiunto un’eguaglianza sul piano criminale ma non nella sfera individuale dove appaiono ancora legate a vincoli tradizionali propri di un sistema di genere patriarcale. Non vi è mai una rottura della dipendenza psicologica ed economica dai propri mariti o compagni, se non nei casi di collaborazione con la giustizia. La mafia nega alla donna qualsiasi forma di parità e di libertà d’espressione della propria individualità. Sicuramente la loro condizione proprio perché caratterizzata in parte da elementi di subordinazione e dipendenza dall’uomo, è una condizione di inferiorità e quindi si può parlare di vittimismo.
3) il comune atteggiamento paternalistico e maschilista, che ha caratterizzato la società, gli addetti ai lavori e la “criminalità di genere”, ha celato il volto femminile della mafia permettendo alla stessa di operare in sordina.
Donne e mafia Compongono e subiscono la criminalità organizzata. La storia delle mafie è anche una storia di donne, una questione di genere. Le loro vite servono a capire la natura stesse delle mafie, i “sentimenti” che le muovono, la cultura di cui sono portatrici, il sistema di “valori” che le caratterizza, il modello sociale di riferimento in cui hanno potuto farsi strada. Le donne in maniera trasversale rappresentano un elemento di “normalizzazione” e nello stesso tempo di “eccezionalità” che caratterizza il fenomeno criminale. L’esempio più lampante è la vendetta. Il torto subito in un contesto che non le riguarda direttamente: la guerra tra cosche per il controllo del territorio, lo sgarro perpetuato tra boss o affiliati, affari economici irrisolvibili se non attraverso il sangue trovano l’apice della soddisfazione e del risarcimento colpendo donne e bambini. Cioè attraverso l’oggetto più importante del possesso. Colpisco la “cosa” che ti è più cara e simbolicamente, per questo motivo, quella che non andrebbe mai colpita. È lo sfregio più grosso da ricevere e anche il più infamante da commettere. Le donne servono per alimentare il silenzio, il silenzio che serve alle cosche per andare avanti nei propri affari. La cura del silenzio permette agli uomini di “lavorare”. Sono madri, mogli che subiscono o che, con complicità, agiscono e creano la cappa d’isolamento del territorio in cui vivono, operano e inviano ordini. Sono però anche quelle che quando rompono il silenzio mettono in crisi l’intero sistema. È una donna la prima testimone di giustizia della storia e sono sempre donne quelle che in Calabria stanno indebolendo la ‘ndrangheta: come Tita Boccafusca e Maria Concetta Cacciola, che hanno taciuto per sempre ingerendo acido muriatico. Dalla bocca sono uscite rivelazioni che non si dovevano fare e attraverso quella stessa bocca si lava via la tentazione di continuare, la disperazione di averci provato, il “disonore” di averlo fatto. Dall’unità d’Italia a oggi sono più di centocinquanta le storie di donne, messe assieme e di nuovo raccontate dal dossier “Sdisonorate/ Le mafie uccidono le donne” dell’associazione daSud. I Siciliani giovani 28 Febbraio 2012
DONNE CONTRO LA ‘NDRANGHETA, PARLA IL PROCURATORE DI REGGIO ALESSANDRA CERRETI “Non si parla mai delle donne legate alla ‘ndrangheta”: così Alessandra Cerreti, sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, ha aperto il suo intervento nella serata conclusiva degli incontri antimafia organizzati dal Collegio S. Caterina di Pavia, dal titolo “La forza espansiva della ‘ndrangheta”. Il procuratore ha ricordato Lea Garofalo e Giuseppina Pesce; è intervenuta poi anche la direttrice di Fimmina Tv.
“Non si parla mai delle donne legate alla ‘ndrangheta”: così Alessandra Cerreti, sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, ha aperto il suo intervento nella serata conclusiva degli incontri antimafia organizzati dal Collegio S. Caterina di Pavia, dal titolo “La forza espansiva della ‘ndrangheta”.“Quando sono arrivata alla DDA di Reggio Calabria – ha spiegato il procuratore – mi è stato detto che le donne all’interno delle cosche mafiose non contavano nulla. Ma io, fin da subito, ci credevo poco”. Infatti, ha raccontato la Cerreti, le intercettazioni utilizzate dalla procura nelle indagini hanno rilevato una componente femminile fondamentale nelle associazioni di ‘ndrangheta, e già nel 1882 due donne furono condannate perché affiliate, anzi “punciute”.
Donne di ndrangheta, e donne che si ribellano. Sempre di più– Le donne hanno avuto un ruolo fondamentale soprattutto nel portare messaggi dei familiari dal carcere al mondo esterno, ma soprattutto, purtroppo, nell’insegnare la cultura e i valori mafiosi ai loro figli. Ma negli ultimi anni le donne sono sempre più in prima linea contro la ‘ndrangheta, ribellandosi a questo meccanismo socio-culturale e criminale. A questo proposito, il procuratore ha ricordato naturalmente il sacrificio di Lea Garofalo, e ha espresso tutto il suo rimpianto per non aver protetto forse abbastanza la collaboratrice di giustizia che è stata raggiunta e uccisa a Milano dal marito – aguzzino. La Cerreti ha raccontato poi una storia positiva, quella di Giuseppina Pesce, giovane mamma calabrese che, grazie alla sua testimonianza, ha permesso l’arresto dei familiari e il sequestro di beni per 224 milioni di euro. E forse sta riuscendo, finalmente, a ritrovare la libertà.
Le fimmine ribelli– Dopo il procuratore di Reggio, è intervenuta nel dibattito Raffaella Rinaldis, direttrice dell’emittente calabrese Fimmina TV, che ha raccontato come le sue trasmissioni cerchino di mostrare un’alternativa di giustizia ai giovani calabresi facendo parlare sempre più le donne: un modo per ribaltare quel processo di trasmissione di cultura mafiosa in cui le stesse donne di ‘ndrangheta sono state protagoniste nel silenzio. Di questi temi si è occupato anche Trame. Festival dei libri sulle mafie, che si è svolto a Lamezia Terme nel giugno scorso con la collaborazione dell’Associazione Antiracket di Lamezia e dell’Associazione italiana editori. E, a proposito, di donne che si ribellano alla ‘ndrangheta, non possiamo non ricordare Anna Maria Scarfò, minacciata e isolata dalla sua comunità a San Martino di Taurianova per aver denunciato un branco di ragazzi del paese affiliati alle cosche che l’avevano violentata ripetutamente per tre anni, da quando ne aveva tredici. Poche settimane fa gli stupratori cono stati condannati in secondo grado per violenza sessuale di gruppo. Claudia Borgia 18/11/2013
LA PM CHE ASCOLTO’ GIUSEPPINA PESCE Prima di lei, nessuna donna di ‘ndrangheta aveva osato tradire e raccontare i segreti di famiglia a un magistrato. Ma Giuseppina Pesce, 33 anni da Rosarno, figlia di un boss e imputata per associazione mafiosa, ha guardato negli occhi i suoi figli e ha intravisto per loro un futuro diverso. A rischio della propria vita.
Di fronte a lei un’altra donna: Alessandra Cerreti, siciliana di Messina, pm della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Che ascolta Giuseppina e porta alla sbarra, nell’inchiesta All Inside, 76 capi e gregari della feroce cosca Pesce, di cui 11 già condannati in primo grado.
Cerreti seguiva anche il tragico caso di Maria Concetta Cacciola, la testimone di giustizia morta suicida il 20 agosto 2011. Con la magistrata, tentiamo un ritratto delle donne di ‘ndrangheta, una holding criminale dal fatturato annuo di 44 miliardi di euro.
Perché il pentimento di Giuseppina Pesce segna una rottura? Nella ‘ndrangheta, la famiglia mafiosa spesso coincide con quella di sangue, il che complica il percorso collaborativo e ha generato il falso mito dell’invincibilità della ‘ndrangheta. Le collaborazioni al femminile sono eccezionali sul piano sociale, prima che giudiziario: dimostrano che le donne possono ribellarsi alla cultura maschilista della mafia calabrese, intaccandone il prestigio criminale.
Anche il loro ruolo subalterno nella cosca è un falso mito? Certo. Quando gli uomini sono detenuti, le donne portano le “ambasciate” nei colloqui in carcere, garantendo la prosecuzione dell’attività criminale. Sono cassiere della cosca o intestatarie fittizie, e trasmettono ai figli il vincolo mafioso. Esiste persino la “ninna nanna du malandrineddu”, in cui la mamma canta al bimbo: cresci in fretta, vendica tuo padre…
Come può nascere il pentimento, in un sistema tanto chiuso? Per queste donne, la collaborazione con la giustizia è un atto d’amore verso i figli, per i quali desiderano un futuro di scelte libere: che i ragazzi non diventino soldati della cosca e che le ragazze non sposino un mafioso, com’è toccato a loro. Spesso si affacciano al mondo attraverso i social network: sebbene allevate secondo modelli obsoleti, per aprire i loro orizzonti basta un clic, e la ‘ndrangheta non può controllarlo. A volte intraprendono relazioni in rete e, per la prima volta a 30 anni, sono corteggiate non come le figlie del boss ma come donne qualunque. È comprensibile che esplodano emotivamente
Com’è la vita di una donna di mafia in Calabria? Le collaboratrici dicono che, di norma, a 13 anni si viene spinte al matrimonio per rinsaldare alleanze mafiose e a 14 si ha il primo figlio. In quella subcultura la donna è un patrimonio, strumento di alleanze. I bambini maneggiano coltelli già a 12 anni, e a 14 la pistola. Ma una donna mandava il figlio all’oratorio contro il volere del marito, dimostrando che una madre può recidere il laccio mafioso. Quel bimbo, oggi, vuole diventare carabiniere.
Perché Giuseppina Pesce s’è fidata proprio di Alessandra Cerreti? Un magistrato donna può abbattere la barriera del pudore, che in loro è forte. Una volta, con un collega, interrogai una donna reticente sulla sua relazione extraconiugale. Lei mi chiamò in disparte dicendo: “Mi vergogno perché c’è un giudice uomo. Se vuole lo dico a lei”.
Solo con l’omicidio Fortugno nel 2005 e la strage di Duisburg nel 2007 si sono accesi i riflettori sulla ‘ndrangheta. Come mai tanto ritardo? La Calabria ha subito un desolante silenzio informativo. Le testate nazionali non hanno una sede qui e gli eventi criminali, tranne quelli eclatanti, sono ridotti a beghe calabresi. Ma le recenti inchieste, prima fra tutte Crimine, condotta in coordinamento tra la nostra procura e quella di Milano, hanno dimostrato che la ‘ndrangheta non è un’accozzaglia di bande bensì una mafia tra le più potenti al mondo, con il cuore e il cervello in provincia di Reggio e ramificazioni ovunque. Ha una struttura unitaria, articolata nei tre mandamenti tirrenico, jonico e Reggio città, e coniuga riti tribali e modernità: un altro suo punto di forza. I figli dei boss oggi studiano all’università, sono professionisti. E se prima era il politico a chiedere voti al boss, oggi i boss cercano di far eleggere i propri uomini.
Lei ha iniziato la carriera a Milano, per poi venire a Reggio. Scelta o caso? Una scelta, un atto doveroso: volevo stare in prima linea nel mio Sud. Sono arrivata qui il 20 gennaio 2010, durante la stagione delle bombe alla procura di Reggio, ma anche nel pieno di un nuovo impulso investigativo: l’allora procuratore Giuseppe Pignatone e il procuratore aggiunto Michele Prestipino avevano compreso che, per sconfiggere una ‘ndrangheta che è una e forte, le forze dell’ordine e le procure devono fare squadra. I risultati sono evidenti: 2.297 arresti e oltre due miliardi di euro di beni sequestrati in soli 4 anni.
Quali i prossimi passi? Nel maxiprocesso a Cosa Nostra, i giudici Falcone e Borsellino ottennero una sentenza definitiva che dimostrava che la mafia esiste. In Calabria non abbiamo una sentenza analoga: in ogni processo dobbiamo dimostrare prima l’esistenza della ‘ndrangheta e poi l’appartenenza del singolo imputato. Un lavoro immane. Se la sentenza Crimine diverrà definitiva, il panorama giudiziario cambierà. E se pensa che la ‘ndrangheta è stata inserita tra le associazioni mafiose solo nel 2010, capirà quanto ancora ci sia da fare. Da Io donna, 13 ottobre 2012
Storie di donne e storie di mafie.
Lo scopo della mia tesi è stato analizzare il ruolo delle donne nei sistemi criminali quali Camorra, ‘Ndrangheta e Cosa nostra. La presenza femminile in questi settori è stata per molto tempo sottovalutata, in quanto è da sempre luogo comune considerare gli stessi come esclusivamente maschilisti, nonché patriarcali.
Il ruolo delle donne nelle varie organizzazioni è condizionato dalla storia di queste ultime e la loro entrata non più da partecipi, ma da protagoniste dei delitti di associazione mafiosa è collegata all’esistenza di un momento patologico dell’organizzazione criminale, il pentitismo attraverso il quale le mogli dei boss arrestati, latitanti o pentiti sono state coinvolte personalmente. Inoltre, l’applicazione dell’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario costituisce la prova provata di una realtà mafiosa femminile.
In Cosa nostra le donne partecipano al clan in maniera subordinata ai maschi, acconsentendo alla violenza esercitata su altri ed eventualmente su loro stesse, eppure troviamo sette donne accusate di attività mafiose nel processo della mafia delle Madonie nel 1927 e quattro nel maxi processo di Palermo del 1986.
La ‘Ndrangheta prevede una particolare sezione femminile, nonostante la proibizione per le donne di partecipare all’organizzazione mediante rito di iniziazione: si tratta della “Sorella di omertà”, una carica formale attribuita alle donne riconosciute particolarmente meritevoli. Pertanto, le donne di ‘ndrangheta partecipano alle attività mafiose senza essere formalmente affiliate.
Differente è il caso della Camorra, in cui la presenza femminile risale alle origini della stessa: fin dall’ottocento la donna ha svolto attività illegali come il controllo di attività clandestine e la vendita delle sigarette di contrabbando, giungendo sino alla gestione di interi settori criminali.
Bisogna mettere da parte come stereotipo la polarizzazione tra uomini aggressivi dediti alla violenza e alla guerra da una parte, e le donne pacifiche riproduttrici della vita dall’altra. Si può avanzare l’ipotesi che, le donne di mafia, proprio perché abituate alla violenza nelle relazioni tra gli affiliati e fra loro e il mondo che le circonda, rappresentino un forte capitale sociale per le organizzazioni criminali. Sono stati tanti i delitti d’onore provocati o incoraggiati dalle donne, in quanto la vendetta era l’arma a portata di mano e una loro tradizionale maniera per amministrare la giustizia.
In tale prospettiva, è fondamentale considerare il fenomeno del pentitismo femminile, ovvero quella tendenza comportamentale in base alla quale un membro di un clan criminale decide di rilasciare dichiarazioni alle autorità competenti tali da permettere alle medesime di prendere misure adeguate per combattere le stesse organizzazioni, ottenendo in cambio delle riduzioni di pena. Sono tante le donne che hanno contribuito a rendere decisiva la scelta dei loro familiari di collaborare e altrettanto numerose quelle che hanno preso le distanze dai loro parenti. Le stesse donne che, invece, hanno deciso in prima persona di collaborare lo hanno fatto essenzialmente per i figli o per amore.
E’ il caso di Giuseppina Pesce, appartenente al clan di Rosarno, in Calabria, la quale scelse definitivamente nel 2010 la via della collaborazione e del pentimento, allontanandosi dalla propria famiglia d’onore per consentire ai figli un futuro migliore e diverso dal proprio.
Giuseppa Vitale, prima donna cui la procura di Palermo contestò il reato per associazione mafiosa nel 1998, decise di collaborare nel 2005 per i figli e per amore nei confronti di un altro detenuto. La stessa, contrariamente alla Pesce, affermò pubblicamente di non pentirsi, poiché considerava il pentimento una condotta inutile e non produttiva nei confronti delle vittime a cui sia lei che il clan di appartenenza avevano inflitto duri colpi.
Più singolare è il caso di Cristina Pinto, la donna killer della Camorra, la quale ha scontato dal 1992 al 2004 ventidue anni di carcere a Pozzuoli, in provincia di Napoli, per reati quali associazione mafiosa, tentato omicidio, traffico illecito di armi e stupefacenti. La Pinto non si è mai pentita, ha chiesto pubblicamente scusa per i reati, come quello concernente il traffico illegale dei rifiuti, e ha altresì ammesso di dissociarsi dalla Camorra per proteggere la figlia che al suo arresto aveva due anni.
Le donne appartenenti alle cosche criminali italiane potrebbero dare un importante contributo alla società intensificando il percorso antimafia e sollecitando altri soggetti che non hanno volontà forte a tal punto da staccarsi in modo definitivo dal mondo malavitoso cui fanno parte. La mafia non è invincibile, ma assecondarne l’iter criminis e condividerne il modus operandi di Ludovica Luongo Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, relatore professore Isaia Sales.
Appunti sulla ricerca su ‘Donne e mafia’
Nell’ambito del Progetto di ricerca “Mafia e società” del Centro Impastato (sono già state svolte le ricerche sull’omicidio a Palermo, pubblicata nel volume: G. Chinnici – U. Santino, La violenza programmata ; sui processi per omicidio, pubblicata nel volume: AA.VV., Gabbie vuote ; sulle imprese mafiose, pubblicata nel volume: U. Santino – G. La Fiura , L’impresa mafiosa), è in corso una ricerca su “Donne e mafia”, di cui sono stati pubblicati il dossier di rassegna stampa Con e contro e i volumi: F. Bartolotta Impastato, La mafia in casa mia e A. Puglisi, Sole contro la mafia con storie di vita.
La ricerca su “Donne e mafia” mira ad analizzare il ruolo delle donne nell’organizzazione e nelle attività mafiose e nella lotta contro la mafia, ma prima ancora nella società siciliana e meridionale, e prevede l’esame della letteratura, la raccolta della documentazione (attraverso atti giudiziari e la rassegna stampa) e di storie di vita. Il quadro generale in cui si inserisce risulta dall’esame critico della letteratura e delle idee correnti sulla mafia e dalla formulazione di quello che abbiamo definito “paradigma della complessità” (si veda: Santino, 1995a).
La donna nella società siciliana e meridionale
Preliminare a una ricerca sul ruolo delle donne nella mafia e contro la mafia è una ricostruzione, anche sintetica e schematica, del ruolo della donna nella società siciliana e meridionale. Limitandoci a un cenno brevissimo, la letteratura esistente, da quella folklorica alla più recente, è in larga parte concorde nel definire il ruolo della donna nella società meridionale come subalterno e passivo, ritagliato esclusivamente nello spazio domestico e interpretabile soprattutto, se non esclusivamente, attraverso lo schema antropologico del codice onorifico. La realtà è più complessa, basti pensare al ruolo delle donne nelle lotte sociali in Sicilia, a cominciare dai Fasci siciliani.
Nell’economia della ricerca, sarà delineato un quadro della letteratura esistente e della condizione della donna, ricostruita attraverso dati sulla presenza nel mercato del lavoro, nelle professioni, l’esame del ruolo nei processi di socializzazione etc.
La mafia come fenomeno complesso
Nel tentativo di andare oltre gli stereotipi (mafia come emergenza, antistato etc.) che sono decisamente fuorvianti e dei paradigmi più affermati (mafia come associazione a delinquere tipica e come impresa) che a nostro avviso danno una rappresentazione parziale, abbiamo considerato la mafia come un fenomeno complesso e polimorfico, adottando la seguente ipotesi definitoria:
Mafia è un insieme di organizzazioni criminali, di cui la più importante ma non l’unica è Cosa nostra, che agiscono all’interno di un vasto e ramificato contesto relazionale, configurando un sistema di violenza e di illegalità finalizzato all’accumulazione del capitale e all’acquisizione e gestione di posizioni di potere, che si avvale di un codice culturale e gode di un certo consenso sociale.
Ci troviamo di fronte a un fenomeno che non può essere analizzato con la categoria criminologica della devianza, utilizzabile per la criminalità comune, ma in cui l’uso della violenza privata è funzionale alle dinamiche di formazione del dominio di classe: all’interno di un sistema relazionale interclassista la funzione dominante è esercitata da strati illegali-legali che abbiamo definito “borghesia mafiosa”: una chiave interpretativa che richiama e attualizza i “facinorosi della classe media” di cui parlava Franchetti.
Com’è noto, il dilemma mafia come organizzazione o modello comportamentale percorre tutta la letteratura antropologica e sociologica dall’ultimo trentennio del secolo XIX a oggi. Mentre fino a pochi anni fa l’idea dominante era quella della mafia come subcultura, comportamento, mentalità diffusa e si negava l’esistenza di una struttura organizzativa, confinandola tra le “idee errate”, dagli anni ’80, sull’onda delle acquisizioni in sede giudiziaria e delle rivelazioni dei cosiddetti “pentiti”, c’è stata una conversione alla tesi organizzativista, per cui oggi si parla di Cosa nostra, con la sua struttura unitaria, gerarchica, piramidale, come unico oggetto di studio. In tal modo si è finiti con l’accodarsi all’attività giudiziaria e i “pentiti” sono diventati la fonte privilegiata di conoscenza del fenomeno mafioso.
Ora, un conto è utilizzare le fonti giudiziarie un altro dipendere totalmente, o quasi, da esse. Il compito dello scienziato sociale è diverso da quello del magistrato e dell’investigatore. Dovrebbe essere scontato, ma a quanto pare non lo è, per cui è bene ribadirlo: il magistrato
deve ricercare elementi di prova tali da poter individuare e colpire i responsabili di comportamenti definiti delittuosi dalle leggi vigenti, mentre lo studioso ha un compito diverso, che si può riassumere nella ricerca delle specificità di un fenomeno e delle sue relazioni con il contesto, per cui fatti irrilevanti penalmente assumono una rilevanza che non possono avere nel quadro di un’inchiesta giudiziaria. Sono diversi gli scopi, gli strumenti, i metodi. È un’altra lingua e un altro sapere (Santino, 1995a, pp. 76 s.).
Continuità e innovazione
Anche per quanto riguarda l’evoluzione storica del fenomeno mafioso, ci sembra scorretta la rappresentazione che fa riferimento a una generica “vecchia mafia”, soppiantata da un’altrettanto generica “nuova mafia”, riproposta nella distinzione tra “mafia tradizionale” e “mafia imprenditrice”. In realtà l’evoluzione del fenomeno mafioso è un intreccio di continuità e innovazione e la sua persistenza si spiega con l’elasticità e la capacità di adattamento a diversi contesti spazio-temporali. Per cui aspetti arcaici, come la “signoria territoriale”, vengono rifunzionalizzati a opportunità e risorse della società contemporanea, come i traffici internazionali di droghe e di armi e i sistemi di riciclaggio.
L’intreccio di continuità e innovazione non toglie la possibilità di distinguere delle fasi nello sviluppo della mafia, sulla base dell’individuazione di un aspetto prevalente rispetto ad altri e con riferimento ai mutamenti del quadro sociale e agli adeguamenti ad essi da parte dei gruppi mafiosi. Abbiamo individuato quattro fasi: 1) una lunga fase di incubazione, dal XVI secolo ai primi decenni del XIX secolo, in cui più che di mafia vera e propria si può parlare di “fenomeni premafiosi” (attività delittuose regolarmente impunite di gruppi armati al servizio dei baroni; finalità accumulative di alcune forme delittuose, come i sequestri di persona, gli abigeati, le estorsioni); 2) una fase agraria, dalla formazione dello Stato unitario agli anni ’50 del XX secolo, con delle subfasi al suo interno; 3) una fase urbano-imprenditoriale, negli anni ’60; 4) una fase finanziaria, dagli anni ’70 a oggi.
Non possiamo dilungarci a illustrare tale ipotesi di periodizzazione. Ci limitiamo a dire che ci è sembrata, finora, la più rispondente al tipo di analisi che abbiamo condotto in questi anni, nel tentativo di cogliere l’interazione tra aspetti permanenti e innovativi, che ha consentito a un fenomeno sorto dentro un orizzonte locale abbastanza limitato – le quattro province della Sicilia occidentale – di estendersi territorialmente e di assumere la rilevanza attuale.
Monosessualità formale e bisessualità di fatto
Anche sotto il profilo di genere, il fenomeno mafioso lungi dal coincidere con le rappresentazioni basate sulla chiusura e rigidità, dimostra una grande capacità di adattamento. La mafia formalmente è un’organizzazione maschile, ma il maschilismo mafioso non è altro che il rispecchiamento del maschilismo del contesto sociale e, poiché la mafia non ha ideologia e le sue prassi sono caratterizzate da un grande opportunismo, non c’è da sorprendersi se essa vada adattandosi a un contesto in cui il ruolo delle donne è cresciuto, a prescindere da valutazioni di carattere etico su contenuti e modalità di esercizio dei ruoli.
Anche se i mafiosi collaboratori di giustizia continuano a sostenere che l’organizzazione mafiosa è monosessuale, che ammessi ai riti di affiliazione sono solo i maschi, le notizie sempre più numerose su compiti di comando assunti da donne in gruppi mafiosi, in seguito all’arresto dei capi, possono benissimo rispondere a verità, se si considera la natura elastica della mafia. La Chiesa cattolica avrà problemi ad ammettere al sacerdozio le donne, come le istituzioni pubbliche hanno avuto e continuano ad avere remore nel praticare le pari opportunità, mentre per la mafia non si pone il problema di attenersi a regole rigide, perché anche quando ci sono, o si dice che ci siano, è ben lontana dal rispettarle nei fatti e perché la sua storia è un continuo processo di mimesi e di adattamento.
Per dare un’idea del ruolo delle donne nel mondo mafioso riportiamo alcuni casi che ci sembrano particolarmente significativi.
Troviamo donne accusate di attività mafiose già nel processo alla mafia delle Madonie del 1927-1928. Tra i 153 imputati (mafiosi e loro fiancheggiatori) c’erano 7 donne, con imputazioni come l’assistenza ai latitanti, la riscossione dei pizzi e la custodia del denaro; mentre nel maxiprocesso di Palermo del 1986, su 460 imputati le donne erano solo 4: due incriminate per traffico di stupefacenti, una per favoreggiamento e un’altra per falsa testimonianza.
Tra le imputate del processo alla mafia delle Madonie c’erano quattro appartenenti alla famiglia mafiosa degli Andaloro e Giuseppa Salvo, definita dai giornali “la regina di Gangi” per il suo ruolo di spicco, che nel corso del processo mantenne un perfetto atteggiamento omertoso (Siragusa-Seminara, 1996, p. 110).
Nello stesso periodo comincia la sua carriera di ricercata dalla giustizia Maria Grazia Genova, detta “Maragè”, una donna di Delia, in provincia di Caltanissetta, nata nel 1909 e morta in ospedale, in miseria, il 15 dicembre 1990, dopo aver collezionato una cinquantina di denunce e ventidue arresti.
Sorella di Diego, “uomo di rispetto” del paese, già nel 1927 viene arrestata per furto. Nel 1949 riuscì ad evadere dal carcere dove doveva scontare una pena in seguito alle indagini sulla faida in cui era coinvolta la sua famiglia e che finì quando non ci fu più nessuno da ammazzare (Cascio – Puglisi (a cura di), 1986, p. 16). Si sospetta che quando qualcuno della sua famiglia aveva problemi con la giustizia ed era necessario pagare gli avvocati, lei si presentasse da professionisti e commercianti di Delia e chiedesse il “contributo” (“L’Ora”, 17 dicembre 1990).
Mandata al confino agli inizi degli anni sessanta, nel ’79, quasi ottantenne, venne proposta di nuovo per il soggiorno obbligato.
Più recente è l’attività di Angela Russo che viene arrestata, assieme ad altre 27 persone tra cui i figli e le nuore, il 13 febbraio del 1982, all’età di 74 anni, perché sospettata di essere stata corriera di droga tra Palermo, le Puglie e il Nord Italia. Ma subito si scopre che la Russo, che viene soprannominata “nonna eroina”, era più che corriera: lei era stata l’organizzatrice del traffico di droga fatto dalla sua famiglia e all’atto dell’arresto, e poi durante il processo e nei confronti del figlio pentito, si comporta da perfetta mafiosa (Cascio – Puglisi (a cura di), 1986, pp. 83 s., 86 s., 96 s.). Chiama il figlio “vigliacco e infame” e in un’intervista dice: “Salvatore io l’ho perdonato, ma non so se Dio potrà mai perdonarlo. … Dicono che fra un anno esce. Lui lo sa che è condannato, lo sa che esce e lo ammazzano. Quelli non perdonano. … Lui prima spera di avere il tempo di vendicare suo fratello Mario, morto ammazzato per causa sua. Ma che pensa di poter fare? Prima ci doveva pensare a Mario. Ora non gli daranno il tempo. Ora, Salvino, quando esce muore” (Pino, 1988, p. 89).
E ancora, non riconoscendosi nel ruolo subalterno che le viene attribuito: “Quindi secondo loro io me ne andavo su e giù per l’Italia a portare pacchi e pacchetti per conto d’altri. … Dunque io che in vita mia ho sempre comandato gli altri, avrei fatto questo servizio di trasporto per comando e conto d’altri? Cose che solo questi giudici che non capiscono niente di legge e di vita possono sostenere”.
Ed espone una sua precisa idea di mafia, fatta di “veri uomini”, come suo padre, di leggi severe che colpivano inesorabilmente chi “sbagliava” e risparmiavano i “figli di mamma”, mentre adesso…: “E vanno a dire mafioso a questo, mafioso a quello. Ma che scherzano? Siamo arrivati a un punto che un pinco pallino qualsiasi che ruba subito è “mafioso”. Io in quel processo di mafiosi proprio non ne ho visti. Ma che scherzano, è modo di parlare di cose serie? Ma dove è più questa mafia, chi parla di mafia, cosa sanno loro di mafia? Certo, sissignora, io ne so parlare perché c’era nei tempi antichi a Palermo e c’era la legge. E questa legge non faceva ammazzare i figli di mamma innocenti. La mafia non ammazzava uno se prima non era sicurissima del fatto, sicurissima che così si doveva fare, sicurissima della giusta legge. Certo, chi peccava “avia a chianciri”, chi sbaglia la paga, ma prima c’era la regola dell’avvertimento… Allora in Palermo c’era questa legge e questa mafia. C’erano veri uomini. Mio padre, don Peppino, era un vero uomo e davanti a lui tremava di rispetto tutta Torrelunga e Brancaccio e fino a Bagheria…” (Pino, 1988, pp. 79 s.).
Un esempio degli ultimi anni è quello di Maria Filippa Messina, giovane moglie di Nino Cinturino, boss di Calatabiano, paese in provincia di Catania, in carcere dal 1992. Il suo è un esempio di donna “supplente”, in assenza del marito capomafia, ma una supplente che dimostra di potere assumere essa stessa il ruolo di capomafia.
Viene arrestata il 4 febbraio 1995 nella sua abitazione a Calatabiano, appunto perché sospettata di essere alla guida della famiglia del paese dopo l’arresto del marito e viene accusata di avere assoldato killer per vendicare l’omicidio di un mafioso della cosca, ucciso assieme alla madre. In alcune conversazioni, intercettate dalla polizia, la Messina dice che era venuto il momento “di pulire il paese”, per ottenere il controllo del territorio occupato dalla cosca rivale dei “Laudani”.
Con lei sono state arrestate altri sette mafiosi, tra cui autori di alcuni delitti commissionati dalla donna (“Giornale di Sicilia” (da ora “GdS”), 5, 6 e 7 febbraio 1995).
In carcere le viene notificato un altro ordine di custodia cautelare, assieme al marito e ad altri presunti mafiosi, per i delitti avvenuti durante una guerra di mafia tra la cosca catanese di Turi Cappello e il suo alleato Nino Cinturino e quella dei Laudani avvenuta tra il 1990 e il 1995. Tra gli arrestati altre due donne, Vincenza Barbagallo e Domenica Blancato, e tra le persone a cui il provvedimento è stato notificato in carcere un’altra donna, Sebastiana Trovato.
Con una lettera al quotidiano “La Sicilia”, pubblicata il 19 dicembre 1996, la Messina lamenta di essere stata sottoposta al carcere duro, cioè all’isolamento secondo l’articolo 41 bis. Sarebbe la prima donna soggetta a questo trattamento (“GdS”, 11 gennaio e 19 dicembre 1996).
Tipologia delle donne di mafia: fedeli compagne, madrine, supplenti…
Nell’esame della documentazione raccolta, per tratteggiare una tipologia delle “donne di mafia” abbiamo tenuto conto di vari fattori, come: la provenienza familiare, i comportamenti quotidiani, le azioni delittuose accertate e perseguite, le cointeressenze economiche, le reazioni di fronte agli arresti o alla notizia della collaborazione con la giustizia dei congiunti.
Tra le donne di famiglie mafiose, abbiamo riscontrato una varietà di comportamenti derivante dalla personalità delle donne, che non si discosta molto dalla tipologia riscontrabile in altre famiglie, anche se la specificità della provenienza mafiosa non può non esercitare un forte condizionamento, ma non fino al punto da tradursi in standard uniformi.
Così abbiamo donne nate in famiglie mafiose e sposate a mafiosi che obbediscono allo stereotipo delle “fedeli compagne”, discrete e premurose, come Rosaria Castellana, moglie di Michele Greco soprannominato “il papa”. Quando il marito, latitante, viene accusato della strage Chinnici, dichiara che è tutta una “assurda macchinazione”: “Il papa? Ho letto questo appellativo sui giornali… Lui è un uomo così tranquillo, sapeste! Adora me e suo figlio. Il tempo lo trascorreva tutto in campagna a curare i suoi agrumeti. E poi è così religioso” (Madeo, 1992, p. 76).
La famiglia Castellana era una famiglia di grossi proprietari terrieri della zona di Ciaculli. L’educazione della signora Rosaria era stata quella che si dava alle ragazze destinate a fare un “buon matrimonio”. Ha studiato musica e lingue straniere. Scrive poesie. Si interessa d’arte. “La mia vita trascorre tra casa e chiesa”, dice. Una donna religiosa, come il marito.
E religiose dichiarano di essere numerose altre donne di famiglie mafiose che coniugano cristianesimo e convivenza con l’assassinio. Per fare qualche esempio recente, ricordiamo Antonietta Brusca, che dopo l’arresto dei figli dichiara di averli educati nel timor di Dio e che la sua vita è tutta casa e chiesa (“La Repubblica”, 24 maggio 1996). Cosa che non le impedisce di essere l’intestataria dei conti bancari dove i suoi figli, educati cristianamente, depositavano il denaro acquisito con il traffico di droga ed altri traffici illeciti.
Religiosissima è Filippa Inzerillo autrice di un appello rivolto alle donne di mafia pubblicato dal “Giornale di Sicilia” il 2 novembre del 1996.
La Inzerillo è vedova di Salvatore, il capo di una delle più importanti famiglie mafiose ucciso nel maggio del 1981, due settimane dopo l’omicidio di Stefano Bontate, all’inizio della guerra di mafia che causò centinaia di morti e portò al predominio dei cosiddetti “corleonesi”. Della famiglia Inzerillo furono uccisi anche due fratelli di Salvatore, due zii, un cugino e il figlio di sedici anni, Giuseppe, che aveva dichiarato di volere vendicare la morte dei congiunti.
La signora Inzerillo, che ora fa parte di un cenacolo di carismatici scrive: “Donne di mafia, ribellatevi. Rompete le catene, tornate alla vita. Sangue chiama sangue, vendetta chiama vendetta. Basta con questa spirale senza fine. Lasciate che Palermo rifiorisca sotto una nuova luce, nel segno dell’amore di Dio. Lasciate che i vostri figli crescano secondo principi sani, capaci di esaltare quanto di bello c’è nel mondo”.
La villa dove abita la Inzerillo, nella borgata Passo di Rigano, è diventata luogo di preghiera. Ma malgrado la sua religiosità, che non abbiamo nessuna ragione di pensare che non sia sincera, la mentalità mafiosa fa capolino nella risposta alla domanda se ha perdonato anche Totò Riina: “È solo un figlio (di Dio) che ha sbagliato. Ha lo spirito malato e dovrebbe pentirsi, non dico davanti ai magistrati (il corsivo è nostro), ma davanti al Signore, prima che sia troppo tardi”. Come dire: l’unica giustizia è quella divina, quella umana non conta nulla. Uno dei principi fondamentali del codice mafioso.
Altre donne invece hanno un ruolo attivo, evidenziato con prese di posizione, in quelle che potremmo chiamare le “relazioni pubbliche” della mafia: donne che svolgono compiti criminali in prima persona (per esempio il traffico e lo spaccio di droghe) e che si possono definire “madrine” a pieno titolo, anche in presenza di uomini, o “supplenti” in seguito all’arresto o alla latitanza degli uomini. Di queste abbiamo già dato qualche esempio, ma l’elenco è nutrito.
Numerose sono le donne che si limitano a favorire le attività delittuose dei congiunti, risultando prestanome, proprietarie di quote o addirittura intestatarie di società e imprese per lo più usate per il riciclaggio del denaro sporco, proprietarie di immobili acquistati con denaro illecito, proprietarie di esercizi commerciali al posto dei mafiosi che non possono comparire (Santino – La Fiura, 1990). Ci si trova di fronte a situazioni notevolmente diverse. Ci sono le donne appartenenti a famiglie storiche della mafia, cioè nate e cresciute in quell’ambiente e, come le ragazze dell’aristocrazia e dell’alta borghesia i cui matrimoni avvenivano e continuano ad avvenire prevalentemente nel loro ambiente, sposate con mafiosi di rango, per le quali è ragionevole pensare che siano coscientemente partecipi delle attività dei congiunti; e ci sono le mogli di piccoli mafiosi, provenienti da ambienti non mafiosi e trovatisi a fare da prestanome probabilmente senza avere piena coscienza dell’origine del denaro impiegato.
Un esempio interessante è quello di Francesca Citarda, non tanto per il caso in sé, quanto per l’atteggiamento del collegio che doveva giudicarla, frutto di una mentalità retriva – questa sì, rigidamente maschilista – e di giudizi stereotipi sulle donne meridionali ancora non del tutto scomparsi negli ambienti giudiziari.
Francesca Citarda, moglie di Giovanni Bontate e figlia di Matteo Citarda, entrambi appartenenti a famiglie mafiose storiche, viene proposta per il soggiorno obbligato nel marzo del 1983, in applicazione della disposizione della legge La Torre che estende ai familiari e ai prestanome dei mafiosi le indagini patrimoniali, finalizzate alla confisca dei beni di cui non venga provata la legittima provenienza. Con lo stesso provvedimento viene richiesto il soggiorno obbligato per altre donne di famiglie mafiose: Rosa Bontate, sorella di Giovanni e Stefano e moglie di Giacomo Vitale, coinvolto nel falso sequestro Sindona; Epifania Letizia Lo Presti e Francesca Battaglia, rispettivamente sorella e moglie di Francesco Lo Presti, mafioso di Bagheria; Anna Maria Di Bartolo, moglie del mafioso Domenico Federico; Anna Vitale, cognata di Gerlando Alberti, proprietaria di una villa a Trabia trasformata in una raffineria di eroina e latitante da quando il laboratorio era stato scoperto.
Queste donne sarebbero, secondo gli inquirenti, “organicamente collegate alla mafia ed inserite in quella fitta rete di legamenti col tessuto sociale e con l’apparato della cosa pubblica” rivelata dalle indagini patrimoniali (Cascio – Puglisi (a cura di), 1986, pp. 32 s.).
Il matrimonio tra Francesca Citarda e Giovanni Bontate viene richiamato nel rapporto della questura come un evidente patto tra famiglie mafiose. Non vi è dubbio che molti matrimoni tra appartenenti a famiglie mafiose sono fatti per consolidarne il potere, ma anche questo, come dicevamo, non è uno specifico della mafia: la storia è piena di matrimoni di convenienza fatti per ragioni di potere o per accumulare ricchezze, rare volte con il consenso, più spesso contro la volontà delle donne. Per il pubblico ministero che fa la richiesta di soggiorno obbligato per Giovanni Bontate e per la moglie, il patrimonio dei due sarebbe in larga parte di origine illecita, costituito con il denaro del traffico di droga e il successivo riciclaggio (ibidem, p. 35).
Il Tribunale di Palermo, presieduto dal giudice Michele Mezzatesta, accoglie la richiesta soltanto per Giovanni Bontate e respinge la richiesta di soggiorno obbligato e la confisca dei beni per Francesca Citarda, con una sentenza che provoca le proteste da parte delle associazioni femminili, come l’Associazione delle donne contro la mafia e l’UDI. Si legge nella sentenza (facciamo notare il confronto fatto con le terroriste, donne del Nord e quindi “emancipate” al contrario dalle donne meridionali):
… pur nel mutevole evolversi dei costumi sociali, non ritiene il Collegio di poter con tutta tranquillità affermare che la donna appartenente ad una famiglia di mafiosi abbia assunto ai giorni nostri una tale emancipazione ed autorevolezza da svincolarsi dal ruolo subalterno e passivo che in passato aveva sempre svolto nei riguardi del proprio “uomo”, sì da partecipare alla pari o comunque con una propria autonoma determinazione e scelta alle vicende che coinvolgono il “clan” familiare maschile.
Troppo lontane per ideologia, mentalità e costumanza sono le cosiddette “donne di mafia” dalle “terroriste” che purtroppo hanno avuto un ruolo di attiva partecipazione alle bande armate che tuttora attentano alla sicurezza dello Stato e all’ordine democratico (Tribunale di Palermo, 1983).
Con analoghe motivazioni sono state prosciolte le altre imputate. In tal modo le donne di famiglie mafiose, secondo questi magistrati, non sono soggetti di diritto penale, sono solo delle eterne minorenni che consumano la loro esistenza all’ombra degli uomini, unici soggetti capaci di autodeterminazione nel clan familiare e quindi pienamente responsabili delle loro azioni.
A nostro avviso l’unico modo per uscire dagli stereotipi correnti è analizzare, senza preconcetti, la realtà e prendere atto della sua multiformità, mentre normalmente accade il contrario: si parte da idee correnti fuorvianti o inadeguate e si cercano conferme nei fatti, gridando alla “novità” e alla “rottura” ogniqualvolta lo stereotipo risulta smentito dalla realtà. Un esempio recente: la lettera di Ninetta Bagarella, pubblicata su “La Repubblica” del 23 giugno 1996, che è parsa a più d’uno la rottura del tabù del silenzio e, sulla base dell’identificazione tra mafia e codice dell’omertà, intesa come silenzio impenetrabile, si è salutata la presa di posizione della Bagarella come un’infrazione dell’omertà e di per sé un atto al di fuori del codice comportamentale mafioso. Senza tenere conto che la Bagarella già più di 20 anni fa rilasciava interviste, faceva dichiarazioni e scriveva memoriali, ovviamente negando tutto, a cominciare dall’esistenza della mafia (nell’agosto del 1971 dice ai giornalisti che le chiedevano cos’è la mafia: “la mafia è un fenomeno creato dalla stampa per vendere più giornali”), protestava l’innocenza sua e dei suoi parenti, come continua a fare con la lettera recente, che non è una presa di distanza ma una vera e propria apologia della mafia, di sé, del marito, di quelle che chiama “le vere istituzioni”, che inequivocabilmente sono quelle mafiose (si veda: Puglisi, 1996).
Le donne e il pentitismo
Il comportamento delle donne di fronte ai congiunti pentiti ha dato luogo a letture del ruolo delle donne che in buona parte ricalcano l’immaginario consueto. Molte hanno accettato di condividere la vita blindata dei loro congiunti diventati collaboratori di giustizia, ma tante al contrario hanno preso le distanze, anche in modo eclatante, pubblicizzandolo attraverso l’uso dei media. Di fronte ad un tale atteggiamento molti hanno parlato di paura di ritorsioni ma soprattutto di donne-vittime, incapaci di sottrarsi a un destino già segnato.
Abbiamo ricostruito vari casi e ipotizzato una chiave di lettura complessa: c’è la paura ma c’è, o almeno ci può essere, una volontà di persistenza nel ruolo, di cui si conoscono opportunità e vantaggi, di fronte a un mondo che sembra crollare, travolgendo con sé opportunità e vantaggi. Ed è interessante notare come da molte espressioni si possa cogliere la netta prevalenza della famiglia mafiosa su quella naturale, nonostante tutto quello che si è scritto sul familismo meridionale e mediterraneo, quando la collaborazione con la giustizia spezza o mette in crisi quella coincidenza o quel collegamento (si veda: Puglisi – Santino, 1995). E in questa apologia della mafia-famiglia ritroviamo solidali vecchie donne di mafia, come la cosiddetta “Nonna eroina”, di cui abbiamo già parlato, e giovanissime, come le congiunte di Emanuele e Pasquale Di Filippo, i pentiti che hanno permesso l’arresto di Leoluca Bagarella.
La moglie di Pasquale Di Filippo, Giuseppina Spadaro, 29 anni, figlia del boss della Kalsa Tommaso, e quella di Emanuele, Angela Marino, 28 anni, appena sanno quanto è accaduto – la notizia è ancora riservata e i nomi dei due nuovi collaboratori non sono ancora apparsi sulla stampa – telefonano all’Ansa di Roma: “Sono venuti quelli della Dia, ci hanno offerto protezione, abbiamo rifiutato. Scrivetelo, fatelo sapere. Noi non abbiamo fatto nulla di male, siamo brave persone, non abbiamo niente di cui pentirci…”.
In una riunione di famiglia in casa sua, Giuseppina Spadaro dice ai giornalisti (ma più tardi deciderà di vivere con il marito in una località segreta): “Meglio morti, meglio se li avessero ammazzati. Invece sono due infami pentiti. Ai miei figli l’ho già detto: “Non avete più un padre, rinnegatelo, dimenticatevi di lui”. … Quando ho sentito bussare la polizia, ho pensato: “Ora mi dicono che mio marito è stato ucciso”. Invece no, invece è stato peggio. se lui fosse morto avrei avuto più onore. Meglio morto che pentito, non ho dubbi” (“GdS” 28 giugno 1995).
La moglie di Emanuele Di Filippo, Angela Marino, fa un quadro idilliaco della vita familiare prima del pentimento del marito: “La nostra era una vita normalissima. Vivevamo tranquilli e beati, gestivamo un distributore di benzina, non ci mancava niente, credetemi. Non capisco perché hanno fatto questa scelta, cosa li abbia spinti a dire quello che hanno detto. Quando non sapevo che “quello” si era pentito dicevo ai miei figli che il padre sarebbe tornato presto, ma adesso lo devono dimenticare, anzi, l’hanno già dimenticato. Per loro è morto, come se un padre non l’avessero mai avuto” (ibidem).
Agata Di Filippo, 27 anni, sorella dei pentiti e moglie di Nino Marchese, fratello del pentito Giuseppe e della moglie di Bagarella, Vincenzina, non è meno dura con i suoi fratelli: “Voglio che si sappia che io, mia madre e mio padre, ci dissociamo totalmente dalla decisione presa dai miei fratelli, anzi dai miei ex fratelli. Sono infami e tragediatori. Lo ripeto: infami e tragediatori. Capiteci, per la nostra famiglia è una tragedia” (ibidem).
Il pentimento dei due Di Filippo ha compromesso ancora di più un quadro già complicato per i corleonesi e i loro alleati. E le donne che hanno fatto da filo per la tessitura dei rapporti di parentela tra le varie famiglie mafiose, ora che è sopravvenuto un nuovo scossone, con l’arresto di Bagarella e il pentimento dei Di Filippo, si ergono con le loro parole e con i loro gesti a presidio di un mondo che rischia di sgretolarsi.
Come è noto, Vincenzina Marchese, moglie di Bagarella e sorella del pentito Giuseppe, si sarebbe suicidata travolta da una situazione diventata insostenibile per lei e per il marito che continua a far parte degli “irriducibili” di Cosa nostra.
In anni precedenti le donne della famiglia Buffa erano state protagoniste di una clamorosa manifestazione nell’aula bunker di Palermo in cui si svolgeva il primo maxiprocesso.
Caterina La Mantia, Maria, Rosa, Carmela, Silvana ed Elvira Buffa provengono da famiglia mafiosa e sono inserite in famiglie mafiose. Caterina La Mantia è figlia di Gaspare La Mantia e sorella di Matteo, imputati nel maxiprocesso, e moglie di Vincenzo Buffa, costruttore, anche lui imputato assieme al fratello Francesco. Maria Buffa è sorella di Vincenzo e Francesco e moglie di Stefano Pace, imputato sempre nel maxiprocesso. La sorella Rosa è moglie del capomafia latitante Carmelo Zanca; la sorella Carmela è moglie di Giovanni Lombardo, imputato anche lui. La sorella Aurora, moglie di Ignazio Pullarà, è dovuta rimanere a casa perché incinta ma ci tiene a far sapere di essere accanto a loro. A provocare la manifestazione delle donne della famiglia Buffa è la notizia del pentimento di Vincenzo Buffa, che ha fatto delle dichiarazioni al giudice istruttore Falcone, rivelando decine di nomi di mafiosi. In seguito alle voci sul suo pentimento Buffa viene trasferito dall’Ucciardone al carcere di Termini Imerese e non è nelle gabbie assieme agli altri imputati. L’avvocato Tommaso Farina chiede al presidente notizie del suo cliente e il presidente risponde che non ha niente da dire. A quel punto esplodono le donne: “Non è un pentito – urlano dalle tribune del pubblico -. Riportatelo nella sua cella all’Ucciardone. Nessuno lo ammazzerà, non gli torceranno un capello”.
Le donne vengono allontanate dall’aula. “C’è un commercio degli innocenti”, dichiarano ai giornalisti, “scrivetelo, noi ci rimettiamo alla giustizia divina perché a quella degli uomini non crediamo più” (“GdS”, 18 marzo 1987).
Una replica si ha nell’udienza del 28 aprile 1987. Vincenzo Buffa chiede al presidente di essere rimesso in gabbia con gli altri imputati e di tornare nel carcere dell’Ucciardone. È una marcia indietro e certamente nella sua decisione di interrompere la collaborazione un peso rilevante hanno avuto i familiari, in testa la moglie e le sorelle. Il Presidente Giordano dice che per il momento “le cose restano come stanno” e dalle tribune scatta un’altra volta la reazione della moglie Caterina La Mantia che viene ancora una volta espulsa dall’aula, dove però i familiari imputati tengono scena.
Di fronte alla fedeltà, o alla sudditanza, alla mafia può cedere anche l’amore della madre verso il figlio. L’abbiamo già visto nel caso di Angela Russo, che non molto velatamente minaccia di morte il figlio pentito. Lo ritroviamo in Giovanna Cannova, che per dissuadere la figlia Rita Atria ha fatto di tutto, arrivando anche lei a minacciarla di morte, dicendo che le avrebbe fatto fare la fine del fratello Nicola.
Dopo il suicidio di Rita, qualche giorno dopo la morte del giudice Borsellino, la Cannova non partecipa al funerale; poi il 2 novembre 1992, giorno dei morti, rompe a martellate la fotografia della figlia sulla tomba degli Aiello dove è stata seppellita; alla fine riesce a portare nella tomba della famiglia Atria il corpo della figlia.
A chi l’ha denunciata per aver profanato la tomba di Rita, frantumando il suo ritratto, Giovanna Cannova risponde: “Non è vero che ho profanato la tomba di mia figlia. Volevo solo far sparire dalla sua tomba quella fotografia. La figlia era mia e alla foto devo pensarci io e non quella lì”: si riferisce alla nuora Piera Aiello (“GdS”, 23 novembre 1992).
È la rivendicazione di un diritto di proprietà materna che la figlia, a suo dire per istigazione della nuora, i magistrati, la polizia, le donne delle associazioni antimafia che hanno portato a spalla la bara di Rita, hanno violato.
Altre madri non si sono limitate a minacciare ma sono arrivate a collaborare con i sicari. Nel caso di Luigina Maggi, madre del pentito Enrico Incognito, il sicario è l’altro figlio, Marcello, accompagnato dal padre. Enrico, che era agli arresti domiciliari e che sapeva di essere stato condannato a morte dalla mafia locale, aveva deciso di collaborare con la giustizia, in un modo originale. Aiutato da un amico, uno dei pochi di cui si fidava, aveva cominciato a raccontare davanti a una telecamera tutto quello che sapeva.
I suoi familiari ricevono un messaggio dagli uomini della mafia: “Pensateci voi a farlo tacere o saremo costretti a intervenire noi”. Pensano che la minaccia riguardi tutta la famiglia e decidono di ucciderlo. La famiglia in questo caso si sostituisce all’organizzazione mafiosa, s’identifica con essa e s’incarica di eseguire la condanna a morte.
La videocamera ha registrato la prima fase del delitto: il suono del campanello della porta; la madre, che era arrivata poco prima, che scoppia a piangere; Enrico che va alla porta; il fratello minore, Marcello, che esplode il primo colpo di pistola; poi il cameraman è fuggito. Dopo vengono esplosi altri due colpi. Presenzia al delitto, oltre alla madre e al vicino, il padre di Enrico, Salvatore.
Vengono accusati dell’omicidio il padre e il fratello di Incognito, mentre la madre, dapprima arrestata, viene scarcerata perché nel video appare piangente accanto al figlio che sta per essere ucciso. Il padre e il fratello si nascondono e in un primo tempo si pensa che siano stati uccisi mentre la madre, dopo la scarcerazione, ricompare in pubblico e torna in ospedale per il suo lavoro di infermiera (“GdS”, 27 marzo, 3 aprile 1994). Si potrebbe dire che nessuno più di lei è adatta per l’assistenza ai moribondi.
Secondo il racconto dei pentiti catanesi Gaetano Disca e Paolo Balsamo, Gaetana Conti, madre di Sebastiano Mazzeo, di 21 anni, un giovane malavitoso scomparso nel 1990, con un tranello avrebbe consegnato personalmente ai suoi sicari il figlio che si accingeva a collaborare con la giustizia.
Iano Mazzeo era chiamato baby killer perché già a 12 anni aveva sparato ad una persona, sostituendo il padre Francesco, paralitico. Il giovane, finito in carcere nel maggio del 1989, avrebbe deciso di collaborare per vendicare il padre, ucciso il 25 maggio 1987, e perché temeva di essere ucciso in carcere. Era a Roma, sotto sorveglianza, ma era scappato e tornato a Catania. La famiglia e la madre avevano deciso di consegnarlo ai suoi nemici per “poter continuare a vivere in mezzo alla gente del quartiere senza dover sostenere il marchio infamante di “parente di pentiti”” (“GdS”, 27 marzo 1994).
Donne collaboratrici di giustizia
Un altro fenomeno molto interessante da analizzare è quello delle donne collaboratrici di giustizia. Ormai la casistica è abbastanza nutrita e annosa, cominciando negli anni ’60 con personaggi come Serafina Battaglia e arrivando fino ai tantissimi casi del nostri giorni.
Soltanto alcune di loro si possono chiamare “pentite”, secondo l’accezione impropria usata per i mafiosi maschi, nel senso che la loro collaborazione riguarda anche le loro attività illecite. La maggior parte delle donne collaboratrici di giustizia sono vedove, orfane, madri a cui hanno ucciso i figli, che solo dopo un avvenimento traumatico come la morte violenta di un loro congiunto, passano dal lutto privato alla testimonianza pubblica; donne, quindi, per le quali il lutto è stato il passaggio necessario che le ha portate a ribellarsi, almeno parzialmente, alla mafia di cui prima avevano accettato regole, potere e ricchezza.
Ma ce ne sono alcune che hanno trovato il coraggio di rompere con i loro parenti mafiosi non necessariamente in conseguenza di un lutto o di un provvedimento giudiziario. E se qualcuna, sopraffatta dai condizionamenti dell’ambiente o dalla paura di ritorsioni ha ritrattato, come è capitato a Patrizia Beltrame, una ragazza diciannovenne di Poggioreale che aveva accusato i suoi fratelli e la madre di essere responsabili di traffico di armi e di un omicidio; altre sono andate fino in fondo, malgrado il trauma che una tale decisione comporta, come Antonella Cangemi che ha fatto arrestare il fratello colpevole di omicidio; Pasqua Burgio che ha accusato di assassinio il marito mafioso di Ravanusa; Concetta Zaccardo, anche lei moglie di un mafioso; Rosalba Triolo, donna di uno dei killer che uccisero Nicola Atria, che dichiara: “In tal modo sento di liberare la mia coscienza dal peso di tutti questi crimini di cui ero venuta a conoscenza per il mio rapporto con lui” (“GdS”, 3 febbraio 1993).
Le donne collaborano con motivazioni diverse (come vedremo, anche per vendicarsi) che non sempre si possono riportare a un calcolo opportunistico. Collaborando, molte donne non reagiscono a un pericolo, ma innescano pericoli e ne sono ben consapevoli, anche se le ritorsioni alla collaborazione degli uomini di mafia sono state certamente più sanguinose. E più d’una è stata capace di fare una scelta autonoma, non condizionata dall’evento delittuoso. Altre, pur non riuscendoci, almeno sono state tentate di farlo, o perché, provenienti da ambienti non mafiosi, sono entrate nel mondo mafioso soltanto per un legame affettivo ma non ne hanno accettato le regole, o comunque perché stanche di una vita permeata di violenza.
Le collaborazioni, qualunque sia l’intento, sono certamente la spia di una crisi dell’universo mafioso ma anche su questo punto bisogna essere molto cauti: possono essere un modo per ottenere l’impunità e un lasciapassare per la ripresa delle attività. Un’ulteriore dimostrazione dell’opportunismo mafioso, in omaggio al vecchio “calati juncu…”.
Come dicevamo, alcune delle collaboratrici hanno parlato anche o soltanto per spirito di vendetta.
Nel Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata per l’anno 1995, del Ministro dell’Interno, si dice: “Si evidenzia allora che proprio quei sentimenti ritenuti caratteristici della cultura mafiosa (odio, vendetta, desiderio di rivalsa e/o di sicurezza), se indirizzati in senso positivo, costituiscono in molti casi la motivazione del ricorso all’Autorità dello Stato, per offrire il proprio contributo ed ottenere giustizia, interrompendo e spezzando quei vincoli di ordine culturale e sociale, legati alla propria ed altrui incolumità personale, che sono risultati “ostativi” in precedenza” (Ministro dell’Interno, 1996, p. 293).
Se questo è vero, è anche vero che qualcuna prima di rivolgersi alla giustizia ha cercato la vendetta privata, e, non essendoci riuscita, ha cercato un altro modo per vendicarsi. Risulta chiaramente in almeno due casi: per Serafina Battaglia e, per sua stessa ammissione, per Giacoma Filippello.
Serafina Battaglia, per vent’anni convivente di Stefano Leale, un mafioso palermitano che venne ucciso il 9 aprile del ’60, si decise a collaborare con il giudice istruttore Cesare Terranova soltanto dopo l’assassinio del figlio, che lei aveva spinto a vendicare la morte del padre, senza riuscirci.
Giacoma Filippello dice, ricordando l’uccisione di L’Ala, avvenuta il 7 maggio del 1990: “Ed io aspettai che lo vendicassero. Ma non accadde nulla. Anzi uno di loro osò fermarmi per la strada. Voleva farmi le condoglianze, figurarsi… e nell’occasione mi fa: “‘Za Giacomina siete stata fortunata perché a voi vi hanno lasciata in vita”. Io persi la testa. Gli urlai: “La mia fortuna sarà la loro sfortuna. Diteglielo. Perché finché avrò un filo di vita e coraggio, io farò di tutto per spaccare il petto e per mangiare il cuore degli assassini di Natale”. Volevo vendetta. Chiesi soddisfazione a chi potevo” (Mazzocchi, 1993).
La vendetta da parte degli ex amici della cosca non arriva e Giacoma Filippello si decide a parlare con il giudice Paolo Borsellino. Lei ha più volte ribadito di non considerarsi “pentita”, ma una donna che tenta di vendicare con i propri mezzi l’uccisione del “compagno della sua vita”.
Abbiamo amato e amiamo Rita Atria. Ci siamo commossi per il suo suicidio, ma anche per il fatto che una ragazza giovane come lei – quando si è uccisa aveva solo 18 anni – fosse stata costretta ad una vita di solitudine, lontana dai luoghi dove era cresciuta, dove erano i suoi amici, lontanissima dalla madre che l’aveva ripudiata. Eppure anche Rita, che ha cominciato a collaborare, seguendo l’esempio della cognata, dopo l’uccisione del fratello che era molto legato a lei, sembra che sia stata spinta in qualche modo dal desiderio di vendicare così i suoi cari, come dice Alessandra Camassa, che come sostituto procuratore a Marsala ha raccolto le sue testimonianze: “Ciò che spinge Rita Atria a diventare una collaboratrice della giustizia è il desiderio di trovare un’altra strada rispetto a quella del fratello Nicola. La stessa rabbia cieca che, dopo l’uccisione di Vito Atria, aveva spinto il figlio maschio ad infiltrarsi tra le cosche per farsi giustizia da solo, vendicando l’assassinio del padre e riabilitando l’onore della famiglia” (Rizza, 1993, p. 76).
Alcune collaboratrici si possono considerare vere e proprie “pentite”, non nel senso etico, anche se in alcuni casi c’è stato un vero pentimento, ma perché sono donne che hanno partecipato in qualche misura alle attività della mafia e, dopo l’arresto, o perché hanno temuto per la propria vita, hanno deciso di parlare.
Esempi molto interessanti sono quelli di Tiziana Augello, una ragazza della borghesia di Caltanissetta arrivata a far parte della cosca di Leonardo Messina, o quello di Daniela Scalzo, appartenente ad una banda del Nisseno e implicata anche nel tentato omicidio del marito che aveva lasciato per mettersi con un appartenente alla banda avversaria.
Uno dei luoghi comuni sulla mafia, quello secondo cui i mafiosi non si confiderebbero con le loro donne perché queste sarebbero incapaci di tacere, è contraddetto dalle dichiarazioni di tutte le collaboratrici che dimostrano, e qualcuna l’ha detto espressamente, che le donne di mafia sanno tutto e spesso condividono tutto.
Da Serafina Battaglia che afferma: “Mio marito era un mafioso e nel suo negozio si radunavano spesso i mafiosi di Alcamo e di Baucina. Parlavano, discutevano e io perciò li conoscevo uno ad uno. So quello che valgono, quanto pesano, che cosa hanno fatto. Mio marito poi mi confidava tutto e perciò io so tutto. Se le donne dei morti ammazzati si decidessero a parlare così come faccio io, non per odio o per vendetta ma per sete di giustizia, la mafia in Sicilia non esisterebbe più da un pezzo” (De Mauro, 1964).
A Giacoma Filippello che dice: “Lo Stato neanche se l’immagina quante cose conosce una donna di mafia. Certo ognuna ha la sua storia. E la mia è quella di una che ha cominciato a capire prima di saltare il fosso” (Mazzocchi, 1993).
A Piera Aiello: “Le mogli… sentono tutto, si fanno carico di tutto. Io ero una spugna. Se ai mariti mafiosi gli fai le domande non ti rispondono, ma se te ne stai buona e zitta quelli… si confidano, perché così si sentono importanti” (Zanuttini, 1994).
Ed è interessante esaminare il ventaglio di giudizi espressi dalle collaboratrici sui mafiosi.
Se Margherita Petralia afferma: “Sono tutti delinquenti, assassini feroci” (“GdS”, 31 ottobre 1989); se Serafina Battaglia, quando decide di rivolgersi alla giustizia dice, baciando il crocifisso: “I mafiosi sono pupi, fanno gli spavaldi solo con chi ha paura di loro, ma se si ha il coraggio di attaccarli e demolirli diventano vigliacchi. Non sono uomini d’onore ma pezze da piedi” (Ministro dell’Interno, 1996, p. 293); e la signora Impastato di Badalamenti dice: “Era un vaccaro che non sapeva neanche pulirsi il naso. Poi si mise con mio cognato Cesare Manzella e lo portò avanti, ma rimase sempre caporale. Quando Manzella morì, Badalamenti si fece i soldi, e siccome si fece i soldi gli avvocati li ha a portata di mano, perché lui non sa neanche parlare” (Bartolotta Impastato, 1986, p. 36); se Tiziana Augello, parlando di Leonardo Messina, dice che era: “abbastanza arrogante e presuntuoso. Si sentiva più grande di quello che era. Poi su di lui sono state dette tante cretinate. Sul suo pentimento, per esempio. Messina non si è pentito vedendo in televisione la vedova Schifani piangere, non è un santo. Lui si è pentito perché qualcuno lo ha convinto a pentirsi, perché ormai era incastrato” (Transirico, 1994, p. 49); altre, almeno per i mafiosi loro congiunti, hanno giudizi non completamente negativi.
A cominciare da Rita Atria, che ci tiene a descrivere il padre come una persona “rispettata”, un mafioso di “vecchio stampo”, che, secondo lo stereotipo del “padrino”, si era opposto al traffico di droga: “Mio padre a Partanna ricopriva un ruolo di “paciere” e a lui si rivolgevano persone di ogni tipo per la risoluzione di problemi, …senza ricavarne vantaggi economici ma soprattutto per questione di prestigio negli ambienti che contano a Partanna, e aveva conoscenze importanti anche a Menfi, Sambuca…” (“GdS”, 23 marzo 1992). E alcuni mesi prima del suo suicidio aveva scritto nel suo diario, descrivendo come avrebbe voluto il suo funerale: “Sarei felice se potessi vivere insieme a Nicola e mio padre – è toccante l’uso del verbo vivere nel momento in cui sta parlando invece di morte -. Spero che Vita Maria un giorno impari ad amare suo padre anche se non lo ricorderà tantissimo. Mi manca tanto il mio Nicola” (Rizza, 1993, p. 128). Sentimenti e giudizi condivisi dalla cognata.
Giacoma Filippello, che descrive la vita con L’Ala come un’avventura, si giustifica usando anche lei l’argomento della differenza tra la mafia di una volta e quella di adesso che non avrebbe più regole: “Pensavo che non era una cosa sbagliata. Adesso lo so che non era così. Ma all’epoca… E del resto la mafia era tutta un’altra cosa. Uccideva, ma non senza preavviso. E le donne e i bambini non si toccavano per nessuna ragione al mondo” (Mazzocchi, 1993). Uno stereotipo usato non solo dalle collaboratrici per giustificare i loro uomini e se stesse, ma da quasi tutti i mafiosi pentiti, i quali però, almeno per quanto ci risulta, di questo asserito cambiamento della mafia sembra che si siano accorti soltanto dopo il loro arresto.
Donne contro
Nella nostra ricerca uno spazio importante ha l’analisi del ruolo delle donne nel movimento antimafia.
Anche qui bisogna misurarsi con gli stereotipi. Secondo l’immaginario collettivo, prima tutti i siciliani, o quasi, erano complici o sudditi della mafia, nella maggior parte dei casi indifferenti, passivi e rassegnati; mentre da qualche anno, a far data dal delitto Dalla Chiesa (1982) o dalle stragi del ’92 e del ’93, tutti i siciliani, o quasi, sono contro la mafia etc. etc. La realtà è ben diversa (si veda: Santino, 1995b). Il grande movimento antimafia è alle nostre spalle ed ha avuto nel movimento contadino il suo principale protagonista, dai Fasci siciliani (1892-94) alle lotte degli anni ’40 e ’50. In questo movimento le donne hanno avuto un ruolo di primo piano. In parecchi paesi siciliani all’interno dei Fasci c’era una presenza massiccia di donne (nel Fascio di Piana dei Greci, su una popolazione di circa 9.000 abitanti, c’erano 2.500 uomini e circa 1.000 donne; nel Fascio di Campofiorito c’erano 214 donne, 80 in quello di San Giuseppe Jato (Ganci, 1977, pp. 362 s.)) e ciò suscitò la meraviglia di cronisti e analisti contemporanei, e anche nelle successive ondate di lotte le donne fecero la loro parte: una presenza significativa ma ignorata, se si toglie qualche caso, come quello della madre di Salvatore Carnevale, accusatrice degli assassini del figlio, al centro di un libro di Carlo Levi (Levi, 1955). In quelle fasi la lotta contro la mafia era lo specifico dello scontro di classe e si legava a un progetto complessivo di riforma sociale e di conquista del potere, a partire dalle amministrazioni locali.
L’attuale movimento antimafia, che raggiunge dimensioni di massa in alcune manifestazioni ma poggia sull’attività continuativa di alcune centinaia di militanti impegnati nell’associazionismo e nel volontariato, nasce soprattutto dall’emozione suscitata da alcuni delitti e, nonostante qualche tentativo, non riesce a darsi un progetto, riflettendo la crisi delle grandi “narrazioni” di fine millennio.
La componente femminile è presente in questo movimento fin dai primi anni ’80, con la nascita dell’Associazione donne siciliane per la lotta contro la mafia, promossa da donne che hanno voluto continuare in modo diverso una militanza iniziata in partiti e movimenti politici e da vedove di magistrati e di altri funzionari dello Stato uccisi dalla mafia: frutto di una presa di coscienza e di una rielaborazione pubblica del lutto (si vedano: Siebert, 1994, 1995) che ha come causa scatenante l’escalation della violenza mafiosa che, all’interno di una gara egemonica suscitata dall’incremento esponenziale dell’accumulazione illegale, colpisce esponenti delle istituzioni che si oppongono all’espansione del potere e degli interessi mafiosi.
Abbiamo avviato un’esplorazione all’interno dell’antimafia al femminile, raccogliendo alcune storie di vita, a cominciare da quella di Felicia Bartolotta Impastato, madre di Peppino, pubblicata nel volume La mafia in casa mia. Le altre storie di vita raccolte sono quelle di Pietra Lo Verso e Michela Buscemi, donne del popolo palermitano costituitesi parti civili in processi di mafia, pubblicate nel volume Sole contro la mafia; di Giovanna Terranova, vedova del magistrato e presidente dell’Associazione delle donne contro la mafia; di Maria Benigno, una donna, anche lei di estrazione popolare, che ha avuto il coraggio di accusare dell’assassinio del fratello e del marito i killer della famiglia Marchese, tra cui Leoluca Bagarella.
Abbiamo riflettuto sul ruolo delle storie di vita nella nostra ricerca (si veda l’Introduzione a Sole contro la mafia) e cercato di ricostruire non solo un brano (il trauma dell’uccisione di un congiunto e la reazione ad esso) ma un’intera vicenda esistenziale e il suo contesto ambientale.
Donne di estrazione borghese e popolare si sono ritrovate all’interno dell’Associazione donne contro la mafia e più in generale del movimento antimafia, ma non sono mancati problemi, come quello dell’isolamento di Michela Buscemi e Vita Rugnetta, le uniche donne del popolo palermitano costituitesi parte civile nel primo maxiprocesso; di Piera Lo Verso, che ha accusato quello che riteneva fosse il mandante dell’uccisione del marito, ucciso con altre sette persone: lei è stata l’unica tra i parenti delle otto persone uccise a fare la scelta di costituirsi parte civile.
Per tutte la scelta di costituirsi parti civili è stata causa di isolamento nella famiglia, nella parentela, nel vicinato. Michela Buscemi, Piera Lo Verso, Vita Rugnetta hanno visto scomparire i clienti dei loro esercizi commerciali e sono state costrette a chiuderli andando incontro ad una grave situazione economica. Ma questo tipo di isolamento possiamo dire che fosse nel conto, in una Palermo che mentre diserta la macelleria di Piera Lo Verso, rea di essersi rivolta alla giustizia, ha continuato a servirsi della macelleria di Domenico Ganci, in pieno centro cittadino e a due passi dalla casa di Giovanni Falcone, anche dopo il suo arresto e la sua incriminazione per la partecipazione a tanti delitti, tra i quali la strage di Capaci.
Ma se questo isolamento era prevedibile, quello che non era nel conto era l’isolamento di gran parte del movimento antimafia, derivante in primo luogo dallo stereotipo secondo cui la mafia è solo un’associazione criminale contro cui lottano giudici e uomini delle forze dell’ordine etichettati come “servitori dello Stato”, una guerra tra guardie e ladri. Ad aiutare queste donne nel momento di maggiore esposizione sono stati soltanto il Centro Impastato e l’Associazione donne contro la mafia, e, per quanto riguarda la seconda, con qualche lacerazione al suo interno. Abbiamo aiutato queste donne non solo perché le abbiamo sentite vicine umanamente ma anche perché abbiamo una concezione diversa della mafia e dell’antimafia.
Riferimenti bibliografici
AA.VV., Gabbie vuote. Processi per omicidio a Palermo dal 1983 al maxiprocesso, F. Angeli, Milano 1992.
Bartolotta Impastato Felicia, La mafia in casa mia, intervista di A. Puglisi e U. Santino, La Luna, Palermo 1986.
Cascio Antonia – Puglisi Anna (a cura di), Con e contro. Le donne nell’organizzazione mafiosa e nella lotta contro la mafia, Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato, Palermo 1986.
Chinnici Giorgio – Santino Umberto, La violenza programmata. Omicidi e guerre di mafia a Palermo dagli anni ’60 ad oggi, F. Angeli, Milano 1989.
De Mauro Mauro, La vedova Battaglia accusa, “L’Ora”, 21 gennaio 1964.
Ganci Massimo, I fasci dei lavoratori, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma 1977.
Levi Carlo, Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia, Einaudi, Torino 1955.
Madeo Liliana, Donne di mafia, Mondadori, Milano 1992.
Mazzocchi Silvana, Quelle iene non mi fanno paura, intervista a Giacoma Filippello, “Il Venerdì di Repubblica”, 23 aprile 1993.
Ministro dell’Interno, Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata per l’anno 1995, Tipografia del Senato, Roma 1996.
Pino Marina, Le signore della droga, La Luna, Palermo 1988.
Puglisi Anna, Sole contro la mafia, La Luna, Palermo 1990.
Puglisi Anna, A proposito della lettera di Ninetta Bagarella e della risposta del giudice Vigna, “Narcomafie”, luglio 1996; ripubblicato in A. Puglisi, Donne, mafia e antimafia, Centro Impastato, Palermo 1998.
Puglisi Anna – Santino Umberto, Donne e pentitismo, pubblicato con titoli redazionali (“Non li ho partoriti io, è stato solo un sogno”, Più che l’amor potè la cosca) in “Narcomafie”, ottobre 1995; ripubblicato in A. Puglisi, Donne, mafia e antimafia, Centro Impastato, Palermo 1998.
Rizza Sandra, Una ragazza contro la mafia. Rita Atria, morte per solitudine, La Luna, Palermo 1993.
Santino Umberto – La Fiura Giovanni, L’impresa mafiosa. Dall’Italia agli Stati Uniti, F. Angeli, Milano 1990.
Santino Umberto, La mafia interpretata, Rubbettino, Soveria Mannelli 1995a.
Santino Umberto, Sicilia 102. Caduti nella lotta contro la mafia e per la democrazia dal 1893 al 1994, Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato, Palermo 1995b.
Siebert Renate, Le donne, la mafia, Il Saggiatore, Milano 1994.
Siebert Renate, La mafia, la morte e il ricordo, Rubbettino, Soveria Mannelli 1995.
Siragusa Mario – Seminara Giuseppina, Società e mafia nella Gangi liberale e fascista, Edizioni Progetto Ganci, Ganci 1996.
Transirico Connie, Braccata. Dal rifugio segreto una pentita racconta, Sigma edizioni, Palermo 1994.
Tribunale civile e penale di Palermo, Misura di prevenzione nei confronti di Citarda Francesca, 11 febbraio 1983.
Zanuttini Paola, La mia guerra alla mafia, intervista a Piera Aiello, “Il Venerdì di Repubblica”, 14 gennaio 1994.
Relazione di A. Puglisi – U. Santino, Università degli studi Di Pisa, Dipartimento di Scienze sociali, Seminario del 10 dicembre 1996. Pubblicata in: Anna Puglisi, Donne, mafia, antimafia, Di Girolamo, Trapani 2005, 2012.
Anna Puglisi – Umberto Santino CENTRO IMPASTATATO 3.3.2015
Il ruolo delle donne nella mafia italiana. Sempre più figure di primo piano, le donne assicurano la tenuta del potere mafioso e maschile
Versione italiana a cura della Redazione del Tacco d’Italia
Con il viso leggermente gonfio e ammanettata, Mariangela Di Trapani scende i gradini, saldamente stretta tra due agenti della Polizia. Il suo sguardo svuotato incontra l’orda di giornalisti che la aspettano. Tutta Palermo la chiama “Patrona” per una semplice ragione: dopo la morte in prigione del padrino dei padrini, Totò Riina, è sospettata di essere stata scelta per riorganizzare le “truppe” del quartiere mafioso di Resuttana. Il 5 dicembre 2017, è stata arrestata durante un’operazione su larga scala chiamata Talea, che ha coinvolto oltre 200 carabinieri.
1° giugno 2019 – “Mafia, si chiude il processo dell’operazione ‘Talea’: 24 condannati e 13 assolti. Quattro anni a Maria Angela di Trapani, moglie del super killer Salvino Madonia, accusato dell’omicidio di Libero Grassi”.
Figlia e sorella dei boss della mafia Cicco e Nicolò Di Trapani, Mariangela conosce la prigione che l’attende per averci già trascorso sette anni. Aveva passato gli ordini del capo di suo marito, Salvino Madonia, ai suoi accoliti mentre lui era dentro per omicidio. Rilasciata nel 2015, passa dall’essere semplice messaggera a “capa” che dà gli ordini, fino a ricadere nella rete della giustizia.
Secondo un recente studio del centro di ricerca italiano TransCrime, sempre più donne assumono un ruolo di primo piano nella mafia italiana. “In molte famiglie di Cosa Nostra e della Ndrangheta, le donne sono diventate figure chiave, molto attive nella gestione dei loro affari di famiglia”, conferma Alessandra Dino, docente di Sociologia giudiziaria all’Università di Palermo. A lungo incaricate di seguire l’educazione dei figli, le donne della mafia gestiscono ora la finanza?
Capi d’azienda
Per mesi un team internazionale di otto ricercatori ha creato modelli sul “rischio di infiltrazione delle criminalità organizzate in imprese legali, in tutti i territori e settori europei”. Alla fine di dicembre 2018, lo studio di “TransCrime” ha concluso che, sebbene il 2,5% dei condannati per reati connessi alla mafia in Italia siano donne, esse possiedono ancora solo un terzo dei beni delle organizzazioni.
Nell’esaminare le aziende nel mondo criminale italiano, i ricercatori hanno anche potuto stabilire che “nei settori dell’edilizia e dei trasporti in particolare, ci sono azioniste quattro volte in più che nell’economia legale”, spiega Michele Riccardi, ricercatore “TransCrime”, che ha partecipato allo studio. Queste madri, sorelle o figlie non assumono più solo ruoli passivi, come dimostrano le indagini condotte dai procuratori antimafia.
“I risultati di questo studio non sono sorprendenti, perché le donne sono spesso percepite come insospettabili ed è quindi più facile cedere loro delle proprietà senza attirare l’attenzione”, dice Felia Allum, docente di Scienze Politiche e Italiano presso l’Università di Bath. I mafiosi preferiscono conferire le responsabilità o la gestione di attività finanziarie ai membri del proprio entourage in modo che i soldi rimangano in famiglia, senza che i veri beneficiari appaiano.
La storia di Maria Campagna illustra questo fenomeno. La quarantenne che ora langue dietro le mura del carcere di Santa Maria Capua Vetere in Campania, stava facendo scorrere centinaia di chili di cocaina in Europa da due anni. Dopo il suo arresto durante l’Operazione Penelope, i tribunali hanno dimostrato come la donna si fosse incaricata della comunicazione tra suo marito, il mafioso Turi Cappello, e il resto del clan, mentre lui era in carcere. Boss di Catania, Cappello aveva una fede cieca in lei e faceva affidamento sul suo talento di trattare con i narcotrafficanti sudamericani.
Secondo il Centro d’inchiesta Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), Campagna non si è limitata a questo. Era, in realtà, specializzata nell’organizzare la raccolta di cocaina attraverso tutti i porti in cui era spedita. L’organizzazione stima che il numero di donne che svolgono questo tipo di ruolo nei clan mafiosi è basso, ma cresce. “Nel 1989, una sola accusa riguardante la mafia è stata presentata contro una donna. Nel 1995 erano 89”, fa sapere Occrp. Con il crescere del fenomeno, la ricerca e la giustizia si sono concentrate sul ruolo di queste donne nei circoli criminali in Italia, dopo anni vissuti all’ombra degli uomini.
Garanti dei valori mafiosi
Il ruolo delle donne nella mafia è stato strutturato a metà del 19° secolo in una società notoriamente violenta e machista, dove le figure femminili occupavano un ruolo essenziale per il clan: il passaggio del testimone, l’eredità. “Con i padri spesso in fuga o in prigione, sono le madri a trasmettere i ‘valori’ mafiosi a i bambini”, afferma la regista Anne Véron, il cui documentario Des femmes dans la Mafia racconta tre donne di cosa nostra. “Per molto tempo sono state la rispettabile vetrina delle famiglie mafiose”, aggiunge Dino. Presenti alle messe o in qualsiasi evento pubblico, devono mostrare alla società di essere perfette sotto ogni aspetto.
A seconda dell’organizzazione di appartenenza, la loro funzione può variare. Secondo Felia Allum, la cui tesi si concentra in particolare sulla camorra (su cui ha anche scritto due libri), i diversi gruppi funzionano diversamente e “anche il territorio ha un impatto sul ruolo delle donne”. Questa disparità “rende difficile generalizzare”, avverte la ricercatrice. A Napoli, le donne sono più emancipate, perché lì c’è “solo la mafia urbana“. Nella mafia calabrese, più rurale, hanno comunque poco spazio, perché prevalgono i legami di sangue. In Sicilia, non possono ufficialmente appartenere a un’organizzazione, “ma ogni donna che fa parte della vita di un uomo di mafia, ne condivide anche le attività”.
Il loro ruolo non deve essere sminuito. “Senza di loro, le mafie non esisterebbero”, ricorda Felia Allun. “Sono colpevoli come gli uomini nel trasmettere i valori della mafia alle nuove generazioni. E come per gli uomini, le pentite sono rare. Coloro che scelgono di cooperare con le autorità per proteggere se stesse o la prole, sono esposte a mille punizioni. Il suicidio della giovane Rita Atria nel 1992, una settimana dopo la morte del suo protettore, il giudice Paolo Borsellino, rimane un tragico e doloroso evento nella lotta antimafia”.
Fino all’inizio degli anni ’90, le mafiose erano di poche parole. E ciò ha indubbiamente contribuito al loro anonimato. “Prendete il possesso illegale di armi da fuoco”, continua Alessandra Dino. “Leggendo i dossier giudiziari, possiamo vedere come sia stato spesso qualificato e trattato come ‘aiuto e complicità’ nel caso di una mafiosa, mentre per un uomo si trattava di ‘associazione mafiosa’”.
Spesso considerate vittime, col passare del tempo sempre più donne sono state condannate anche a vent’anni di galera. “Solo nel 1999, il sistema giudiziario italiano ha riconosciuto che una donna poteva essere accusata di crimini legati alla mafia, anche in assenza di un’affiliazione formale”, spiega Dino. Garanti della vendetta e dell’omertà, le mafiose appaiono agli occhi di tutti come delle manager. Ma non hanno ancora abbastanza potere.
Pseudo emancipazione
Nonostante tutto, la mafia rimane “una società eminentemente machista”, esclama Felia Allum. “Le donne ci sono sempre state, ma non le si vedeva! Il loro disvelarsi potrebbe quindi realizzarsi solo se venisse concessa loro maggiore attenzione. Da 25 anni, il numero di giudici donne e di ricercatrici che osservano questo fenomeno, è andato crescendo”, afferma.
Inoltre, le donne spesso prendono il potere solo temporaneamente. Una volta tornati dal carcere, gli uomini riprendono il loro posto. “A volte capita che le donne ottengano più potere all’interno di un’organizzazione, ma solo quando gli uomini ne hanno bisogno”, conferma Felia Allum descrivendo questo fenomeno come un “potere per delega”. Le mafie rimangono organizzazioni orientate agli uomini e le eccezioni a questa regola sono rare, sebbene ci siano alcuni casi interessanti. Sebbene più proattive di prima, “le donne sono come un esercito di riserva. Hanno incorporato tutti i trucchi del mestiere e possono entrare in battaglia quando vengono chiamate”.
Il caso di Giusy Vitale illustra perfettamente questa emancipazione. Soprannominata “Lady Mafia”, questa siciliana apparteneva a cosa nostra. Quando il marito e i fratelli si ritrovarono dietro le sbarre negli anni ’90, la giovane prese le redini a Partinico (Palermo). Arrestata nel giugno 1998 e di nuovo nel 2003, ha guidato la famiglia con il pugno di ferro per alcuni anni, ma non le era permesso partecipare alle riunioni. Ha collaborato con la polizia nel 2005 e oggi vive sotto pseudonimo, in un luogo segreto.
Allora è possibile un’inversione di forze? Nel 2012, Allum ha avuto un incontro fuori dall’ordinario. Una testimone di giustizia – di cui tace l’identità – le ha affidato la sua visione del futuro. Per lei, arriverà il momento in cui le donne saranno più potenti. “Era convinta che gli uomini tendessero a essere più violenti, ma che le donne fossero più intelligenti e capissero meglio l’economia”, dice.
La ricercatrice sembra in dubbio sulla prospettiva di un simile cambiamento. “Con sempre più uomini in prigione, forse queste donne troveranno l’opportunità di rimanere al potere per più tempo e quindi avere maggiore impatto”, aggiunge.
A ogni modo, lo studio recentemente pubblicato da TransCrime ha il merito di aver squarciato il velo di invisibilità calato sulle donne mafiose. Era ora di fare luce. Redazione
Le storie di sei donne, sei madri che volevano salvare i loro figli dalla mafia: uccise per il “reato” di libertà
Cetta Cacciola, Tita Buccafusca, Rossella Casini, Lea Garofalo, Angela Costantino e Maria Chindamo morte per aver detto no alla ‘ndrangheta
- Maria Concetta Cacciola, morta il 20 agosto 2011
- Santa (Tita) Buccafusca, morta il 18 aprile 2011
- Rossella Casini, scomparsa il 22 febbraio 1981
- Lea Garofalo, uccisa il 24 novembre 2009
- Angela Costantino, scomparsa il 16 marzo 1994
- Maria Chindamo, scomparsa il 5 maggio 2016
Hanno tentato di riprendere in mano le loro vite facendo delle scelte di libertà. Ma in una terra segnata profondamente dalla cultura mafiosa, hanno pagato un prezzo altissimo. Sono tante le donne uccise dalla ‘ndrangheta, colpevoli di aver infranto le regole del silenzio o di aver scelto di essere altro da ciò che veniva imposto loro.
Cetta Cacciola, Tita Buccafusca, Rossella Casini, Lea Garofalo, Angela Costantino, Maria Chindamo, tante storie diverse accomunate dallo stesso desiderio di cambiamento. I loro volti continuano a raccontare e i loro sogni sono diventati una bandiera per altre giovani donne che hanno trovato nel loro esempio, la forza e il coraggio di ribellarsi e mettere in salvo i loro figli.
Maria Concetta Cacciola, morta il 20 agosto 2011
“O stai cu nnui o cu iddi”, le diceva sua madre, riferendosi ai carabinieri ai quali la figlia si era rivolta. Aveva 31 anni e tre figli di 16, 12 e 7 anni, Maria Concetta Cacciola, “Cetta”, la giovane donna di Rosarno, che il 20 agosto del 2011 avrebbe ingerito dell’acido muriatico o sarebbe stata costretta a farlo, per sottrarsi alle pressioni della sua famiglia che voleva ritrattasse le dichiarazioni rese spontaneamente ai magistrati della Dda, sui legami di ‘ndrangheta di cui era a conoscenza, prima di essere allontanata e portata in una località protetta.
Il padre, Michele Cacciola, con dei trascorsi criminali di tutto rispetto, era cognato del boss Gregorio Bellocco. E Cetta era cresciuta in quella famiglia di ‘ndrangheta con regole rigide e soffocanti. Per questo a tredici anni decise di accettare il corteggiamento di un ragazzo del suo paese, Salvatore Figliuzzi, che le appariva in quel momento come un’ancora di salvezza. Ma Salvatore, scegliendola, aveva soltanto pianificato il suo futuro criminale sancendo un’appartenenza mafiosa che ora gli spettava di diritto. Cetta capì di essere in trappola, di aver involontariamente rinsaldato quel sistema dal quale aveva voluto fuggire.
Ma quando suo marito finì in carcere perché fu condannato insieme al boss Gregorio Bellocco e quasi una ventina di affiliati al suo clan, Cetta cercò altre strade per poter esistere e Facebook, seppur virtualmente, le offrì l’opportunità della parola e la libertà di scegliere con chi comunicare. E tra i tanti contatti, uno in particolare, le riaccese la speranza del cambiamento.
Un uomo attirò la sua attenzione, la coinvolse, le parlò e nel contempo si dimostrò disponibile ad ascoltare la sua sofferenza.
S’innamorò Cetta e accolse quella storia a distanza e solo immaginata, come quel segno del cielo che aspettava da troppo tempo. Ed è con questa consapevolezza e con la voce tremante che quando si recò in caserma perché a suo figlio sedicenne avevano rubato il motorino, vide nel maresciallo dei carabinieri che aveva davanti, una possibilità di salvezza. Ma sua madre, dalla località protetta dove era stata portata, la convinse a ritornare usando i suoi figli come esca. Qualche giorno dopo Cetta fu trovata morta. Si sarebbe tolta la vita.
Santa (Tita) Buccafusca, morta il 18 aprile 2011
Una sposa di ‘ndrangheta, questa è stata Santa Buccafusca, per tutti Tita, moglie di Pantaleone Mancuso, boss di Limbadi, soprannominato “Luni Scarpuni”, morta suicida il 18 aprile del 2011, dopo aver ingerito come Cetta Cacciola, un grosso quantitativo di acido muriatico. Una morte sospetta la sua, sulla quale gli inquirenti hanno lungamente indagato nella speranza di trovare un nesso causale tra il tentativo disperato di Tita di uscire dalla famiglia Mancuso che la portò appena due mesi prima, era il 14 febbraio, ad entrare nella caserma dei carabinieri di Nicotera Marina con in braccio il figlioletto Salvatore per chiedere protezione, e quanto avvenne appena un mese dopo essere ritornata a casa da suo marito.
Fu l’omicidio di Vincenzo Barbieri, detto “u ragioniere”, noto narcotrafficante capace di trattare con i cartelli sudamericani per conto dei clan del vibonese, ucciso da un commando armato nel centro di San Calogero, a spaventare Tita. Comprese che lei e la sua famiglia erano in pericolo e che soprattutto dopo quell’omicidio altro sangue sarebbe stato versato.
Aveva paura ma voleva soprattutto cambiare vita. Le era fin troppo chiaro ormai, cosa significasse essere la moglie di Mancuso e quali erano le regole alle quali doveva rigorosamente attenersi. A poche ore dal delitto, con il suo bimbo in braccio si presentò dai carabinieri di Nicotera Marina per chiedere di intervenire: “Si ammazzano come i cani – disse loro – mettete posti di blocco dappertutto”.
Tita parlò con i magistrati e raccontò quanto sapeva ma prima di firmare i verbali, chiese di telefonare a suo marito. Pregò Pantaleone Mancuso di seguire la sua stessa strada, di cambiare vita e di farlo soprattutto per suo figlio. Lui la chiamò pazza e gli chiese di ritornare a casa. Ma fu la sorella di lei, chiamata subito dopo, a convincerla a ritornare da suo marito. Tita non firmò mai quei verbali, e qualche giorno dopo si sarebbe suicidata. Così dissero i suoi familiari.
Rossella Casini, scomparsa il 22 febbraio 1981
Rossella Casini, 25 anni, studentessa fiorentina, scomparve a Palmi il 22 febbraio del 1981. La ragazza era fidanzata con Francesco Frisina, un giovane studente universitario di Palmi, coinvolto nella faida in atto tra i Gallico e i Parrello-Condello.
Rossella, figlia unica, conobbe Francesco nel 1977, quando il ragazzo di Palmi, studente di Economia, andò ad abitare nella palazzina ottocentesca dove viveva la famiglia Casini, nel quartiere di Santa Croce.
I due ragazzi si fidanzarono e i genitori di lei più volte si recarono in Calabria ospiti della famiglia del giovane. Nessuno di loro inizialmente percepì il pericolo di quel sentimento, fino all’uccisione del padre di Francesco nelle campagne di Palmi il 4 luglio del ’79, e il ferimento del ragazzo alla testa, cinque mesi dopo, in un agguato.
Da quel momento iniziò un’altra storia. Rossella fece trasferire il suo fidanzato alla clinica neurochirurgia di Firenze e oltre alle amorevoli cure gli offrì la possibilità di diventare altro, di tagliare definitivamente con le sue origini e con la storia della sua famiglia coinvolta nella terribile faida tra i Gallico e i Parrello-Condello che stava insanguinando le strade di Palmi.
Francesco e la stessa Rossella affidarono le loro verità ai magistrati fiorentini che trasmisero gli atti alla procura di Palmi. Da quel momento la ragazza, considerata da tutti la forestiera, divenne anche una traditrice. Ma lei continuò ad inseguire il sentimento che la animava e che era più forte dei ragionevoli dubbi che ogni tanto l’assalivano.
Dopo tredici anni dalla scomparsa della ragazza, il pentito palermitano Vincenzo Lo Vecchio, rivelò che Rossella era stata violentata, assassinata e il suo corpo tagliato a pezzi e buttato in mare al largo della tonnara di Palmi, per aver convinto il suo fidanzato a diventare testimone di giustizia. Quattro le persone rinviate a giudizio per la sua morte. Il processo per il sequestro e l’omicidio della studentessa fiorentina iniziò il 25 marzo del 1997 e si concluse nove anni dopo con una sentenza di assoluzione.
Lea Garofalo, uccisa il 24 novembre 2009
A Lea Garofalo uccisero il padre quando lei aveva appena otto mesi e suo fratello Floriano, boss di Petilia Policastro, nel 2005.
Ad appena sedici anni Lea si innamorò di Carlo Cosco e l’anno dopo ebbe una figlia da lui, Denise. Si trasferirono subito dopo nel capoluogo lombardo dove insieme agli altri fratelli si occupava del traffico di droga e di affari poco puliti.
Lea si rese ben presto conto della vita che l’attendeva e soprattutto per la sua bambina, nel 2002, decise di dare una svolta lasciando il suo compagno e reagendo alle sue minacce e alle intimidazioni, denunciandolo alle forze dell’ordine e rivelando anche le faide interne esistenti tra la sua famiglia e quella dei Cosco.
Lea in seguito alla sua testimonianza venne ammessa al programma di protezione insieme a sua figlia ma nel 2006 venne estromessa perché le sue rivelazioni non furono più considerate particolarmente significative.
Solo grazie a un ricorso al Consiglio di Stato nel 2007, le fu riconosciuto lo status di collaboratrice di giustizia ma non di testimone. Lea aveva problemi economici e soprattutto si sentiva abbandonata da quello Stato a cui lei si era rivolta per uscire da quell’inferno. Due anni dopo decise di rinunciare alla tutela e qualche mese dopo, era il 24 novembre del 2009, fu uccisa dal suo ex compagno Carlo Cosco a Milano.
Angela Costantino, scomparsa il 16 marzo 1994
Angela Costantino, 25 anni, sposata con il boss Pietro Lo Giudice e madre di quattro figli in tenera età, scomparve da casa il 16 marzo del 1994 e di lei non si ebbero più notizie. Il fratello della giovane ne denunciò la scomparsa e iniziarono le sue ricerche.
Anche la famiglia del marito, che molti anni dopo risultò essere coinvolta nella sua morte, partecipò attivamente facendo fare anche degli appelli via radio nella speranza che Angela potesse ritornare a casa dai suoi figli. Una vera e propria messinscena per allontanare i sospetti.
L’auto della donna, una “Fiat Panda”, venne ritrovata qualche giorno dopo a Villa San Giovanni con all’interno delle ricette mediche comprovanti il fatto che Angela in quel momento soffrisse di crisi depressive e il sedile posizionato in modo tale che a guidare l’auto non avrebbe mai potuto essere stata la ragazza bensì una persona molto più alta.
Qualche giorno dopo inoltre, arrivò una telefonata anonima alle forze dell’ordine nella quale veniva affermato con certezza che la giovane donna era stata sequestrata ed uccisa.
Nonostante le evidenti anomalie, non c’erano, però, elementi tali da dare corpo, sul piano investigativo, a quelle rivelazioni e il fascicolo inerente la scomparsa della donna rimase per molti anni fermo senza produrre verità sostanziali.
La svolta arrivò 18 anni dopo, quando nel corso di un’operazione vennero arrestati, tra gli altri, Vincenzo Lo Giudice, considerato uno dei capi della cosca, il cognato Bruno Stilo e il nipote Fortunato Pennestrì, accusati di essere mandanti ed esecutori dell’omicidio di Angela Costantino, colpevole di aver avuto delle relazioni amorose mentre suo marito era detenuto in carcere.
Pare addirittura che la giovane fosse rimasta incinta e che avrebbe abortito in una clinica privata. La sua condanna a morte fu decisa dalla famiglia per salvare l’onore di Pietro e perché Angela era ormai considerata ingestibile e pericolosa. Della sua esecuzione aveva già parlato anni prima Maurizio Lo Giudice, fratello di Pietro, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia. Le sue rivelazioni furono poi consolidate da quelle di altri due pentiti, Paolo Iannò e Domenico Cera.
Il giudice Carlo Alberto Indellicati condannò a trent’anni di reclusione ciascuno, Bruno Stilo e Fortunato Pennestrì, ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore materiale dell’omicidio di Angela Costantino. Il giovane con il quale Angela aveva avuto una relazione, scomparve qualche giorno dopo il suo sequestro e di lui non si ebbero più notizie.
Maria Chindamo, scomparsa il 5 maggio 2016
“Il sacrificio di Maria voglio che si trasformi in una possibilità di riscatto per la nostra martoriata terra”. Vincenzo Chindamo, nonostante il carico di dolore che si porta dentro da quel 5 maggio del 2016, giorno in cui sua sorella Maria scomparve davanti al cancello della sua azienda agricola, a Limbadi, cerca di dare forma e sostanza al suo bisogno di verità e giustizia, per lui e per tutta la sua famiglia ma soprattutto per i nipoti Vincenzino, Federica e Letizia, i figli che Maria avrebbe voluto veder crescere e che sono la testimonianza diretta di una vita vissuta nel rispetto dei valori e dei sentimenti.
Ma di lei non c’è più traccia e tocca a suo fratello tentare di togliere quella coltre pesante che avvolge la storia di una donna bella e combattiva, colpevole soltanto di aver scelto come vivere la propria vita.
Maria incontrò Ferdinando Puntoriero, il suo futuro marito, quando aveva appena 14 anni. Dopo gli studi universitari in Economia e Commercio portati avanti con tenacia anche dopo il matrimonio e la nascita di Vincenzino, prese l’abilitazione alla professione di commercialista e aprì uno studio a Rosarno.
La crisi coniugale che investì in seguito la coppia, portò al suicidio di Ferdinando, incapace di reggere la richiesta di libertà avanzata da sua moglie. Qualche pentito ha raccontato particolari agghiaccianti sulla morte di Maria (LEGGI) ma la verità sembra ancora lontana e la giustizia tarda ad arrivare.
Il Quotidiano del Sud
Ombretta Ingrascì, Donne d’onore. Storie di mafia al femminile
«[Le donne di mafia] non sono protagoniste della violenza in prima persona, generalmente non uccidono, non sono pari agli uomini sul piano delle decisioni, eppure oggi tutti gli addetti ai lavori, dai magistrati ai poliziotti, dagli studiosi agli psicologi dei servizi pubblici concordano che il loro ruolo dalle molteplici sfaccettature sia di grande rilevanza» (p. VIII). Con queste parole che Renate Siebert utilizza nella prefazione, appare chiara l’importanza del volume che la storica Ombretta Ingrascì dedica al fenomeno delle donne appartenenti alla mafia siciliana e alla ‘ndrangheta, a conclusione di un percorso che la vede impegnata su questo fronte da più di dieci anni. Il suo studio ha il merito non solo di inserirsi in un filone accademico ampiamente studiato negli ultimi quindici anni, ma anche di presentare una rinnovata prospettiva, più ampia e completa dal punto di vista dell’approccio. Se le storie e il vissuto delle donne di mafia, inseriti in un’analisi sociologica tesa all’individuazione di codici culturali comuni, erano già stati documentati dalla stessa Siebert negli anni ’90, e se la particolare trasversalità del “femminile”, ripudiato e osannato allo stesso tempo dagli uomini mafiosi, era già stata oggetto dei contributi di Alessandra Dino, Ingrascì riesce a fondere nelle stesse pagine la complessità di entrambi i temi.
Che ruolo hanno le donne nella criminalità organizzata? Esiste la possibilità di un’evoluzione di tale ruolo nel corso degli anni? Quanti sono gli elementi a disposizione dello studioso per tracciare un quadro d’insieme? A partire da queste domande di fondo, Ingrascì analizza la problematica da una prospettiva non solo temporale ma anche culturale e criminale, non dimenticandosi di quelle figure femminili che negli anni recenti sono state condannate, e chiedendosi se in realtà non sia stata la percezione di queste donne mafiose ad essere cambiata nel tempo e non la loro essenza specifica. Ecco giustificato l’ampio spazio dato all’analisi dell’evoluzione del fenomeno mafioso, in riferimento alla presenza più o meno consapevole delle donne sullo sfondo del contesto criminale. Ingrascì ci introduce in una sfera complessa, che va dall’analisi della passività insita nello stesso principio di non associabilità femminile alla mafia (le donne non possono prestare giuramento) o nell’utilizzo delle donne come oggetto di scambio per le politiche matrimoniali mafiose, al primigenio ruolo attivo di educatrici dei figli secondo principi etici mafiosi o di Erinni furenti in cerca di vendetta personale. Queste codifiche, diventate a volte stereotipi puri, hanno impedito all’inizio un’identificazione chiara delle caratteristiche e responsabilità delle donne da parte della giustizia italiana. Seguendo il percorso di Ingrascì si capisce molto bene come questo luogo comune sia potuto cambiare solo dopo l’avvento del pentitismo e la scoperta che le donne mafiose, in assenza del capofamiglia arrestato o ucciso, possono rivestire una funzione suppletiva. La questione principale, in riferimento a questa considerazione, è quella che ruota attorno al concetto di pseudoemancipazione: le donne si sono improvvisamente ritrovate protagoniste di un mondo che le aveva escluse, ma senza diventare soggetti con libertà di movimento e di pensiero, sono rimaste strumenti in mani altrui, utilizzate per necessità. Le logiche della società mafiosa, patriarcale e maschilista, non hanno finora consentito una trasformazione in senso assoluto, e cioè un’emancipazione vera e propria. La bravura di Ingrascì sta nel suo continuo ricorrere alle fonti, nel suo giustificare ogni affermazione sulla base di studi precisi, di materiali processuali e soprattutto delle voci in prima persona dei pentiti. L’ultima parte del libro è infatti dedicata a ricostruire le storie personali e criminali delle pentite, in particolare la vicenda di Rosa N., ex affiliata ad una cosca calabrese della ‘ndrangheta. Vicenda esemplare e paradigmatica, che dimostra da sola tutte le precedenti considerazioni fatte dall’autrice. STORICAMENTE
Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione
Sommario: 1. Introduzione – 2. Il ruolo culturale della donna nella mafia – 3. Il ruolo criminale della donna nella mafia – 4. Vittimizzazione delle donne di mafia – 5. Conclusioni
1. Introduzione
“Le donne di mafia non sono protagoniste della violenza in prima persona, generalmente non uccidono, eppure oggi tutti gli addetti ai lavori, magistrati,poliziotti,studiosi, concordano che il ruolo dalle molteplici sfaccettature sia di grande rilevanza” (Renate Siebert)
Gli studi dedicati al ruolo della donna nella mafia accompagnati da esempi di storie vere ci rivela come la condizione delle donne all’interno del sistema mafioso oscilli tra complicità, responsabilità e vittimizzazione intesa come subordinazione e sfruttamento. Il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali di stampo mafioso è ancora poco studiato e conosciuto ed è sempre stato piuttosto ambiguo. Infatti la donna anche se formalmente esclusa tuttavia partecipa sostanzialmente alla vita dell’ organizzazione in quanto la figura femminile è centrale nella funzionalità del sistema socio-culturale e criminale mafioso. Sebbene ufficialmente le donne continuino a non far parte dell’organizzazione, a non poter essere formalmente affiliate e a non partecipare ai riti di iniziazione, sono state sempre presenti nelle dinamiche di potere delle organizzazioni mafiose e in molti casi si sono sostituite agli uomini incarnando i medesimi disvalori.
Per anni l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori ovvero poliziotti, magistrati, studiosi si erano assestati sul vecchio stereotipo, proposto dagli stessi mafiosi, della donna silente, defilata, che aveva soltanto un ruolo passivo di madre e moglie e sostanzialmente all’oscuro degli affari e degli atti criminali perpetrati dai propri congiunti, padre, marito, figli. Infatti il binomio donna-crimine era difficilmente accettato in quanto violava le aspettative sociali: dunque la donna di mafia ha goduto per molto tempo di una sorta di impunità connaturata in quanto la donna era considerata per natura conforme alle regole e l’importanza che la società ha attribuito al ruolo di madre ha contribuito a rappresentare le donne come lontane da un comportamento criminale di tipo mafioso. Le donne hanno usufruito della insospettabilità ed invisibilità, per operare, semplicemente, approfittando di una società che non voleva ammettere che le donne fossero capaci di un comportamento criminale. Inoltre i primi studi sulla criminalità femminile, risalenti alla Scuola Positivista e in particolare all’opera di Cesare Lombroso (“La donna criminale”,1893), partendo dal presupposto che i comportamenti criminali poco si addicono al ruolo e alla condizione sociale della donna, convengono che la vera natura della donna, l’essere madre, sia antitetica rispetto al crimine e che il conservatorismo che la caratterizza la porti a essere più rispettosa della legge e meno congenitamente incline dell’uomo a commettere reati.
Tale immagine è andata pian piano dissolvendosi a partire dalla fine degli anni 80 quando nuovi studi sul fenomeno mafioso e le testimonianze dei collaboratori e soprattutto delle collaboratrici di giustizia hanno svelato una realtà nascosta facendo emergere ruoli femminili più attivi e pregnanti rispetto agli stereotipi dominanti e un’immagine della donna di mafia assai differente, articolata e fortemente contrastante con l’icona precedente. Infatti nel corso degli anni le donne hanno assunto ruoli sempre più importanti all’interno delle organizzazioni criminali, tanto che alcune hanno ricoperto addirittura ruoli di primo piano, sono divenute vere e proprie boss.
L’aumento della partecipazione delle donne, favorito dall’espansione del traffico di stupefacenti e dalle crescente esigenza di riciclare denaro sporco, e la constatazione che le attività di alcune cosche mafiose proseguivano nonostante la detenzione del capo, hanno fatto si che la donna perdesse la caratteristica di “deviante segreta” (Becker: deviante segreto è chi infrange le regole sociali ma non viene etichettato come deviante perchè non viene scoperto) e gli addetti ai lavori superassero i tradizionali luoghi comuni e prendessero coscienza di una realtà nascosta che ha avvantaggiato le associazioni mafiose dal momento che le donne hanno potuto agire quasi indisturbate e quindi essere proficuamente utilizzate in vari settori. Infatti tale invisibilità ha garantito alla mafia una sostanziale impunità per le attività delittuose commesse dalle donne, attività che, di norma sono state ritenute non socialmente pericolose e non rilevanti ai fini della configurazione della fattispecie associativa. Significativa è la sentenza del 1983 con la quale il Tribunale di Palermo, pur attestando l’autenticità del legame tra Cosa nostra e le famiglie degli imputati, prosciolse l’ imputata di sesso femminile (Francesca Citarda, moglie del boss Giovanni Bontate e figlia del boss Matteo Citarda), specificando che le donna non poteva essere colpevole perchè, in quanto moglie di un mafioso, non aveva raggiunto un livello di emancipazione sufficiente per essere in grado di commettere il reato per cui era stata sottoposta a giudizio cioè non poteva aver rivestito un ruolo attivo negli affari della mafia perchè carente delle elementari cognizioni tecnico-finanziarie e per la naturale estraneità al difficile mondo degli affari. Per i giudici di Palermo la donna di mafia ancora non aveva un ruolo decisionale di autodeterminazione nell’ambito del sistema mafioso e quindi non procedettero al sequestro dei beni del marito.
Solo nell’ultimo ventennio le donne hanno acquisito una indubbia visibilità, rivelando un universo fluido e diversificato. Infatti le donne che troviamo nel raggio di influenza della mafia sono estremamente diverse tra di loro e la loro partecipazione alle attività criminali varia a seconda della provenienza familiare, delle condizioni ambientali e dell’indole personale. In particolare l’universo femminile mafioso comprende:
A) donne nate e cresciute nelle famiglie mafiose: esse, mogli, figlie e sorelle dei boss, agiscono da trait d’union fra gli uomini latitanti o in carcere e i membri dell’organizzazione che possono muoversi alla luce del sole. Sono perfettamente a conoscenza degli atti violenti perpetrati dai loro uomini e svolgono un ruolo fondamentale che va dal sostegno psicologico e materiale alla temporanea delega del potere attraverso attività di prestanome, gestioni patrimoniali e finanziarie, estorsioni e mediazioni;
B) un esercito di donne che vivono ai margini della società, in codizioni economiche disagiate che vengono utilizzate dalla mafia soprattutto nel settore del narcotraffico. Infatti le donne coinvolte nel traffico di stupefacenti sono estranee alle logiche dei gruppi criminali per i quali lavorano e di fronte all’opportunità di racimolare qualche spicciolo accettano le “proposte lavorative” della criminalità organizzata.
All’interno delle organizzazioni mafiose le donne hanno, da sempre, sia esercitato compiti tradizionali nella sfera privata quali l’educazione dei figli e l’incitamento alla vendetta; sia svolto anche dei ruoli importanti nell’ambito criminale soprattutto in funzioni di supporto e di sostituzione agli uomini al fine di garantire il buon andamento dei principali traffici illeciti in cui la famiglia è inserita. In entrambi i casi le donne hanno contribuito a rafforzare la struttura socioculturale del sistema mafioso, garantendone la sopravvivenza nonostante le condanne penali a carico degli uomini. In pratica la donna riveste all’interno dell’ organizzazione mafiosa due ruoli fondamentali: il ruolo culturale e il ruolo criminale.
Dopo questa introduzione passerò, nei prossimi capitoli, ad esaminare l’effettivo ruolo che le donne ricoprono nella mafia e le varie teorie criminologiche ad esso riferibili, partendo dal loro ruolo tradizionale, ai loro compiti di gregarie, supplenti e vere e proprie sostitute del boss, fino al loro sfruttamento da parte dei maschi del clan.
2. Il ruolo culturale della donna nella mafia
“Molte disgrazie, molte tragedie del Sud sono venute dalle donne, soprattutto quando diventano madri. Quanti delitti d’onore sono stati provocati, istigati o incoraggiati dalle donne! Dalle donne madri, dalle donne suocere.” (Leonardo Sciascia, La Sicilia come metafora)
Quello culturale è il ruolo tradizionale nel quale la donna è responsabile del processo educativo e della trasmissione della cultura e del codice mafioso. Le donne hanno rivestito e rivestono tuttora un ruolo fondamentale nella socializzazione dei figli all’odio e alla vendetta e nella trasmissione di un certo modo di porsi. Infatti soprattutto la madre ha un ruolo centrale nel processo educativo dei figli e nella creazione della cd”psiche mafiosa”: la madre è educatrice, a lei spetta il compito di inculcare cioè radicare in maniera irreversibile nei figli l’ideologia mafiosa ovvero le consuetudini e i disvalori di cui si nutre la criminalità mafiosa quali omertà, vendetta, disprezzo dell’ autorità pubblica, indicati come “giusti” in contrasto con i principi diffusi nella società civile. La mafia si configura come una vera e propria subcultura criminale cioè come sottogruppo avente un’ esistenza e un ruolo storico in seno alla società e dotato di un autonomo patrimonio culturale (valori, idee, concetti, miti), di un proprio linguaggio e di una propria legislazione interna appresi e condivisi dai suoi membri e antiteci rispetto ai valori della cultura dominante. Infatti la mafia è un’ organizzazione criminale con una propria ideologia culturale, un sistema di valori alternativo e prevalente rispetto a quello proposto dalla società civile.
La mafia non è soltanto un sistema criminale ma coinvolge anche la psicologia di chi vi è coinvolto e sin dall’infanzia il sentire mafioso ha origine nella famiglia la quale si configura come luogo privilegiato di formazione dell’identità e della coscienza, come ambiente privilegiato per la trasmissione dei valori su cui si basa l’agire mafioso. Ai figli si insegna l’agire criminale sotto forma di apprendimento durante la fase della socializzazione primaria cioè quella che si realizza all’interno del gruppo familiare. Il bambino apprende, assimila il modello culturale mafioso attraverso l’ osservazione e la partecipazione per poi arrivare ad interiorizzarlo, si identifica con chi si prende cura di lui all’inizio della sua vita e gli mostra un modello di valori e principi su cui costruirà i propri punti di riferimento. Si tratta di un tipo di apprendimento cultural-criminale che ricorda quanto sostenuto da Sutherland nella Teoria delle associazioni differenziali: l’agire criminale, al pari del comportamento sociale, si impara, si apprende e quindi l’individuo sviluppa una condotta conforme oppure deviante a seconda dei modelli sociali favorevoli o contrari alla legalità con i quali viene a contatto. Il luogo ideale per l’apprendimento è costituito da un’attività intima e privata quale è la famiglia o il gruppo amicale. Nel caso degli esponenti mafiosi il comportamento criminale è un comportamento appreso percepito come vero e proprio valore trasmesso all’interno della famiglia; il mestiere di criminale si impara in casa. Inoltre la madre ha il potere di influenzare le scelte del figlio, è un elemento cruciale affinchè il figlio assimili il modello paterno.
Un modello di donna che ha cresciuto i figli secondo i valori dell’ideologia mafiosa è quello di Ninetta Bagarella: donna di lignaggio mafioso è sorella di Leoluca Bagarella e moglie di Totò Riina (capo dei capi di Cosa Nostra fino ai primi anni 90) condivide la latitanza con il marito e nel mentre si occupa dell’educazione dei figli; le imputazioni per associazione di stampo mafioso a cui entrambi i figli sono stati sottoposti e l’ergastolo per omicidio cui è stato condannato il maggiore testimoniano il risultato di questo progetto educativo.
Inoltre la donna è titolare anche della cd “pedagogia della vendetta” (termine coniato da Renate Siebert) cioè di quel modello educativo incentrato sul mito del sangue e dell’onore con il quale sono cresciute dalle madri intere generazioni di mafiosi. Le donne hanno il compito di incitare continuamente i figli a vendicare l’onore del padre ucciso, a riparare il torto subito, non lasciando impuniti i suoi assassini. La vendetta, strettamente legata al concetto di onore, è un principio chiaro insegnato all’interno dell’organizzazione mafiosa e l’ invocazione femminile alla vendetta è accompagnata da un codice linguistico simbolico che si rifà al sangue: “sangue lava sangue”; “l’offesa va lavata con il sangue”. L’ideologia dell’onore può essere interpretata come una specie di “tecnica di neutralizzazione”del comportamento criminale (teoria di Sykes e Matza): le motivazioni onorifiche offrono all’affiliato una sorta di giustificazione morale alle proprie azioni efferate.
E’ proprio il complesso di valori della subcultura mafiosa di appartenenza, trasfusi in modo martellante sin dall’infanzia, che spiega come il giovane possa neutralizzare i valori della società civile, favorevoli alla giustizia e al rispetto delle leggi, attraverso il richiamo ad una lealtà più alta, quella della propria comunità e della propria famiglia mafiosa.
La funzione di incitamento alla vendetta va intesa non come parte di un ruolo fisiologicamente tipico della donna, ma come una funzione culturale tradizionalmente attribuitale nella divisione sessuale dei compiti all’interno di una determinata comunità: infatti studi della criminologia di stampo femminista (tra cui la criminologa Sonia Ambroset) hanno decostruito i preconcetti della criminologia classica in base ai quali la donna è stata storicamente considerata, per natura, più incline ad istigare il delitto piuttosto che a compierlo.
3. Il ruolo criminale della donna nella mafia
“Quando la mafia è davvero nei guai chiama a raccolta le sue donne” (sostituto procuratore Antonio Laudati). Anche se formalmente escluse dall’onorata società, in quanto non affiliate, le donne hanno assunto nel corso del tempo, accanto al ruolo tradizionale ricoperto nella sfera privata, un ruolo criminale. Infatti negli anni è emerso e si è affermato sempre di più un ruolo significativo delle donne non solo come trasmettitrici della cultura mafiosa in seno alla famiglia ma anche nella gestione delle attività delle cosche. Negli ultimi anni sono sempre di più le donne coinvolte in affari illeciti e l’intervento femminile nella sfera criminale da sporadico è diventato più sistematico. Le donne nel corso degli ultimi decenni hanno assunto il ruolo di gregarie e supplenti dei boss e talvolta sono giunte ad incarnare il ruolo di vero e proprio leader. Inoltre i numerosi casi di cronaca hanno smentito le convinzioni circa il ruolo esclusivamente pedagogico della donna all’interno della criminalità organizzata e l’immagine della moglie, della madre e della sorella del mafioso che per anni ci è stata tramandata come quella di una donna silenziosa, che non sa ciò che accade intorno a lei. Il coinvolgimento femminile nella sfera criminale conferma le capacità della mafia di adattarsi alle sfide economiche, giudiziarie e sociali: infatti il ruolo criminale delle donne è stato influenzato sia dalle esigenze di adattamento ai nuovi mercati illeciti sia dalla reazione alle attività di contrasto delle autorità pubbliche, che hanno portato a dei mutamenti interni al sistema mafioso. Per capire i cambiamenti interni alla mafia è utile rifarsi alla distinzione tra power syndicate (esso indica la struttura famiglia, con le rigide affiliazioni) e enterprise syndicate (esso rappresenta la molto più mobile rete degli affari cioè la dimensione economico-finanziaria) proposta dal criminologo Alan Block. Tale distinzione tra power e enterprise syndicate è fondamentale per inquadrare la posizione della donna la quale può prendere parte alla dimensione economico-finanziaria ma non le è concesso essere ammessa al power syndicate. Tuttavia tale schema proposto da Block è riduttivo perchè consente di spiegare la condizione di coloro che non possono essere ufficialmente membri del sodalizio criminale ma vengono assoldati per il solo fatto di soddisfare le nuove esigenze dell’organizzazione, come accade proprio nel caso delle donne; al contrario non permette di analizzare quei casi prevalenti di donne che sono già presenti nella struttura culturale della mafia e che, nonostante la loro ordinaria esclusione, possono prendere parte al power syndicate nei momenti di crisi del consorzio criminale.
A partire dagli anni 70 l’allargamento delle attività criminali in termini qualitativi, quantitativi e geografici, in particolare l’espansione del traffico internazionale di stupefacenti e la crescente necessità di riciclare i profitti illeciti hanno costretto i consorzi mafiosi a incrementare il personale impiegando in tali affari anche soggetti non affiliabili, secondo il codice mafioso, all’ “onorata società”, tra cui proprio le donne. Tale coinvolgimento si è consolidato nei periodi più critici per i consorzi mafiosi conseguenti alle guerre tra clan o alla repressione statale. A seguito della detenzione e della latitanza di numerosi esponenti anche di spicco dell’organizzazione mafiosa, come risulta dai fatti di cronaca nonchè da numerose sentenze, la donna ha assunto la direzione della cosca forte anche del fatto che alcune di esse si sono inserite nel tessuto sociale, nelle professioni e quindi possono aiutare la mafia con le loro attività parallele. Infatti quando i mariti si trovano in carcere sono le mogli, spesso aiutate dai parenti, ad assumere il controllo degli affari di famiglia. Dunque la mancata affiliazione non ha precluso alle donne un’effettiva partecipazione alle attività dell’organizzazione.
In particolare oggi le donne di mafia sono parte attiva nello svolgimento della criminalità mafiosa, la loro partecipazione è reale ed effettiva e sono tre i settori chiave in cui esse si inseriscono: traffico di droga, settore economico-finanziario e attività di gestione del potere.
Traffico di droga: l’espansione dei traffici ha posto la necessità di trovare manodopera fidata. Nel settore del narcotraffico le donne vengono assoldate, agiscono, come corrieri e spacciatrici. Infatti trasportare la droga è un mestiere particolartmente adatto alle donne sia perchè possono nascondere facilmente le confezioni di stupefacenti simulando una gravidanza o arrotondando fianchi e seno sia perchè più sicure in quanto insospettabili (proprio l’insospettabilità è preminente nell’assoldare figure femminili) e meno controllate dalla polizia (è altamente improbabile che vengano sottoposte a perquisizioni in aeroporto). Le donne coinvolte nel narcotraffico sono estranee alle logiche dei gruppi criminali per i quali lavorano: infatti si tratta di donne del poplo, soprattutto casalinghe madri di famiglia incensurate che vivono ai margini della società, hanno un numero elevato di figli da mantenere e faticano ad arrivare a fine mese. Queste donne accettano di entrare in traffici illeciti sia per provvedere alla propria famiglia sia per soddisfare il desiderio di raggiungere le mete consumistiche proposte dalla società.
Emblematica è la storia di un gruppo di casalinghe residenti a Torretta (paesino vicino Palermo) che nei primi anni 80 venivano sfruttate dalla mafia per trasportare ingenti quantità di droga da Palermo a New York (con indosso panciere riempite di eroina e ben profumate per non essere individuate dai cani antidroga, si imbarcavano all’aeroporto di Punta Raisi per New York dove consegnavano la merce ad altri affiliati dell’organizzazione. Dopo alcuni giorni ritornavano a Palermo con i dollari appiccicati sul corpo con il nastro adesivo). Le storie di vita delle donne di Torretta mettono bene in luce le condizioni di elevata marginalizzazione che connotano le criminali donne le quali sono spesso indotte al reato da situazioni di degrado e di miseria. Infatti di fronte all’opportunità di racimolare qualche spicciolo (infatti svolgono compiti comunque poco remunerativi anche se altamente rischiosi) accettano le “proposte lavorative” della criminalità organizzata che approfitta proprio di persone che versano in difficili condizioni economiche. Tuttavia a suscitare le condotte illegali non sono solo le necessità economiche di base, ma anche la mancanza di mezzi sufficienti per raggiungere le mete consumistiche proposte dalla società. Dunque il loro agire va letto attraverso la combinazione di due teorie sociologiche della devianza: la teoria della marginalizzazione e la teoria dell’anomia di Merton. Il sociologo struttural-funzionalista Merton mutua il concetto di anomia da Durkheim ma attribuisce ad esso un diverso significato: infatti utilizza il concetto di anomia per spiegare l’origine del delitto, intentendo il delitto come risposta a una società che ha le caratteristiche anomiche cioè la sua cultura propone delle mete senza che vengano forniti a tutti i mezzi per conseguirle. Infatti guadagnare soldi trasportando droga permetteva loro di colmare il gap prodotto da un’esperienza sociale condizionata da una situazione di anomia nel senso inteso da Merton. Questo risulta evidente sia dal modo in cui spendevano il denaro illecitamente guadagnato: lo spendevano per comprare prodotti superflui e consumistici; sia anche dalle osservazioni di una delle donne coinvolte la quale per giustificare la propria condotta sostiene di avere avuto bisogno di quei soldi per pagare le bollette e al contempo ammette di averli usati anche per abbellire la propria abitazione, una casa popolare (“ho fatto quello che ho fatto per il grande bisogno. La casa quando ce l’hanno data era bruttissima: porte, finestre, bagno, cucina, tutto era scarso come in tutte le case popolari; io l’ho trasformata perchè ho sempre sognato una casa bella come quella dei signori”). Dunque il denaro illecito risolveva talune strette necessità e contemporaneamente alleviava parte delle proprie frustrazioni. Infatti in contesti caratterizzati da un elevato livello di anomia cioè in cui vi è una forte disgregazione socio-economica la mafia trova facilmente lavoratori da assoldare perchè gli individui che vivono in condizioni di disagio vedono il mondo criminale come un’alternativa alla miseria economica, un’alternativa che oltre a fornire loro delle prospettive di vita, risulta allettante e garantisce anche un certo status sociale a cui altrimenti essi non potrebbero arrivare.
Nel settore del narcotraffico le donne vengono coinvolte anche nell’ organizzazione di traffici di droga: è il caso di Angela Russo, detta “Nonna Eroina”, arrestata nel 1982 per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Non ha avuto solo un semplice ruolo di corriera della droga ma è stata proprio lei a reggere anche le fila dell’ingente narcotraffico fatto dalla sua famiglia: infatti era lei che coordinava l’attività dei figli e delle nuore coinvolti nel traffico di droga, smistava le ordinazioni e a volte trasportava lei stessa la droga non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti. Nonna Eroina, nata e cresciuta in una famiglia mafiosa, può considerarsi una donna boss anche perchè aderisce totalmente e con convinzione al mondo mafioso: infatti sia al momento dell’arresto sia poi durante il processo e nei confronti del figlio pentito si comporta da perfetta mafiosa, presenta gli atteggiamenti tipici dei boss, mostrandosi forte e determinata, negando con convinzione l’esistenza della mafia e disprezzando la legge statale; ripudiando pubblicamente uno dei figli (Salvatore) quando decide di collaborare con la giustizia chiamandolo “infame” e “vigliacco” anche davanti ai giudici.
Altri esempi di donne che si sono comportate come vere e proprie boss sono rappresentati da: Ninetta Bagarella, moglie di Totò Riina, la quale in un’intervista affermò “la mafia non esiste è tutto un’invenzione dei giornali per vendere più copie”; e Serafina Buscetta, sorella di Tommaso (Masino), la quale rinnegò il fratello per la sua scelta di collaborare con la giustizia affermando in un’intervista “Non dite ancora che è mio fratello. Mi ha rovinato la vita”.
Settore economico-finanziario: l’esigenza di riciclare sempre più denaro sporco ha generato un lavoro criminale non necessariamente violento e compatibile con i tratti relazionali e culturali femminili. E’ il settore in cui si riscontra il maggior coinvolgimento femminile perchè questo ambito è particolarmente adatto alle donne sia perchè non richiede l’utilizzo delle violenza fisica che in generale, e nella mafia in particolare, è associata al sesso maschile sia perchè le donne anche grazie alla loro preparazione e ai loro studi molto spesso risultano più competenti e affidabili degli uomini. In tale settore le donne vengono utilizzate come la faccia pulita dell’organizzazione: infatti sono numerose le donne che favoriscono le attività delittuose dei congiunti, risultando prestanome, proprietarie di quote o addirittura intestatarie di società e imprese per lo più usate per il riciclaggio del denaro sporco, proprietarie di immobili acquistati con denaro illecito, proprietarie di esercizi commerciali, al posto dei mafiosi che non possono comparire.
Un esempio di donna particolarmente attiva in tale settore è quello di Nunzia Graviano: detta la “picciridda”, la sorella dei boss (Giuseppe e Filippo Graviano) del mandamento di Brancaccio (condannati per l’omicidio di padre Pino Puglisi e ritenuti responsabili dell’omicidio dei giudici Falcone e Borsellino), è stata caratterizzata da un certo spessore criminale e ha svolto efficacemente il ruolo di supplente durante la carcerazione dei fratelli reggendo le fila dei loro affari. Si è occupata soprattutto del settore finanziario, reinvestendo le ingenti risorse economiche della cosca, perchè ha tutte le potenzialità per occuparsi di investimenti in quanto è una donna sveglia, intelligente e acculturata: infatti la Graviano conosce le lingue straniere, sa usare il computer e legge il “Sole 24 ore” per tenersi aggiornata sulla Borsa e scegliere al meglio le azioni su cui investire i proventi illeciti.
La partecipazione delle donne nella sfera economico-finanziaria rimane nascosta, garantendo l’occultamento delle origini illegali dei beni accumulati dalla mafia, fino alla seconda metà degli anni 80 cioè fino a che non viene applicata la legge Rognoni-La Torre (approvata nel 1982): essa consente di emettere ordinanze di sequestro nei confronti di proprietà registrate sotto nomi “puliti”, ma sospettati di nascondere patrimoni mafiosi. Tale legge dunque estende ai familiari e ai prestanome dei mafiosi le indagini patrimoniali finalizzate alla confisca dei beni di cui non venga provata la legittima provenienza. Un esempio interessante al riguardo è quello di Francesca Citarda, moglie del boss Giovanni Bontate e figlia del boss Matteo Citarda entrambi appartenenti a famiglie mafiose storiche, la quale viene proposta per il soggiorno obbligato insieme al marito nel 1983 in applicazione della legge Rognoni-La Torre perchè il patrimonio dei due coniugi sarebbe in larga parte di origine illecita, costruito con il riciclaggio del denaro ricavato dal traffico di droga. Tuttavia il Tribunale di Palermo, pur attestando l’autenticità del legame tra Cosa Nostra e le famiglie degli imputati, respinge la richiesta di soggiorno obbligato solo per la donna sostenendo che non poteva essere colpevole perchè, in quanto moglie di un mafioso, non aveva raggiunto un livello di emancipazione sufficiente per essere in grado di commettere il reato per cui era stata sottoposta a giudizio cioè la donna non poteva aver rivestito un ruolo attivo negli affari della mafia per la naturale estraneità al difficile mondo degli affari. Infatti per lungo tempo i giudici hanno ritenuto le donne di mafia estranee alle imprese e agli affari di famiglia e la concezione mafiosa della donna incompatibile con la possibilità che essa assuma un ruolo attivo, rilevante penalmente o anche solo ai fini dell’applicabilità di una misura di prevenzione. Questo è uno dei casi più rappresentativi di trattamento preferenziale dei giudici nei confronti del genere femminile.
Attività di gestione del potere: le donne possono ricoprire anche ruoli più direttamente correlati alla gestione del potere mafioso e questo accade soprattutto quando la figura maschile è assente perchè è in carcere o perchè latitante. Nelle vesti di messaggere le donne trasportano, per conto dei membri del clan, le cd “ambasciate” (messaggi),dal carcere all’esterno oppure da un luogo di latitanza all’altro, attraverso le quali gli uomini possono supervisionare l’esercizio del potere temporaneamente delegato ad altri affiliati o, in certi casi, alle donne stesse. Le donne acquistano posizioni di comando quando il proprio uomo è assente (in carcere o latitante) ed il loro potere è meramente delegato, sostitutivo e temporaneo: infatti il potere delle donne scaturisce dallo stato detentivo o di latitanza del congiunto e dall’appartenenza familiare e gli uomini finchè sono in carcere concedono il potere a sorelle, mogli, figlie che lo esercitano fino a quando qualche uomo della famiglia riesce ad uscire dal carcere e a riprendere in mano la direzione del clan. Le donne boss sono accomunate dal fatto di essere temute e rispettate dai membri dell’organizzazione mafiosa sia per il loro cognome sia per la loro forte personalità.
In particolare nei momenti di crisi dell’organizzazione, dovuti all’assenza o alla collaborazione degli uomini del clan e al potenziamento dell’azione repressiva da parte delle Autorità competenti, la presenza femminile soprattutto nei ruoli di comando semplicemente si intensifica; infatti le donne sono presenti nella scena criminale anche nei momenti “di tranquillità”. La delega temporanea del potere costituisce un’intensificazione della presenza femminile soprattutto nelle posizioni di comando e non un semplice neoinserimento perchè le donne che da un giorno all’altro si rivelano così adatte all’attività criminale vera e propria sono già inserite in modo latente nel contesto criminale mafioso. Infatti le donne appena sono chiamate a ricoprire cariche elevate cioè si pongono alla guida del clan dimostrano immediatamente notevoli capacità di gestione delle attività grazie al know-how mafioso precedentemente acquisito perchè non è possibile improvvisare l’amministrazione di attività criminali che esige conoscenze e competenze specifiche. Le donne mostrano di avere una profonda conoscenza degli assetti mafiosi senza la quale non sarebbero in grado di sostituire il congiunto assente. Si tratta di un sapere costruito in passato, utile nelle situazioni di emergenza, segno che le donne sono in qualche modo coinvolte nel power syndicate già prima di comparire sulla scena criminale cioè fanno parte del gruppo mafioso già prima di rimpiazzre i loro congiunti. Infatti quasi tutte le mogli, le figlie e le sorelle degli uomini d’onore sono nate e cresiute in famiglie mafiose, hanno respirato aria di mafia fin dalla nascita e perciò conoscono benissimo il modo di fare e di pensare di un mafioso. Emblematico è il caso di Giusy Vitale la quale faceva parte del gruppo mafioso già prima di rimpiazzare i fratelli alla guida del sodalizio: infatti si permette addirittura di esprimere la propria opinione riguardo la scelta del nuovo capo mandamento, dopo aver visionato uno dei pizzini che i fratelli erano soliti consegnarle per comunicare tra di loro.
Giusy Vitale: è la prima donna condannata per associazione mafiosa (1998). Nota come “boss in gonnella”, ultima di quattro fratelli, è stata cresciuta per diventare una vera mafiosa. E’ l’unica donna nella storia di Cosa Nostra ad aver preso decisioni normalmente appannaggio degli uomini e dei boss, è l’unica ad aver veramente comandato: infatti quando i fratelli finiscono in carcere si ritrova ad essere la loro erede, prende il loro posto diventando capo mandamento di Partinico, e in questo ruolo fa eseguire sentenze di morte, omicidi, partecipa ai traffici di droga, ricicla il denaro sporco, ordina taglieggiamenti a commercianti e imprenditori, partecipa ai vertici mafiosi, si procura armi e ha contatti con importanti esponenti della cosca, da Bernardo Provenzano, a Matteo Messina Denaro e Giovanni Brusca.
Altro esempio significativo è Maria Filippa Messina: è la prima donna ad essere stata sottoposta al 41 bis cioè al cd carcere duro (nel 1996). E’ la moglie del boss Nino Cinturino e fu arrestata nel 1995 per aver sostituito completamente il capomafia assente dal 1992. La sua storia mette bene in luce la presa di potere come concessione scaturita dallo stato detentivo del marito e avente carattere delegato e sostitutivo: infatti quando il marito viene arrestato insieme a numerosi affiliati del suo clan si apre per Maria Filippa l’opportunità di dimostrare le proprie doti criminali, dapprima fungendo come anello di congiunzione tra il carcere e il mondo esterno, e successivamente sostituendosi al marito alla testa del consorzio criminale, una volta che questi fu sottoposto alla detenzione speciale. Infatti dal momento dell’arresto del marito diventa lei la guida del clan mostrando un particolare spessore criminale: è il vero polmone dell’organizzazione, tiene a raccolta gli uomini di maggior prestigio del clan e organizza con essi le sorti dell’ organizzazione criminale di cui è a capo. Non si limita a riscuotere tangenti per conto del marito in galera ma assume il comando militare della cosca e progetta massacri contro le bande rivali, incitando i membri del sodalizio a fare fuori i nemici. Infatti viene accusata di aver assoldato un killer per vendicare l’omicidio di un associato del clan e al momento dell’arresto era in procinto di ultimare l’organizzazione di una strage per eliminare esponenti del clan rivale e ristabilire il dominio della cosca dei Cinturino.
4. Vittimizzazione delle donne di mafia
Le vittime della mafia non sono solo quelle persone che vengono uccise ma anche quelle donne, sia estranee sia interne alla famiglia mafiosa, che vengono sfruttate dalle associazioni mafiose per soddisfare gli interessi dell’organizzazione stessa e quelle donne nate e cresciute in famiglie mafiose che, nonostante arrivino a ricoprire ruoli di comando, continuano comunque ad essere sottoposte ai maschi della famiglia (padri, mariti, fratelli) anche per quanto riguarda la sfera prettamente privata, la loro vita personale.
Infatti la condizione della donna nella mafia presenta anche aspetti di vittimizzazione cioè A) di sfruttamento perchè sia il diretto coinvolgimento negli affari criminali (come corrieri della droga, spacciatrici) sia l’attribuzione del potere di comando (cioè la donna si pone alla guida del clan, si configura come lady boss) rispondono alla logica secondo cui l’uomo utilizza le donne nel mercato criminale quando gli servono perchè sono indispensabili alle attività illecite maschili in quanto l’adempimento dei loro incarichi è unicamente funzionale agli interessi dell’organizzazione. Le donne fanno il loro ingresso in momenti di espansione delle attività criminali (cioè quando il mercato criminale richiede manodopera: esempio l’aumento della partecipazione delle donne è favorito dall’espansione del traffico internazionale di stupefacenti) e nei periodi di emergenza cioè nei periodi di conflitto tra fazioni rivali e di potenziamento dell’azione repressiva da parte delle Autorità competenti: infatti in tali situazioni le donne divengono pedine utili per accrescere le attività criminali, nei momenti di espansione, o per sopravvivere in tempi difficili. Significative sono al riguardo le storie delle donne di Torretta e di alcune lady boss quali Nunzia Graviano e Maria Filippa Messina.
B) di subordinazione al potere di controllo degli uomini della famiglia anche sul piano delle scelte che riguardano la sfera personale. Per esempio persino una donna, apparentemente emancipata come Nunzia Graviano, trattata dai fratelli al pari di un membro della cosca, si ritova a dover rinunciare alla propria individualità per sottostare alle regole maschili della famiglia. La sua libertà personale è limitata dalla volontà dei fratelli che, non gradendo la storia d’amore di Nunzia (aveva intrapreso una relazione con un medico siriano),tra l’uomo amato e la famiglia d’origine, la costringono a scegliere quest’ultima.
5. Conclusioni
In base a quanto espresso nelle pagine precedenti possiamo arrivare alla conclusione che: 1) anche nella mafia come in ogni famiglia e in ogni società la figura femminile riveste e rivestirà sempre un ruolo fondamentale e indispensabile perchè le donne costituiscono l’architrave su cui poggiano le organizzazioni mafiose: esse hanno la funzione di procreare, mettere al mondo i figli e di educarli e formarli come figli d’onore garantendo così il futuro dell’organizzazione; di intervenire nelle situazioni di difficoltà dell’organizzazione assicurando la prosecuzione del comando, del potere dell’uomo in carcere o latitante e garantendo così la sopravvivenza dell’organizzazione. Alla mafia la donna serve: serve, in primo luogo, anzi è indispensabile nell’essere madre, poiché in tale veste è la principale, se non l’unica responsabile, della trasmissione ai figli del codice disvaloriale mafioso concorrendo a formare perfetti futuri Riina o Provenzano e perfette future Palazzolo o Bagarella; serve perché tra detenuti, latitanti e pentiti la donna rimane la persona più affidabile cui impartire importanti compiti che si traducono nella commissione di svariati illeciti; ed ancora serve ed è necessaria se grazie ad una certa miopia del mondo giuridico e degli altri addetti ai lavori, che ha creduto alla sua marginalità, ha goduto di maggiori sconti di pena se non addirittura dell’impunità, garantendole, per più di 20 anni, un indisturbato sviluppo.
2) nonostante nel tempo il coinvolgimento femminile nella sfera criminale da sporadico sia diventato più sistematico e sia aumentato il numero di casi di supplenza e di donne capo è sbagliato pensare che le organizzazioni mafiose abbiano avviato una politica di pari opportunità per le donne perchè le storie delle donne di mafia rivelano che la condizione femminile nella mafia è mutata tanto quanto è rimasta intatta in quanto la mafia continua a conservare il suo carattere maschilista e a ricorrere alle donne per i suoi affari criminali solo in caso di necessità. Infatti il mondo mafioso continua ad essere caratterizzato nei confronti delle donne da: relazioni di genere di tipo patriarcale, dipendenza economica, controllo degli uomoni sulla loro vita, assunzione di lavori poco remunerativi e altamente rischiosi, concessione del potere meramente temporanea; tutti elementi che testimoniano sia come l’inclusione della donna si configuri quale sfruttamento femminile strumentale alle attività criminali dell’organizzazione stessa sia come la mafia non riconosca il valore della libertà femminile intesa come presa di coscienza della propria autonomia individuale.Infatti l’inserimento sempre più organico e stabile, non è emancipazione, ma una gentile “concessione” dell’Onorata Società rispondente solo all’egoistica necessità di preservare se stessa. La mafia ha consentito l’accesso alle attività criminali ad una nuova generazione di donne, più istruite e libere di muoversi rispetto al passato ma allo stesso tempo, però, ha negato loro la completa indipendenza fisica, psicologica ed emotiva. Le donne sembrano aver raggiunto un’eguaglianza sul piano criminale ma non nella sfera individuale dove appaiono ancora legate a vincoli tradizionali propri di un sistema di genere patriarcale. Non vi è mai una rottura della dipendenza psicologica ed economica dai propri mariti o compagni, se non nei casi di collaborazione con la giustizia. La mafia nega alla donna qualsiasi forma di parità e di libertà d’espressione della propria individualità. Sicuramente la loro condizione proprio perché caratterizzata in parte da elementi di subordinazione e dipendenza dall’uomo, è una condizione di inferiorità e quindi si può parlare di vittimismo.
3) il comune atteggiamento paternalistico e maschilista, che ha caratterizzato la società, gli addetti ai lavori e la “criminalità di genere”, ha celato il volto femminile della mafia permettendo alla stessa di operare in sordina.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
DONNE VITTIME DI MAFIA
- Adriana Vassallo
- Agata Azzolina
- Agata Zucchero
- Angela Calvanese
- Angela Costantino
- Angela Fiume
- Angela Talluto
- Angelica Pirtoli
- Anna Maria Brandi
- Anna Nocera
- Anna Pace
- Anna Prestigiacomo
- Anna Rosa Tarantino
- Annalisa Durante
- Annamaria Esposito
- Barbara Rizzo
- Carmela Minniti
- Caterina Liberti
- Concetta Lemma
- Concetta Matarazzo
- Cristina Mazzotti
- Domenica Zucco
- Emanuela Loi
- Emanuela Sansone
- Emanuela Setti Carraro
- Federica Taglialatela
- Francesca Moccia
- Francesca Morvillo
- Gelsomina Verde
- Giovanna Giammona
- Giovanna Sandra Stranieri
- Giuditta Levato
- Giuseppina Guerriero
- Giuseppina Savoca
- Grazia Scimè
- Graziella Campagna
- Graziella Maesano
- Ida Castelluccio
- Letizia Palumbo
- Liliana Caruso
- Lucia Cerrato
- Lucia Precenzano
- Luisella Matarazzo
- Marcella Di Levrano
- Maria Angela Ansalone
- Maria Antonietta Savona
- Maria Chindamo
- Maria Colangiuli
- Maria Concetta Cacciola
- Maria Giovanna Elia
- Maria Luigia Morini
- Maria Maesano
- Maria Marcella
- Maria Stillitano
- Maria Teresa Pugliese
- Mariangela Passiatore
- Martina Kušnírová
- Masina Perricone Spinelli
- Matilde Sorrentino
- Natalina Stillitano
- Nicolina Biscozzi
- Nicolina Mazzocchio
- Palmina Gigliotti
- Palmina Scamardella
- Patrizia Scifo
- Raffaella Scordo
- Renata Fonte
- Rita Atria
- Rita Cacicia
- Rosa Fazzari
- Rosa Zaza
- Rosalia Pipitone
- Rossella Casini
- Santa Buccafusca
- Santa Puglisi
- Silvana Foglietta
- Silvia Ruotolo
- Susanna Cavalli
- Tommasa Perricone
- Valentina Guarino
- Valeria Moratello
- Vincenza La Fata
- Vincenza Spina
- Vita Dorangricchia
Note
- Salta↑ Falcone, Cose di Cosa Nostra, p.80-81
- Salta↑ Siragusa-Seminara, 1996, p. 110
- Salta↑ Cascio – Puglisi (a cura di), 1986, p. 16
- Salta↑ «L’Ora», 17 dicembre 1990
- Salta↑ Cascio – Puglisi (a cura di), 1986, pp. 83 s., 86 s., 96 s.
- Salta↑ Pino, 1988, p. 89
- Salta↑ Pino, 1988, pp. 79 s.
- Salta↑ «Giornale di Sicilia», 5, 6 e 7 febbraio 1995
- Salta↑ «Giornale di Sicilia», 11 gennaio e 19 dicembre 1996
- Salta↑ Madeo, 1992, p. 76
- Salta↑ «La Repubblica», 24 maggio 1996
- Salta↑ Cascio – Puglisi (a cura di), 1986, pp. 32 s.
- Salta↑ Ivi, p. 35
- Salta↑ Ingrascì O., Donne, ‘ndrangheta, ‘ndrine. Gli spazi femminili nelle fonti giudiziarie. Donne di mafia. Rivista Meridiana, p. 39
- Salta↑ Ingrascì O., Donne, ‘ndrangheta, ‘ndrine. Gli spazi femminili nelle fonti giudiziarie. Donne di mafia. Rivista Meridiana, p. 52
- Salta↑ Alessandra Dino, Un mondo in frantumi, Inchiesta: donne e’ndrangheta, Rivista Narcomafie marzo 2012, p.47
- Salta↑ Ingrascì O., Donne d’onore, storie di mafia al femminile,Bruno Mondadori, 2007, p.43
- Salta↑ Dino A., Un mondo in frantumi, Inchiesta: donne e ‘ndrangheta, Rivista Narcomafie, marzo 2012, p.45
- Salta↑ Ingrascì O.Donne d’onore, storie di mafia al femminile, Bruno Mondadori, 2007, p. 71.
- Salta↑ Siebert R., Donne di mafia, Rivista Meridiana, p. 27
- Salta↑ Renate Siebert, Donne di mafia, Rivista Meridiana, p.96
- Salta↑ Siebert R., Donne di mafia, Rivista Meridiana, p.105
- Salta↑ Siebert R., Donne di mafia, Rivista Meridiana, p.116
- Salta↑ Corte di Cassazione, Prima sezione penale, Sentenza n. 10953, 26 maggio 1999
- Salta↑ Siebert R., Donne di mafia, Rivista Meridiana, p.133
- Salta↑ Siebert R., Donne di mafia, Rivista Meridiana, p.152
Bibliografia
- Bartolotta Impastato Felicia, La mafia in casa mia, intervista di A. Puglisi e U. Santino, La Luna, Palermo 1986.
- Beretta F., Le figure femminili nei processi di ‘ndrangheta. Il caso lombardo attraverso gli atti giudiziari 2009-2012, tesi di laurea, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano, 2012
- Cascio Antonia – Puglisi Anna (a cura di), Con e contro. Le donne nell’organizzazione mafiosa e nella lotta contro la mafia, Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato, Palermo 1986.
- Chinnici Giorgio – Santino Umberto, La violenza programmata. Omicidi e guerre di mafia a Palermo dagli anni ’60 ad oggi, F. Angeli, Milano 1989.
- De Mauro Mauro, La vedova Battaglia accusa, «L’Ora”, 21 gennaio 1964.
- Ganci Massimo, I fasci dei lavoratori, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma 1977.
- Levi Carlo, Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia, Einaudi, Torino 1955.
- Madeo Liliana, Donne di mafia, Mondadori, Milano 1992.
- Mazzocchi Silvana, Quelle iene non mi fanno paura, intervista a Giacoma Filippello, «Il Venerdì di Repubblica», 23 aprile 1993.
- Ministro dell’Interno, Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata per l’anno 1995, Tipografia del Senato, Roma 1996.
- Pino Marina, Le signore della droga, La Luna, Palermo 1988.
- Puglisi Anna, Sole contro la mafia, La Luna, Palermo 1990.
- Puglisi Anna, A proposito della lettera di Ninetta Bagarella e della risposta del giudice Vigna, «Narcomafie», luglio 1996; ripubblicato in A. Puglisi, Donne, mafia e antimafia, Centro Impastato, Palermo 1998.
- Puglisi Anna, Donne, mafia e antimafia, Centro Impastato, Palermo 1998.
- Rizza Sandra, Una ragazza contro la mafia. Rita Atria, morte per solitudine, La Luna, Palermo 1993.
- Santino Umberto – La Fiura Giovanni, L’impresa mafiosa. Dall’Italia agli Stati Uniti, F. Angeli, Milano 1990.
- Santino Umberto, La mafia interpretata, Rubbettino, Soveria Mannelli 1995a.
- Siebert Renate, Le donne, la mafia, Il Saggiatore, Milano 1994.
- Siebert Renate, La mafia, la morte e il ricordo, Rubbettino, Soveria Mannelli 1995.
- Siragusa Mario – Seminara Giuseppina, Società e mafia nella Gangi liberale e fascista, Edizioni Progetto Ganci, Ganci 1996.
- Transirico Connie, Braccata. Dal rifugio segreto una pentita racconta, Sigma edizioni, Palermo 1994.
- Tribunale civile e penale di Palermo, Misura di prevenzione nei confronti di Citarda Francesca, 11 febbraio 1983.
- Zanuttini Paola, La mia guerra alla mafia, intervista a Piera Aiello, «Il Venerdì di Repubblica”, 14 gennaio 1994.
a cura di Claudio Ramaccini Direttore Centro Studi Sociali contro la mafia – Progetto San Francesco