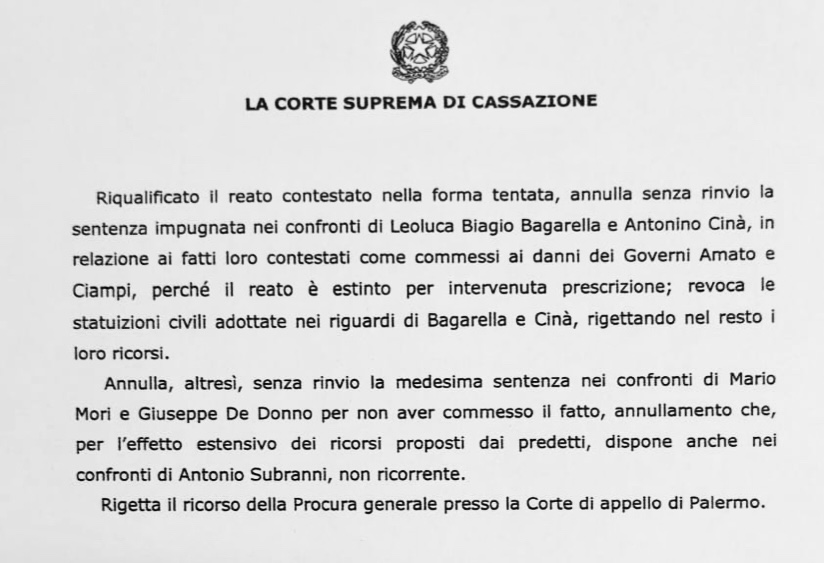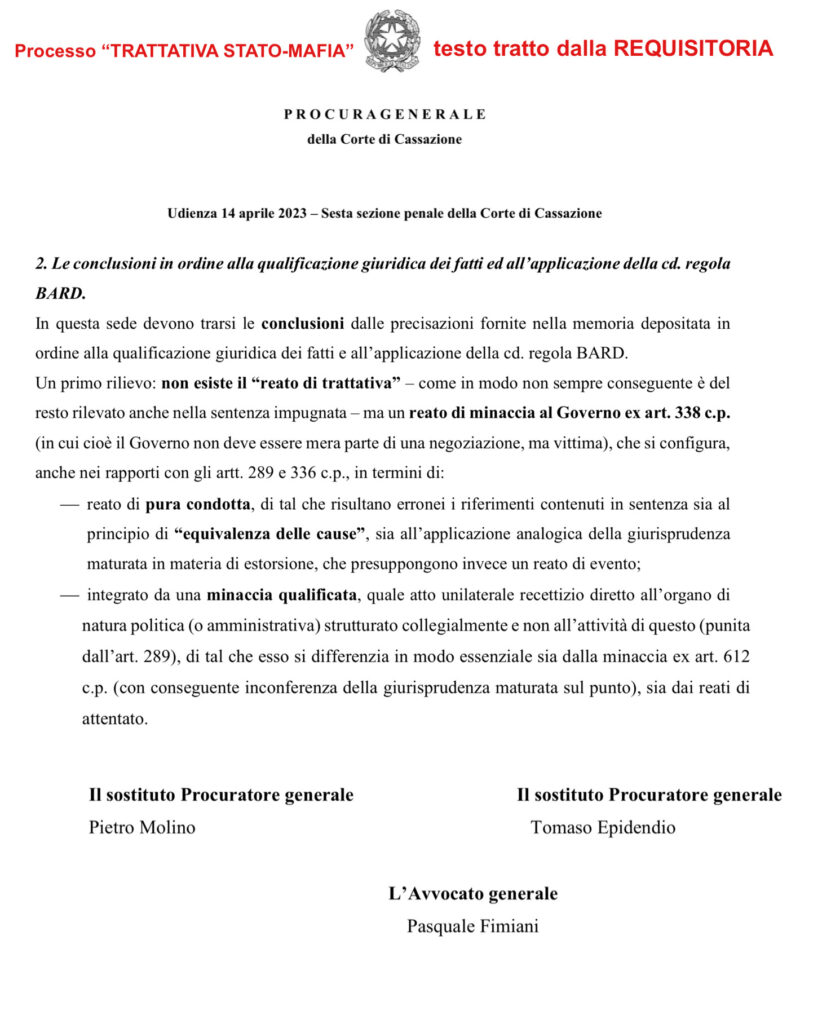27.4.2023 – Stato-mafia: confermate le assoluzioni per Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri. La Cassazione demolisce le accuse. Prescritta l’accusa per Bagarella. Mori: “Sempre stato convinto della mia innocenza”
Demolito dalla Cassazione l’impianto accusatorio dell’indagine sulla presunta trattativa Stato-Mafia.
I giudici della sesta sezione hanno confermato l’assoluzione per gli ex investigatori del Ros, per l’ex parlamentare Marcello Dell’Utri e riconosciuto la prescrizione per il boss di Cosa Nostra, Leoluca Bagarella e per il medico Antonino Cinà, ritenuto vicino a Totò Riina.
Al termine della camera di consiglio i giudici hanno annullato la sentenza di appello senza rinvio, con la formula per non avere commesso il fatto, per quanto riguarda il generale dell’Arma, Mario Mori e per gli ufficiali dei carabinieri Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. I supremi giudici sono quindi andati oltre quanto già deciso dai giudici di secondo grado di Palermo perché nel fare cadere le accuse hanno utilizzato una formula più ampia.
Per le posizioni di Bagarella e Cinà, condannati in secondo grado rispettivamente a 27 anni e 12 anni, i giudici del Palazzaccio hanno riqualificato i reati di violenza e minaccia ad un corpo politico dello Stato nella forma del tentativo: con la riqualificazione la fattispecie è andata, quindi, in prescrizione.
In aula, al momento della lettura del dispositivo, era presente Mori che lasciando la Cassazione ha affermato di sentirsi “parzialmente soddisfatto”della decisione “considerando che per 20 anni mi hanno tenuto sotto processo. Ero convinto di non avere fatto nulla, il mio mestiere lo conosco, so che se avessi sbagliato me ne sarei accorto”. I magistrati non hanno quindi accolto le richieste del pg che aveva sollecitato un nuovo processo di appello per i tre ex Ros e per Bagarella e Cinà.
Nelle conclusioni della sua requisitoria, nell’udienza del 14 aprile scorso, il rappresentate dell’accusa aveva sollecitato “l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla minaccia nei confronti dei governi Amato e Ciampi”.
Per il pg, la sentenza di secondo grado ha descritto “la trattativa negli anni ma non fa una precisa ricostruzione della minaccia e di come sia stata rivolta al governo” e lo fa solo in modo “congetturale”. Con la decisione di oggi i giudici sostanzialmente affermano che le minacce furono soltanto dei meri tentativi da parte di alcuni esponenti di Cosa Nostra.
I supremi giudici erano chiamati a decidere sul ricorso presentato dalla Procura generale del capoluogo siciliano dopo la sentenza del 23 settembre 2021 che ribaltò il verdetto assolvendo la gran parte degli imputati condannati in primo grado. In primo grado Mori e Subranni furono condannati a 12 anni mentre Giuseppe De Donno ad 8 anni. Nelle migliaia di pagine delle motivazioni della sentenza di secondo grado i giudici siciliani, spiegando le ragioni dell’assoluzione dal reato di minaccia a Corpo politico dello Stato e parlando del ruolo svolto dai militari dell’Arma, hanno scritto che “una volta assodato che la finalità perseguita, o comunque prioritaria, non fosse quella di salvare la vita all’ex ministro Mannino o ad altre figure di politici che rischiavano di fare la fine di Lima, nulla osta a riconoscere che i carabinieri abbiano agito avendo effettivamente come obbiettivo quello di porre un argine all’escalation in atto della violenza mafiosa che rendeva più che concreto e attuale il pericolo di nuove stragi e attentati, con il conseguente corredo di danni in termini di distruzioni, sovvertimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e soprattutto vite umane”. ANSA
Il 27 maggio 2013 inizia il processo relativo alla vicenda della trattativa Stato-mafia.
Il 20 aprile 2018 viene pronunciata la sentenza di primo grado, con la quale vengono condannati a 12 anni di carcere Mario Mori, Antonio Subranni, Marcello Dell’Utri, Antonino Cinà, ad 8 anni Giuseppe De Donno e Massimo Ciancimino, a 28 anni Leoluca Bagarella; sono prescritte, come richiesto dai pubblici ministeri, le accuse nei confronti di Giovanni Brusca, e viene assolto Nicola Mancino. La sentenza è emessa dalla Corte d’Assise di Palermo presieduta dal dott. Alfredo Montalto, in un’aula stracolma, alla presenza dei Pubblici Ministeri Antonino Di Matteo, Roberto Tartaglia, Francesco Del Bene e Vittorio Teresi.
Il processo d’appello inizia a Palermo nell’aprile 2019.
Nel giugno 2021 la procura generale chiede la conferma delle condanne di primo grado.
Il 23 settembre dello stesso anno la Corte d’assise d’appello di Palermo assolve gli ex ufficiali del ROS Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno perché “il fatto non costituisce reato” e l’ex senatore Marcello Dell’Utri “per non aver commesso il fatto”, accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato, mentre sono prescritte le accuse a Giovanni Brusca, viene ridotta a ventisette anni la pena al boss Leoluca Bagarella e viene confermata la condanna a dodici anni del capomafia Antonino Cinà.
Il 6 agosto 2022 sono depositate le motivazioni della sentenza che stabilisce che la trattativa si sostanziò in una “improvvida iniziativa”, nell’ottica di voler evitare ulteriori stragi, degli ufficiali dei Carabinieri (comunque assolti dalle accuse di reato) e non politica.[102][103][104]
Il 27 aprile 2023 la Corte di Cassazione assolve gli ex ufficiali del ROS Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e l’ex senatore Marcello Dell’Utri dall’accusa di minaccia a Corpo politico dello Stato per “non aver commesso il fatto“, mentre l’accusa nei confronti di Leoluca Bagarella ed Antonino Cinà viene riderubricata a “tentata minaccia a Corpo politico dello Stato” e dichiarata prescritta.
27.4.2023. Confermata dai giudici di Cassazione l’assoluzione, per i tre ex investigatori del Ros, Mori, Subranni e De Donno. I giudici hanno annullato la sentenza di appello senza rinvio con la formula per non avere commesso il fatto nel procedimento sulla presunta trattativa stato-mafia. Assoluzione definitiva anche per l’ex parlamentare Dell’Utri.
I giudici della sesta sezione della Cassazione hanno dichiarato la prescrizione per il boss di Cosa Nostra, Leoluca Bagarella, condannato dai giudici di Appello di Palermo a 27 anni e per il medico Antonino Cinà, ritenuto vicino a Totò Riina, a cui in secondo grado furono inflitti 12 anni di reclusione nell’ambito del procedimento sulla presunta trattativa stato-mafia. I giudici hanno infatti riqualificato i reati di violenza e minaccia ad un corpo politico dello Stato nella forma del tentativo. Con la riqualificazione la fattispecie è andata in prescrizione.
“Sono parzialmente soddisfatto considerando che per 20 anni mi hanno tenuto sotto processo. Ero convinto di non avere fatto nulla, il mio mestiere lo conosco, so che se avessi sbagliato me ne sarei accorto“. Lo afferma il generale ex Ros, Mario Mori commentando la decisione della Cassazione.
“Di fronte all’assoluzione definitiva degli imputati nel processo sulla fantomatica trattativa Stato-mafia, non possiamo che avere una duplice reazione. Grande gioia e soddisfazione, perché è stata riconosciuta l’innocenza del senatore Dell’Utri, degli ex generali del Ros dei carabinieri, Mori e Subranni, e dell’ex ufficiale De Donno. Servitori dello Stato dei quali non abbiamo mai dubitato l’integrità e la correttezza. Una sentenza, tuttavia, che se da una parte restituisce l’onore, agli uomini e all’Arma dei carabinieri, che un’inchiesta dissennata aveva cercato di deturpare, dall’altra non può mai ripagare anni e anni di gogna giudiziaria, un tormento che ha coinvolto non solo gli imputati ma anche le loro famiglie“. Così, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.
“La pietra tombale che arriva dalla Corte di Cassazione con le assoluzioni del generale Mori, del generale Subranni, del colonnello De Donno e di Marcello Dell’Utri per il processo sulla cosiddetta ‘Trattativa’ costituiscono la fine di un calvario che oltre ad aver sconquassato la vita degli imputati, ha minato la credibilità delle Istituzioni“. Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè in una nota. Il parlamentare ‘azzurro’ sottolinea che: “Ai tre ufficiali dell’Arma e all’ex senatore, nessun risarcimento potrà restituire ciò che è stato tolto da un’iniziativa giudiziaria basata su un astruso e mai provato teorema che si reggeva su inesistenti pilastri d’accusa. L’onestà, il rigore e la credibilità di Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri viene sancita dopo decenni di indagini e processi costati un patrimonio dal punto di vista finanziario che hanno visto intaccare il patrimonio inestimabile dell’onore degli imputati“. IL SICILIA
“Trattativa Stato-mafia”: le memorie e la requisitoria della Procura Generale presso la Corte di Cassazione
Segnaliamo, in merito al processo sulla cd. “Trattativa Stato-mafia”, le due memorie e il testo della requisitoria, con annesse conclusioni, della Procura Generale presso la Corte di Cassazione (a firma dell’Avvocato generale Pasquale Fimiani, del sostituto Procuratore generale Pietro Molino e del sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio).
L’udienza si è tenuta presso la sezione sesta della Corte di Cassazione in data 14 aprile 2023 ed è stata rinviata per la decisione al 27 aprile 2023. In tutti i provvedimenti si è proceduto all’oscuramento dei dati sensibilisecondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati Sulla medesima vicenda abbiamo già pubblicato su questa Rivista:
- – le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo
- – le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo
- Scarica la memoria depositata il 22 marzo
- Scarica la memoria integrativa depositata il 30 marzo
- Scarica la requisitoria e le conclusioni
Trattativa Stato-mafia: le motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo
Corte di Assise di Appello di Palermo, Sez. II, 6 agosto 2022 (ud. 23 settembre 2021). Presidente Pellino, Relatore Anania
Segnaliamo ai lettori, con riferimento al procedimento sulla cd. trattativa Stato-mafia, le motivazioni della sentenza con cui, il 23 settembre 2021, la Corte di Assise di Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto Marcello Dell’Utri (con la formula “per non aver commesso il fatto“), Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno (con la formula “perché il fatto non costituisce reato“).
- Il provvedimento – 3.000 pagine circa in tutto – è suddiviso in tre parti:
- – la prima (da pagina 86 a pagina 991) è dedicata all’esposizione della sentenza di primo grado, con la ricostruzione dei fatti e le valutazioni operate dalla Corte di primo grado (senza che sia anticipato o espresso alcun giudizio di condivisione o dissenso);
- – la seconda (da pagina 992 a pagina 1255) è dedicata all’esposizione dei singoli atti d’appello;
- – la terza (da pagina 1256 a pagina 2968) è la vera e propria motivazione della sentenza d’appello, in cui si espongono la (parzialmente) diversa ricostruzione e le differenti valutazione formulate in esito al giudizio d’appello dalla Corte d’Assise d’Appello.
Tramite questo link è possibile scaricare la sentenza emessa, in primo grado, dalla Corte di Assise di Palermo nei confronti degli stessi imputati che sono stati giudicati con il rito ordinario.
Quanto alla posizione dell’ex ministro Calogero Mannino – giudicato con il rito abbreviato – tramite questo link è possibile scaricare la sentenza di primo grado e tramite questo link è possibile scaricare la sentenza di appello.
26.9.2021 – Processo Trattativa, fra i pubblici ministeri di Palermo ci fu chi disse no
- 25.4.2023 Trattativa Stato Mafia, i Pg: “Tremila pagine di sentenza, ma manca la prova della minaccia”
- 28.4.2023 Processo trattativa Stato-mafia, l’avvocato dei Borsellino: “Persi tanti anni”
- 28.4.2023 La trattativa Stato-mafia non c’è mai stata
- 28.4.2023 Processo trattativa Stato-mafia, i Ros “assolti per non aver commesso il fatto”
- 28.4.2023 Trattativa Stato-mafia, fu un tentativo. Un commento alla sentenza della Cassazione
- 28.4.2023 Chi sono i registi dell’operazione trattativa: 10 anni di balle su Mori e i Ros, carriere di magistrati e giornalisti costruite sul fango
- 28.4.2023 Processo Trattativa, legale Mori: “Ora basta persecuzioni e schizzi di fango”
- 28.4.2023 Trattativa, non c’è Stato LA RIFLESSIONE DI SALVATORE BORSELLINO
- 29.4.2023 Trattativa, il processo ha svelato fatti e verità
- 30.4.2023 Processo su trattativa non sarebbe mai dovuto iniziare, giustizia usata per altri obiettivi”, parla l’avvocato Manes
- 30.4.2023 FIANDACA: “Il processo sulla trattativa Stato-mafia andava bloccato subito”
- 30.4.2023 Dalle condanne alle assoluzioni definitive, la storia del processo “Trattativa Stato-Mafia”
29.4.2023 MARIO MORI: «L’inchiesta trattativa, con Falcone e Borsellino, non l’avremmo avuta» Parla MARIO MORI, l’ex generale dei Carabinieri assolto dopo un quarto di secolo da imputato
«In tutti i campi, in ogni settore, sono le singole persone, che contano, più della sovrastruttura di cui fanno parte. Vale per l’Arma dei carabinieri come per la magistratura. Tengo a dire altre due cose. In questi anni, la tensione per un’accusa e un processo iniziati nel 1997 mi hanno tenuto sempre vivo: forse devo dire grazie a tutto questo; e poi, soprattutto, se ci fossero stati ancora Giovani Falcone e Paolo Borsellino, nulla di quanto è avvenuto nelle attività giudiziarie relative alla mafia sarebbe accaduto, in questi ultimi venticinque anni». Mario Mori sa, non lo nasconde, di aver servito lo Stato anche con il proprio sacrificio di imputato. Insieme con Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, ha sopportato con tenacia, rigore, straordinaria tenuta morale, più di quanto avrebbe potuto sopportarlo chiunque, il peso del lunghissimo processo sulla presunta trattativa Stato- mafia, dal quale giovedì scorso è uscito definitivamente assolto in Cassazione, insieme con gli altri imputati, compreso l’ex senatore e cofondatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri. Mori non perde la serenità, la forza, persino l’ottimismo che l’hanno evidentemente sorretto finora. Ma neanche risparmia critiche a chi ha ritenuto che una complicità, negli anni bui della mafia stragista, potesse annidarsi nel Ros dei carabinieri.
Generale Mori, dopo un quarto di secolo da imputato, che idea ha della giustizia italiana?
Io resto fermo sui principi che mi hanno consentito di andare avanti, e nei quali ho sempre creduto. È molto semplice: l’Arma dei carabinieri, la giustizia, lo Stato, sono sovrastrutture. Poi c’è chi ne fa parte. E certo, possono capitare gli incidenti di percorso: il mio è stato effettivamente un po’ prolungato Come ha resistito?
Si sorprenderà di quanto dico, ma io ho bisogno di un avversario. Nel senso che nella mia vita il confronto con una posizione anche radicalmente avversa alla mia mi ha sempre dato forza. Ho sempre avuto una controparte, in questi venticinque anni. Non sono stati pochi. Ma mi verrebbe da dire che potrei ricominciare tutto daccapo. È la mia vita, è stata la mia vita.
Stare in tensione, oppresso da un’accusa tremenda come quella di aver minacciato lo Stato per conto della mafia stragista, lo ha tenuto vivo, dice?
E sì: sono sempre stato in tensione, forte dei miei convincimenti, della consapevolezza di essere nel giusto. Soprattutto, di aver avuto comportamenti consoni al mio incarico, alle mie funzioni, e di non essere mai andato fuori dal perimetro. Sì, avevo bisogno di un avversario, tanto che subito dopo la sentenza della Cassazione mi sono detto: e ora che faccio?
Ritiene che una parte della magistratura abbia pensato di poter ricostruire la storia del Paese, oltre che perseguire specifiche condotte individuali?
Io ho presente la Costituzione: e secondo la Costituzione, il magistrato deve applicare la legge, non estenderne il significato. In ogni caso, l’idea di dover fare luce su una fase della storia italiana avrebbe dovuto riguardare le competenze non della magistratura, ma di una commissione parlamentare d’inchiesta. Ecco, quella sarebbe stata una strada corretta per provare a comprendere il senso di quanto avvenuto nella storia del nostro Paese in quegli anni. Non capisco invece, un’attività giudiziaria che si proponga un obiettivo del genere.
Le indagini sulla cosiddetta trattativa hanno suscitato, per lungo tempo, grandi consensi e aspettative diffuse: un fenomeno del genere si spiega con quello stesso sentimento di diffidenza nei confronti delle istituzioni che ha accompagnato prima le inchieste di Mani pulite e poi le indagini sulla politica degli anni successivi?
Di sicuro non credo che un clima del genere possa aver condizionato le scelte della magistratura. Altrimenti ci saremmo trovati di fronte a un pericolo molto grave. La magistratura è un’altra cosa e ha ben altri compiti.
I magistrati che hanno condotto indagini sulla mafia sono stati esposti a rischi tremendi. La consapevolezza di essere un bersaglio può incidere sulle scelte di un magistrato?
Ritengo che nessuno possa farsi condizionare nell’attività che svolge. Nella mia vita professionale ho corso dei rischi non trascurabili. Se me ne fossi sentito schiacciato, non avrei potuto fare quel lavoro. D’altra parte, ho dovuto fare i conti con la sofferenza di questi anni, che non è stata lieve.
Cosa direbbero Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con i quali lei ha lavorato, di questa sentenza?
Le rispondo indirettamente: se ci fossero stati loro non sarebbe avvenuto nulla di quanto è avvenuto in questi ultimi venticinque anni nell’ambito dei processi relativi alla mafia. Sarebbe stata tutta un’altra storia.
Crede che Falcone e Borsellino abbiano lasciato tracce, per le indagini su Cosa nostra, che non sono state seguite abbastanza?
Sicuramente il filone “Mafia e appalti” poteva essere valorizzato meglio.
Ormai è tardi?
Sono scomparsi quasi tutti, quasi tutti coloro che avrebbero potuto essere un riferimento per esplorare quelle ipotesi. Io all’epoca dell’indagine “Mafia e appalti”, sulla quale lavorai, ero un giovincello, ora ho 83 anni.
Vengono a mancare le testimonianze. La famiglia Borsellino svolge un’opera meritoria e nobilissima, ma le possibilità di arrivare a dei risultati si sono ridotte terribilmente.
I giudici del processo “trattativa” sono stati un esempio di autonomia e indipendenza, non crede?
Hanno dovuto fare i conti con una pressione ambientale notevole, si sono trovati davanti una Procura importantissima come quella di Palermo. Hanno esaminato le carte, ascoltato i testimoni e redatto in tutta onestà la loro sentenza. Dai giudici palermitani ho ottenuto tre assoluzioni.
Su “Mafia e appalti” lei dice che c’è ormai poco da sperare: e per la possibilità di fare luce su via D’Amelio?
Mi auguro vi sia qualcuno in grado di trovare il bandolo, ma anche qui non vedo molte possibilità.
Un’ultima parola sugli avvocati che l’hanno difesa fino all’assoluzione definitiva: alcuni giovani, come Basilio Milio.
In Cassazione sono stato difeso da un grande luminare come il professor Vittorio Manes. Ho iniziato ad affrontare le mie vicende penali assistito dall’onorevole Pietro Milio, padre di Basilio. Dal padre, la mia difesa è passata al figlio, che ho visto crescere da che era un giovanissimo avvocato fino a diventare un grande professionista, animato da una fiducia e da una forza straordinarie.
Non voleva che il lavoro del padre restasse incompiuto.
Esatto. 29 aprile, 2023 • IL DUBBIO Errico Novi
27.4.2023 “Tutti assolti”. La trattativa Stato-mafia non c’è mai stata…
La Cassazione annulla senza rinvio la sentenza d’appello: assolti definitivamente gli ex Ros Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni e l’ex senatore Marcello dell’Utri. La trattativa Stato-mafia non solo non è più presunta, ma non c’è mai stata. La Corte di Cassazione ha annullato – senza rinvio – la sentenza d’appello, riformulando l’assoluzione nei confronti degli ex Ros Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni. Da “Il fatto non costituisce reato”, gli ermellini li hanno definitivamente assolti con “non hanno commesso il fatto”. Quindi non solo sono innocenti, ma non hanno veicolato alcuna minaccia mafiosa nei confronti dei governi Amato e Ciampi. Ricordiamo che il capo d’accusa è infatti “minaccia al corpo politico dello Stato”.
Un teorema che ha fatto acqua da tutte le parti fin dall’inizio. E infatti ha perso i pezzi durante questo decennio di travaglio giudiziario pompato mediaticamente. I politici della Prima Repubblica, quelli che secondo la tesi giudiziaria avrebbero dato l’avvio alla trattativa per garantirsi l’incolumità dalla mafia corleonese, sono stati assolti già dal primo grado. L’ex ministro democristiano Calogero Mannino, che ha scelto il rito abbreviato, è stato assolto fino in Cassazione per non aver commesso il fatto. Mentre l’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino è stato scagionato in primo grado per non aver commesso falsa testimonianza. L’unico politico imputato rimasto è quello della Seconda Repubblica. Parliamo dell’ex senatore Marcello Dell’Utri, colui che avrebbe proseguito, al posto dei Ros, la trattativa: in quel caso, la vittima sarebbe stato il governo Berlusconi. Assolto con formula piena in secondo grado e confermata dalla Cassazione.
Poi ci sono gli imputati mafiosi: Totò Riina e Bernardo Provenzano che nel frattempo sono morti, e Leoluca Bagarella. Mentre è già uscito di scena, perché assolto in primo grado, il mafioso pentito Giovanni Brusca. La corte d’Appello ha fin da subito dichiarato prescritto il reato di Massimo Ciancimino, il figlio di don Vito. Sia Brusca che Ciancimino, usciti incolumi dal processo, sono stati i testimoni chiave che hanno permesso di avviare il processo trattativa. Senza di loro, il processo non si sarebbe mai potuto imbastire. E di fatto, le loro tesi sono stati già smontate da vari giudici: Ciancimino è risultato contraddittorio, calunnioso e anche fabbricatore di una prova rivelatasi una patacca: il fantomatico “papello di Riina”. Poi c’è Brusca che – come hanno evidenziato i giudici di primo e secondo grado che assolsero Mannino – si è fatto chiaramente suggestionare dalle notizie, dai processi in corso e non per ultimo da chi lo interrogava.
Il giornalismo non è cinema, bisogna raccontare i fatti scremati dalle suggestioni e tesi giudiziarie inconcludenti che hanno causato un danno enorme all’opinione pubblica. Ma non solo. Hanno infettato il dibattito politico su argomenti importanti, seppur divisivi, sul funzionamento dello Stato di Diritto. Sono nati addirittura movimenti politici, pensiamo al Movimento Cinque Stelle, che ne hanno tratto linfa vitale per la propaganda populista giudiziaria. Ma pensiamo anche a destra che usa la storia totalmente infondata del non esistente “papello di Riina” per affermare la necessità o addirittura l’indurimento del 41 bis.
La lotta alla mafia, soprattutto negli anni terribili delle stragi, necessitava non solo del coraggio, ma anche della competenza. Dopo la strage di Capaci e subito dopo quella di Via D’Amelio ci fu un momento di gravissima crisi dello Stato. Tutto era fermo, la procura di Palermo di allora era gravemente lacerata dai problemi interni, veleni, alcune opacità mai del tutto chiarite ancora oggi. Tutti hanno in mente le parole del magistrato Antonino Caponnetto: «È finito tutto» disse a un giornalista, uscendo dall’obitorio dopo l’ultimo saluto a Paolo Borsellino. In quel frangente, tra le due stragi inaudite ordite dai corleonesi, l’allora generale Mario Mori decise di fare un salto di qualità nelle indagini antimafia. Di fatto lui era il responsabile a livello nazionale del reparto criminalità organizzata dei Ros. Decise, quindi, una strategia in due tempi: sensibilizzare i suoi ufficiali per avere fonti confidenziali di maggiore qualità e creare una struttura per la cattura dei latitanti, tra cui in particolare Totò Riina.
Quest’ultimo non solo perché era il capo di Cosa nostra, ma anche perché l’allora maresciallo Antonino Lombardo gestiva una fonte che aveva riferito una buona strada per arrivare a Riina, dicendo che “tutte le strade per catturarlo passavano per la Noce, i Ganci e i fratelli Sansone, clan dell’Uditore”. Mori dette l’incarico all’allora capitano Ultimo, alias Sergio De Caprio, per il primo gruppo. Cosa che poi, grazie anche al coordinamento di altri elementi sopravvenuti come la cattura in Piemonte dell’ex autista Di Maggio (utile solo per il riconoscimento del capo dei capi) da parte dell’allora generale Delpino, si arrivò alla cattura di Riina. Ogni tassello è stato fondamentale per concludere l’operazione dei Ros.
Per quanto attiene alla ricerca di nuove e più qualificate fonti, l’allora capitano Giuseppe De Donno disse a Mori di aver già indagato su Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo, per due indagini che portarono all’arresto dello stesso, e alla condanna in via definitiva per associazione semplice. Sempre all’inizio del 1992 Ciancimino fu condannato per associazione mafiosa. Si trovava, dunque, in una situazione in cui i Ros pensavano che potesse diventare una buona fonte, anche per i suoi rapporti sia con la politica che con Cosa nostra. Così De Donno fu autorizzato da Mori nel tentare di contattare Vito Ciancimino. Ribadiamo un concetto: gli ex Ros non hanno mai negato che ci sia stato un contatto preliminare tra loro e Ciancimino. La procura di Palermo è stata avvisata – compreso del contenuto dell’interlocuzione – subito dopo che è andato via Giammanco e si è insediato Caselli come nuovo capo procuratore. Nulla di scandaloso o inedito.
D’altronde, per capire bene di che cosa si sta parlando, bisogna premettere che i pentiti non nascono dal nulla. Lo ha spiegato molto bene l’allora magistrato Guido Lo Forte al Csm nel 1992, quando si riferì alla gestione di Mutolo: “Un collaboratore non viene fuori dal nulla, ma c’è tutta una fase preliminare di contatti, di trattative, che normalmente non sono dei magistrati ma di altri organi”. Ed è esattamente quello che hanno tentato di fare Mori e De Donno con Ciancimino, con l’aggiunta di volerlo in qualche modo “reclutare” per entrare nel sistema degli appalti. Operazione fallita, perché subito dopo – per ordine dell’allora ministro della giustizia Claudio Martelli (lo testimonia lui stesso) – Ciancimino è stato sbattuto al carcere romano di Rebibbia. Punto. Dopodiché tutto è stato stravolto, tra pentiti come Brusca che ritrattano la loro memoria a seconda di quello che apprende nei notiziari e nei processi, e il figlio di don Vito che collaborava con la procura calunniando e fornendo prove farlocche, mentre nel contempo riciclava il “tesoro” di suo padre. Non solo. Come oramai è collaudato ai tempi del caso Tortora, si aggiungono altri pentiti (e presunti testimoni) di serie b che improvvisamente si accodano nell’accusare Mario Mori di aver fatto cose “indicibili”.
Ora c’è il sigillo definitivo in questo travaglio che dura da vent’anni. Processati i Ros di allora per ben tre volte. Dalla mancata cattura di Provenzano, la cosiddetta mancata perquisizione del covo (che però covo non era) di Riina fino alla (non) trattativa Stato-mafia. Assolti su tutto. E ci mancherebbe visto che sono tesi pieni di congetture, utili magari per le prossime serie su Netflix. Speriamo non più per un’aula giudiziaria. IL DUBBIO
27.4.2023 Trattativa, le reazioni dei carabinieri assolti: “Abbiamo servito lo Stato e siamo stati infangati”
I commenti di Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, ma anche della difesa dell’ex senatore Marcello Dell’Utri: “Questo processo non doveva neppure iniziare”. Interviene pure il legale della famiglia di Paolo Borsellino: “Adesso si indaghi sul dossier ‘Mafia e Appalti’ e sul nido di vipere…”
Gli ex ufficiali del Ros
“Sono parzialmente soddisfatto – ha dichiarato Mori, che con gli altri militari è difeso dall’avvocato Basilio Milio – considerando che per 20 anni mi hanno tenuto sotto processo. Ero convinto di non avere fatto nulla, il mio mestiere lo conosco, so che se avessi sbagliato me ne sarei accorto”. Per De Donno si tratta di una sentenza che “ripaga di tante sofferenze e ingiuste umiliazioni. Ho sempre servito lo Stato e combattuto la mafia. I nomi del Ros e dell’Arma sono stati infangati. Finalmente ci è stata restituita la dignità”. La difesa di Subranni ha rimarcato che il verdetto della Cassazione “conferma sua assoluta innocenza”. All’Adnkronos ha rilasciato una dichiarazione anche il comandante generale dei carabinieri, Teo Luzi: “Le sentenze vanno rispettate, sono contento per l’esito e perché si è finalmente arrivati al termine di una lunga vicenda giudiziaria”.
La difesa di Marcello Dell’Utri
Il legale di Dell’Utri, l’avvocato Francesco Centonze, sottolinea che “questo processo non doveva neanche cominciare, alla luce di come è finito. Marcello Dell’Utri era estraneo a tutte le accuse e ora gli viene riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione. La trattativa era insussistente – ha detto ancora il penalista all’Adnkonos – e in ogni caso Dell’Utri era estraneo. Oggi viene riconosciuto il lavoro di questi anni ma non abbiamo mai dubitato che finisse così”.
Il commento della famiglia di Paolo Borsellino
Anche la famiglia del giudice Paolo Borsellino, attraverso l’avvocato Fabio Trizzino, marito della figlia maggiore del magistrato, Lucia, commenta la sentenza tramite l’Adnkronos: “Adesso è arrivato il momento di concentrarsi sul ‘nido di vipere’ di cui parlava Paolo Borsellino… Si sono persi tanti anni preziosi. Ora, finalmente, c’è spazio per la verità storica”. E ha aggiunto: “Hanno tentato in tanti modi a spiegare l’accelerazione della strage di via D’Amelio, pur di non guardare altrove – dice Trizzino – e si sono persi tanti anni. È giunto il momento di capire perché non si volle guardare a quello che Borsellino voleva fare e alle terribili difficoltà che incontrò dentro la Procura di Palermo. C’è spazio per una verità storica e per l’accertamento di eventuali recenti depistaggi sul tema del difficile periodo di Borsellino in quella procura retta da Pietro Giammanco”. PALERMO TODAY
- L’opinione: “A cosa è servito il processo?”
- L’ex pm Ingroia: “Lo Stato si autoassolve, non è un bel segnale”
- La sentenza della Cassazione
Sentenza Trattativa, gli imputati esultano. Mori: “Sempre convinto della mia innocenza”. Ingroia: “Lo Stato si autoassolve”
“Sono parzialmente soddisfatto, considerando che per 20 anni mi hanno tenuto sotto processo. Ero convinto di non aver fatto nulla. Il mio mestiere lo conosco e so che se avessi sbagliato me ne sarei accorto”. Il generale, ex Ros, Mario Mori, assolto con gli altri imputati in via definitiva dalla Cassazione nel processo sulla trattativa Stato-mafia commenta così il verdetto della Suprema corte su uno dei processi più complessi della storia recente. Storia in cui una trattativa ci fu da parte dei carabinieri, ma nell’interesse dello Stato come hanno ritenuto i giudici di secondo grado. Alle parole di Mori si aggiungono quelli di Giuseppe De Donno: “Il nome del Ros e l’Arma sono stati infangati. Finalmente ci è stata restituita la dignità” dice all’Adnkronos l’ufficiale. Per Antonio Subranni parla la figlia Danila che dice “Onore ai combattenti. A quelli ancora in piedi e forti e a quelli seduti, per malattia e per stanchezza. Come mio padre. Arrivi vigore a tutti da questa sentenza che dà la convinzione e anche la speranza che la giustizia, se sbaglia, può tornare indietro. Io non ho il dono della dimenticanza e per me chi sbaglia deve pagare. Magistrati onorevoli hanno finalmente restituito la dignità non a mio padre, non ai “combattenti” che mai l’hanno perduta, ma alla giustizia stessa di cui predicano il verbo. In altre sedi e in modo lineare, a testa alta, io e la mia famiglia chiederemo a uno a uno, nei linguaggi e nei modi che la legge consente, il risarcimento di tanto dolore inflitto che non ha portato bene neanche a loro, vergogna dello Stato. La Cassazione, confermando l’assoluzione per non avere commesso il fatto, silenzia per sempre le voci scomposte degli accusatori di professione e di occasione e le voci degli ignoranti. La tela di ragno è stata squarciata dal vento, il loro castello si è infranto. Adesso, si pieghino e ne raccolgano, in silenzio, i pezzi”.
“Questo processo non doveva neanche cominciare, alla luce di come è finito. Marcello Dell’Utri era estraneo a tutte le accuse e ora gli viene riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione – dice all’Adnkronos Francesco Centonze, legale dell’ex senatore di Forza Italia -. La trattativa era insussistente. E in ogni caso Dell’Utri era estraneo. Oggi viene riconosciuto un lavoro di questi anni ma non abbiamo mai dubitato che finisse così”. E parlando degli ultimi anni tra indagini, processo di primo e secondo grado, Centonze dice: È chiaro che è stato un periodo durissimo – spiega – 30 anni di processo che avrebbero fiaccato chiunque. La verità che Dell’Utri ci trasmetteva andava in questa direzione, non abbiamo mai dubitato che dovesse finire in questo modo”.
L’ex pm Ingroia: “Cronaca di una sentenza annunciata” – “Se dovessi definire questa sentenza, mi verrebbe da fare una semi citazione letteraria ‘Cronaca di una sentenza annunciata’. Perché era stato annunciato e preannunciato che lo Stato italiano intendesse autoassolversi. C’era già stata una anticipazione nella sentenza di appello del processo trattativa di Palermo, nella quale si era riconosciuto che la trattativa c’era stata e che c’era stata la minaccia nei confronti dello Stato, ma che ne rispondevano solo i mafiosi e non gli uomini dello Stato che si erano fatti veicolo. Perché il fatto, secondo i giudici di secondo grado, non costituisce reato. Ora, in Cassazione, c’è stato un ulteriore salto in avanti nella autoassoluzione dello Stato italiano. E cioè ora gli uomini dello Stato vengono assolti per non avere commesso il fatto” spiega all’Adnkronos è l’ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, che ha lasciato la magistratura e oggi è avvocato penalista. Fu lui a rappresentare l’accusa nel processo di primo grado, almeno fino a quando lasciò la Procura per trasferirsi in Sud America, in Guatemala, dove faceva parte della Commissione per l’impunità. “Quindi – spiega dopo avere appreso la notizia della assoluzione per generali e politici – il fatto c’è. C’è stata anche la minaccia che costituisce la premessa della trattativa, una minaccia che però ora i giudici di Cassazione dicono che non è una minaccia compiuta, ma una minaccia tentata. Così rimane senza conseguenze penali per nessuno. Anche i mafiosi per i quali il reato viene dichiarato prescritto. A me pare una sentenza contraddittoria, perché bene o male la sentenza di appello aveva una sua logica, seppure discutibile”. Per Ingroia “c’è stata una minaccia, c’è stata la trattativa e di questo rispondono i mafiosi, perché gli uomini dello Stato lo avevano fatto “a fin di bene”, una impostazione da noi non condivisa ma con una logica”. “Leggeremo le motivazioni per capire la logica dei giudici della Suprema Corte – aggiunge l’ex magistrato all’Adnkronos – ma se il fatto c’è, tanto è vero che Mori e De Donno vengono assolti per non avere commesso il fatto, questo fatto attraverso quali canali è andato?”. “Quali sono i canali attraverso cui il fatto è stato commesso? Questo non è ben chiaro. leggeremo le motivazioni della sentenza – dice ancora Antonio Ingroia – È possibile che si voglia mettere in discussione il ‘papello’. Quindi le dichiarazioni dei collaboratori sul ‘papellò. Non è ben chiaro. Certo è che l’esito di questa vicenda processuale, non è incoraggiante per i cittadini. Questa sentenza ha acclarato che si è tentato di sottoporre sotto minaccia lo Stato, che c’ stata una trattativa ma alla fine nessuno ne risponde, né gli uomini dello Stato neppure la mafia. Insomma, non è un bel segnale che lo Stato lancia ai cittadini”.
La famiglia Borsellino: “Accertare eventuali recenti depistaggi” – “Adesso è arrivato il momento di concentrarsi sul ‘nido di vipere’ di cui parlava Paolo Borsellino… Si sono persi tanti anni preziosi. Ora, finalmente, c’è spazio per la verità storica” commenta l’avvocato Fabio Trizzino, legale della famiglia del giudice Paolo Borsellino e marito di Lucia Borsellino, la figlia maggiore del giudice. Un mese prima di morire Paolo Borsellino “appariva come trasfigurato, senza più sorrisi. Era provato, appesantito, piegato”, aveva detto in aula il magistrato Massimo Russo, che collaborava con Borsellino. Da poche settimane la mafia aveva ucciso il suo amico Giovanni Falcone nel massacro di Capaci, e lui continuava a lavorare nel suo ufficio di procuratore aggiunto a Palermo, che però considerava “un nido di vipere”. Da qui la frase dell’avvocato di famiglia. “Hanno tentato in tanti modi per spiegare l’accelerazione della strage di via D’Amelio, pur di non guardare altrove – dice Trizzino – Si sono persi tanti anni. È giunto il momento di capire perché non si volle guardare a quello che Borsellino voleva fare e alle terribili difficoltà che incontrò dentro la Procura di Palermo. C’è spazio per una verità storica e per l’accertamento di eventuali recenti depistaggi sul tema del difficile periodo di Borsellino in quella procura retta da Pietro Giammanco“. “In tutti questi anni si è sempre cercato di spiegare l’anomala accelerazione della esecuzione della strage di via D’Amelio facendo voli pindarici, prima inserendo Bruno Contrada sul luogo della strage, ora prospettando n qualche modo che Paolo Borsellino avesse saputo di questa trattativa e che si era messo di mezzo ostacolandola e per questo muore – dice ancora Trizzino- Sono tutti tentativi, in qualche modo, per non guardare a ciò che stava facendo e a cià di cui si stava occupando e quello che stava accadendo all’interno della Proucra”. Il legale parla, quindi, “dell’interesse che Borsellino mostrava sul dossier mafia e appalti”, “tanto è vero che il giudice incontrò segretamente Mori e De Donno per dare sfogo a quel rapporto”. “Nel frattempo c’era stata la famosa archiviazione del dossier del 13 luglio 1992, pochi giorni prima della strage di via D’Amelio. E’ giunto il momento di andare a guardare lì cosa è successo” e “se ci sono state manovre depistatorie anche recenti” per “riuscire ad allontanare il focus dell’attenzione dal nido di vipere”. E conclude: “Evidentemente qualcuno ci ha lavorato…”.
Fiammetta Borsellino: “C’è chi ha costruito le loro carriere su questo processo, immeritatamente” – “Non ho letto la sentenza, quindi preferisco non entrare nel merito del processo trattativa, però una cosa la voglio dire: c’è chi ha costruito le loro carriere su questo processo, immeritatamente – dice Fiammetta Borsellino, figlia minore del giudice all’Adnkronos – Sa quale è il danno più grande? Questo processo, come altri prima, sono stati celebrati fuori dalle aule di giustizia, prima ancora che si esaurissero nei tre gradi di giudizio. A prescindere dalla innocenza degli imputati”. Fiammetta Borsellino se la prende, senza mai citarli, con i magistrati dell’accusa che sono stati ospiti in numerose trasmissioni televisive. “L’ho trovato un comportamento scorretto che fa male alla società tutta – dice – , è assurdo che tutti conoscano un processo di questo tipo solo perché mediaticamente è stato pubblicizzato, mentre nessuno conosce processi come il ‘Borsellino quater‘ Io mi soffermo sul fatto che prima ancora che finisse l’iter giudiziario – aggiunge Fiammetta Borsellino – sono stati pubblicizzati da chi li aveva in carico, ripeto: prima ancora della fine del processo. È un atteggiamento che ho sempre criticato”. “Poi, è ovvio che la giustizia debba fare il suo corso, ma è deontologicamente scorretto fare una operazione del genere. Ribadisco che su questo c’è chi ha costruite delle carriere, sul nulla. Su processi che poi si sono dimostrati dei fallimenti. Ne faccio una questione deontologica”. “È un messaggio brutto da dare alla società – aggiunge Fiammetta Borsellino – che alla fine si costruiscono carriere su processi che vengono pubblicizzati prima della fine del processo”. E aggiunge: “Ci sono stati anche giornalisti che sono stati complici di operazioni del genere… c’è tutto un sistema che va dietro al potere”. “Queste persone hanno raggiunto questa fama, che non è fondata su nulla se non sull’autorefenzialità. E il messaggio che si da ai giovani non è positivo. Passa il messaggio che basta scrivere libri o andare in tv per diventare famosi”. E conclude: “Non commento la sentenza ma il comportamento portato avanti in questi anni, lo ripeto. Una operazione altamente scorretta”.
“L’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili di Firenze, preso atto del dispositivo della Cassazione di oggi, ricorda che per cinque sentenze precedenti la trattativa Stato-mafia del 1992 c’è stata; che tale trattativa per la Cassazione costituisce reato di tentata minaccia ai governi Amato e Ciampi e che il Ros non ha concorso nel tentativo di minaccia al governo. Resta dunque il fatto storico inoppugnabile che quella trattativa, interrotta con la cattura di Riina, portò alle stragi in continente del 1993 e al sangue innocente di Caterina e Nadia Nencioni, dei suoi genitori e di Dario Capolicchio”. Così, in una nota, l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili di Firenze. “Siamo stupiti e delusi delle conclusioni del procedimento in Cassazione – commenta il presidente dell’associazione, Luigi Dainelli – perché ben altri cinque giudizi precedenti avevano confermato quella improvvida trattativa era stata l’antefatto della decisione della mafia di spostare i propri attacchi allo Stato nel 1993 a Firenze, Roma e Milano”. L’avvocato ha poi ribadito “l’interesse che Borsellino mostrava sul dossier mafia e appalti, tanto è vero che il giudice incontrò segretamente Mori e De Donno per dare sfogo a quel rapporto. Nel frattempo c’era stata la famosa archiviazione del dossier del 13 luglio 1992, pochi giorni prima della strage di via D’Amelio. E’ giunto il momento di andare a guardare lì cosa è successo” e “se ci sono state manovre depistatorie anche recenti” per “riuscire ad allontanare il focus dell’attenzione dal nido di vipere”. E conclude: “Evidentemente qualcuno ci ha lavorato…”.
Fine della trattativa
La Cassazione chiude senza rinvio la lunga storia del processo Stato-Mafia. Assoluzioni “perché il fatto non sussiste” per politici e carabinieri del Ros, prescrizione per i boss mafiosi La parola fine alla storia giudiziaria della trattativa Stato-mafia la mette la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, annullando senza rinvio le condanne dei boss mafiosi e confermando le assoluzioni dei politici e dei carabinieri del Ros. Un finale inglorioso per la procura di Palermo (quella del 2012, Ingroia e Di Matteo i pm protagonisti dell’accusa), per quanto annunciato dalla sentenza di appello e prima dalle assoluzioni definitive in processi paralleli di Calogero Mannino, il politico Dc presunto motore della trattativa, e dei Ros dei Carabinieri che sarebbero stati il tramite dello scambio criminale la mafia. Se il processo di appello aveva ribaltato le condanne di primo grado, assolvendo Dell’Utri per non aver commesso il fatto, i Ros Mori, Subranni e De Donno perché il fatto non costituiva reato, condannando solo i boss mafiosi Bagarella e Cinà (il medico mafioso che ha protetto la latitanza di Riina e Provenzano), la Cassazione è andata oltre. Oltre anche le richieste della procura generale, per la quale bisognava rinviare gli atti all’appello in quanto le accuse ai boss mafiosi non erano sufficientemente provate. La sesta sezione penale ha deciso invece di confermare l’assoluzione di Dell’Utri accogliendo le tesi dell’appello: l’ex senatore non avrebbe trasferito le richieste di Cosa nostra a Berlusconi, presidente del Consiglio. Assolti anche i carabinieri del Ros, ma questa volta con formula piena. Se per l’appello avevano sì preso parte nella trattativa, veicolando le richieste dei mafiosi, ma solo al fine di interromper le stragi e dunque il fatto non costituiva reato, per la suprema Corte va «esclusa ogni responsabilità degli ufficiali negando ogni ipotesi di concorso nel reato tentato di minaccia a corpo politico». Sorte migliore anche per i boss della mafia, anche per loro il processo trattativa si chiude qui. Al posto del rinvio, infatti, gli ermellini hanno riqualificato il reato: non più minaccia a corpo dello stato ma tentata minaccia, dunque pena edittale più bassa e, come da comunicato,la Cassazione «ha dichiarato la prescrizione nei confronti di Leoluca Bagarella e Antonino Cinà in relazione alle minacce ai danni dei governi Ciampi e Amato, essendo decorsi oltre 22 anni dalla consumazione del reato tentato». La verità giudiziaria è che ci fu solo un tentativo di trattativa. La Cassazione ha confermato infatti «la decisione della Corte di assise di appello di Palermo nella parte in cui ha riconosciuto che negli anni 1992-1994 i vertici di Cosa nostra cercarono di condizionare con minacce i governi Amato, Ciampi e Berlusconi, prospettando la prosecuzione dell’attività stragista se non fossero intervenute modifiche nel trattamento penitenziario per i condannati per reati di mafia ed altre misure in favore dell’associazione criminosa». Per l’avvocato dei Ros, Vittorio Manes, «è stato definitivamente chiarito che hanno agito nel pieno rispetto delle leggi e dei loro doveri, anche a costo della propria incolumità, pur di difendere lo stato dalla violenza stragista». «Questo processo, come altri prima, è stato celebrato fuori dalle aule di giustizia e questo è un male – ha commentato. FIAMMETTA BORSELLINO figlia minore del giudice Paolo – e c’è chi ha costruito la sua carriera immeritatamente su questo processo». Non vacilla l’ex pm Ingroia, oggi avvocato: «L’esito di questa vicenda processuale non è incoraggiante per i cittadini. La sentenza ha acclarato che si è tentato di porre sotto minaccia lo stato, che c’è stata una trattativa, ma lo stato ha deciso di auto assolversi».
Fiammetta Borsellino Questo processo, come altri prima, è stato celebrato fuori dalle aule di giustizia e questo è un male. C’è chi ha costruito la sua carriera immeritatamente su questo processo
TRATTATIVA STATO MAFIA – Doc.
PROCESSO D’APPELLO “TRATTATIVA STATO-MAFIA”, TUTTI ASSOLTI I PRINCIPALI IMPUTATI
Sentenza del processo sulla trattativa Stato-mafia: la Procura generale di Palermo ricorre in Cassazione
La Procura generale di Palermo ha presentato ricorso in Cassazione alla sentenza del 2021 sulla trattativa tra Stato e mafia. In poco meno di tremila pagine, ad agosto scorso, erano state depositate le motivazioni della sentenza di appello con cui la Corte di assise di appello di Palermo, ribaltando il verdetto di primo grado aveva assolto l’ex senatore Marcello Dell’Utri, gli ufficiali del Ros dei carabinieri, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l’ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donno. RAINEWS 11.10.2022
Trattativa Stato-mafia, per Procura generale Corte Appello ha illogicamente assolto Subranni, Moro e De Donno
Impugnata la sentenza emessa il 23 settembre 2021 che aveva assolto gran parte degli imputati condannati in primo grado
“La Corte di Assise di Appello ha contraddittoriamente ed illogicamente assolto gli imputati Subranni, Mori e De Donno, sul presupposto erroneo che gli stessi abbiano agito con finalità “solidaristiche” e, comunque, in assenza del dolo – anche sotto forma della volizione eventuale e pertanto accettata – ovvero di aver agito per alimentare la spaccatura asseritamente già esistente (ut infra) in Cosa Nostra tra l’ala stragista e l’ala moderata, amplificando, oltremodo, i motivi dell ‘agere illecito, pacificamente, irrilevanti ai fini della connotazione dell’elemento soggettivo”. E’ quanto si legge nel ricorso per Cassazione della Procura generale di Palermo della sentenza del processo d’appello sulla trattativa tra Stato e mafia. “Una tale valutazione non può essere condivisa, posto che, innanzi tutto, contraddice quanto dalla stessa Corte affermato in modo chiaro ed esplicito alla p. 12 71 della motivazione”, scriva la Procuratrice generale Lia Sava. “Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Assise di Appello non possono, dunque – prosegue la procura generale – essere condivise, poiché adottate sulla scorta di una palese erronea applicazione della legge penale ed in conseguenza, anche, di una evidente contraddittorietà del percorso logico-argomentativo, peraltro carente e sovente irrazionale”. Il ricorso è stato firmato dalla Procuratrice generale Lia Sava in persona e dai sostituti Giuseppe Fici e Sergio Barbiera, che hanno rappresentato l’accusa nel procedimento di secondo grado. Al momento dalla Procura generale preferiscono il silenzio. Lo scorso 6 agosto, dopo quasi anno, erano state depositate le motivazioni della sentenza di appello. La Corte d’assise d’appello di Palermo aveva assolto «perché il fatto non costituisce reato», l’ex senatore Marcello Dell’Utri, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l’ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donno, tutti e tre ex ufficiali del Ros e aveva ridotto la pena a 27 anni per il boss corleonese Leoluca Bagarella. Confermata invece la sentenza del medico Antonino Cinà. In primo grado erano stati condannati a 28 anni di carcere il boss Leoluca Bagarella, a 12 anni Dell’Utri, Mori, Subranni e Cinà e a 8 anni per De Donno. LA SICILIA 11.10.2022
La guerra “ibrida” con Bernardo Provenzano per isolare Totò Riina
I rapporti con Ciancimino non vengono meno
D’altra parte, sappiamo che nonostante lo shock di Ciancimino all’atto dello showdown, quando Mori e De Donno gli rivelano quali erano le loro vere intenzioni, la loro collaborazione non si è mai interrotta, pur pRoseguendo su un registro completamente diverso da come lo stesso Ciancimino l’aveva intesa.
E contatti non si sono mai interrotti e Mori personalmente si è adoperato, sia pure con la dovuta prudenza, per perorare alcune delle richieste avanzate da Ciancimino (andando a sondare la Ferraro sulla questione del passaporto; e girando tra l’altro a Ciancimino il secco invito di Violante a presentare una formale richiesta alla Commissione Antimafia, se voleva essere sentito: e la conseguente lettera pervenuta poi brevi manu al Presidente della Commissione antimafia è datata 26 ottobre). Sicché non deve essere passato più di qualche giorno prima che l’ex sindaco di Palermo si decidesse a passare il suo Rubicone.
Inoltre, prima che venisse arrestato, Ciancimino era andato a Palermo per contattare i suoi referenti mafiosi (e naturalmente Mori si era guardato dal monitorarne spostamenti e contatti) e ne era tornato fiducioso di un proficuo sviluppo; e Mori, dopo avere constatato che era davvero in grado di comunicare con esponenti di vertice dell’organizzazione mafiosa, attraverso canali che portavano ai suoi “compaesani”, poteva ragionevolmente confidare che la sua proposta fosse giunta a destinazione: la proposta che senza più infingimenti e paludamenti di sorta aveva avanzato a Ciancimino, e che doveva intendersi come una sollecitazione rivolta ad una componente dell’organizzazione mafiosa che reputava potesse essere interessata e disponibile a disinnescare la Minaccia stragista, neutralizzando lo schieramento mafioso che se ne faceva fautore.
E poiché il pontiere Ciancimino si era mostrato fiducioso e più che mai impegnato a cooperare alla cattura di Riina, Mori poteva dedurne che la proposta non solo fosse giunta a destinazione, ma anche che vi fossero tutti i presupposti perché venisse raccolta. E ora sappiamo che fu così, perché in quella temperie Ciancimino, nel collaborare alla cattura di Riina, era “in missione per conto di Cosa nostra”, anche se non era, ovviamente, la missione che lo stesso Riina aveva inizialmente autorizzato. (E non poteva esserlo perché all’atto della rivelazione fatta da Provenzano ad un esterrefatto Giuffré il Riina era stato già arrestato ad opera di quegli stessi Carabinieri con i quali era intercorsa la presunta trattativa; e quindi, se quelli erano stati i frutti, la missione predetta non poteva essere quella che Riina aveva inteso autorizzare. Inoltre, all’atto di quella sorprendente rivelazione, Provenzano sembrava un’altra persona, perché vagheggiava una strategia che era agli antipodi rispetto a quella imposta da Riina a tutta l’organizzazione. La missione insomma era iniziata con il placet di Riina, ma aveva subito, strada facendo, una sostanziale interversione dei suoi fini).
A questo punto sopraggiunge l’arresto di Ciancimino, in coincidenza però con la soffiata che permette ai Carabinieri di individuare il Di Maggio in quel di Borgomanero, con tutto quello che ne seguì. Ora, Mori poteva sapere o semplicemente sospettare che vi fosse lo zampino di Provenzano in quella soffiata; come poteva non avere alcun elemento di valutazione al riguardo. E ad avere un peso risolutivo al riguardo non possono essere le voci rimbalzate da Catania o la confidenza che il Col. Riccio raccoglie dalla fonte Oriente, e cioè la convinzione di Luigi Ilardo che fosse stato Provenzano a propiziare l’arresto di Riina (non avendo tale confidenza aggiunto alcun elemento concreto che andasse al di là dei rumors che sottotraccia covavano negli ambienti di Cosa nostra); e neppure le convinzioni maturate dallo stesso Giuffré, ragionando e discorrendo con gli altri esponenti mafiosi del suo gruppo.
Fili sottili si legano a Di Maggio (e a Provenzano)
[…] Vicende successive, tuttavia, lasciano intravedere dei fili sottili che sembrano riannodarsi agli aspetti più oscuri dell’arresto del Di Maggio, e alimentare il sospetto che Provenzano vi abbia avuto un ruolo. Si scoprirà infatti che Giuseppe Maniscalco, uomo d’onore della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, ma divenuto (a partire dal ‘95) confidente del Ros, nonché molto legato al reggente del mandamento, Salvatore Genovese, ritenuto di area provenzaniana (v. infra) era stato colui che aveva avvisato il Di Maggio che Brusca lo cercava per ammazzarlo, inducendolo a riparare al nord.
Il Di Maggio pagò il debito di gratitudine, negando, quando già era divenuto collaboratore di giustizia, che il Maniscalco fosse uomo d’onore; e grazie anche alla decisione di La Barbera e Di Matteo di avvalersi al dibattimento della facoltà di non rispondere, così sostanzialmente ritrattando la chiamata in correità che entrambi avevano formulato nei riguardi del Maniscalco, quest’ultimo fu assolto, in primo grado nel processo a suo carico per il reato di associazione e mafiosa (“Aiello +14”).
E a sua volta, non mancò di ripagare il Di Maggio, dando ai carabinieri, nella sua veste di confidente, delle imbeccate depistanti sulla catena di delitti che e attentati che avevano insanguinato il territorio di San Giuseppe Jato tra la fine del 1996 e il settembre del 1997. Infatti, sebbene le vittime risultassero persone vicine ai Brusca, ne attribuì la paternità a questi ultimi, insinuando che quei delitti fossero funzionali al piano di depistaggio dei Brusca, che era già venuto alla luce nella fase iniziale della loro collaborazione, ma che secondo il Maniscalco persisteva, ed era diretto a screditare i collaboratori di giustizia e in particolare il Di Maggio, facendo ricadere su di lui la responsabilità di quei delitti.
Quando, a seguito dell’ennesimo omicidio, il Maniscalco inizio a collaborare con la giustizia (…), confessò la propria partecipazione ad alcuni di quei delitti oltre che l’appartenenza a Cosa nostra e svelò il disegno ordito dal Di Maggio che aveva raccolto intorno a sé un gruppo di uomini d’onore e soggetti a lui fedeli per riprendersi con le armi il territorio di San Giuseppe Jato, orfano dei Brusca, ma conteso da altri pretendenti (come Vito Vitale, boss di Partinico). […] Certo è che il Maniscalco era legato e devoto al Di Maggio, che a sua volta aveva con lui un debito di gratitudine per avergli salvato la vita; come è certo che lo stesso Maniscalco era a sua volta legato a Salvatore Genovese, e quest’ultimo al Provenzano: non è solo una conoscenza remota del dott. Sabella perché in occasione dell’arresto del Maniscalco gli fu trovato – o lui fece trovare – un bigliettino indirizzato da Bernardo Provenzano al Genovese, con l’invito ad adottare gli opportuni provvedimenti per fare abbassare la cresta a Vito Vitale. E quel bigliettino insieme ad altri rinvenuti in occasione dell’arresto di Giovanni Brusca daranno contezza dell’autenticità dei 14 pizzini dattiloscritti che la fonte Oriente aveva consegnato al Col. Riccio, indicandoli come provenienti dal Provenzano.
Ora, è arduo credere che quest’ultimo potesse accettare tra i suoi più fidati “postini” un soggetto come Giuseppe Maniscalco, che aveva un legame tanto profondo, risalente nel tempo ma più che mai attuale — rispetto all’epoca in cui si prestava a favorire le comunicazioni da e per il boss corleonese latitante – con quel Balduccio Di Maggio passato agli onori della cronaca per essere stato colui che aveva consegnato il capo di Cosa nostra a ai Carabinieri, se lui stesso Provenzano, non fosse stato in qualche misura partecipe o non ostile a quel legame (essendo ancora più arduo pensare che ne fosse totalmente all’oscuro) e ai frutti che aveva generato.
Ma anche se al risultato della cattura di Riina perseguito come priorità anche strategica si fosse pervenuti per una via investigativa autonoma rispetto alla collaborazione intrapresa per il tramite di Ciancimino e frutto di una fortunata concomitanza di fattori, la proposta di “dialogo” restava valida perché la cattura di Riina era una tappa necessaria, ma solo una tappa di un cammino ancora lungo e periglioso. Ed ecco che la mancata perquisizione del covo di Riina, ma anche la contestuale dismissione di ogni attività di intercettazione nei riguardi dei fratelli Sansone, e poi la perdita di interesse per la pista delle mappe che avrebbe potuto portare troppo a ridosso di un pericoloso latitante che tuttavia poteva, in quel contesto temporale, trasformarsi in un prezioso alleato, tornerebbero come tasselli di un disegno coerente.
E quando Vito Ciancimino, che è oramai pronto a tutto pur di non finire i giorni che gli restano da vivere in prigione, si mostra disponibile a riprendere quel lavoro Riinasto in sospeso, i Carabinieri del Ros raffreddano ogni entusiasmo e lasciano letteralmente Morire quella pista, rinunciando persino ad adoperarsi per nuovi colloqui investigativi. (Anche se vi sarà un’appendice investigativa, con la realizzazione, a cura dell’Arma territoriale, circa un anno dopo la richiesta avanzata dalla procura, di rilievi aerofotogrammetrici).
Un’ipotesi coerente ma eccentrica
Ma quand’anche si volesse accedere a questa ipotesi ricostruttiva, di una guerra ibrida, nella quale si profila un’innaturale coalizione di due antagonisti che trescano a distanza o per interposta persona in quanto accomunati dall’interesse a contrastare uno stesso nemico, il rapporto di collaborazione a distanza tra Ros e Provenzano s’iscriverebbe comunque in una prospettiva che non giova affatto all’accusa nei riguardi degli ex ufficiali del Ros, odierni appellanti.
Ne uscirebbe confermato, infatti, che non era negli intendimenti e nei propositi e nelle previsioni di Mori, De Donno e Subranni di avviare un negoziato con i vertici mafiosi per una soluzione politica globale. Si sarebbe trattato, piuttosto, di un’operazione di intelligence finalizzata alla costruzione di un’alleanza ibrida, sotto l’impellenza di ragioni superiori e di una reciproca convenienza di ragioni contingenti e di reciproca convenienza, anche se suscettibili di acquistare un respiro strategico (sotto il profilo dell’auspicato ripristino di un rapporto di non belligeranza o di conflittualità sostenibile tra Stato e mafia).
D’altra parte, v’è cospicua traccia agli atti di questo processo di una prassi consolidata di contatti e relazioni pericolose tra appartenenti alle forze dell’ordine e membri dell’onorata società, soprattutto prima che il fenomeno del pentitismo esplodesse diventando uno strumento formidabile dell’azione di contrasto alla criminalità mafiosa. Una prassi che peraltro è proseguita anche dopo che quello strumento aveva cominciato a dare, dal maxi processo in poi, i suoi frutti.
Non mancano esempi rilevanti — e Vito Ciancimino non era stato il primo caso e non sarebbe stato l’ultimo – del ricorso a confidenti o addirittura a soggetti, organici o contigui alle cosche, con i quali s’instauravano relazioni ambigue in cui era difficile tracciare una netta linea di confine tra la veste di confidente, o di partner di occasionali scambi di favori (e tale poteva essere anche lo scambio di notizie di reciproco interesse): come nel caso delle fonti del M.llo Lombardo, o nel caso di Siino Angelo; o, più lontano nel tempo, come rammenta Giuffré nel caso di Rosario Riccobono.
Per non parlare delle voci sui rapporti di Madonia Antonino con appartenenti alle forze dell’ordine o ai servizi; o addirittura di esponenti mafiosi che da confidenti si trasformavano in infiltrati per conto dello Stato, ma non del tutto o non ancora passati completamente dalla parte dello Stato: come la fonte Oriente, alias Ilardo Luigi, che da confidente del Col. Riccio fece arrestare non meno di sette pericolosi latitanti ed esponenti delle cosche operanti nella Sicilia orientale, ma nel frattempo saliva i gradini della gerarchia mafiosa, fino al ruolo di vice-rappresentante della provincia mafiosa nissena; o quel Giuseppe Maniscalco, persona legata a Salvatore Genovese, a sua volta reggente del mandamento di San Giuseppe Jato che però, secondo le informazioni in possesso della procura di Palermo, si collocava nell’area provenzaniana.
Il Maniscalco, come s’è visto, pur collaborando come fonte confidenziale con i Carabinieri del Ros, continuava imperterrito a delinquere per conto di Cosa nostra, partecipando anche alla vicenda sanguinosa e nota come “il ritorno in armi” di Baldassare Di Maggio, che alla testa di un gruppo di affiati a lui fedeli, aveva tentato, quando già era collaboratore di giustizia, a suon di attentati e omicidi di riprendere il controllo del territorio di San Giuseppe Jato, approfittando della condizione di estrema debolezza dei Brusca.
E proprio il Maniscalco – che aveva un grosso debito di gratitudine nei riguardi de Di Maggio, che gli aveva procurato un’insperata assoluzione nel processo per il reato di associazione mafiosa e altri gravi delitti, negando che fosse uomo d’onore e inducendo anche La Barbera e Di Matteo a ritrattare o comunque a non ripetere al dibattimento le dichiarazioni accusatorie che avevano reso nei suoi confronti nella fase delle indagini; e il Di Maggio, a sua volta, era grato al Maniscalco per avergli in pratica salvato la vita avvisandolo che Brusca lo cercava per ammazzarlo – aveva depistato i carabinieri, dando loro false imbeccate che facevano ricadere su Brusca e sugli uomini d’onore rimasti a lui fedeli, la paternità di quella catena di delitti: come poi lui stesso ammise, quando, sottoposto a fermo dopo l’ennesimo omicidio (Arato Vincenzo, uomo dei Brusca), iniziò subito a collaborare.
E fece trovare, tra l’altro un pizzino di Provenzano che era diretto a Salvatore Genovese, con delle frasi che suonavano come un invito a prendere provvedimenti contro Vito Vitale, accusato di avere “invaso” un territorio, come quello di San Giuseppe Jato che non gli apparteneva.
EDITORIALE DOMANI 8.12.2022
- AUDIO LETTURA DELLA SENTENZA DEL PROCESSO D’APPELLO
- INTERVISTA al GENERALE MARIO MORI
- INTERCETTAZIONI SULLA TRATTATIVA
FIAMMETTA BORSELLINO: “Trattativa? Sempre avuto dubbi, pm scorretti”
A parlare in una intervista all’Adnkronos è Fiammetta Borsellino, la figlia minore del giudice Paolo Borsellino, che ha appena appreso della sentenza di assoluzione del processo trattativa Stato-mafia, che ha ribaltato la sentenza di primo grado.
- “Tutte le energie dedicate a questa vicenda giudiziaria potevano essere indirizzate verso altre piste”.
- “Io non li ho mai assolti gli ufficiali dei Carabinieri ma ho avuto sempre molti dubbi, dubbi che oggi sono stati confermati dalla giustizia con la sentenza di appello. E poi ho ritenuto scorretto pompare mediaticamente un processo da parte di chi è titolare, prima ancora che questo processo avesse concluso le fasi di giudizio, un comportamento scorretto che mio padre non avrebbe mai approvato”.
- “Si è assistito a un lancio mediatico del processo trattativa – denuncia Fiammetta Borsellino – fin dal suo inizio, quando veniva pubblicizzato con i libri. Quando non era concluso neppure il primo grado. Altro punto di critica enorme, insieme con gli altri”.
- “Io non ho mai assolto gli ufficiali dei carabinieri ma ho avuto sempre molti dubbi, dubbi oggi confermati dalla giustizia con la sentenza di appello. E poi ho ritenuto scorretto pompare mediaticamente un processo da parte di chi è titolare, prima ancora che questo processo avesse concluso le fasi di giudizio, un comportamento scorretto che mio padre non avrebbe mai approvato”.
- “Si è assistito a un lancio mediatico del processo Trattativa fin dal suo inizio, quando veniva pubblicizzato con i libri, quando non era concluso neppure il primo grado. La grande amarezza è che queste energie investigative dedicate al processo Trattativa potevano essere indirizzate verso delle piste che, secondo me, volutamente non si sono percorse. Ancora una volta siamo di fronte al fatto che si sono seguite piste inesistenti quando da sempre abbiamo ribadito che bisognava approfondire quel clima che mio padre viveva dentro la Procura di Palermo”
- “Si doveva approfondire il filone dei dubbi e del senso di tradimento che mio padre manifestò parlando a mia madre dei colleghi, il perché non si è voluto indagare sul procuratore Giammanco. Secondo noi queste erano le piste su cui si doveva indagare, non altre…Per noi l’accelerazione è stata data dal dossier mafia e appalti, ma non lo dice la mia famiglia, lo dice il processo Borsellino Ter, che l’elemento acceleratore è stato il dossier mafia-appalti, che è stato archiviato il 15 luglio, cioè pochi giorni prima della strage di via D’Amelio. Nonostante mio padre il 14 luglio avesse chiesto conto e ragione del perché a quel dossier non venisse dato ampio respiro”.
Stato mafia, la figlia di Borsellino: “Sotto accusa chi aiutò mio padre”. Difende i carabinieri, attacca i pm
«In questi anni, a proposito del processo trattativa, non ho mai voluto esprimermi anche se ho sempre avuto molti dubbi e perplessità sulle accuse da parte della Procura. E devo dire che i miei sospetti sono stati confermati dalla sentenza della Corte d’appello di Palermo».
Lo ha affermato ieri, all’indomani della sentenza che ha assolto gli ufficiali del Ros dei carabinieri e Marcello Dell’Utri, Fiammetta Borsellino, la figlia del magistrato Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio 1992 da una Fiat 126 imbottita di tritolo in via D’Amelio a Palermo.
Signora Fiammetta, sono anni che si batte per la ricerca della verità sulla morte di suo padre. Cosa ha pensato alla notizia dell’assoluzione dei generali Mario Mori e Antonio Subranni? «Mi chiedevo sempre come fosse possibile che uomini che erano stati al suo fianco potessero essere realmente artefici di una trattativa con gli esponenti di Cosa nostra, che invece avevano sempre combattuto».
Le sembrava assurdo? «Ma sì. Del resto fu lo stesso Subranni aportare un’informativa all’allora procuratore di Palermo Pietro Giammanco, su un carico di tritolo destinato a mio padre. Ricordo ancora i pugni che mio padre diede sul tavolo quando raccontò a casa che il procuratore non lo aveva neppure avvisato».
Lei e la sua famiglia avete in molte occasioni fatto riferimento ad altre piste investigative che non sono state percorse. Ci può spiegare? «Sono anni che sto chiedendo di approfondire il clima che mio padre viveva dentro la Procura di Palermo, che seppi aveva definito un “nido di vipere”. Mio padre disse a mia madre che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo ma i suoi colleghi che lo avrebbero permesso».
Ha parlato in diverse occasioni del dossier “mafia appalti”. Cosa c’entra nel procedimento sulla trattativa? «Pur essendo passati ormai tanti anni, non mi capacito del fatto che nessuno abbia mai voluto fare luce sul perché venne archiviato questo dossier, a cui mio padre aveva manifestato di tenere moltissimo».
Di cosa trattava nello specifico questo dossier? «Era un’informativa redatta da Mori e dall’allora capitano Giuseppe De Donno con Giovanni Falcone sul rapporto tra mafia, politica e appalti a livello nazionale. È anche per questo che la tesi della trattativa non mi ha mai convinta. Del resto bisognava farsele delle domande. Io me le ero poste. Oggi una sentenza ci ha dato una risposta di giustizia».
A Caltanissetta, sulla morte di suo padre, è arrivata la sentenza Borsellino Quater. I giudici riconoscono che l’accelerazione alla sua uccisione sia stata data proprio dal dossier mafia-appalti. «Si, questo non lo dice la mia famiglia, lo dice una sentenza che l’elemento acceleratore è stato il dossier mafia e appalti archiviato con una richiesta della Procura vistata dal procuratore Giammanco il 22 luglio, cioè tre giorni dopo la morte di mio padre. E questo nonostante mio padre il 14 luglio avesse chiesto conto e ragione del perché a quel dossier non venisse dato ampio respiro, nell’occasione di una riunione nella Procura davanti a tutti i sostituti. Ci sono tutti i riscontri di questo che sto dicendo».
Aveva parlato anche dei Ros, suo padre, in quell’occasione? «Si, disse che erano molto contrariati del fatto che non avesse avuto seguito».
Nella sentenza di primo grado del processo trattativa si negava che suo padre avesse persino mai letto il dossier mafia appalti. «Ad avvalorare i miei dubbi intervenne anche questa menzogna: mio padre conosceva eccome il dossier mafia appalti e lo aveva letto già nel 1991 quando era in Procura a Marsala».
Mentre lei si poneva le domande più che legittime di cui ci ha detto, i media pubblicizzavano il processo. Cosa avrebbe pensato suo padre? «Mio padre non scriveva libri sui suoi processi, preferiva andare nelle scuole per parlare ai ragazzi di cosa è la mafia. Su questa vicenda non avrebbe gradito il clamore mediatico che è stato dato in corso di processo».
Il processo “trattativa”, fra primo e secondo grado, si è svolto in circa 300 udienze. «Non mi faccia dire nulla su quanto sarà costato questo processo. I pm andarono anche in Sud Africa per ascoltare dei testimoni». LIBERO 25.9.2021
TRATTATIVA STATO-MAFIA/ Così il copione di un film è “diventato” un fatto reale
Proviamo allora, a beneficio dei meno esperti in queste faccende, a fare un po’ d’ordine.
Prima ancora di entrare nel merito, occorre precisare che le motivazioni della sentenza constano di ben 3mila pagine circa e sono suddivise in tre parti: la prima (da p. 86 a p. 991) è dedicata all’esposizione della sentenza di primo grado, con la ricostruzione dei fatti e le valutazioni operate dalla Corte di primo grado; la seconda (da p. 992 a p. 1255) è dedicata all’esposizione dei singoli atti d’appello, mentre la terza (da p. 1256 a p. 2968) è la vera e propria motivazione della sentenza d’appello, in cui si espongono la (parzialmente) diversa ricostruzione e le differenti valutazioni formulate in esito al giudizio d’appello dalla Corte d’assise d’appello.
Realizzare una lettura unitaria dell’intero provvedimento è opera non facile. In estrema sintesi, vi si afferma che sì, vi fu l’iniziativa dei vertici del Ros dopo l’omicidio Falcone di bloccare l’azione stragista intrapresa dai corleonesi, ma essa, a differenza di quanto sostenuto dalla procura di Palermo, non mirò affatto a “creare le basi di un accordo politico” con Cosa nostra.
L’affermazione non appare di poco momento e segna la differenza con la sentenza di primo grado.
Sebbene, come vedremo, le motivazioni presentino non pochi punti di perplessità, su un punto hanno l’indubbio merito di fare chiarezza. Scrivono infatti i giudici, che “(..) sebbene fosse molto più che una spregiudicata iniziativa di polizia giudiziaria, assumendo piuttosto la connotazione di un’operazione di intelligence, essa non era affatto diretta a creare le basi di un accordo ‘politico’ con gli stessi autori della minaccia mafiosa, accettando il rischio che ne uscisse rafforzato il proposito di rinnovarla o di specificarla, ed anzi strumentalizzando tale rischio per indurre il governo a fare delle concessioni, sia pure come male necessario per prevenire nuove stragi ed arrestare l’escalation mafiosa. Al contrario, l’obbiettivo era disinnescare la minaccia mafiosa, incuneandosi con una proposta divisiva in una spaccatura che si confidava già esistente all’interno di Cosa nostra, per volgerla a favore di una disarticolazione e neutralizzazione dello schieramento e della linea stragisti”.
La Corte d’assise d’appello sposa in sostanza la ricostruzione secondo la quale, in seguito all’omicidio di Salvo Lima il 12 marzo 1992, e soprattutto di Giovanni Falcone il 23 maggio dello stesso anno, tra lo Stato e la mafia non si avviò alcuna trattativa su ordine di esponenti politici e di governo, fatta di reciproche proposte e concessioni; al contrario, ciò che avvenne fu invece un’autonoma iniziativa di alti ufficiali dei Carabinieri, ovvero Mori e De Donno, che contattarono Vito Ciancimino per acquisire da lui notizie di interesse investigativo, cercando al contempo di “instaurare un dialogo con i vertici mafiosi finalizzato a superare la contrapposizione frontale con lo Stato”.
Viene così archiviata la grande suggestione della “trattativa Stato-mafia” che, sin dall’inizio, aveva destato non poche perplessità da parte della maggioranza degli addetti ai lavori. Al contempo, provando a rivolgere alla sentenza uno sguardo oggettivo, non si può non rilevare come essa non riesca a sottrarsi alla tentazione di assumere le sembianze di un lungo “romanzo storico” sui rapporti tra mafia, politica e Ros, piuttosto che a un provvedimento giudiziario.
Se, tuttavia, è la stessa ipotesi accusatoria a rendere quasi inevitabile questo effetto, le motivazioni non lesinano nel propugnare al lettore granitiche certezze su ogni singolo evento che ha segnato quel periodo sanguinario, nonostante ogni fatto appaia suscettibile di essere interpretato in maniera diversa.
Non si comprende, ad esempio, su quali basi probatorie si affermi che l’intenzione dei vertici del Ros fosse quella di “insinuarsi in una spaccatura che si sapeva già esistente all’interno di Cosa nostra” tra un’ala stragista guidata da Riina e una ritenuta più moderata capeggiata da Provenzano. Altrettanto discutibile appare la decisione dei giudici di tornare su due eventi già oggetto di processi e su cui i vertici dei Ros sono già stati assolti, come la mancata perquisizione del covo di Riina, definita un “segnale di buona volontà e di disponibilità a proseguire sulla via del dialogo”, e persino sulla latitanza di Provenzano, che i Ros avrebbero “favorito in modo soft”. Il rilievo è sull’opportunità che la sentenza abbia affrontato questi argomenti ponendosi in sostanziale contraddizione con le sentenze specifiche che di quei fatti si sono occupati con ciò sollevando un problema di ne bis in idem.Tuttavia, occorre riconoscerlo, la Corte d’assise d’appello, nell’offrire una ricostruzione che attribuisce a una precisa scelta la mancata perquisizione, va nella direzione di avallare una ipotesi che appare più logica rispetto a quella ufficiale secondo la quale vi fu una mera incomprensione fra carabinieri e procura della Repubblica, a dimostrazione di quanto le questioni in oggetto siano più complesse di quanto possa apparire e rispetto alle quali permane sembra una considerevole zona grigia. Le stesse entro cui si sono mossi i vertici dei Carabinieri nel contattare Ciancimino.
Spicca poi un ulteriore passaggio in cui, per un verso, si afferma la stipulazione di un accordo elettorale tra Dell’Utri e Cosa nostra in previsione delle elezioni del 1994, rispetto al quale, per altro verso, non avrebbe “fatto seguito la fase ulteriore della comunicazione della minaccia a Berlusconi in qualità di parte offese e di presidente del Consiglio per ottenere l’adempimento, appunto sotto la minaccia mafiosa, degli impegni assunti dallo stesso Dell’Utri nella precedente campagna elettorale”.
Insomma, luci ed ombre. È stato fatto notare, dai fautori della “trattativa”, che la sentenza di primo grado della Corte d’assise di Palermo si ispirava a un’altra era geologica della storia d’Italia, ovvero quella in cui la lotta alla mafia faceva in qualche modo capolino nelle agende politiche di governo. Ebbene, questo assioma appare francamente pericoloso. Se senza alcun dubbio la sentenza di primo grado si ispirava ad una diversa ricostruzione dei fatti in conseguenza dei quali erano stati condannati i principali imputati, non si deve far passare l’idea che le assoluzioni di secondo grado sono semplicemente ispirate da una volontà di “normalizzazione” nei rapporti fra Stato e mafia. Un approccio di autocritica sarebbe da preferire, senza con ciò volere indebolire il fronte della lotta alla mafia.
Sia chiaro che non si vuole certo affermare il principio che con la mafia si deve trattare o peggio, come disse un ministro della Repubblica, si deve convivere. Tuttavia, che in quel maledetto 1992 alti ufficiali dei Carabinieri abbiano approcciato un personaggio come Ciancimino nella speranza (vana) di bloccare quello che si palesava come il principale pericolo per l’ordine democratico non può per ciò solo essere considerata una trattativa con la mafia, per di più con mandato politico. Ci furono ombre in quella e in tutte le stagioni che ha visto protagonista la mafia e tutto il suo apparato di supporto che coinvolge parte del mondo economico e politico. La citata mancata perquisizione del covo di Riina resta un fulgido esempio, purtroppo, di quelle zone d’ombra. Ma l’imputazione che ha formulato la procura della Repubblica di Palermo sottace a una visione del mondo che crediamo non giovi alla lotta alla mafia.
Su un punto, invece, vi è piena convergenza con quanto afferma il dott. Scarpinato, ovvero che vi erano ben altri scheletri che rischiavano di uscire dall’armadio se Borsellino fosse rimasto in vita e avesse potuto trasfondere in atti giudiziari l’esito delle sue indagini sui responsabili e le complesse causali della strage di Capaci. Scheletri che spiegano perché gli interventi di soggetti esterni attraversino ininterrottamente tutta la sequenza stragista, da Capaci nel maggio ’92 alle stragi del ’93 nel continente, come emerge da una pluralità di elementi probatori e come relazionò la Dia già nel ’93 con un’informativa in cui si comunicava che dietro le stragi si muoveva una “aggregazione orizzontale, in cui ciascuno dei componenti è portatore di interessi particolari perseguibili nell’ambito di un progetto più complesso in cui convergono finalità diverse”; e dietro gli esecutori mafiosi c’erano menti dotate di “dimestichezza con le dinamiche del terrorismo e i meccanismi della comunicazione di massa nonché una capacità di sondare gli ambienti della politica e di interpretarne i segnali”.
Più utile scavare a fondo sulle ragioni sottese al clamoroso depistaggio sulla strage di via d’Amelio, avallato da pubblici ministeri e giudici. Più utile capire chi e perché era presente, in giacca e cravatta, sul luogo della strage a pochi minuti dall’esplosione, chi ha sottratto la famosa agenda rossa e soprattutto il perché della clamorosa scelta di accelerare la strage. Non vogliamo negare l’esistenza di distorti rapporti fra Stato e mafia, ma solo dire che essi non si concretizzano in quel disperato approccio fra i Ros e Ciancimino.
Trattativa Stato-mafia, la sentenza: assolti gli imputati principali di Giovanni Bianconi Corriere della Sera
Cadono le accuse per gli ufficiali dei carabinieri Mori, Subranni e De Donno e anche per Marcello Dell’Utri. Quanto ai boss, prescrizione per Brusca, pena ridotta a Bagarella, condanna confermata per Cinà
La Corte d’assise d’appello di Palermo ha ribaltato la sentenza di primo grado sul processo per la presunta trattativa Stato-mafia: ha assolto tutti gli imputati principali a cominciare dai carabinieri Mori, De Donno e Subranni. Assolto anche Marcello Dell’Utri. Quanto ai boss mafiosi, prescritte le accuse a Brusca, pena ridotta a Leoluca Bagarella, condanna confermata a Cinà.
La sentenza di primo grado, pronunciata dalla corte d’assise il 20 aprile 2018, aveva stabilito che la minaccia allo Stato avanzata da Cosa nostra con le stragi del 1992 e del 1993 – un vero e proprio ricatt o: o si allenta la pressione antimafia o gli attentati proseguiranno – era stata «veicolata» da uomini delle istituzioni che in questo modo rafforzarono e resero più concrete le pretese dei boss: da un lato i carabinieri del Ros, gli ex generali Antonio Subranni e Mario Mori, e l’ex colonnello Giuseppe De Donno; dall’altro l’ex senatore Marcello Dell’Utri, che dall’inizio del ’94 avrebbe veicolato il messaggio mafioso al nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi. Il quale, chiamato a deporre dai difensori di Dell’Utri, si è avvalso della facoltà di non rispondere in quanto indagato nel procedimento connesso sui mandanti occulti delle stragi del 1993.
Tutti condannati: Mori e Subranni a dodici anni di carcere come dell’Utri, De Donno a otto, insieme al boss Leoluca Bagarella (28 anni) e al medico legato a Cosa nostra Antonino Cinà (12 anni). La trattativa Stato-mafia era condensata in queste condanne, scaturite per un verso dagli incontri tra i carabinieri e l’ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino nell’estate del 1992, e per l’altro dai collegamenti tra Dell’Utri e la mafia, con il boss Vittorio Mangano e non solo, che hanno contribuito anche alla condanna definitiva dell’ex senatore per concorso esterno in associazione mafiosa. Tra gli imputati c’era pure un altro politico, l’ex ministro democristiano Calogero Mannino, ulteriore presunto tramite del ricatto; anzi il promotore della trattativa, secondo l’accusa, nel timore di essere una vittima designata delle cosche. Lui però ha scelto di farsi giudicare con il rito abbreviato, ed è stato assolto «per non aver commesso il fatto» in tutti i gradi di giudizio.
Tra la sentenza di primo grado e quella di oggi l’assoluzione di Mannino è diventata definitiva, e l’ultimo verdetto è stato abbastanza categorico nel contraddire la ricostruzione formulata dai pubblici ministeri; sia quelli della Procura, in primo grado, che quelli della Procura generale, in corte d’appello. Una sentenza che s’è posta in contrasto anche con la decisione della corte d’assise che in primo grado aveva condannato gli altri imputati.
Per la corte d’assise che ha dichiarato colpevoli i vertici del Ros, la proposta di «trattativa» dei carabinieri a Ciancimino ebbe l’effetto di «far sorgere o quantomeno consolidare il proposito criminoso risoltosi nella minaccia formulata nei confronti del governo della Repubblica sotto forma di richieste di benefici, al cui ottenimento i mafiosi condizionavano la cessazione delle stragi».
Per i giudici che hanno assolto Mannino, invece, l’iniziativa del Ros fu nient’altro che «un’operazione info-investigativa di polizia giudiziaria, realizzata attraverso la promessa di benefici personali al Ciancimino di assicurare, ove possibile, le richieste nell’esclusivo interesse di Ciancimino stesso; tale operazione si proponeva, mediante la sollecitazione a un’attività di infiltrazione in Cosa nostra del predetto Ciancimino, che ne avrebbe dovuto contattare i capi, il fine della cattura di Totò Riina, interrompendo così la stagione delle stragi».
Due ricostruzioni e due valutazioni opposte, che racchiudono il nodo della presunta trattativa tra i boss e alcuni rappresentanti delle istituzioni al tempo delle stragi: ne scaturì un reato, agevolando il ricatto mafioso allo Stato, oppure no? E’ lo stesso nodo che ha dovuto affrontare la corte d’assise d’appello presieduta dal giudice Angelo Pellino, seduto accanto al giudice a latere Vittorio Anania e ai sei componenti della giuria popolare.
L’assoluzione definitiva di Mannino è una delle novità intervenute durante lo svolgimento del processo d’appello. Insieme a nuove testimonianze come quelle proposte sia dall’accusa (ulteriori pentiti su presunti aspetti misteriosi delle stragi e dei contatti tra mafia e istituzioni) che dalla difesa (ad esempio la testimonianza dell’ex pm di Mani pulite Antonio Di Pietro, che ha raccontato i suoi dialoghi con Paolo Borsellino tra le stragi di Capaci e via D’Amelio, e l’interesse del magistrato assassinato per le inchieste sulla corruzione e gli appalti intrecciate con quelli milanesi).
Due anni e mezzo di dibattimento in appello hanno prodotto la nuova sentenza. Pronunciata secondo i principi che il presidente Pellino aveva specificato nell’aprile 2019, alla prima udienza. Per replicare a chi si lamentava che quello sulla trattativa Stato-mafia è stato un processo alla storia anziché a singoli imputati accusati di specifici reati, il presidente chiarì: «Può accadere che in un processo che riguarda fatti molto eclatanti la riscrittura di un pezzo di storia di un Paese sia un effetto inevitabile dei temi trattati e del lavoro delle parti processuali che hanno concorso a scavare nei fatti; ma lo scopo del processo d’appello è verificare la tenuta della decisione di primo grado sotto la lente d’ingrandimento dei motivi d’appello. Gli imputati non sono archetipi socio-criminologici, bensì persone in carne e ossa che saranno giudicate per ciò che hanno o non hanno fatto, se si tratta di reati. Questo è l’impegno della corte, e mi sento di rassicurare le parti».
La sentenza di oggi è figlia di quell’impegno, e le motivazioni spiegheranno come ci si è arrivati.
LA TRATTATIVA STATO-MAFIA ACCELERO’ LA MORTE DI BORSELLINO ? Secondo quanto deliberato dai Giudici di primo grado: “Può ritenersi provato oltre ogni ragionevole dubbio che fu proprio l’improvvida iniziativa dei carabinieri del Ros (la trattativa con Vito Ciancimino, nda) a indurre Riina a tentare di sfruttare ai propri fini quel segnale di debolezza delle istituzioni pervenutogli dopo la strage di Capaci” “Non vi è alcun elemento di prova che possa collegare il rapporto Mafia e Appalti all’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione di Borsellino”. Piuttosto “l’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione di Borsellino” fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo, e di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci, pervenuti a Riina attraverso Ciancimino nel periodo precedente la Strage di via d’Amelio”.
4.2.2021 FIAMMETTA BORSELLINO: (…) “Mi viene in mente il contrasto fra le tesi espresse dalla sentenza “Trattativa Stato-mafia” e quelle emesse a Caltanissetta per la strage di via D’Amelio. La prima individua quale elemento acceleratore la trattativa. La corte del Borsellino quater rileva invece che l’accelerazione sarebbe stata determinata dal dossier mafia e appalti, al quale mio padre era molto interessato. La sentenza “Trattativa” arriva a negare questo interesse. Com’è possibile avere queste due opposte valutazioni?”. dall’intervista di Salvo Palazzolo – Repubblica
28.4.2021 – FIAMMETTA BORSELLINO, ‘NELLA SENTENZA TRATTATIVA C’È UNA MENZOGNA SU MIO PADRE” Nella sentenza trattativa si dice una menzogna, una bugia. Si dice che mio padre fosse addirittura disinteressato al dossier ‘Mafia e appalti’ o che non lo conoscesse ma non è vero, perché lo conosceva benissimo”. E’ la denuncia di Fiammetta Borsellino, la figlia minore di Paolo Borsellino nello speciale Mafia di Enrico Mentana su La7. “La cosa grave è che il 14 luglio 1992 (cinque giorni prima della strage ndr) mio padre fece una riunione con i suoi sostituti in cui chiese come mai l’indagine di sua competenza non fosse confluita nel dossier Mafia e appalti”. (Adnkronos)
Al fine di giungere ad un accordo volto a porre fine alle stragi mafiose, da parte di ufficiali dei Carabinieri, tramite l’ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, fu avviata con Cosa nostra una sorta di trattativa. Il primo a riferirne ai magistrati fu Giovanni Brusca nel ’96 avendone sentito parlare da Totò Riina. La sentenza del processo di primo grado, che confermò la sua esistenza, venne pronunciata il 28 Aprile 2018. Secondo i giudici di Primo grado, “L’improvvisa accelerazione che ebbe l’attentato a Paolo Borsellino“ fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo – ed in sostanza, di cedimento Cosa Nostra culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Amelio“. Per i giudici del processo Trattativa Stato-mafia, “non vi è dubbio” che i contatti fra gli ufficiali dei carabinieri Mori e De Donno con Vito Ciancimino, unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l’avvicendamento di quel ministro dell’Interno che si era particolarmente speso nell’azione di contrasto alle mafie, in assenza di plausibili pubbliche spiegazioni) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Salvatore Riina già come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa nella misura in cui quegli ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato”. I giudici scrivono ancora: “Ove non si volesse prevenire alla conclusione dell’accusa che Riina abbia deciso di uccidere Borsellino temendo la sua opposizione alla trattativa, conclusione che peraltro trova una qualche convergenza nel fatto che secondo quanto riferito dalla moglie, Agnese Piraino Leto, Borsellino, poco prima di morire, le aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle istituzioni e mafiosi, in ogni caso non c’è dubbio che quell’invito al dialogo pervenuto dai carabinieri attraverso Vito Ciancimino costituisca un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino, con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato e di lucrare, quindi, nel tempo dopo quell’ulteriore manifestazione di incontenibile violenza concretizzatasi nella strage di via d’Amelio, maggiori vantaggi rispetto a quelli che sul momento avrebbero potuto determinarsi in senso negativo”.
- QUANDO IL GENERALE MORI CHIESE A CIANCIMINO: “MA NON SI PUÒ PARLARE CON QUESTA GENTE?”
- CLAUDIO MARTELLI: QUAND’ERO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
- LA MEMORIA DIFENSIVA DEL GEN. MARIO MORI
- MARIO MORI E I SUOI MISTERI
- DEPOSIZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA GIUSEPPE PIGNATONE – 14.1.2016
CERCA
PROCESSO D’APPELLO “STATO MAFIA”
Al via l’appello per la trattativa Stato-mafia, la difesa di Mori: “Nessuna minaccia allo Stato” Si torna in aula a un anno dalla sentenza di primo grado. L’ex capo del Ros, il generale Mario Mori, era stato condannato a 12 anni di carcere mentre il capitano Giuseppe De Donno a 8 anni. Il difensore di Dell’Utri indica l’ex premier Berlusconi come teste
AUDIO UDIENZE PROCESSO D’APPELLO
- 17.09.2021
- 20.07.2021
- 14.07.2021
- 12.07.2021
- 05.07.2021
- 28.06.2021
- 21.06.2021
- 14.06.2021
- 07.06.2021
- 31.05.2021
- 24.05.2021
- 17.05.2021
- 10.05.2021
- 03.05.2021
- 19.04.2021
- 22.03.2021
- 03.03.2021
- 15.02.2021
- 19.01.2021
- 18.12.2020
- 14.12.2020
- 23.11.2020
- 26.10.2020
- 19.10.2020
- 05.10.2020
- 28.09.2020
- 21.09.2020
- 23.07.2020
- 13.07.2020
- 06.07.2020
- 26.06.2020
- 08.06.2020
- 26.05.2020
- 18.05.2020
- 02.03.2020
- 10.02.2020
- 16.01.2020
- 09.12.2019
- 25.11.2019
- 11.11.2019
- 04.11.2019
- 14.10.2019
- 03.10.2019
- 26.09.2019
- 19.09.2019
- 12.09.2019
- 22.07.2019
- 11.07.2019
- 08.07.2019
- 24.06.2019
- 17.06.2019
- 10.06.2019
- 31.05.2019
- 13.05.2019
- 29.04.2019
.5.2012 – TRATTATIVA STATO-MAFIA, IL “FUORI ONDA” DI MANNINO ARRIVA AL PROCESSO MORI “Questa volta ci fottono, questa volta ci incastrano”. La conversazione tra Calogero Mannino e Giuseppe Gargani, raccolta dalla giornalista del Fatto Sandra Amurru, fa il suo ingresso al processo contro Mario Mori e Mauro Obinu
IL PM DI MATTEO IN AULA: “SULLA TRATTATIVA QUALCUNO NELLE ISTITUZIONI MENTE”. L’ex ministro dell’Interno Mancino depone in aula a Palermo, ma su quello che accadde nel 1992-1993 le versioni dei politici dell’epoca non quadrano. Spunta un documento inedito della Dia che già prima delle stragi metteva in guardia dal “cedere” ai mafiosi sul 41 bis. Feb2012
14.6.2021 – Legale Bagarella, ‘processo trattativa va annullato, no patto tra Riina e Mori’. “Questo processo, che negli anni ha assunto una valenza politica eccessiva, va annullato, va fermato, perché andava celebrato a Caltanissetta e non a Palermo. E’ un processo che va fermato”. A dirlo, in aula, nel corso dell’arringa difensiva al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e mafia è stato l’avvocato Luca Cianferoni, che difende il boss mafioso Leoluca Bagarella. In passato Cianferoni ha assistito anche il boss Totò Riina, fino alla sua morte. In primo grado il boss Leoluca Bagarella fu condannato a 28 anni di carcere, a 12 anni gli ex ufficiali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni, l’ex senatore di Fi Marcello Dell’Utri e l’ex medico fedelissimo di Totò Riina, Antonino Cinà. Otto anni la pena inflitta all’ex capitano del Ros Giuseppe De Donno. La Corte, in primo grado, aveva inoltre dichiarato il non doversi procedere nei confronti del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, anche lui accusato di minaccia a corpo politico dello Stato per intervenuta prescrizione visto il riconoscimento delle attenuanti previste per i collaboratori di giustizia. Anche Massimo Ciancimino era stato condannato a 8 anni per calunnia e concorso esterno ma poi, nel secondo grado, la sua posizione è stata stralciata perché il reato è andato prescritto. In oltre quattro ore di arringa Cianferoni ha parlato dallo sbarco degli americani fino alla morte di Mino Pecorelli, da Ali Agca a Fantozzi. E alla fine ha chiesto l’assoluzione per Leoluca Bagarella perché “il fatto non sussiste”, in alternativa “il ne bis in idem” o in alternativa ancora l’annullamento del processo “che si sarebbe dovuto celebrare a Caltanissetta”. Parlando della trattativa tra Stato e mafia, Cianferoni arriva a citare il ragionier Fantozzi e la corazzata Potemkin. “A mio avviso – dice – parlando della ipotesi della trattativa mi viene da citare Paolo Villaggio quando commenta la corazzata Potemkin, disse ‘Questa è una cag..a pazzesca’. Rivolgendosi ai giudici della Corte d’assiste d’appello dice: “Conosco e stimo i giudici togati, obiettivi e professionisti”. Poi ribadisce che Bagarella andrebbe assolto oppure andrebbe dichiarato il ne bis in idem, che viene usato quando si è già stati condannati per lo stesso reato perché, a suo dire, “è stato già condannato per Capaci e per le stragi in continente. ADNKRONOS
Quando il Generale Mori chiese a Ciancimino: “Ma non si può parlare con questa gente?” di Redazione Servizio Pubblico L’ex Generale dei Ros Mario Mori racconta in aula come si avviò la Trattativa Stato-mafia. Come ‘un muro contro muro’ tra lo Stato e la Mafia: “Ma non si può parlare con questa gente?” – chiede Mori a Vito Ciancimino, in un incontro avvenuto a Roma nell’estate 1992 – “La buttai lì, convinto che dicesse una cosa tipo ‘Cosa vuole da me’. Invece disse che si poteva fare”. La deposizione del Generale Mori Riporta Il Fatto Quotidiano in merito ai rapporti tra Mori e Ciancimino:
“Vidi Violante quattro volte, tra agosto e novembre del 1992, e gli riferii in più fasi che avevo iniziato un rapporto confidenziale con Ciancimino, il quale mi aveva espresso la richiesta di essere sentito dall’Antimafia senza condizioni: gli parlai anche di un libro che l’ex sindaco aveva scritto”, ha detto Mori, che di quelle manovre non avvisò mai la magistratura. “Lo stesso Violante – ha aggiunto il generale – mi chiese se avevo avvisato l’autorità giudiziaria e io gli risposi di no, perché, visti i contrasti sorti con la Procura per l’indagine mafia-appalti, mi riservavo di farlo dopo l’insediamento del nuovo procuratore, previsto di lì a poco. Lui non replicò, ne dedussi che approvava”. In uno dei passaggi delle sue dichiarazioni, Mori ha anche fatto cenno al blitz mai ordinato il 31 ottobre del 1995 a Mezzojuso, dove si nascondeva Provenzano, e alla lunghissima ricerca del boss corleonese poi arrestato solo nel 2006. “Nessuno impedì mai ad altre forze di polizia di cercarlo. Anche se il Ros, per molto tempo, fu l’unico reparto di polizia giudiziaria a occuparsi con determinazione della ricerca”.
8.6.2021 il Pg: «Ho sbagliato, quell’agendina non era di Totò Riina» Diamo atto al Pg Giuseppe Fici di essersi scusato con la Corte e di aver ammesso l’errore evidenziato dal nostro giornale Il procuratore generale Giuseppe Fici ha ammesso il suo errore e ha chiesto scusa alla Corte durante la requisitoria di lunedì scorso al processo d’appello sulla presunta trattativa Stato-mafia in svolgimento a Palermo. Il riferimento è allo “svarione” evidenziato nelle pagine de Il Dubbio il 5 giugno scorso. Lo “svarione” durante l’udienza del 31 maggio È accaduto che durante la requisitoria dell’udienza precedente (31 maggio scorso), il Pg Fici ha detto testualmente: «Nel rileggere le conversazioni intercettate in carcere tra il predetto Riina Salvatore e il Lo Russo (il suo compagno d’ora d’aria, ndr), particolare attenzione ha destato un passaggio di queste conversazioni quando il Riina, nel commentare il giorno del suo arresto, ha fatto anche riferimento alla circostanza che gli venne trovata addosso un’agendina, e il capitano che operava in quel momento all’interno del covo gli avrebbe detto che non gli sarebbe stata sequestrata perché a loro – ai carabinieri sul posto – non interessava quei numeri». L’agendina era del compagno di Riina al 41 bis Il Pg ha aggiunto: «Di fatto poi l’agendina non gli venne rinvenuta!». Per il procuratore generale questa circostanza si va ad aggiungere ad una lunga catena di disattenzioni e omissioni.Il Dubbio ha fatto notare che, in realtà, la vicenda dell’agendina non riguarda Totò Riina, ma il suo compagno d’ora d’aria al 41 bis Alberto Lorusso, boss della Sacra Corona Unita. Lunedì il Pg ha ammesso l’errore Lunedì scorso, 7 giugno, alla conclusione della sua requisitoria al processo trattativa Stato-mafia, il Procuratore generale Fici ha ammesso il suo errore, spiegando che glielo ha detto qualcuno, ma ha commesso lo sbaglio di non aver letto bene le intercettazioni. Ha anche spiegato di aver disposto degli accertamenti su questa misteriosa agendina, ma una volta realizzato l’errore ha subito revocato il mandato. «Devo fare una errata corrige – ha detto il Pg -. Nella scorsa udienza ho fatto riferimento ad una circostanza errata. Ho voluto verificare in udienza, mi ero fatto trasmettere la trascrizione delle conversazioni in carcere tra Riina e Lorusso. Ho dato una veloce lettura, ho riscontrato quello che mi ricordavo che mi era stato detto. Ma ho letto male».Le scuse alla Corte e agli interessati. IL DUBBIO Aliprandi
8.6.2021 – PROCESSO TRATTATIVA STATO-MAFIA. VERITÀ INCONFESSABILI SU DELL’UTRI & C. CHIESTA LA CONFERMA DI TUTTE LE CONDANNE IN APPELLO. IL PG: “O SI È CONTRO COSA NOSTRA O SI È COMPLICI” Ci sono “verità che anche se scomode, devono essere raccontate”. Inizia con queste parole la requisitoria con cui il sostituto procuratore generale di Palermo, Sergio Barbiera, ha chiesto la conferma di tutte le condanne di primo grado relative al processo sulla trattativa Stato-Mafia. “Uomini delle istituzioni, apparati istituzionali deviati dello Stato, hanno intavolato una illecita e illegittima interlocuzione con esponenti di vertice di Cosa nostra per interrompere la strategia stragista” ha proseguito il magistrato ricordando come “la celebrazione del presente giudizio ha ulteriormente comprovato l’esistenza di una verità inconfessabile, di una verità che è dentro lo Stato, della trattativa Stato-mafia che, tuttavia, non scrimina mandanti ed esecutori istituzionali perché, come ha ricordato il Capo dello Stato Sergio Mattarella, nello corso delle commemorazioni dell’anniversario della strage di Capaci, o si sta contro la mafia o si è complici. Non ci sono alternative”. REQUISITORIA FIUME. Una requisitoria fiume, iniziata il 25 maggio nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo e terminata ieri, con cui i procuratori generali, Barbiera e Giuseppe Fici, hanno sollecitato al presidente della Corte d’Assise d’Appello di Palermo, Angelo Pellino, la conferma delle pesantissime sentenze emesse in primo grado (leggi l’articolo). In quell’occasione, ossia nel lontano 20 aprile 2018, con una sentenza storica la Corte d’Assise, presieduta da Alfredo Montalto, aveva inflitto 28 anni di carcere al boss Leoluca Bagarella, 12 all’ex senatore Marcello Dell’Utri (nella foto), agli ex vertici dei carabinieri del Ros Mario Mori e Antonio Subranni, e Antonino Cinà ossia il medico di Totò Riina, 8 al colonnello dei Carabinieri Giuseppe De Donno. All’epoca dei fatti tutti loro erano stati ritenuti colpevoli di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato, reato previsto dall’articolo 338 del Codice penale. Si tratta di quelle che ripercorrendo il caso in Aula, il procuratore Fici ha definito “le stesse menti raffinatissime che avevano sostenuto la coabitazione tra il potere criminale e le istituzioni, avviando la trattativa” che hanno “consentito a Riina di dire che lo Stato si è fatto sotto” per trattare. Un accordo che, ha detto il magistrato, sarebbe proseguito anche dopo l’arresto “di Riina e dei fratelli Graviano”, con le stesse persone che avrebbero “garantito una latitanza protetta per lo ‘zio’, Bernardo Provenzano”. Proprio mentre tutto ciò accadeva, spiega il procuratore generale, “nasceva Forza Italia” con Dell’Utri che “ha ricoperto un ruolo decisivo in questa situazione di convivenza gattopardesca”, “curando la tessitura dei rapporti tra Cosa nostra e ‘ndrangheta con il potere politico”. Non solo. “Lo stesso Silvio Berlusconi, chiamato a testimoniare sull’argomento quando era premier, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Un suo diritto, certo, ma ci si aspettava un contributo diverso” ha segnalato Fici nella propria requisitoria. Ombre e sospetti su apparati dello Stato deviati che per il magistrato sono confermati anche dai “due dossier su mafia e appalti” compilati dai Carabinieri del Ros tra il 1991 e il 1992. “Nella prima informativa”, spiega Fici, sono stati “omessi i nomi dei politici, potenti, dall’allora ministro Calogero Mannino a Salvo Lima” salvo poi riapparire un anno e mezzo dopo. All’udienza era presente il boss pentito Giovanni Brusca, che ha partecipato da uomo libero dopo la recente scarcerazione per fine pena. LA NOTIZIA 8.6.2021
7.6.2021 – TRATTATIVA STATO-MAFIA, LA PROCURA GENERALE CHIEDE LA CONFERMA DELLE CONDANNE Si è conclusa la requisitoria davanti alla Corte d’Assise d’Appello nel processo che vede imputati mafiosi come Leoluca Bagarella e Antonino Cinà, ufficiali del Ros dei carabinieri e pure l’ex senatore Marcello Dell’Utri. Il pentito Giovanni Brusca ha partecipato all’udienza per la prima volta da uomo libero. Al termine di una lunga requisitoria, la Procura generale ha chiesto la conferma delle condanne emesse in primo grado nell’ambito del processo d’appello sulla presunta trattativa tra pezzi deviati dello Stato e Cosa nostra. E sono pene pesantissime quelle che la Corte d’Assise, presieduta da Alfredo Montalto, aveva inflitto ad aprile del 2018, ovvero 28 anni per il boss Leoluca Bagarella, 12 anni a testa per l’ex senatore Marcello Dell’Utri e gli ex ufficiali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni, nonché per l’ex medico e uomo di fiducia di Totò Riina, Antonino Cinà, 8 anni per l’ex capitano dei carabinieri Giuseppe De Donno. Nel frattempo è andata prescritta la condanna a 8 anni per Massimo Ciancimino, il figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo, Vito, accusato di concorso esterno, e la prescrizione era già stata sancita per il pentito Giovanni Brusca, tornato libero qualche giorno fa. Un altro imputato, l’ex ministro Calogero Mannino, che secondo l’accusa avrebbe avviato la trattativa con i boss finalizzata a far cessare le stragi, è stato però assolto in via definitiva dalla Cassazione. Era stato l’unico a scegliere il rito abbreviato, che è durato comunque anni. In appello a sostenere l’accusa sono i pg Giuseppe Fici e Sergio Barbiera che hanno chiesto la conferma della sentenza alla Corte presieduta da Angelo Pellino. All’udienza di oggi ha partecipato per la prima volta da uomo libero proprio Brusca, collegato da un “sito riservato”. L’accusa ha fatto i conti anche con l’assoluzione di Mannino: “Non c’è alcun intendimento di riscrivere un giudicato assolutorio – ha detto infatti Fici, come riporta l’Adnkronos – né di arrivare a una ‘ossessione persecutoria’, come è stato scritto in modo offensivo”. Barbiera ha sottolineato che “uomini delle istituzioni, apparati istituzionali deviati dello Stato, hanno intavolato una illecita e illegittima interlocuzione con esponenti di vertice di Cosa nostra per interrompere la strategia stragista”. E ha concluso: “Conclusivamente può affermarsi che la celebrazione del presente giudizio ha ulteriormente comprovato l’esistenza di una verità inconfessabile, di una verità che è dentro lo Stato, della trattativa Stato-mafia che, tuttavia non scrimina mandanti ed esecutori istituzionali perché, come ha ricordato il Capo dello Stato nello corso delle commemorazioni dell’anniversario della strage di Capaci o si sta contro la mafia o si è complici. Non ci sono alternative”. Al termine della requisitoria sono state fissate le udienze per lasciare la parola alle parti civili e alle difese degli imputati: si andrà avanti almeno fino al 20 luglio e poi sarà stabilita la data per la sentenza.
5.6.2021 – SVARIONE AL PROCESSO TRATTATIVA: IL PG ATTRIBUISCE L’AGENDINA DI UN ALTRO BOSS A TOTO’ RIINA Al processo per la presunta trattativa Stato-mafia l’accusa ha fatto confusione nelle intercettazioni, attribuendo il racconto di Alberto Lorusso, suo compagno di socialità, a Totò Riina di Damiano Aliprandi Dalle intercettazioni di Totò Riina al 41 bis, la procura generale di Palermo ha finalmente individuato un passaggio dove l’ex capo dei capi di Cosa nostra avrebbe raccontato qualcosa di gravemente compromettente durante la fase del suo arresto da parte dei Ros. L’unico passaggio di Riina, dove davvero potrebbe rafforzarsi la tesi della trattativa Stato-mafia. Ma è così? Ora riveliamo l’arcano.
Il mistero dell’agendina sparita In sostanza si parla di una agendina misteriosa che un capitano (potrebbe essere Ultimo?) avrebbe sottratto a Riina. Il Pg ne parla durante la sua requisitoria di lunedì scorso al processo d’appello trattativa. «Nel rileggere le conversazioni intercettate in carcere tra il predetto Riina Salvatore e il Lo Russo (il suo compagno d’ora d’aria, ndr) – spiega il Pg durante la requisitoria – , particolare attenzione ha destato un passaggio di queste conversazioni quando il Riina, nel commentare il giorno del suo arresto, ha fatto anche riferimento alla circostanza che gli venne trovata addosso un’agendina, e il capitano che operava in quel momento all’interno del covo gli avrebbe detto che non gli sarebbe stata sequestrata perché a loro – ai carabinieri sul posto – non interessava quei numeri». Il Pg aggiunge: «Di fatto poi l’agendina non gli venne rinvenuta!».
Dalle intercettazioni emerge che l’agendina era di Lorusso Per il procuratore generale questa circostanza si va ad aggiungere ad una lunga catena di disattenzioni e omissioni. In effetti è un episodio decisamente inquietante e ciò porrebbe numerosi interrogativi. Peccato però che Il Dubbio è andato a rileggere le intercettazioni, scoprendo così che quell’episodio è stato effettivamente narrato durante le chiacchierate tra i due. Però non riguarda Totò Riina, ma il suo compagno d’ora d’aria Alberto Lorusso. Precisamente alla trascrizione del colloquio area passeggio del 10 agosto 2013, Lorusso dice a Riina: «Però … vi posso dire una cosa io?». Al che racconta tutta la storia: «lo portavo nel portafoglio una piccola agenda con i numeri della famiglia mia, i numeri di mio fratello, di mia sorella, della mia cosa… i numeri dell’avvocato … no? Il Capitano dei Carabinieri vide l’agenda là l’orologio, l’agenda, il portafoglio, i documenti, la patente poggiati là… ha preso l’agenda in mano… mi guardò e mi disse… neanche voglio vedere che cosa sta nell’agenda, dice, non vorrei trovare, non vorrei trovare qualche numero telefonico chissà di chi e l’ha lasciata l’agenda». Non è il racconto di Riina, ma è una vicenda che riguarda l’allora sua, come si suol dire nell’offensivo gergo carcerario, “dama di compagnia”. Lorusso aggiunge: «Non c’era niente, non c’era niente perché… Allora questi, quello mi ha fatto capire, quello mi ha fatto capire che teneva paura che forse nella mia agendina piccola, davanti nel portafoglio, ci potesse essere non so che cosa… e loro potessero passare i guai». Risolto il mistero dell’agendina di Riina: non era la sua, ma del boss della Sacra corona unita Lorusso.
Riina nelle intercettazioni fa chiarezza sulla “mancata perquisizione” Il procuratore generale di Palermo si è evidentemente confuso con la lettura delle intercettazioni. Cose che capitano. A questo punto, visto che tutti i magistrati sostenitori della tesi della trattativa concordano – ed è esattamente così – nel ritenere genuine le intercettazioni di Riina, ci permettiamo umilmente di consigliare di leggerle bene. Ad esempio, molto probabilmente saranno sfuggiti tutti i passaggi dove il capo dei capi smentisce la trattativa, persino il discorso dei presunti documenti spariti dalla sua cassaforte a causa della cosiddetta “mancata perquisizione”. Prendiamo ad esempio sempre la trascrizione di quel giorno stesso, quando appunto Lorusso parla della sua agendina. Il tema è la tesi processuale che vede qualche manina oscura far sparire documenti scottanti di Riina ritrovati nel suo covo, o meglio la sua abitazione dove viveva la famiglia. Non è vero nulla, dice il capo dei capi. «Questa … questa è la casa. Che cosa è successo poi – racconta Riina – … che mia moglie, verso le dieci le undici mia moglie se n’era andata… i picciutteddi… i figli… dice, io tutte cose … e poi… ci sono andati a scattiari i miei nipoti a prenderla… Là dentro c’era una stanza che era con la porta blindata avevo tappeti, avevo quadri… avevo il bene di Dio… e poi … tutte cose hanno preso. Eh… una cassetta nel muro, dietro il quadro … così… quando ..». Lorusso lo interrompe: «Una cassetta piccola, una cassetta dietro il quadro, di quelle…». Ed ecco che Riina risponde in modo categorico: «Sai, si, però non ci tenevo niente io… ci tenevo solo là … oggetti di famiglia!».
Riina a Lorusso: nella cassaforte di casa mia non ho mai tenuto niente A quel punto Riina approfondisce: «E là sotto… là… in questa… sarà che sono rimasti quadri, queste cose… avevo una valigia di brillantini dei picciutteddi… non avevo cose di traffici, di questi che riguardano, traffici in casa, niente. Perciò qualcuno gli diceva qualcuno di questi che fanno i pentiti… lui deve avere un tesoro, deve avere dentro, documenti, delle cose importanti. Ma i …». Lorusso gli finisce la frase: «Non c’era niente». Riina conferma: «Non ho mai tenuto niente!». Lorusso gli dice che quindi erano fantasie loro. «Erano fantasie di loro – rimarca Riina – . Tanto è vero che poi i miei nipoti, le mie cognate… a mio cognato l ‘hanno denunciato per furto… dice che fu… no furto… per questa, questa cosa di questa casa. Insomma in questa casa che risultò pulita, tutti i mobili cummigghiati (coperti), belli sistemati, sistemato… ed hanno denunciato quattro, cinque miei parenti… uno per tutti… poi hanno fatto cadere… hanno fatto scadere la denuncia…». In pratica, da queste intercettazioni appare chiaro che la vicenda dei documenti scomparsi, è una “fantasia loro”, giusto per usare le parole di Riina. In realtà teneva gioielli, oggetti di valore, tanto che la moglie ha fatto una denuncia per furto. Ma sicuramente sarà un passaggio sfuggito ai Pg, per questo ci permettiamo di segnalarlo.
Il capo dei capi non crede che Provenzano l’abbia tradito Resta anche sullo sfondo un altro dato. Totò Riina, come si evince dalle intercettazioni, soprattutto quella del 3 novembre del 2013, in più occasioni dice che non crede alla tesi che Provenzano l’abbia tradito, venduto in nome di una trattativa. «Provenzano – dice Riina – ha portato sempre acqua nel mulino… eh… , il mulino… macinato. Quindi… inc… il mulino è macinato. Quindi se uno è traditore non mi porta acqua… in questa maniera!». Più avanti Riina giunge alla sua conclusione: «Eccomi perché non posso credere queste illazioni che vogliono fare … il magistrato, le cose… perché… un altro detenuto magari può dire… l’ho sentito dire… la televisione… dice che è pronto a collaborare… lascia stare…, per il suo tornaconto e per il nostro tornaconto. No, non… Binnu (Provenzano, ndr) non è persona di queste… non è persona di queste. Però quando io mi sono reso conto che lui … la carrettella pesava … eh … ogni minuto io gli mettevo un peso che pesava, pesava…, Binnu… tu… inc… l’ho lasciato libero. Sempre, sempre, debbo dire la verità, non… confidenza non gliene davo e se si parlava di cose nostre… non… gli dicevo… cose mie personali». In realtà è solo uno dei tanti passaggi interessanti che si scovano nelle migliaia di pagine di intercettazioni. Tanti sono gli spunti, gli indizi che si possono ricavare. Compresa l’accelerazione della strage di Via D’Amelio e chi era presente all’esecuzione. Ma questo sarà un capitolo che Il Dubbio affronterà a parte. IL DUBBIO 5.6.2021
24.5.2021 – TRATTATIVA STATO-MAFIA, PROCESSO D’APPELLO: DELL’UTRI PER LA PRIMA VOLTA IN AULA In primo grado era stato condannato a 12 anni. Pg: “Incomprensibili omissioni guidate da logiche estranee a democrazia” “Incomprensibili omissioni”, rappresentanti dello Stato che si sono comportati “in modo opaco” e “certamente delittuoso” e “pupari” e “menti raffinatissime” che “hanno agito nell’ombra” per avviare una trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra per chiedere di fermare le stragi mafiose. Non usa giri di parola il sostituto procuratore generale di Palermo Giuseppe Fici che, nella prima udienza del processo d’appello trattativa Stato-mafia dedicata alla requisitoria, ribadisce con forza: “Chi ha agito fuori dalle leggi lo ha fatto per salvare un determinato assetto di potere e per tutelare il rapporto con la politica. Lo ha fatto facendo favori ai mafiosi, al di fuori dalle corrette dinamiche democratiche. E noi vogliamo sapere perché”. Una domanda che aleggia da anni, già nel primo grado del processo. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado i giudice scrissero che “L’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione del dottore Borsellino” fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo – ed in sostanza, di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Amelio”. Alla sbarra, per minaccia a Corpo politico dello Stato, gli ex ufficiali dei carabinieri Mario Mori e Giuseppe De Donno e l’ex capo del Ros Antonio Subranni, l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, che oggi per la prima volta è pesante in aula, i boss Leoluca Bagarella e Antonino Cinà e il pentito Giovanni Brusca. Gli imputati, tranne Brusca per cui fu dichiarata la prescrizione, sono stati condannati a pene pesantissime. La Corte d’Assise d’appello ha, invece, dichiarato prescritto il reato di calunnia contestato a Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo. Per i giudici di primo grado un ruolo importante determinante sarebbe stato svolto anche da Marcello Dell’Utri: “Con l’apertura alle esigenze dell’associazione mafiosa Cosa nostra, manifestata da Dell’Utri nella sua funzione di intermediario dell’imprenditore Silvio Berlusconi nel frattempo sceso in campo in vista delle politiche del 1994, si rafforza il proposito criminoso dei vertici mafiosi di proseguire con la strategia ricattatoria iniziata da Riina nel 1992”, scrissero nelle motivazioni. Oggi la Procura generale, che prosegue sulla stessa linea dei pm di primo grado, è rappresentata dai sostituti Giuseppe Fici e Sergio Barbiera. “C’è qualcuno in quest’aula – ha detto Fici – che dopo avere letto e sentito le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, gli atti su via D’Amelio, dubiti dell’esistenza di soggetti che hanno agito nell’ombra? Nessuno, riteniamo noi, dubita dell’esistenza di menti raffinatissime, di ‘pupari’ che hanno agito nell’ombra con evidenti gravi condotte che appaiono non comprensibili e certamente non giustificabili”. “Qui siamo di fronte a un sistema per cui bisogna credere per atto di fede – spiega Fici – Se ci venisse spiegato il perché del più grande depistaggio della storia o magari della restituzione dei cellulari a Giovanni Napoli, saremmo in grado di valutare e magari avviare una riconciliazione con chi invece chiede ancora oggi giustizia e verità. Invece, si preferisce tacere o dichiarare il falso piuttosto che raccontare la verità”. Fici sottolinea: “Da ciò che è emerso nel corso del lungo dibattimento possiamo ricavare una certezza: che negli anni un cui si sono verificati i fatti nella risposta al crimine organizzato da parte degli organi preposti qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto funzionare. Ci si riferisce, è bene essere espliciti, a comportamenti opachi e certamente delittuosi, da parte di appartenenti allo Stato di soggetti alcuni dei quali sono rimasti nell’ombra”. “Durante la discussione finale on ripeteremo frasi come ‘Fuori la mafia dallo Stato’ – dice ancora Fici riferendosi allo slogan usato dai rappresentanti delle ‘Agende rosse’ che anche oggi sono in aula – ma è evidente che in questo processo sono emerse alcune scelte di politica criminale e alcune incomprensibili omissioni, guidate da logiche rimaste estranee al corretto circuito istituzionale, ovvero alle corrette dinamiche democratiche”. “In un processo penale sono importanti i fatti provati e non le suggestioni e, tuttavia, è molto difficile restare del tutto insensibili a ciò che in questa terra si sa da decenni – prosegue il pg Giuseppe Fici – Si dice ‘vox populi vox dei’, espressione medievale che non si addice ai crismi del giusto processo, posto che le opinioni e i giudizi del popolo non possono essere ritenuti, in quanto tali, giusti e veri. E, tuttavia, come non tornare a quello che gridava con toni disperati una moltitudine di cittadini ai funerali di Falcone, Borsellino?”. “Come non ricordare la rabbia esasperata dei colleghi degli agenti di scorta uccisi nelle stragi di Capaci e in via d’Amelio? – prosegue il magistrato – Avevano intuito qualcosa evidentemente e avevano persino aggredito il Capo della polizia Parisi, rischiando che la rabbia travolgesse anche l’allora Capo dello Stato Scalfaro. “Chi ha agito violando le regole lo ha fatto per la salvezza di un determinato assetto di potere. Anche a costo di calunniare degli innocenti, distruggendo famiglie e seminando dolore e lo ha fatto al di fuori delle dinamiche democratiche. Noi invece vogliamo capire. Lo dobbiamo a tutti i familiari delle vittime”, sottolinea ancora Fici. Il pg Sergio Barbiera ha incentrato la sua parte di discussione, che proseguirà nella prossima udienza, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che sono stati sentiti nel corso del dibattimento. “L’escussione di numerosi collaboratori di giustizia ha ulteriormente rafforzato la ricostruzione fattuale e il già di per se granitico quadro probatorio”, dice Barbiera. In futuro, non dalla prossima udienza che si terrà il 31 maggio, ma da quella successiva, la requisitoria proseguirà nell’aula bunker del carcere Pagliarelli. Lo ha deciso il Presidente della Corte d’assise d’appello Angelo Pellino dopo le rimostranze del pg Fici a inizio udienza. “L’accumulo di anidride carbonica e di aria viziata è molto pericoloso, come dicono anche gli esperti. Chiedo che la prossima udienza venga fatta in un’aula diversa, più grande, dove si possano rispettare meglio le distanze sociali. Non vorrei che dopo un anno ci confondessimo proprio all’ultimo”, lamenta Fici. “Credo che la cosa importante sia l’uscita dall’emergenza sanitaria, ma chiedo nelle prossime udienza un’aula più grande perché parleremo per cinque, sei ore di seguito”, dice ancora Fici. Questa mattina già la Corte d’assise d’appello si era trasferita in un’aula diversa, più grande. Ecco la replica del Presidente Pellino a Fici: “In questa aula ci sono 40 persone cioè il limite previsto dalle norme, ma in futuro ci trasferiremo in aula bunker Pagliarelli”, annuncia. (di Elvira Terranova) ADNKRONOS
22.4.2018 – VI RACCONTO COSA C’È DIETRO AL PROCESSO SULLA TRATTATIVA. PARLA CLAUDIO MARTELLI L’ex ministro di Grazia e Giustizia racconta a Formiche.net la sua versione dei fatti su cui hanno indagato i pm di Palermo nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia La sentenza di primo grado della Corte d’Assise di Palermo sulla “Trattativa Stato-mafia” irrompe nello scenario politico e lascia aperte molte domande. Alcune di queste troveranno forse una risposta quando i giudici leggeranno le motivazioni. Nel frattempo Formiche.net ha chiesto a Claudio Martelli, ministro di Grazia e Giustizia dal febbraio del 1991 all’inizio del 1993, protagonista assoluto di quella stagione politica, la sua ricostruzione dei fatti. Strenuo difensore della linea dura con Cosa Nostra, che perseguì nella veste di Guardiasigilli con provvedimenti come il 41-bis e l’ interpretazione autentica nel calcolo della decorrenza dei termini di prescrizione, Martelli, al pari dell’allora ministro dell’Interno Vincenzo Scotti, non è stato sfiorato dall’inchiesta dei pm palermitani, che anzi nella rogatoria hanno fatto ampio riferimento al suo operato politico, definendo l’asse Martelli-Scotti-Falcone “l’immagine del cambiamento dell’azione politica”. Claudio Martelli, lei è stato un protagonista di quegli anni. Concorda con Di Maio e i Cinque Stelle, quando dicono che con questa sentenza “muore la Seconda Repubblica”? Tutte queste repubbliche che vanno e vengono mi sembrano le oche del Campidoglio. Perché ci sia una nuova Repubblica ci vuole innanzitutto una nuova Costituzione. Il tentativo di passare alla seconda, o alla terza, è fallito il 4 dicembre del 2016. Come al solito ci stiamo aggirando tra le macerie della Prima Repubblica, un esercizio sportivo che dura da 25 anni. La sentenza di primo grado dei giudici di Palermo prevede condanne molto dure anche per i vertici del Ros. Che idea si è fatto? Sono molto curioso di leggere le motivazioni, che dovranno contenere qualche elemento di prova di questo “tradimento”. Perché di questo si tratterebbe, se un’Arma che ha per motto “Nei secoli fedele” avesse davvero perpetrato un “attentato al corpo politico dello Stato”. Solo dalle motivazioni capiremo cosa abbia fatto scattare nei giudici questa convinzione: addentrarsi nei meandri dei tribunali palermitani è facile, uscirne fuori è difficilissimo. C’è l’impressione che siamo di fronte a una contesa storica, quasi atavica, tra i Ros e la procura di Palermo. Cominciò nel momento stesso dell’arresto di Totò Riina, quando Giancarlo Caselli, che all’epoca era ancora giudice a Torino e dunque non c’entrava nulla, si precipitò a Palermo a prendersi il merito dell’operazione. In quel momento ha avuto inizio questa partita senza esclusioni di colpi. Quando era ministro della Giustizia percepiva un’eccessiva autonomia da parte del Ros nella conduzione delle indagini? C’erano effettivamente degli atteggiamenti anomali. Il capitano De Donno si presentava al ministero e parlava direttamente con Liliana Ferraro a nome del colonnello Mori. Chiedeva una copertura politica per un’indagine sui generis. Il cui scopo, non lo metto in dubbio, era la prevenzione di nuove stragi, un compito non sottoposto alle autorità giudiziarie. Questa è la linea difensiva dell’avvocato di Mori Basilio Milio, persona che stimo e rispetto. Ad ogni modo trovai anomalo che il Ros chiedesse una copertura politica per stabilire un contatto con Vito Ciancimino. L’istituzione della Dia, fortemente voluta da Giovanni Falcone, rischiava di limitare l’autonomia del Ros? Cercherei di rinunciare al vezzo di citare Falcone. La Dia è opera dell’allora ministro degli Interni Vincenzo Scotti, così come la Dna fu opera mia. Quando Falcone venne al ministero non aveva una particolare competenza di questi strumenti giudiziari, perché non se ne era mai occupato. La stessa Superprocura nacque da una vecchia idea di Leo Valiani che io ripescai: Falcone rimase molto colpito, ma aveva il timore che non potesse essere realizzata. È importante non trasformare Falcone in un santino: lo hanno fatto in molti dopo la sua morte, soprattutto chi in vita lo ha avversato. Le indagini dei pm hanno fatto ampio uso delle dichiarazioni dei pentiti. È stato opportuno? Anche lei fu accusato da un pentito, Francesco Onorato, di aver ricevuto fondi dalla mafia per la campagna elettorale. Assolutamente no, non è serio procedere in questo modo. Anche perché, come si è visto, spesso sono pentimenti a singhiozzo, che si prolungano nel tempo dando luogo a esaltazioni, aggiustamenti e slittamenti graduali di significato. Mi sembra che il processo sia costruito non tanto sui fatti e le responsabilità dell’epoca, ma su come in un secondo momento, magari a distanza di vent’anni, quei fatti sono stati commentati e rivisti. Peraltro non dai protagonisti, ma da parte di qualcuno che ha sentito brandelli di conversazione da terze persone e si è fatto un’idea. Nella rogatoria i pm hanno accreditato la tesi del “golpe bianco”: l’avvicendamento di Vincenzo Scotti al Viminale e poi il suo al ministero della Giustizia preludevano a un cambio di passo nella strategia di contrasto alla mafia, iniziato con l’omicidio di Salvo Lima. Sono abbastanza convinto di questa ricostruzione. Ci sono però molte mistificazioni su quegli anni. Una su tutte: la leggenda di un “fronte unitario” contro la mafia dopo la strage di Capaci, quando il parlamento e le forze politiche avrebbero serrato le fila. Tutto falso. Quando Scotti ed io presentammo il “decreto Falcone” con le misure più severe contro Cosa Nostra, si riunì l’assemblea congiunta di deputati e senatori Dc che all’unanimità respinse il decreto, che fu poi dichiarato incostituzionale dalla Commissione problemi dello Stato di Cesare Salvi e Luciano Violante. Altro che unità. La verità è che se non ci fosse stato l’assassinio di Paolo Borsellino quel decreto probabilmente non sarebbe passato. E forse non bastò neanche quello: ai primi di agosto del 1992, due settimane dopo, il capogruppo del Pds al Senato Lucio Libertini chiedeva di rinviare il decreto. Cosa cambiò con l’arrivo di Nicola Mancino agli Interni? Mi trovai un po’ più solo di prima. Io e Scotti avevamo un ottimo rapporto, ma soprattutto una visione comune: bisognava passare a un atteggiamento più duro nel contrasto e nello smantellamento della Cupola. Io e Mancino avevamo due diverse visioni culturali, non c’era la corrispondenza che avevo con Scotti, ma non ci sono mai stati conflitti. Sono soddisfatto della sua assoluzione, credo che abbia subito sospetti assolutamente ingiustificati. C’è una tendenza generale, quando c’è una responsabilità di ordine politico, a farla divenire responsabilità penale. Sarebbe meglio evitare di intasare i tribunali con scemenze. Lei ha spesso parlato di “cedimento” dello Stato davanti alla mafia e non di trattativa. Qual è la differenza? La trattativa presuppone che due persone si incontrino e negozino un compromesso. Escluderei che questo sia successo. Anche se la fantasia di Ciancimino è senza limiti: prima ha parlato del papello 1, poi del papello 2 e 3, tutti scomparsi dal processo. È sorprendente che un tribunale ignori come si è sviluppata la tesi accusatoria nel corso di un’indagine lunghissima, che in realtà fin dalla cosiddetta “mancata perquisizione del covo”, dopo l’arresto di Riina, non è mai finita. Nel dibattito di questi giorni la sentenza di primo grado è stata definita una “sentenza politica”. Crede che oggi più che in passato ci sia una indebita vicinanza di alcune procure al mondo politico? È un fenomeno a macchia di leopardo. Le procure di punta, Palermo, Napoli, Milano, Roma, sono state accusate, a volte ingiustamente, di un’eccessiva vicinanza con ambienti politici. La verità è che i giustizialisti si ritrovano fra di loro, che siano giornalisti, politici o magistrati, perché c’è un idem sentire, e lo stesso si può dire dei garantisti. FORMICHE
03.03.2021 – TRATTATIVA, PROCESSO CHIUSO: L’ULTIMO MISTERO DEI DATI DIMENTICATI. Finita l’istruttoria dibattimentale a Palermo. “Cercate macchine per scrivere!”. Questo fu l’imput che fu dato ai militari del Ros che la notte del 10 novembre 1998 andarono ad arrestare Giovanni Napoli, fedelissimo del boss latitante Bernardo Provenzano, a cui puntavano i carabinieri. E però a casa di Giovanni Napoli, niente macchine per scrivere, lo strumento preferito da Binnu per scrivere i suoi pizzini. Ma ben altro, tanto altro. Telefonini, tre, floppy disk, un’agenda elettronica e anche un personal computer. Una “potenziale” miniera di informazioni sul tesoro segreto di Bernardo Provenzano su cui, però, non furono effettuati particolari approfondimenti. Sequestrati di notte e restituiti l’indomani mattina alla moglie di Giovanni Napoli. Riemerge, al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e mafia, questo caso. Sul banco dei testimoni, davanti alla Corte di assise presieduta da Angelo Pellino, l’accusa infatti chiama due sottufficiali che, all’epoca dei fatti, erano al ROS ed eseguirono l’arresto di Giovanni Napoli. Sebastiano Serra, oggi 49 anni, all’epoca era in tirocinio al Reparto anticrimine di Monreale: “Io mi occupai, una volta arrivati a casa di Giovanni Napoli, di notificare il provvedimento e di redigere il verbale di arresto e di perquisizione. Non ho fatto il giro dell’appartamento e ho scritto – ha detto alla Corte di assise di appello – sempre sotto lo sguardo adirato e innervosito di Napoli. Erano altri militari e forse anche il maresciallo Gigliotti, che si occuparono della perquisizione”. Il dato è che vengono sequestrati i 3 telefonini, 1 rilevatore di microspie – “che vengono acquisiti per fini investigativi” – ma l’indomani in tarda mattinata vengono restituiti. Nel verbale di restituzione, fa presente l’accusa, solo su un telefonino sono stati effettuati controlli: “Io non mi sono occupato di questo e non so che tipo di verifiche e controlli siano stati fatti. Non so nulla dei floppy disk”. Ancora più “opachi” i ricordi di Pasquale Gigliotti, nome di battaglia “Tigre”, che dopo oltre un decennio tra varie stazioni dell’Arma e il nucleo investigativo del comando provinciale, approda tra aprile e maggio del ‘98 al ROS. “Non ho alcun ricordo dell’operazione che riguarda Giovanni Napoli – ha detto il sottufficiale oggi in pensione ma che dal 2001 al 2018 è transitato al Sismi/Aisi – in linea di massima comunque io mi occupavo della logistica. Non ricordo di alcun sopralluogo a Mezzojuso (altra abitazione di Giovanni Napoli, ndr) e non avevo alcuna competenza informatica. Se ho firmato i verbali di restituzione dei dischetti – ha proseguito – è per rispetto dei miei colleghi che si occupavano delle indagini, è una questione di fiducia. Ma io non c’entravo nulla, a novembre ancora non ero stato assegnato ad alcuna sezione”.di Wladimir Pantaleone LIVE SICILIA 3.3.2021.
15.2.2021 – Stato-mafia, le difese si oppongono a nuove audizioni – L’avvocato Centonze (difesa Dell’Utri): “Baiardo? Neanche lo temiamo”. “Pietro Riggio? Inattendibile totalmente”. “La sentenza ‘Ndrangheta stragista? Non acquisibile e irrilevante”. “Le dichiarazioni di Baiardo? Non le temiamo. Ma ae la Procura generale le ritiene rilevanti per il procedimento, sul contraddittorio delle parti sentiremo anche questo collaboratore o presunto tale”. Sono questi alcuni degli argomenti che il legale della difesa Dell’Utri, Francesco Centonze, interloquendo sulle richieste fatte la scorsa udienza dalla Procura generale tra acquisizioni di documenti e ulteriori audizioni. Sia Centonze che Basilio Milio, legale dell’ex ufficiale del Ros Mario Mori, si sono opposti alla nuova audizione del generale Pellegrini e del colonnello Tersigni, già sentiti innanzi alla Corte d’assise d’appello lo scorso 27 gennaio. Secondo Centonze “la richiesta di riascoltare Tersigni e Pellegrini, anche per interpretare un appunto anonimo, va rigettata. Dopodiché noi non temiamo alcun testimone. Neanche temiamo le dichiarazioni di questo signor Baiardo”. Un riferimento, quello al “gelataio” di Omegna, uomo vicino ai boss di Brancaccio Giuseppe e Filippo Graviano di cui gestì la latitanza, per certi versi “preventivo” in vista di una possibile futura richiesta da parte della Procura generale. Allo stato, infatti, i sostituti Pg, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera hanno semplicemente chiesto l’acquisizione della sentenza del processo ‘Ndrangheta stragista, emessa dalla Corte d’Assise di Reggio Calabria lo scorso luglio, e l’acquisizione di una scheda specifica su Baiardo. Quest’ultimo, intervistato da Paolo Mondani per la trasmissione Report, aveva parlato di incontri avvenuti tra Graviano, Berlusconi e Dell’Utri. “Noi non abbiamo neanche voluto vedere la trasmissione. Non ci interessa. E non l’abbiamo rivista neanche dopo le parole del Procuratore generale – ha detto Centonze in aula – Vogliamo comunque ricordare che la sentenza di Reggio Calabria non è definitiva e le conclusioni non possono essere utilizzate. Crediamo che non sia possibile surrogare la legittima richiesta di sentire un testimone con il deposito di un documento di una sentenza non definitiva. Se la Procura riterrà rilevanti per il procedimento le sue dichiarazioni lo dovrà chiamare e sentire nel contraddittorio delle parti”. In precedenza, contro la sentenza della Corte d’Assise calabrese, si era espresso anche l’avvocato Milio, in quanto, a suo dire, sarebbero errate le ricostruzioni in merito alla vicenda Bellini e a quella sulla Falange Armata. L’avvocato si è anche opposto alle acquisizioni, e all’eventuale richiesta di audizione dei militari Sebastiano Serra e Pasquale Gigliotti, sentiti sul sequestro effettuato nei confronti di Giovanni Napoli, fedelissimo di Provenzano, di alcuni floppy disk, di telefonini e di un rilevatore di microspie. Aspetti su cui la Procura generale ha compiuto nei mesi scorsi un’ulteriore attività istruttoria. A sua volta Milio ha depositato la sentenza d’appello del Borsellino quater e quella definitiva di Cassazione rispetto all’ex ministro Dc Calogero Mannino, aggiungendo anche la testimonianza in Commissione antimafia della dottoressa Liliana Ferraro e del magistrato Felice Lima. Su quest’ultimo documento, però, si è opposta la Procura. La Corte, sentite tutte le partisi è riservata di decidere alla prossima udienza, prevista il 22 febbraio. Una data in cui sarà anche definito il possibile calendario di udienze per la discussione che, salvo imprevisti, si svilupperà tra maggio e giugno con 3 udienze per la requisitoria della Procura generale e sei udienze per le difese, comprese le parti civili. ARON PETTINARI ANTIMAFIA DUEMILA 15.2.2021
20.1.2021 – BORSELLINO QUATER, I GIUDICI: “NELLA STRAGE DI VIA D’AMELIO POSSIBILI INTERESSI CONVERGENTI DI GRUPPI DI POTERE ESTRANEI A COSA NOSTRA Con 377 pagine i giudici della corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta motivano la sentenza emessa il 15 novembre 2019: ergastolo per i boss Tutino e Madonia, 10 anni per i falsi pentiti Andriotta e Pulci. I magistrati non credono che Borsellino fu ucciso per la Trattativa: “Non può condividersi l’assunto difensivo secondo cui la ‘Trattativa Stato-mafià avrebbe aperto “nuovi scenari” in relazione alla “crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali” e al possibile collegamento fra “la stagione degli atti di violenza” e l’occasione di “incidere sul quadro politico italiano” “E’ possibile che la decisione di morte assunta dai vertici mafiosi nella corale riunione degli auguri di fine anno 1991 della Commissione provinciale e nelle precedenti riunioni della Commissione regionale, abbia intersecato convergenti interessi di altri soggetti o gruppi di potere estranei a Cosa nostra”. Lo scrivono i giudici del processo d’appello ‘Borsellino quater‘ nelle motivazioni della sentenza emessa il 15 novembre 2019 e adesso depositate in cancelleria. Si tratta dell’ultima “verità giudiziaria” sulla strage di via d’Amelio, in cui il 19 luglio del 1992 morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta. “Le numerose dichiarazioni raccolte dai testi escussi hanno rivelato numerose contraddizioni che non è apparso possibile superare, gettando al tempo stesso l’ombra del dubbio che altri soggetti possano essere intervenuti sul luogo della strage, nell’immediatezza dell’esplosione – scrivono i giudici della corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta nelle 377 pagine di motivazioni – ‘in giacca‘ nonostante la calura del mese estivo e l’ora torrida, non appartenenti alle forze dell’ordine e individuati anzi da taluni agenti intervenuti nella immediatezza come ‘appartenenti ai servizi segreti“. I magistrati sottolineano che “tale ultimo particolare appare ancora più inquietante se si considera che ‘di un uomo estraneo a Cosa nostra ha riferito anche il collaboratore Gaspare Spatuzza, indicandolo come presente nel magazzino di via Villasevaglios, il pomeriggio precedente la strage, veniva consegnata la Fiat 126 che sarebbe stata, di lì a poco, imbottita di tritolo”, aggiunge la corte presieduta dal giudice Andreina Occhipinti con consigliere estensore Gabriella Natale. L’accusa era rappresentata dal Procuratore generale Lia Sava e dai sostituti Antonino Patti, Carlo Lenzi, Lucia Brescia, Fabiola Furnari. La sentenza ha confermato le condanne all’ergastolo per i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, il primo come mandante, in qualità di reggente della famiglia di Resuttana, ed il secondo tra gli esecutori della Strage di via d’Amelio del 19 luglio 1992. Condannati a 10 anni di carcere per calunnia anche i ‘falsi pentiti‘ Francesco Andriotta e Calogero Pulci, che avevano confermato molte delle menzogne riferite da Vincenzo Scarantino (per cui il reato di calunnia è stato prescritto): è il più grande depistaggio della storia italiana ed è stato smontato solo dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza. “La strage di via D’Amelio – continua la sentenza depositata dai giudici nisseni – rappresenta indubbiamente un tragico delitto di mafia, dovuto a una ben precisa strategia del terrore adottata da Cosa nostra, in quanto stretta dalla paura e da fondati timori per la sua sopravvivenza a causa della risposta giudiziaria data dallo Stato attraverso il Maxiprocesso“. Nello specifico secondo la corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, “ogni tentativo della difesa di attribuire una diversa paternità a tale insana scelta di morte e terrore non può trovare accoglimento, potendo, al più, le emergenze probatorie indurre a ritenere che possano esservi stati anche altri soggetti o gruppi di potere interessati alla eliminazione del magistrato e degli uomini della sua scorta”. “Ma tutto ciò – dicono – non esclude la responsabilità principale degli uomini di vertice dell’organizzazione mafiosa che, attraverso il loro consenso tacito in seno agli organismi deliberativi della medesima organizzazione, hanno dato causa agli eventi di cui si discute”. Per i giudici della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta sottolineano anche che “non si hanno elementi in grado di adombrare profili di erroneità nella ricostruzione del momento deliberativo della strage e nella configurazione della ‘paternità mafiosa della stessa“. “Non è sufficiente che il proposito di rendere dichiarazioni calunniose sia stato ingenerato nell’imputato Vincenzo Scarantino – continua la sentenza – da una serie di discutibili e inquietanti e iniziative poste un essere da alcuni investigatori che hanno esercitato in modo distorto i loro poteri, con il compimento di una serie di forzature, tradottesi in indebite suggestioni e nella agevolazione di una impropria circolarità tra diversi contribuiti dichiarativi, tutti radicalmente difformi dalla realtà”. Per il depistaggio delle prime indagini sulla strage Borsellino sono attualmente a processo i poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di calunnia, aggravata dall’aver favorito Cosa nostra. Secondo la corte d’Assise d’Appello nissena, poi, non ci sarebbe un collegamento tra la Trattativa Stato-mafia e la morte di Borsellino, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’Assise di Palermo nel processo concluso nel 2018 per mafiosi, ufficiali dei carabinieri e politici. “Non può condividersi l’assunto difensivo secondo cui la ‘Trattativa Stato-mafià avrebbe aperto “nuovi scenari” in relazione alla “crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali” e al possibile collegamento fra “la stagione degli atti di violenza” e l’occasione di “incidere sul quadro politico italiano” con riferimento a coloro che “si accingevano a completare la guida del paese nella tornata di elezioni politiche del 1992. Invero, gli elementi acquisiti nel presente procedimento consentono di affermare che l’uccisione del giudice Paolo Borsellino, inserita nell’ambito di una più articolata “strategia stragista” unitaria, sia stata determinata da Cosa Nostra per finalità di vendetta e di cautela preventiva”. Per i giudici nisseni, poi, “è anche logico affermare che vi sia stata una finalità di ”destabilizzazione’ intesa ad esercitare una pressione sulla compagine politica e governativa che aveva fino a quel momento attuato una drastica politica di contrasto all’espansione del crimine organizzato mafioso”, scrivono i giudici. I magistrati considerano le indagini sulla strage avvolte ancora dai “coni” d’ombra: “Le emergenze probatorie acquisite nel procedimento costituiscono singoli pezzo di un mosaico che, nel suo complesso, continua a rimanere in ombra in alcune sue parti. Basti pensare alla ‘scomparsa misteriosà dell’agenda rossa del magistrato e alla ricomparsa della borsa stessa in circostanze non chiarite nell’ufficio di Arnaldo La Barbera”. IL FATTO QUOTIDIANO 20.1.2021
18.1.2021 -TRATTATIVA STATO-MAFIA, ”L’ECTOPLASMA RIGGIO” ALLA RICERCA DI PROVENZANO – LA TESTIMONIANZA DEL GENERALE PELLEGRINI NEL PROCESSO D’APPELLO. “Pietro Riggio? Il suo nome mi fu fatto da un personaggio che non ricordo, ma probabilmente forse ho anche trovato il nome riguardando le mie vecchie carte. Una persona, probabilmente dei servizi, che mi fu segnalato da un collega. Io ho il dubbio se mi è stato segnalata da una collega della Dia o della Territoriale. Potrei anche identificarla penso, ma non lo so dire di preciso. Mi è venuto un dubbio e lo farò presente al Procuratore Paci (reggente presso la Procura di Caltanissetta)”. A parlare è Angiolo Pellegrini, generale dei carabinieri in pensione ed ex capocentro della Dia a Reggio Calabria, Roma e Palermo, sentito oggi nel processo trattativa Stato-mafia, in corso davanti alla Corte d’assise d’Appello, presieduta da Angelo Pellino (a latere Vittorio Anania). Rispondendo alle domande dei sostituti procuratori generali, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera ha cercato di spiegare le modalità con cui venne in contatto con il collaboratore di giustizia nisseno, che al tempo avviò un rapporto confidenziale con la Dia. Una testimonianza a tratti confusa, specie quando si è trattato di individuare la genesi di quel rapporto e chiarire il ruolo di alcuni soggetti. “A Roma lo conobbi in modo particolare – ha ribadito – Mi venne segnalato che c’era una persona che lo aveva conosciuto in carcere e che Riggio era disponibile a dare indicazioni su Bernardo Provenzano. Incontrai questa persona, che si chiamava Antonio Mazzei, classe’48, a Caserta. E mi disse che Pietro Riggio conosceva cose di Provenzano. Ne parlai con il vice direttore operativo della Dia, Cesare Palazzo. Sapevo che il dottor Chelazzi svolgeva indagini in ambito del procedimento ‘Abisso’ per capire se dalle carceri fosse arrivato qualche input per le stragi. Tenuto conto che Riggio era un ex agente di custodia ne parlai con Pierluigi Vigna e con lo stesso Chelazzi. Il motivo? Io avevo un interesse particolare per Provenzano. Mi occupai di lui arrivando a scoprire le sue attività imprenditoriali, nonostante il personale limitato. Venire a sapere che qualcuno poteva dare informazioni su Provenzano stimolò molto il mio interesse”. Mazzei non era un uomo comune. Pellegrini gli diede anche un soprannome: “il Principe”. “Vestiva in modo appariscente, come fosse un nobile. Mi pare di ricordare che avesse un anello con le sue iniziali”. Un tratto distintivo, quest’ultimo, che era stato anticipato anche al pentito nisseno che lo aveva indicato come soggetto appartenente ai Servizi. Consultando alcune agende dell’epoca, acquisite al processo, Pellegrini ha confermato le date degli incontri avvenuti nell’estate 1999: “Il 2 luglio incontrai Mazzei e gli dissi che non avrei fatto colloquio investigativo con Riggio ma che sarebbe stato interrogato il 7 luglio da Chelazzi e che se avesse avuto qualcosa da dire l’avrebbe potuta dire a Chelazzi”. In quella data del 7 luglio Pellegrini ebbe modo di avere un incontro informale, precedente all’interrogatorio di Chelazzi, a cui presenziò anche Mazzei. Quell’incontro, secondo quanto detto dal teste, “fu casuale. Un’occasione per capire se effettivamente c’era qualcosa su Provenzano”. Nonostante i ripetuti tentativi di chiarimento da parte dei due magistrati e dello stesso Presidente della Corte, non si è ben compreso a che titolo potesse partecipare a quella chiacchierata. “Mazzei era un ex detenuto, non so cosa facesse di preciso – ha spiegato – Se era dei Servizi? Probabilmente, visto che chi me lo ha presentato era qualcuno dei Servizi, ma non mi disse che era collaboratore”. E poi ha aggiunto rispondendo ad una domanda del Presidente Pellino: “Lui era un trait d’union. Uno che disse che Riggio era disponibile a collaborare per dare notizie su Bernardo Provenzano”. Di quel colloquio informale il generale avrebbe parlato anche con Chelazzi il 28 luglio: “Io manifestai a Chelazzi il mio interesse per Provenzano. Venni a sapere che Riggio con Chelazzi non voleva collaborare e gli dissi che la mia impressione era che il suo intento fosse uscire dal carcere per poi tentare di infiltrarsi nell’ambiente per poter arrivare a Provenzano”. Nel corso dell’esame, però, l’ex capocentro della Dia ha riferito di non aver mai stabilito con Riggio un’infiltrazione in Cosa nostra, ma ha confermato il rapporto di collaborazione, tanto che furono anche informati i vertici della Direzione centrale ed anche l’autorità giudiziaria nelle persone dei magistrati Leopardi e Messineo a Caltanissetta e Prestipino a Palermo. L’operazione “Crepuscolo”. Nel 2001 venne inviata anche una lettera della Dia dando un nome all’operazione, chiamandola “Crepuscolo”. Pellegrini ha anche confermato la circostanza per cui Riggio “riferì che un suo conoscente, tale Peluso, per conto della criminalità doveva venire a Palermo a fare qualcosa. Io andai a parlare con Grasso a Palermo. E chiesi la possibilità di fare intercettazioni sulle utenze di Peluso. Grasso disse che non c’erano elementi sufficienti per fare intercettazioni. Vista la risposta io chiesi al primo reparto della Dia la possibilità di fare intercettazioni preventive. Durarono 4 mesi, ma non emerse nulla. Anzi ricordo anche considerazioni pesanti, come se Peluso fosse un millantatore o un truffaldino”. Se in un primo momento Pellegrini ha detto di “non sapere quale fosse l’episodio criminale particolare a cui fece riferimento Riggio”, dopo la lettura in aula dell’informativa del gennaio 2001 in cui si fa anche riferimento ad un’ipotesi di attentato, ha ribadito: “Io non ho fatto considerazioni, ma ho riferito quello che diceva Riggio. Anche in merito alla spaccatura in Cosa nostra già emergeva che Provenzano avesse preso le distanze da Riina e che tenesse più agli interessi finanziari ed economici”. Pellegrini ha anche spiegato i motivi per cui solo a partire da maggio vennero protocollate le relazioni di servizio: “Venne il dubbio che Riggio approfittasse delle sue attività per chiedere soldi in giro. Venimmo a conoscenza che era sottoposto ad indagine dal Ros e così decidemmo di cristallizzare tutto”. Al contempo ha negato che al Riggio fu detto di infiltrarsi delinquendo: “Lui doveva solo riferire quello che sapeva. Era una fonte ed aveva parenti mafiosi. Doveva essere un ectoplasma ed allargarsi nel territorio. Cosa chiedeva in cambio? Di essere reinserito nella polizia penitenziaria. Le sue informazioni non erano false, ma riguardavano personaggi di primo piano. Veniva fuori anche riferimenti a persone con precedenti penali e quelle informazioni andavano sviluppate. Anche se poi non ci portarono a Provenzano”. Successivamente a salire sul pretorio è stato il colonnello Tersigni che se in un primo momento aveva solo accompagnato Pellegrini agli incontri con l’allora confidente nisseno, poi ha gestito in prima persona il rapporto. Questi ha raccontato che Pellegrini lo coinvolse solo in un secondo momento e che nulla gli fu detto rispetto alle dichiarazioni pregresse dei mesi che vanno dal gennaio all’aprile 2001. Ciò significa che nulla seppe rispetto al “fatto eclatante da compiersi a Palermo” a cui Riggio fece riferimento. Il pentito, quando è stato sentito nel processo, aveva dichiarato di averne parlato con entrambi gli ufficiali, ma Tersigni ha negato in maniera categorica la circostanza, come di aver offerto denaro per l’eventuale arresto di Emmanuello. Invece ha confermato il tentativo di coinvolgere Carmelo Barbieri proprio per giungere alla cattura del latitante. Il processo è stato poi rinviato al prossimo 8 febbraio con la Procura generale che ha già annunciato di voler rinunciare all’esame testimoniale della dottoressa Ferraro. In apertura di udienza, infine, è stata data notizia che il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca si trova in isolamento in quanto ha contratto il Covid-19. Brusca in primo grado è stato assolto per intervenuta prescrizione, visto il riconoscimento delle attenuanti specifiche per i pentiti. Aaron Pettinari 18 Gennaio 2021 ANTIMAFIA DUEMILA
Alfonso Giordano, classe 1928, è il magistrato siciliano che ha presieduto il maxi processo a CosaNostra. Ha accettato di presiederlo quando più di qualcuno, tra i suoi colleghi, adduceva pretesti per declinare: troppe incognite, troppo lavoro e troppi rischi di essere ucciso. E invece il più ampio processo penale della storia è stato concluso dopo un lavoro ciclopico, svolto per il I grado in ventidue mesi serrati: 460 imputati, 200 avvocati, culminato con 19 ergastoli e 4665 anni di pene detentive complessive. È in questi giorni a Palermo l’appello Stato-mafia, come andrà a finire? Le sentenze del processo a Mannino mettono in chiaro ruoli e dinamiche: non è esistita. Che qualche elemento dello Stato possa aver parlato con qualche elemento della mafia, non lo escludo. Ma non per rispondere a un interesse generale, a un disegno complottistico come quello di cui si legge. Ho conosciuto sul campo il valore di uomini che hanno sfidato la morte centinaia di volte, pur di contrastare Cosa Nostra. E vedere i loro nomi in quel processo mi fa male, mi creda. Il Generale Mario Mori, per esempio? Mori, per esempio, certo. Uno che colpiva con grande decisione la criminalità organizzata, a cui lo Stato dovrebbe gratitudine, piuttosto. Ha avuto interlocuzioni, ha cercato informatori, ha seguito la pista di qualche infiltrato che riferiva? Io ho potuto condannare sulla base delle operazioni che ha portato a termine Mori, se vuole la mia testimonianza è questa. Tratto da IL RIFORMISTA 9.1.2021
“Trattativa Stato-mafia mai esistita”/ Alfonso Giordano “Berlusconi e Cosa Nostra…”.Alfonso Giordano, in un’intervista sulle colonne de “Il Riformista”, rivela: “Chiunque conosca i fatti non può credervi”. La verità su Andreotti, Berlusconi e… Alfonso Giordano è il giudice che ha presieduto il maxi processo a Cosa Nostra, caratterizzato da numeri a dir poco impressionanti: 460 imputati, 200 avvocati 19 ergastoli e 4.665 anni di pene detentive complessivi. Il magistrato siciliano classe 1928 è intervenuto quest’oggi sulle colonne de “Il Riformista”, a cui ha concesso un’intervista esclusiva nella quale ha subito bocciato l’esistenza della chiacchierata trattativa Stato-mafia. “Io ho rappresentato lo Stato nel processo più duro contro Cosa Nostra – afferma –. Il nostro compito era quello di non fare sconti a nessuno e non ne abbiamo fatti. Diciannove ergastoli comminati insieme e poi confermati in appello e in Cassazione significano che lo Stato con la mafia ci andava giù duro. Alla storia della cosiddetta trattativa non credo e nessuno che conosca i fatti può credervi. Si era incaricato di smentirla Giovanni Falcone, l’aveva considerata un’ipotesi inesistente Paolo Borsellino“.
“LA MAFIA IN PARTE DIALOGAVA CON LA POLITICA”. Nel prosieguo dell’intervista concessa a “Il Riformista”, Alfonso Giordano asserisce che l’istruttoria del maxi processo fu fatta “molto bene” da Falcone e Borsellino, i quali giunsero a una fondamentale conclusione: “La mafia era gelosa delle sue cose e la Commissione, che rappresentava il vertice della Cupola, emetteva le sue sentenze senza dare ascolto né a servizi deviati, né a emissari della massoneria, né altri”. Tuttavia, una sorta di dialogo della mafia con la politica è esistita, “c’è sempre stata. I politici che prendevano parte al dialogo con Cosa Nostra sono sempre stati quelli siciliani, con incarichi amministrativi. Non c’erano, nei nostri riscontri, politici di primo piano nazionale”. Fra gli interrogati vi fu Giulio Andreotti e Giordano ricorda che il confronto con lui fu “serio, serrato. Lo andai a sentire a Roma. Andreotti mise a disposizione le informazioni che aveva, negando un suo coinvolgimento diretto. A fine interrogatorio ci fece gli auguri di buon lavoro e non interferì mai, in nessun modo, con le indagini”.
“COSA NOSTRA MINACCIÒ BERLUSCONI” Alfonso Giordano ha poi rivelato a “Il Riformista” che Silvio Berlusconi, “per quel che so, ha avuto delle minacce da parte di Cosa Nostra, sia dal punto di vista economico, sia da quello fisico. Attraverso Dell’Utri, di cui si fidava, accettò di assumere Mangano, un personaggio incaricato da Pippo Calò di tenere Berlusconi sotto protezione. Come è noto, abbiamo condannato Calò e Mangano dopo avere acquisito tantissima documentazione. Agli atti non risulta niente di più su Berlusconi, ma vedo che il suo nome continua a circolare a prescindere”. In questi giorni, a Palermo, andrà in scena l’appello Stato-mafia: come andrà a finire? Giordano pare non nutrire dubbio alcuno: “Le sentenze del processo a Mannino mettono in chiaro ruoli e dinamiche. La trattativa non è esistita. Che qualche elemento dello Stato possa avere parlato con qualche elemento della mafia, non lo escludo, ma non per rispondere a un interesse generale, a un disegno complottistico come quello di cui si legge”. Sussidiario 11.01.2021 – Alessandro Nidi
6.1.2021.Trattativa Stato-mafia: vent’anni di panzane
Trattativa Stato-mafia, i 10 punti della difesa Mori. “Non vi è prova che i contatti tra carabinieri del Ros e Vito Ciancimino si sostanziarono in una ‘trattativa’ tra lo Stato e la mafia”, “anzi vi sono le prove contrarie”. E ancora. “Il giudice che ha emesso la sentenza non ha creduto a Massimo Ciancimino e al ‘papello’ consegnato dallo stesso”. E sulla sostituzione ai vertici del Dap tra Nicolò Amato e Adalberto Capriotti, avvenuta nel giugno 1993, è “emerso in modo cristallino come gli autori dell’avvicendamento siano stati Scalfaro, Conso ed i cappellani carcerari” e “non il generale Mori”. A un anno esatto dalla sentenza di primo grado del processo sulla trattativa tra Stato e mafia, prende il via domani il processo d’appello che vede ancora alla sbarra, tra gli altri, l’ex capo del Ros, il generale Mario Mori che in primo grado venne condannato a 12 anni di carcere, come il capitano Giuseppe De Donno, ad 8 anni. La difesa dei due ufficiali, in vista dell’appello, rilancia. Adnkronos è in grado di elencare tutti i punti su cui Mori e i suoi avvocati ribatteranno per dimostrare l’estraneità del generale alle accuse contestate e alla condanna subita. Al processo trattativa, in primo grado, venne condannato a 28 anni di carcere anche il boss mafioso Leoluca Bagarella – e la Procura ne aveva chiesti 16 – a 12 anni l’altro mafioso Antonino Cinà, a 12 anni l’ex senatore Marcello Dell’Utri. E poi 12 anni al generale Antonio Subranni e a Massimo Ciancimino, superteste creduto ma ‘bacchettato’ dagli stessi giudici.
IL PRIMO PUNTO– La difesa del generale Mori punta sugli aspetti “più controversi”, del processo. Al primo punto c’è la mancata proroga dei 41 bis, cioè il carcere duro, per un gruppo di detenuti accusati di mafia. Per Mori e per i suoi difensori un dato incontrovertibile dimostra che le mancate proroghe dei 41 bis, operate da Conso nel novembre 1993, non furono dovute ad alcuna “trattativa”, tuttavia taluni documenti sono stati ignorati e Mori è stato tacciato di essere, da sempre “geneticamente deviato”, ancorché nel 1973, mentre era al Sid, sventò un attentato di matrice palestinese ad un aereo israeliano, “salvando tante vite e, per questo, ebbe un encomio solenne”. Il reato contestato al generale Mario Mori e al capitano De Donno è quello di minaccia a corpo politico dello Stato, quindi al Governo, come prevede l’articolo 338 del Codice penale. “Perché esso possa configurarsi”, per la difesa è necessario che la minaccia giunga a destinazione e venga, quindi, percepito dalla vittima, vale a dire – nel caso specifico – il governo; “viceversa non esiste alcuna minaccia nei confronti del soggetto passivo, ossia il Governo stesso”. In primo grado la difesa aveva posto a tutti i testi che all’epoca ricoprivano incarichi istituzionali e di Governo, da Giuliano Amato a Luciano Violante, da Claudio Martelli al Prefetto Gianni De Gennaro, “quindi le asserite vittime”, la stessa domanda: “Avete ricevuto minacce dal capitano De Donno o dal generale Mori?”. Le risposte di tutti i testi, fanno presente i difensori, si sono concretizzate in una serie di “No””. E quindi, la minaccia, per Mori non è sicuramente giunta a destinazione o, a tutto voler concedere, “non lo è giunta tramite gli ufficiali dei carabinieri e, quindi, si è nella impossibilità di configurare il reato e comunque di addebitarlo ai carabinieri.
IL SECONDO PUNTO – Secondo punto della difesa, l’ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino, padre del superteste Massimo Ciancimino. Vito Ciancimino mnon avrebbe parlato “né di asserite ‘spaccature’ tra i boss Riina e Provenzano, né in occasione degli incontri con gli ufficiali del Ros, né negli interrogatori resi nel 1993 ai dottori Caselli ed Ingroia e prodotti dalla difesa dei Carabinieri”. Per gli imputati mancherebbe, quindi, la prova che il generale Mori avesse quelle conoscenze addebitategli e che le abbia portate a Di Maggio. “Anzi, esistono, come detto e ridetto, le prove contrarie”. E ancora. Secondo l’accusa, il generale Mori e De Donno avrebbero contattato Vito Ciancimino su incarico di Subranni, a sua volta “indotto dall’onorevole Calogero Mannino”, il quale, per salvarsi la vita avrebbe chiesto a Subranni di attivarsi in qualsiasi modo. Anche qui, per Mori e De Donno, manca però la prova che Mannino abbia sollecitato iniziative a Subranni.
IL CASO BORSELLINO – Nel processo ‘appello che prenderà il via domani si ripercorrerà tutta la vicenda riguardante proprio l’uccisione di Paolo Borsellino. Il giudice fu ucciso per la “trattativa” tra Stato e mafia, come titolato da tutti i giornali il giorno dopo il deposito della sentenza?. Come apprende l’Adnkronos, i legali di Mario Mori spiegano che “le prove acquisite sono tutte contrarie alla tesi” secondo cui la strage Borsellino sarebbe stata accelerata dalla trattativa. “La conclusione secondo cui il dottor Borsellino fu ucciso per la “trattativa” è stata raggiunta grazie a rilevanti lacune probatorie” in quanto non è stata ammessa una sentenza della Corte di Assise di Catania, ormai passata in giudicato da anni che collega la strage all’interessamento di Borsellino per le indagini del Ros sugli appalti e alla possibile nomina a Procuratore Nazionale Antimafia; quella sentenza è stata, peraltro, acquisita nel processo “Borsellino Quater” che è pervenuto alle stesse conclusioni dei giudici di Catania. Ma i giudici di primo grado del processo trattativa non la pensano così. Nelle motivazioni, depositate tre mesi dopo la sentenza, proprio il 19 luglio, giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio, il Tribunale ha scritto che “l’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione del dottor Borsellino” fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo – ed in sostanza, di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Ameliio”. Per i giudici del processo Trattativa Stato-mafia, “non vi è dubbio” che i contatti fra gli ufficiali dei carabinieri Mori e De Donno con Vito Ciancimino, unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l’avvicendamento di quel ministro dell’Interno che si era particolarmente speso nell’azione di contrasto alle mafie, in assenza di plausibili pubbliche spiegazioni) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Salvatore Riina già come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa nella misura in cui quegli ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato”. Domani comincia il processo di secondo grado. Prevista la relazione introduttiva del giudice a latere del dibattimento. E poi si entra nel vivo.
MAFIA E APPALTI– La difesa del generale Mario Mori rilancerà inoltre anche sul dossier su ‘mafia e appalti’. E’ un’indagine che fu avviata dai Carabinieri del Ros nel 1989 sotto la direzione del dottor Falcone. Essa aveva ad oggetto la illecita gestione degli appalti pubblici e, in essa, erano coinvolti politici, imprenditori e appartenenti alla mafia. Ma quale fu il problema che determinò contrasti tra il Ros e la Procura di Palermo? Secondo la Procura, i Carabinieri del Ros avrebbero operato la cosiddetta “doppia refertazione”, ossia “avrebbero consegnato, nel 1991, alla Procura di Palermo, nelle mani del dottor Falcone, un’informativa nella quale non vi erano le intercettazioni dalle quali emergevano i nomi dei politici. L’informativa completa, comprensiva anche dei riferimenti ai politici sarebbe stata consegnata, tempo dopo, e dopo l’uccisione del dottor Borsellino, alla Procura di Catania”. “La tesi della “doppia refertazione” è stata sostenuta da tutti i magistrati escussi, sebbene con alcune differenze tra loro (taluni hanno parlato di “differenze tra la informativa consegnata a Palermo e a Catania”, altri di un “Rapporto del Ros in versione completa consegnato al Procuratore di Palermo Giammanco che lo mise in cassaforte e che non lo diede ai sostituti”)” ma è smentita da due documenti provenienti da De Donno e che recano la firma di Giovanni Falcone e Guido Lo Forte. Documenti che la difesa dei Carabinieri ha chiesto di produrre ma che la Corte non ha ammesso perché ritenuti superflui.
VICENDA BELLINI – altro punto della difesa Mori, la vicenda di Paolo Bellini, un pregiudicato, di origine romagnola, il quale, nella primavera-estate del 1992, conosce presso un antiquario il Maresciallo Tempesta, del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico. Quest’ultimo chiede al Bellini informazioni su alcune opere d’arte rubate alla Pinacoteca di Modena, al fine di recuperarle. Bellini, qualche tempo dopo, contatta il Tempesta e gli propone il recupero di altre opere d’arte, diverse da quelle trafugate a Modena, chiedendo in cambio gli arresti ospedalieri per 5 boss mafiosi (Bernardo Brusca, Pippo calò, Giuseppe Giacomo Gambino, Giuseppe Marchese e Luciano Liggio indicati nominativamente in un foglietto di carta), più l’aggiustamento di un suo processo in Cassazione e 200 milioni di lire.
IL ‘BOOMERANG’ BRUSCA – La difesa del generale Mario Mori e del capitano Giuseppe De Donno ricorda poi le dichiarazioni del pentito Giovanni Brusca e del giudice Liliana Ferraro. “Perfino Brusca, cioè la “parte mafiosa”, ha affermato che i Carabinieri li avevano presi “in giro. Ma quelli avevano fatto solo e semplicemente il loro lavoro, gli investigatori”, come disse il pentito in un’udienza il 12.12.2013 . “Stupisce come si possa affermare l’esistenza di una “trattativa” ed, altresì, l’esistenza di un accordo”. E ancora: “Liliana Ferraro, che incontra il Capitano De Donno intorno al 20-25 giugno 1992, ha riferito che De Donno piangeva per la morte di Falcone e le disse (nel 1992), in merito a Vito Ciancimino, che “bisognava fare di tutto per cercare di scoprire gli autori di questa … strage e che lui si era ricordato di avere conosciuto in passato il figlio dell’ex sindaco di Palermo inquisito negli anni ’80 da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Caponnetto e che aveva incontrato questo figlio di Vito Ciancimino anche di recente e che forse valeva la pena di vedere attraverso il figlio se era possibile contattare il padre e vedere se il padre, visto quello che era successo, era disponibile a collaborare con i Carabinieri”. Su quei contatti con Vito Ciancimino, i giudici che hanno assolto Mori in due processi hanno scritto: “Se la cattura del Riina fosse stata il frutto dell’accordo con lo Stato, tramite il quale era stata siglata una sorta di “pax” capace di garantire alle istituzioni il ripristino della vita democratica, sconquassata dagli attentati, ed a “cosa nostra” la prosecuzione, in tutta tranquillità dei propri affari, sotto una nuova gestione “lato sensu” moderata, non si comprenderebbe perché l’associazione criminale abbia invece voluto proseguire con tali eclatanti azioni delittuose, colpendo i simboli storico-artistici, culturali e sociali dello Stato, al di fuori del territorio siciliano, in aperta e sfrontata violazione di quel patto appena stipulato”. E ancora: “Anche i progetti elaborati dal Provenzano di sequestrare od uccidere il cap. De Caprio, di cui hanno riferito in dibattimento, in termini coincidenti, i collaboratori Guglielmini, Cancemi e Ganci, appaiono in aperta contraddizione con la tesi della consegna del Riina al Ros”. “Se così fosse avvenuto, il boss non avrebbe avuto alcun interesse alla ricerca del capitano “Ultimo”, mentre, da quanto sopra, è stato accertato che effettivamente si cercò di individuarlo, tramite un amico del compagno di gioco al tennis”.
LA FARSA DAP – Altri spunti della difesa del generale Mario Mori riguardano la sostituzione ai vertici del Dap tra Nicolò Amato e Adalberto Capriotti, avvenuta nel giugno 1993. “E’ emerso in modo cristallino come gli autori di tale avvicendamento siano stati Scalfaro, Conso ed i cappellani carcerari, Mons. Fabbri e Mons. Curioni. Mentre per quanto riguarda la nomina di Francesco Di Maggio al posto di Edoardo Fazzioli, quale vicedirettore, è emerso un interessamento del Capo della Polizia Parisi, e l’intervento di Scalfaro. “In spregio di tali evidenze, che dimostrano come Mori (che all’epoca era solo un Colonnello, per quanto importante e conosciuto ma che, proprio in quegli anni 1993 e seguenti, indagava con il suo Reparto – il Ros – anche su Scalfaro) non c’entri nulla, si è scritto in sentenza che dietro Parisi, “suggeritore” della nomina di Di Maggio, vi sarebbe il “suggeritore del suggeritore”, cioè Mori”, come dirà la difesa. Queste le parole della sentenza: “Ed appare logico, allora, pensare ad un “suggeritore” nella individuazione della persona del Di Maggio quale soggetto destinato a sostituire Nicolò Amato, tanto più che tale individuazione risale, come si è visto, già ad alcuni mesi prima della formalizzazione della nomina e, in particolare, al mese di febbraio 1993,quando, con le dimissioni del Ministro Martelli, fautore della linea di maggiore rigore per i detenuti di mafia, si aprì la prospettiva di una rivisitazione della politica carceraria instauratasi dopo le stragi dell’anno precedente. Vi sono alcuni elementi di fatto che inducono a individuare tale “suggeritore” del Capo della Polizia Parisi tra i Carabinieri, con alcuni dei quali il Di Maggio, a differenza che col Parisi, in virtù anche della sua naturale propensione derivante dal fatto di essere figlio di un sottufficiale dell’Arma ed anche per la sua predilezione soprattutto per il Ros”, come risulta dalla sentenza. Ma il vero nodo cruciale è un altro: per i legali del generale la sentenza di primo grado sostiene che Mori avrebbe portato la minaccia a Conso, tramite Francesco Di Maggio, il 27 luglio 1993, allorquando incontrò quest’ultimo. Secondo la sentenza il generale Mori, in quella occasione, avrebbe rappresentato a Di Maggio l’esistenza di una “spaccatura” tra Riina e Provenzano, il primo stragista ed il secondo assestato su una linea morbida e non di contrapposizione frontale allo Stato. Di Maggio, a sua volta, ne avrebbe riferito a Conso che, nella speranza di accontentare Provenzano, avrebbe deciso di non prorogare 334 provvedimenti 41 bis. In questo sarebbe consistita la minaccia al Governo. Mori, secondo la sentenza, avrebbe appreso la notizia riferita a Di Maggio da Salvatore Cancemi, appena 5 giorni prima. Se non chè le dichiarazioni di Cancemi, rese il 22 luglio 1993 davanti ai Procuratori Caselli, Scarpinato e Sabatino e senza che fosse presente personale del Ros, smentiscono la tesi della sentenza, perché Cancemi non parla, nè in quell’occasione, nè in altre successive, di “spaccature” tra i due boss corleonesi. Quel verbale, però, ancorchè acquisito perchè prodotto dalla difesa del generale, è stato ignorato. Un dettaglio di non poco conto, visto che la sentenza sostiene anche che Mori avrebbe appreso pure da Vito Ciancimino la notizia della “spaccatura” tra Riina e Provenzano. E se casca la tesi Conso, casca tutto… ADNKRONOS 28.4.2019 ELVIRA TERRANOVA
Strage via D’Amelio, Fiammetta Borsellino: “Usare la parola “trattativa” è pericolosa semplificazione“ “Mai come in queste indagini sono stati compiuti errori e omissioni di così grande entità. Coinvolgere i servizi segreti nelle prime fasi di inchiesta è stato gravissimo. Imputare questa strage soltanto alla trattativa o solamente a una strage di tipo mafioso – ha detto – è molto semplificativo ma fa comodo a chi vuole impedire il raggiungimento della verità”.
L’ex ministro della Giustizia, Claudio Martelli : dopo Capaci…
LA TRATTATIVA Graviano cita Berlusconi. Accellerò via D’Amelio. Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta muoiono per l’improvvisa accelerazione della decisione stragista di Riina determinata dalla trattativa Stato-mafia, e in particolare “dai segnali di disponibilità al dialogo – e di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci – pervenuti al boss Totò Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Amelio”.
E Silvio Berlusconi era perfettamente consapevole della minaccia mafiosa veicolata da Dell’Utri al suo governo, fino al dicembre del ’94: è lui, inoltre, a essere citato in carcere dal boss di Brancaccio Giuseppe Graviano con quel “Berlusca” che la Corte ritiene pronunciato dal boss, “togliendo qualsiasi dubbio’.
Nel giorno del 26° anniversario della strage di via D’Amelio la Corte d’assise di Palermo deposita nei 90 giorni previsti le motivazioni della sentenza rilanciando la tesi di una strettissima connessione tra l’uccisione di Borsellino e il dialogo Stato-mafia e gettando l’ombra di una pesantissima responsabilità morale nei confronti degli ufficiali dei carabinieri Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno che quella trattativa avviarono e condussero all’insaputa della magistratura, coinvolgendo la politica per la contropartita richiesta.
Nelle 5200 pagine della sentenza con cui hanno motivato le condanne di mafiosi, ufficiali dei carabinieri e politici, i giudici Alfredo Montalto e Stefania Brambille ribaltano le conclusioni della Procura nissena che nella requisitoria del Borsellino quater non aveva ritenuto sufficientemente provata la relazione: “Non c’è dubbio che quell’invito al dialogo pervenuto dai carabinieri attraverso don Vito costituisca un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino”, con la finalità di approfittare “di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato”.
La Corte si spinge oltre e scrive che “non vi è alcun elemento di prova che possa collegare il rapporto mafia e appalti all’improvvisa accelerazione della strage Borsellino”, come sostenuto dalle difese degli ufficiali del Ros, per cui, secondo i giudici, “non vi è dubbio” che i contatti fra Mori, De Donno e Ciancimino “ben potevano essere percepiti da Riina come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa, nella misura in cui quegli ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato”. Ancor più, concludono i giudici, se si tiene conto del fatto che l’indagine su mafia e appalti “non era certo l’unica, né la principale di cui Borsellino ebbe a interessarsi in quel periodo”.
GRAVIANO E “BERLUSCA”, ALTRO CHE “BRAVISSIMO” Per il perito della Corte era “Berlusca’’, per i consulenti della difesa invece “bravissimo”. Due cuffie e un pc con scheda audio sciolgono ogni dubbio sul riferimento del boss Graviano a Berlusconi: “È stato possibile percepire con sufficiente chiarezza – scrive la Corte dopo avere ascoltato la registrazione – la parola Berlusca’’.
Ma a togliere “qualsiasi dubbio’’ è statala versione ripulita del file audio messa a disposizione dei difensori di Dell’Utri, “laddove sono chiaramente percepibili le vocali ‘e’ ed ‘u’, inesistenti nella parola ‘bravissimo’’’. D’altronde, chiosa la Corte, “appare singolare che su oltre 21 ore di registrazione il consulente non abbia concordato sulle uniche due, brevi frasi nelle quali viene nominato, dal Graviano, Berlusconi’’, tenuto conto, aggiungono i giudici, che il boss di Brancaccio si riferisce a Berlusconi, senza citarlo, anche in occasione della sua visita sull’Etna (29 ottobre 2002) e in Bielorussia (30 novembre 2009, negli stessi giorni in cui era chiamato a testimoniare al processo Dell’Utri).
LA RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICIALI DEL ROS Avviando il dialogo con i vertici di Cosa Nostra, Mori, Subranni e De Donno agirono con “il dolo specifico di colui che abbia lo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso o che comunque abbia fatto propria tale finalità”. E difatti “il termine trattativa è stato usato sia da Mori che da De Donno, oltre che dal loro interlocutore Vito Ciancimino sino a quando essi non hanno preso consapevolezza delle conseguenze nefaste di quella loro improvvida iniziativa”. Secondo la Corte di Palermo, gli ufficiali del Ros stimolarono “il superamento del muro contro muro e quindi l’indicazione, da parte dei vertici mafiosi, delle condizioni per tale superamento”. In questo modo, si legge nelle motivazioni, “si sono inevitabilmente rappresentati…non soltanto il vantaggio che sarebbe potuto derivare per coloro che si temeva potessero essere vittime della vendetta mafiosa (i politici, ndr), ma altresì il vantaggio che sarebbe in ogni caso derivato per Cosa Nostra nel momento in cui fosse venuta meno la contrapposizione frontale e soprattutto la forte azione repressiva dello Stato”, già culminata con il maxiprocesso e, dopo Capaci, col decreto dell’8 giugno ’92.
BERLUSCONI CONSAPEVOLE: OMBRE SU PALAZZO CHIGI E se Dell’Utri ha veicolato l’ultima minaccia, quella al governo Berlusconi nato nel ’94, il leader di Forza Italia era perfettamente consapevole del ricatto mafioso almeno sino al dicembre ’94. A quella data le società di Berlusconi proseguono i versamenti alla mafia, e in quel periodo mentre “faceva da intermediario di Cosa Nostra per i pagamenti, Dell’Utri riferiva a Berlusconi riguardo ai rapporti coi mafiosi ottenendone le necessarie somme di denaro e l’autorizzazione a versarle a Cosa Nostra”. Proprio nello stesso periodo nel quale incontrava Vittorio Mangano “per le problematiche relative alle iniziative legislative che i mafiosi si attendevano dal governo”. Lo provano le dichiarazioni del pentito Salvatore Cucuzza, secondo cui Dell’Utri informò Mangano di una modifica legislativa in materia di arresti per gli indagati di mafia. “Ciò dimostra – prosegue la Corte – che Dell’Utri informava Berlusconi dei suoi rapporti con i clan anche dopo l’insediamento del governo da lui presieduto, perché solo Berlusconi, da premier, avrebbe potuto autorizzare un intervento legislativo come quello tentato e riferirne a Dell’Utri per tranquillizzare i suoi interlocutori”.
IL RUOLO DELL’EX MINISTRO MANNINO La Corte d’assise osserva come l’ex ministro Calogero Mannino, (assolto in primo grado nel processo col rito abbreviato e ora imputato in appello), nel ’92 bersaglio di minacce da parte di Cosa Nostra, si sia rivolto “non a coloro che avrebbero potuto rafforzare le misure della sua sicurezza, ma a ufficiali dell’Arma ‘amici’ e in particolare a Subranni”. I giudici fanno rilevare che quest’ultimo “non aveva competenza per preservare Mannino da attentati”, e che dunque il politico lo contattò con l’obiettivo esclusivo di “attivare un canale che per via info-investigativa potesse acquisire notizie dettagliate sui movimenti di Cosa Nostra”. Non è dato sapere, prosegue la Corte, “come sia stata recepita da Subranni quella sollecitazione”, ma è un dato di fatto che “dopo Capaci, De Donno, sollecitato dai suoi superiori Subranni e Mori, contatta Ciancimino”, lanciando “un oggettivo invito all’apertura di un possibile dialogo con i vertici di Cosa Nostra e all’accantonamento della strategia mafiosa nell’ambito della quale si collocava l’uccisione di Mannino”.
IL “PAPELLO” E IL RUOLO DI DON VITO Il fatto che il documento sia stato consegnato da Massimo Ciancimino e che possa identificarsi con il “papello” solo per le dichiarazioni di quest’ultimo, scrive la Corte, “è un ostacolo insormontabile alla conclusione che possa trattarsi del vero papello”. E, d’altra parte, argomentano i giudici, “se anche fosse il vero papello, ci si troverebbe davanti al frutto avvelenato della scellerata condotta di Massimo Ciancimino che impedisce di utilizzare persino quel nucleo di fatti veri sui quali egli poi ha costruito le sue fantasiose sovrastrutture”. Ma attenzione: la “probabile falsità del documento”, non significa che Ciancimino padre “non sia stato effettivamente destinatario di richieste, eventualmente anche scritte, da parte dei vertici mafiosi quali, almeno in parte, quelle del papello esibito da Massimo e acquisito agli atti”. La questione cruciale, infatti, “è accertare che Riina, anche solo oralmente, abbia posto condizioni per l’abbandono della strategia mafiosa e che queste condizioni siano giunte al destinatario finale (il governo)”. Queste condizioni sono qualificabili come minacce? Sì. Sul punto, conclude la Corte, “è stata raggiunta la prova sulla formulazione e l’inoltro, da parte di Riina, tramite il canale Ciancimino aperto dai carabinieri, di alcune espresse condizioni cui subordinare la cessazione della contrapposizione totale di Cosa Nostra allo Stato”.
LA MANCATA PERQUISIZIONE DEL COVO DI RIINA Fermo il principio del ne bis in idem, scrivono i giudici, “non vi è preclusione ad analizzare i fatti”, tanto più che la sentenza che nel 2006 mandò assolti Mori e Sergio De Caprio per la mancata perquisizione del covo di via Bernini “era basata su un compendio di prove assolutamente esiguo”. La condotta degli ufficiali del Ros desta ancora oggi “profonde perplessità”, osserva la Corte, che ricorda come anche i giudici dell’appello Mori-Obinu, nel verdetto del maggio 2016, ebbero a definire “davvero singolare” la scelta di non perquisire l’abitazione del boss dopo la sua cattura nel gennaio del ’93. La stessa “strategia attendista” evocata dai carabinieri come giustificazione, “avrebbe senso solo nel contesto di un’effettiva sorveglianza del covo”, che invece non ci fu. La sentenza fa dunque riferimento a “condotte omissive” dirette “a preservare da interferenze la propria interlocuzione coni vertici di Cosa Nostra”.
CIANCIMINO JR. TESTE INATTENDIBILE In sette righe, infine, i giudici decretano la fine della carriera di collaboratore per Ciancimino jr, che con le sue parole, insieme a quelle di Brusca, aveva consentito l’avvio dell’inchiesta: “Ritiene la Corte che non si possa e debba attribuire alcuna valenza probatoria alle dichiarazioni di Massimo Ciancimino per la sua verificata complessiva inattendibilità che ne impedisce qualsiasi uso, ma senza che, però, da ciò possa e debba farsi derivare una valutazione negativa sulla reale esistenza di fatti e accadimenti sol perché gli stessi siano stati eventualmente inseriti nel più ampio racconto dello stesso Ciancimino”. Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza Fatto Quotidiano del 20/07/2018
Il 29 Aprile 2019 INIZIA l’appello del processo Stato-Mafia. Cosa era stato deciso in primo gradoLa trattativa c’è stata. Il patto scellerato tra pezzi dello Stato e Cosa nostra è stato siglato. Questo è emerso dal duro dispositivo della Corte d’assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, pronunciato il 20 aprile 2018 nell’aula bunker del Pagliarelli al termine di oltre quattro giorni di camera di consiglio. Con questa conclusione processuale, formulata in primo grado, si deve confrontare adesso il processo d’appello che si è aperto. Le motivazioni sono state depositate il 19 luglio dell’anno scorso, nel ventiseiesimo anniversario della strage di via D’Amelio. Dopo cinque anni di udienze, boss e politici sono stati dichiarati in primo grado colpevoli del reato di minaccia e violenza al corpo politico dello Stato. La trattativa sarebbe stata intavolata dai carabinieri fino al 1993, dall’anno successivo in poi dall’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri. Condannati a 12 anni di carcere, oltre a Dell’Utri, i generali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni e il boss Antonino Cinà; a 28 anni Leoluca Bagarella, la pena più pesante. Otto anni al colonnello Giuseppe De Donno. Stessa pena per Massimo Ciancimino accusato di calunnia nei confronti dell’allora capo della polizia Gianni De Gennaro, mentre è stato assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Prescrizione per Giovanni Brusca. Assolto l’ex ministro Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza.
La trattativa accelerò “l’esecuzione” di BorsellinoUna motivazione colossale per un processo poderoso. Tra le 5252 pagine la convinzione che “l’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione del dottore Borsellino” fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo – e in sostanza, di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Amelio“. Per cui, secondo i giudici di primo grado, “non vi è dubbio” che i contatti fra Mario Mori e Giuseppe De Donno con Vito Ciancimino, “unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l’avvicendamento di quel ministro dell’Interno che si era particolarmente speso nell’azione di contrasto alle mafie) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Riina già come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa nella misura in cui quegli ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato”. Insomma, “quell’invito al dialogo pervenuto dai carabinieri attraverso Vito Ciancimino costituisce un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino” con la finalità di approfittare “di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato”. E questo è un fatto anche laddove non si volesse convergere sulla conclusione dell’accusa secondo cui “Riina abbia deciso di uccidere Borsellino temendo la sua opposizione alla trattativa”.
Riina incoraggiato a mettere in ginocchio lo StatoSecondo i giudici “quei contatti che già all’indomani della strage di Capaci importanti e conosciuti ufficiali dell’Arma avevano intrapreso attraverso Vito Ciancimino, unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l’avvicendamento Scotti-Mancino al ministero dell’Interno, ndr) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Riina già come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa”. In altre parole “se effettivamente quei segnali pervennero a Riina nel periodo immediatamente antecedente alla strage di via D’Amelio (e che ciò effettivamente avvenne risulta provato) è logico e conducente ritenere che Riina, compiacendosi dell’effetto positivo per l’organizzazione mafiosa prodotto dalla strage di Capaci, possa essersi determinato a replicare, con la strage di via D’Amelio, quella straordinaria manifestazione di forza criminale per mettere definitivamente in ginocchio lo Stato ed ottenere benefici sino a pochi mesi prima (quando vi fu la sentenza definitiva del maxi processo) assolutamente per lui impensabili”.
I Ros agevolarono il progetto di Cosa NostraMario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, i carabinieri condannati poco più di un anno fa, agirono con “il dolo specifico di colui che abbia lo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso o che comunque abbia fatto propria tale finalità”. Gli imputati, secondo la sentenza del processo stato-mafia, stimolarono “il superamento del muro contro muro e quindi l’indicazione, da parte dei vertici mafiosi, delle condizioni per tale superamento”. In questo modo, “si è inevitabilmente rappresentato il vantaggio che certamente sarebbe in ogni caso derivato per Cosa nostra nel momento in cui fosse venuta meno la contrapposizione frontale la forte azione repressiva dello Stato, già culminata nelle pesanti pene del maxiprocesso e più recentemente dopo la strage di Capaci nelle misure anche di rigore carcerario del decreto legge adottato dal governo l’8 giugno 1992”. Il ruolo di Marcello Dell’Utri “come intermediario delle minacce di Cosa nostra a Silvio Berlusconi – secondo i giudici di primo grado – non si colloca nel momento in cui quest’ultimo decise di scendere in politica, ma fu espresso dopo che fu formato e insediato il nuovo governo presieduto proprio da Berlusconi“.
Dell’Utri intermediario, minacce a BerlusconiIl riferimento sono gli incontri che Dell’Utri, condannato a 12 anni, ebbe con l’ex stalliere di ArcoreVittorio Mangano “in almeno due occasioni, la prima tra giugno e luglio 1994, la seconda nel dicembre dello stesso anno, per sollecitare l’adempimento degli impegni presi durante la campagna elettorale, ricevendo, in entrambe le occasioni, ampie e concrete rassicurazioni”. Il collegio concordava con le argomentazioni difensive di Dell’Utri, che negano che le iniziative “fossero state effetto diretto di una minaccia”, legandole piuttosto a “libere scelte di quella consistente componente di soggetti facenti parte di Forza Italia che, per risalente asserita vocazione garantista, da tempo si battevano contro alcuni provvedimenti adottati in funzione antimafia dai precedenti governi”. “Ciò pero’ non toglie che ugualmente gli interventi di Mangano nei confronti di Dell’Utri possano avere avuto una obiettiva attitudine ad intimorire il destinatario finale, individuato dai mafiosi in Berlusconi, indipendentemente dal fatto che l’effetto intimidatorio, purché comunque percepibile, possa avere inciso concretamente sulla sua liberta’ psichica e morale di autodeterminazione”. “Le promesse o quantomeno la disponibilità manifestata da Dell’Utri per soddisfare le esigenze di Cosa nostra hanno contribuito all’entusiastico appoggio dato da quest’ultima in Sicilia alla nascente nuova forza politica”. I giudici parlavano di un ruolo di Dell’Utri “tutt’altro che neutro, perché non si sarebbe limitato ad ascoltare e a raccogliere le richieste dei mafiosi, ma avrebbe ancora manifestato disponibilità nel farsi carico delle iniziative del governo Berlusconi”. I magistrati ricordavano che “l’evento del reato contestato non è costituito dai provvedimenti legislativi poi adottati, ma esclusivamente dalla percezione da parte di Berlusconi, in qualità di capo del governo, della pressione psicologica operata da Cosa nostra col ricatto, esplicito o implicito che fosse, della reiterazione delle stragi”. In altri termini la Corte sosteneva che Dell’Utri “continuava ad informare Berlusconi di tutti i suoi contatti anche dopo l’insediamento del governo da quest’ultimo presieduto e vi è la definitiva conferma che anche il destinatario finale della pressione o dei tentativi di pressione, venne a conoscenza della minaccia in essi insita e del conseguente pericolo di reazioni stragiste che una inattività nel senso delle richieste dei mafiosi avrebbe potuto fare insorgere”. AGI 1.5.2019
7.1.2021 La trattativa Stato-Mafia secondo Salvatore Borsellino. Il linguaggio è importante: la trattativa Stato-Mafia non è “presunta”. La trattativa Stato-Mafia esiste ed è provata, come dice Salvatore Borsellino. Lui è il fratello di Paolo Borsellino, ucciso nella strage di via D’Amelio il 19 luglio del 1992. “Smettiamola di chiamarla così. Una sentenza di primo grado ne ha già riconosciuto l’esistenza, definirla “presunta” confonde solo le idee di chi ascolta”. Le dichiarazioni ad Adnkronos di Salvatore Borsellino seguono il servizio di Report andato in onda la sera del 4 gennaio. Nel programma di Sigfrido Ranucci si è parlato dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Salvatore Baiardo a Report: l’agenda rossa è in mano alla mafia Il servizio di Report ha per protagonista Salvatore Baiardo. Si tratta di colui che ha coperto la latitanza della famiglia dietro la strage di via D’Amelio. Ci riferiamo ai Graviano. I fratelli Graviano, infatti, erano dei killer al servizio di Totò Riina. Ed è nella famiglia Graviano che sarebbe finita l’agenda rossa. Al riguardo ci sarebbe stato un incontro ad Orta, in Piemonte. Sarebbero stati presenti anche rappresentanti di quei Servizi Segreti arrivati fin troppo in fretta sulla scena della morte di Borsellino. Riguardo la trattativa Stato-Mafia, Baiardo ha parlato di incontri con Silvio Berlusconi. Ne parla anche il collaboratore di Borsellino Giovanni Paparcuri, che ribadisce la volontà di Borsellino di indagare sul politico, su spinta di Giovanni Falcone. Baiardo parla di giri di soldi fra Marcello dell’Utri e Berlusconi, e la famiglia Graviano. Lo stesso Giuseppe Graviano aveva ribadito in passato come avesse incontrato tre volte Berlusconi, nell’aula bunker di Reggio Calabria per il processo ‘Ndrangheta stragista.
L’opinione di Salvatore Borsellino La grande quantità di teorie, però, ha infastidito Salvatore Borsellino. Il fratello del magistrato non ha apprezzato l’unione fra verità e teorie non confermate. Chi conosce la storia non ne ha ricavato nulla di nuovo, chi non è addentro alle cose è rimasto stordito. Una serie di notizie, di ipotesi, di informazioni, affastellate una dietro l’altra che hanno generato solo una grandissima confusione. Un frullato di cose vere e altre poco attendibili. Ognuno degli argomenti affrontati ieri sera avrebbe avuto bisogno di una trasmissione dedicata, di un approfondimento. Sono cose serie, non notizie. Una delle ipotesi, per esempio, riguarda una delle copie dell’agenda rossa, forse finita nelle mani di Matteo Messina Denaro. Non è alla mafia che interessava l’agenda rossa di Paolo Borsellino ma alle parti deviate dello Stato. E se quell’agenda fosse nelle mani di Matteo Messina Denaro, avrebbe uno strumento di ricatto incredibile.
L’agenda rossa di Borsellino e la trattativa Stato-Mafia L’agenda rossa di Borsellino, oltre ad avere un valore simbolico riguardo l’antimafia, è una delle prove chiave sulla trattativa Stato-Mafia. Secondo chi conosceva Paolo Borsellino, il magistrato aveva cominciato a prendere una serie di appunti considerati fondamentali. Non si separava mai dalla sua agenda, ma era sparita dalla scena del crimine di via d’Amelio. Salvatore Borsellino ha definito all’Adnkronos “una scellerata congiura del silenzio che è durata per 20 anni” ciò che ruota attorno all’agenda. C’era qualcuno che aspettava per fare sparire l’agenda rossa e per impadronirsene […] Quell’agenda è stata sottratta perché doveva servire per gestire i ricatti incrociati con i nomi.
Ad oggi è uno dei più gravi depistaggi della storia italiana. Un’agenda, un oggetto apparentemente innocuo, potrebbe far luce sul torbido rapporto fra politica e mafia. Questo oggetto apparentemente innocuo diventa pericoloso, vitale ed essenza della lotta contro la criminalità organizzata. In ogni sua forma. Magari un giorno l’agenda rossa finalmente finirà nelle mani giuste: quelle della giustizia. 7 GENNAIO 2021 Ultima Voce Giulia Terralavoro
14.12.2020 Trattativa Stato-mafia, citati a deporre ex giudice pool antimafia di Palermo e ufficiali Carabinieri Si tratta di Leonardo Guarnotta e dei due ufficiali dei carabinieri, il generale Angiolo Pellegrini e il colonnello Alberto Tersigni La Procura Generale, che sostiene l’accusa al al processo d’appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, ha chiesto che vengano chiamati a deporre l’ex giudice del pool antimafia Leonardo Guarnotta e due ufficiali dei carabinieri, il generale Angiolo Pellegrini e il colonnello Alberto Tersigni. La corte d’assise che giudica per minaccia a Corpo politico dello Stato ex ufficiali del Ros, boss mafiosi e l’ex senatore Marcello Dell’Utri, si è riservata di decidere se ammettere l’istanza. Al centro della deposizione sollecitata dai pg le rivelazioni del confidente Pietro Riggio, ex guardia penitenziaria poi arrestata per mafia e ora collaboratore di giustizia, su un “fatto eclatante «che si sarebbe dovuto verificare nel 2001 a Palermo che avrebbe dovuto riguardare Guarnotta. Una «soffiata» mai verificata nonostante, dopo le confidenze di Riggio, che disse di aver saputo le informazioni da un poliziotto colluso, siano state effettuate intercettazioni proprio a carico dell’agente sospettato. Sulla circostanza la Procura generale ha depositato alla corte i verbali di sommarie informazioni rese da Tersigni e Guarnotta, nel 2019. «Negli anni 2000-2001 presiedevo il collegio che giudicava Marcello Dell’Utri a Palermo. Al tempo non ebbi alcuna notizia di un progetto di attentato ai miei danni», ha detto Guarnotta. “Pellegrino avvicinò Riggio con l’obiettivo di catturare Provenzano può darsi che abbia parlato anche di attentati nei confronti di magistrati ma non ne ho ricordo. In ogni caso delle sue confidenze furono redatte annotazioni di servizio», ha, invece, dichiarato Tersigni ai magistrati di Caltanissetta. La prossima udienza si terrà il 18 dicembre. LA SICILIA
14.12.2020 – Depistaggio via d’Amelio, Mancino e la reticenza dei ”non ricordo” L’avvocato Repici chiede la trasmissione in Procura del verbale della testimonianza dell’ex ministro. Per la prima volta sentito in aula anche il generale Borghini Quando fu chiamato a deporre nel processo Borsellino quater Nicola Mancino era un imputato di reato connesso, accusato di falsa testimonianza a Palermo nel processo per la trattativa Stato-mafia, e scelse di avvalersi della facoltà di non rispondere”. Ora che da quell’accusa è stato definitivamente assolto, in quanto né la Procura di Palermo né la Procura generale ha appellato per la sua posizione la sentenza pronunciata dalla Corte d’assise, lo step successivo, “complice” a suo dire il lungo lasso di tempo trascorso da certi fatti, è quello del ricorso quasi sistematico ai “non ricordo”. L’ex ministro è stato sentito come testimone al processo sul depistaggio sulla strage di via d’Amelio che vede imputati i tre poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di calunnia aggravata dall’aver favorito Cosa nostra. Una testimonianza al termine della quale Fabio Repici, legale di parte civile di Salvatore Borsellino, ha chiesto ufficialmente al Tribunale la trasmissione in Procura dei verbali della deposizione. E il Presidente del Tribunale Francesco D’Arrigo si è riservato di decidere sul punto. “Dico non ricordo”. L’ex ministro degli Interni, sentito in videoconferenza, più volte ha mostrato una certa insofferenza nel rispondere alle domande dell’avvocato, come quando ha fatto presente di aver depositato tre volumi della propria attività di ministro al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia (“Se ritiene ne può fare richiesta presso la Procura della Repubblica di Palermo. E’ pubblico e può essere letto in udienza a prescindere dall’udienza del testimone qui presente. Non mi può dire niente. Io ho fatto quella dichiarazione e mi riporto a quella dichiarazione”). Una visione distorta del compito che ogni cittadino, ancor di più se ha avuto un ruolo istituzionale, dovrebbe avere. Evidentemente c’è un certo fastidio nel salire sul banco dei testimoni. Fastidio ingiustificato se l’idea è quella di offrire un contributo di verità su quella terribile stagione di bombe. Uno dei temi affrontati durante l’esame, ovviamente, il famoso incontro del primo luglio con il giudice Paolo Borsellino.
“Aveva mai visto una sua immagine in tv o sui giornali?” ha immediatamente chiesto Repici. “Io all’epoca ho detto di non ricordare. Come posso oggi dire che ricordo? Ho detto di no ed oggi non posso dire di sì” ha risposto l’ex Presidente del Senato, dimostrando la propria insofferenza. Quindi ha aggiunto: “Non ho mai avuto contatti con lui, non lo conoscevo e non avevamo mai avuto rapporti – ha dichiarato – Ci siamo limitati solo a una stretta di mano il giorno in cui mi insediai come ministro. Ma non ci siamo parlati”. In quel giorno, al Viminale, è certo, si recarono in tanti. Ma anche in questo caso i ricordi sono stati ad intermittenza. “C’erano molte persone quel giorno che volevano congratularsi con me per la mia nomina. Io non conoscevo fisicamente il dottor Borsellino. Poi ho potuto dire, solo a distanza di tempo, che lo avevo incontrato solo perché il capo della Polizia mi aveva detto che, dovendo andare al Viminale, si poteva approfittare della sua visita per salutare il Ministro dell’Interno. Borsellino era accompagnato da Vittorio Aliquò ma questo l’ho saputo dopo. Chi era presente? Non ricordo. Erano tanti che volevano congratularsi col ministro. C’era una folla notevole, parecchi amici, funzionari, persone che facevano politica, altre persone interessate a conoscere il ministro”. Alla richiesta di riferire qualche nome dei presenti, o a chi diede l’incarico di dirigere la propria segreteria, però, la risposta è stata sempre la stessa: “Non ricordo”. Però l’ex ministro ha ricordato altre cose, come l’esser stato a Palermo tra il 5 ed il 7 luglio per incontrare i Prefetti e gli appartenenti alle Forze di Polizia; l’incontro con il cognato di Falcone, Alfredo Morvillo; e lo scambio di battute con Parisi “sulla necessità di catturare Totò Riina”. Poi il solito mantra per ricordare le proprie attività parlamentari in favore del 41 bis. Durante la deposizione Mancino ha anche raccontato un dettaglio in riferimento ad un incontro avuto con l’ex Sisde Bruno Contrada. Ciò non sarebbe avvenuto il giorno dell’insediamento, ma a dicembre: “Ho incontrato Bruno Contrada solo una volta, per un saluto, alla vigilia di natale del 1992, quando ero ministro dell’Interno. Mi disse ‘Io non sono responsabile delle accuse che mi vengono mosse’ e io gli augurai che potesse venir fuori la verità. Se mi disse che l’autorità giudiziaria lo stava indagando? Non lo ricordo. Dico di no”. Quell’incontro, a detta del teste, fu promosso dal Capo della Polizia Parisi (“Mi disse che Contrada voleva parlarmi”). Certo è che Contrada fu arrestato nel Natale 1992. Sulla propria nomina a ministro degli Interni Mancino ha dichiarato che nessuno parlò con lui, parlamentare e membro della Prima commissione degli affari Costituzionali, della designazione. Quindi ha escluso che qualcuno gli abbia chiesto la disponibilità a ricoprire quel ruolo tanto da averlo appreso “solo nel momento in cui fui incaricato”. Poi ancora ha aggiunto di non aver mai conosciuto l’allora capo della squadra Mobile di Palermo Arnaldo La Barbera e di non essere mai stato coinvolto dall’allora ministro della Giustizia Giovanni Conso in materia di applicazione dei decreti del 41bis. Altri argomenti “caldi” il rapporto con Martelli (“Non sempre ci siamo incontrati nella trascrizione delle versioni… Certo che non ho avuto trattamenti di buona collaborazione da parte di Martelli…”) e la natura delle fonti da cui ricavò le informazioni sul dualismo tra Riina e Provenzano e sulla imminente cattura di Totò Riina, così come disse nel dicembre 1992 come riportato dal Giornale di Sicilia (“L’intento di catturare Riina non è un intento astratto ma è obiettivo concretamente perseguibile. Si deve perseguire con tenacia questo obiettivo, prefetto Parisi, attraverso l’impegno quotidiano delle energie migliori che dispongano ogni mezzo di indagine (…) La mafia sta cambiando. Forse è alla vigilia di una scissione come quella che spaccò la Camorra indebolendola”). Come aveva appreso quelle informazioni? “Io ho sempre sostenuto che bisognasse liberarsi di Riina con l’arresto. Non ricordo. Non sarei stato così imprudente da annunciarla. La spaccatura? Se ne parlava sui giornali. I quotidiani ne parlavano spesso” ha ribadito il teste. Quando fu sentito in Commissione antimafia, l’8 novembre 2010, disse di essere stato consapevole, già nel 1992, di una spaccatura tra l’ala stragista di Cosa nostra di Riina e quella moderata di Provenzano e disse anche che potrebbe averlo saputo dai due maggiori responsabili della Dia del tempo: De Gennaro ed Arlacchi. Tuttavia è noto che il dato, in quel momento, non era noto da quegli organi giudiziari e che l’unica fonte che aveva paventato una possibilità simile era Vito Ciancimino, l’ex sindaco mafioso di Palermo, che fu contattato dal Ros. Ma Mancino di quella vicenda non ha mai riferito nulla.
La testimonianza di Borghini. Altro audito nell’udienza di venerdì, per la prima volta in un processo sulla strage di via d’Amelio, è stato il generale Emilio Borghini, oggi in pensione e al tempo Comandante del gruppo carabinieri Palermo uno. Una testimonianza resasi necessaria dopo che lo stesso era stato individuato in un video da Angelo Garavaglia Fragetta (agenda rossa e collaboratore di Salvatore Borsellino). Nelle immagini di quel 19 luglio 1992 lo si vede lasciare l’auto di servizio in via Autonomia Siciliana per dirigersi a piedi, tra idranti, fumo e macerie, verso la Croma blindata di Paolo Borsellino, saltato in aria con i cinque agenti di scorta poco tempo prima. L’orario del suo arrivo, calcolato misurando l’ombra del sole sul muro del palazzo di via D’Amelio, è quello delle 17.28. Un’ora contestuale a quei frame, registrati pochi minuti dopo, in cui compare l’allora capitano Giovanni Arcangioli mentre si allontana dal luogo dell’esplosione, con la borsa del giudice assassinato in mano, per dirigersi verso via Autonomia Siciliana. Rispondendo alle domande di Repici ha ricordato quanto vissuto il giorno dell’attentato: “Mi trovavo nella mia abitazione, vicino al Teatro Massimo. Sentii l’esplosione molto forte e da quel momento fu un susseguirsi di telefonate. Mi recai in via d’Amelio oltre mezz’ora dopo l’esplosione”. Una volta giunto sul luogo “c’era una devastazione totale. C’era molta confusione, sembrava un evento post bellico. In vent’anni successivi di servizio, mai visto una cosa del genere. C’era sgomento. C’era un’area a sinistra con i muri distrutti, carcasse di auto e molta acqua a terra. Una parte centrale dove c’erano uomini della polizia, carabinieri e guardia di finanza. C’erano molte persone ma non in divisa. Sulla destra persone attonite, vestite anche in maniera elegante e magistrati”. Rispetto alle gerarchie all’interno del reparto operativo e quelle che erano le funzioni di polizia giudiziaria Borghini ha riferito che il responsabile “era il maggiore Marco Minicucci che collaborava con il capitano Arcangioli (colui che compare in immagini e video con in mano la borsa di Borsellino, ndr), quel giorno di turno al nucleo operativo. Ricordo di aver incrociato a piedi Arcangioli. Non ricordo se avesse qualcosa in mano, ma aveva un abbigliamento estivo, poco formale”. Borghini, che in alcune immagini appare vicino al capitano dei carabinieri, ha riferito di non aver parlato con Arcangioli in quel giorno (“Tra me e lui c’erano tre livelli gerarchici, ma se non ricordo male era alle dipendenze di un soggetto che poi andò al Ros, credo che si chiamasse De Donno”). Non solo. Non avrebbe parlato con nessuno del personale operante nel luogo della strage. Una scelta precisa (“E’ opportuno lasciare lavorare le persone nelle loro sfere di competenza”). Così sarebbe rimasto in disparte, con il cellulare in mano, per rispondere alle continue telefonate ricevute. Tra le persone che riconobbe in quel giorno vi era anche Giuseppe Ayala, ex magistrato che del prelievo della valigetta in pelle dall’auto carbonizzata di Borsellino ha fornito diverse ricostruzioni contrastanti. Nel proseguo dell’esame Borghini ha anche ricordato quel che avvenne il giorno dopo l’attentato: “Ci fu una scelta di campo istituzionale. In queste indagini il ruolo principale spettava di diritto alla Polizia di Stato perché colpita nella strage con gli uomini della scorta. Poi la scelta cadde sul Ros e sulla Dia e sostanzialmente il mio Comando, non dico che fu estromesso, ma si dedicò alla gestione ordinaria. E Minicucci mi disse che avevano provveduto ad inviare l’attività di reperimento alla Procura della Repubblica”. Il processo è stato poi rinviato al prossimo 15 gennaio quando sarà sentito l’ultimo teste delle parti civili, Don Franco Neri. Successivamente, a partire dal 22, sarà la volta dei tre poliziotti imputati. Aaron Pettinari 14.12.2020 ANTIMAFIA DUEMILA
26.10.2020 Lo Stato-mafia secondo Riggio: la Cia, i libici, la Dia, passando per il SappeNel processo di Appello su Stato-mafia concluso oggi il controesame da parte di Basilio Milio e Francesco Romito, difensori degli ufficiali Ros Se si dovesse prendere alla lettera la testimonianza del collaboratore di giustizia Pietro Riggio, un ex agente penitenziario che è poi diventato un mafioso di rango, Cosa nostra non è in realtà com’è stata dipinta da Giovanni Falcone. Il controesame a Riggio da parte dell’avvocato Basilio Milio e Francesco Romito, difensori dei Ros nel processo d’Appello Stato-mafia si è concluso oggi. La mafia non solo ha ricoperto un ruolo secondario, ma addirittura è stata presa anche per i fondelli dai poliziotti e servizi segreti perfino internazionali. Il telecomando che ha azionato il tritolo a Capaci non sarebbe stato premuto da Giovanni Brusca. O meglio, quest’ultimo lo ha premuto credendo che l’esplosione sia stata merito suo, mentre invece a premere il pulsante vero sarebbero stati i poliziotti che collaboravano con i servizi. Quindi Brusca, ma addirittura Totò Riina che fino agli ultimi giorni della sua vita (pensiamo alle intercettazioni ambientali al 41 bis) ha miserabilmente osannato le sue gesta relative agli attentati di Capaci e via D’Amelio, sarebbero stati dei poveri ingenui.
Tutto gestito da “zio Toni” Ma non c’entrano solo i carabinieri e servizi italiani. A organizzare la logistica dell’attentato di Capaci sarebbero stati addirittura i servizi segreti libici composti da una donna misteriosa, il suocero dell’ex poliziotto Giovanni Peluso facente parte del complotto e un certo Nasser, un ex pugile egiziano ma che era al servizio di Gheddafi. Attenzione, sempre secondo Pietro Riggio, tutti loro (poliziotti, carabinieri della Dia e servizi libici) sarebbero stati gestiti da un certo “zio Toni”, che di nome fa Antonio Miceli, il quale però era al servizio della Cia. Sono sempre loro, in questo caso specifico la Dia, a chiedere a Riggio di fare una sorta di agente sotto copertura all’interno della mafia. Lo scopo? Reperire notizie per catturare Bernardo Provenzano. Anzi no. Riggio – come si evince dall’interrogatorio del 2018 davanti al procuratore di Caltanissetta Gabriele Paci e a quello di Firenze – percepisce un “doppio gioco” e dice di aver capito che la Dia in realtà lo usava per non catturare Provenzano. Qualcuno gli fece anche capire che era in pericolo. Ma non si capisce bene il perché. Ed è il procuratore Paci a farglielo presente con domande serrate e precise, visto che troppe cose da lui raccontante non sembrerebbero avere un filo logico. Dopo un botta e risposta per capire la logica, a pagina 88 del verbale dell’interrogatorio Paci gli chiede testualmente: «Riggio scusi, lei mi deve spiegare il senso di questa frase perché non ha senso: “tu sei un uomo morto, io t’ho salvato perché non hai capito che i carabinieri vogliono acquisire notizie ognuno dai referenti che hanno per non farlo prendere, per non prenderlo”. Allora io veramente non ne esco fuori, noi non ne usciamo fuori. È come dire: “tu stai facendo una cosa inoffensiva, che Provenzano lo sa perché sa che si parla con i carabinieri, gli va bene che li date le notizie. Queste notizie questi non le utilizzano perché non lo vogliono prendere, però io ti ho salvato in vita”. Non fila».
Un’incredibile memoria fotografica La narrazione prosegue, ma – almeno da quello che si evince dal verbale – si fa sempre più fatica a comprenderla. Riggio parla di tutto, dice anche di aver incontrato il poliziotto “faccia di mostro”, ovvero quello che poi lo ha riconosciuto come tale dopo aver visto le foto sui giornali. Si ricorda che lui (si faceva chiamare Filippo) era su una Bmw, accompagnato da una misteriosa donna con la mimetica. Riggio si ricorda il numero di targa a distanza di decenni. Il pm Paci gli chiede come fa a ricordarselo senza aver segnato il numero su un foglietto, e lui risponde che ha una memoria fotografica. Sempre Paci gli fa notare che tante cose che dice (apprese dal poliziotto Peluso, il presunto 007 conosciuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere) sono notizie già uscite fuori, compresa la storia della famosa telefonata dell’onorevole Rudy Maira fatta alla mafia per avvisare che Falcone sarebbe atterrato a Capaci. Da sottolineare che ci fu un processo e fu assolto, quindi innocente. Una storia, quindi, non vera. Riggio però risponde di non aver appreso della telefonata sui giornali, ma solo da Peluso. Quest’ultimo, ricordiamo, sempre secondo il pentito sarebbe il poliziotto al servizio del Sismi che avrebbe non solo azionato il telecomando per l’attentato di Capaci, ma anche organizzato un attentato – fortunatamente mai arrivato a compimento – negli anni 2000 contro il giudice Guarnotta. Il pentito ha parlato pure del caso di Antonello Montante, anche questa notizia già conosciuta.
Riina, Brusca e co.? Degli ingenui… L’ex poliziotto penitenziario poi passato alla mafia, sembra che conosca tanti segreti. Una narrazione che però – se presa alla lettera – potrebbe far percepire che la mafia sia stata quasi ingenua, come se alla fine fosse tutto organizzato dalle altre “entità”. Riggio lo hanno voluto sentire come testimone durante il processo Capaci bis proprio gli avvocati degli imputati mafiosi. E hanno tutte le ragioni per averlo fatto: se la mafia ha ricoperto un ruolo secondario, o addirittura nemmeno ha azionato il telecomando che ha creato la terribile esplosione, la loro posizione si sarebbe dovuta affievolire. Ma fortunatamente non è stato così e il 21 luglio scorso sono stati confermati gli ergastoli per tutti e quattro i boss. Vale la pena riportare un altro racconto, questa volta delle carceri, quando Riggio faceva l’agente di custodia. Dice di aver fatto parte del Sappe, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria di cui il segretario era (ed è tuttora) Donato Capece. Il pentito, sempre nel verbale del 2018, per spiegare i presunti favori che Forza Italia avrebbe fatto alla mafia, aggiunge questo dettaglio: «La segreteria si trova, per capirci, sopra il bar Mandara a Roma, vicino piazzale Clodio, perché qui ho avuto modo di verificare dove la politica si incontrava con le richieste della mafia perché Capece in contatto con dei personaggi politici che allora facevano parte, diciamo dell’entourage di Forza Italia, cominciò a battersi per la chiusura delle carceri di Pianosa e dell’Asinara». Ora il Sappe, a parere di chi scrive, ha tanti difetti proprio perché cavalca il populismo penale. Che abbia addirittura indirettamente favorito la mafia non è lontanamente immaginabile. Un po’ tutti i sindacati, per tutelare la qualità di vita lavorativa dei loro iscritti, hanno chiesto la chiusura di questi famigerati penitenziari. Carceri delle torture fortunatamente chiuse nel 1998 tramite decreto, ma non per merito di Forza Italia che nemmeno era al governo. Così come il discorso del non rinnovo automatico del 41 bis per circa 300 soggetti, di cui solo una minima parte erano mafiosi. Lo fece Giovanni Conso, ministro della Giustizia del governo di centrosinistra e per rispettare il dettame della Consulta. All’epoca, anno 1993, Forza Italia ancora non era nata. Anche la tesi della trattativa, d’altronde, non la inserisce in quel contesto. Tanta, troppa confusione sotto il cielo. Ma ci penseranno i giudici a valutare la sua attendibilità. Pietro Riggio, ricordiamo, è sentito come testimone al processo d’appello sulla trattativa Stato mafia. In quell’occasione ha aggiunto qualcosa in più: sarebbe stato Marcello Dell’Utri a dettare alla mafia i luoghi dove compiere gli attentati. Un Totò Riina ridotto a fare lo scendiletto dei politici e servizi? Se così fosse, allora è tutta da rifare l’analisi sulla natura della mafia, a partire da ciò che si evince dal libro “Cose di Cosa Nostra” scritto a quattro mani da Marcelle Padovani e Falcone. In realtà quest’ultimo l’aveva capita molto bene la mafia e i suoi interessi affaristico-politici, per questo era stato trucidato con una quantità impressionante di tritolo tanto da squarciare l’autostrada. Stessa sorte, 57 giorni dopo, a Paolo Borsellino. Nel frattempo oggi si è concluso il controesame a Riggio da parte dell’avvocato Basilio Milio e Francesco Romito, difensori dei Ros nel processo d’Appello Stato-mafia. Damiano Aliprandi. IL DUBBIO
26.10.2020 – Le morti di Gioé e Ilardo nelle dichiarazioni di RiggioAlla scorsa udienza lo aveva anticipato (“Ancora ho detto poco perché Caltanissetta non è riuscita ad approfondirmi su altre cose che voi state trattando: sul telefono di Riina, sull’omicidio di Gioé e tante altre cose che ancora non ho potuto parlare”), oggi Pietro Riggio, il pentito nisseno che dal 2018 ha avviato una nuova fase della propria collaborazione con la giustizia raccontando una serie di circostanze sulla strage di Capaci, è tornato sul punto nel processo Stato-Mafia con rivelazioni roboanti. Rispondendo alle domande dei sostituti Pg, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera, ha approfondito quel suo accenno alle morti del pentito di Altofonte, Antonino Gioé (ritrovato morto, la notte tra il 28 e il 29 luglio del 1993, impiccato con i lacci delle scarpe nella cella in cui trascorreva la detenzione nel carcere di Rebibbia) – e La morte di Luigi Ilardo, omicidio di Stato E’ nei primi anni duemila che Pietro Riggio entrerà ufficialmente in Cosa nostra ed è in quel contesto che prende contatto con Angelo Ilardo, cugino del confidente-infiltrato morto nel maggio 1996. E’ con lui che parlò della morte del capomafia nisseno. “Lui mi disse espressamente che il cugino era morto perché voleva parlare di tutti quelli che erano stati gli intrecci che si erano succeduti tra il 1992 ed il 1995. Di tutte le cose più importanti che erano accadute, tra cui la strage di Falcone, di via d’Amelio, della massoneria, della nascita di Forza Italia, di Dell’Utri, di quelle cose che erano accadute in quel frangente temporale. E soprattutto mi disse che nessuno sapeva che era andato a Roma per iniziare ufficialmente quella che era la collaborazione. E pochissime persone sapevano di quella scelta: il procuratore Tinebra, il procuratore di Palermo di allora, la dottoressa Principato, e lo sapeva anche Riccio ed il colonnello Mori che si trovava lì quel giorno. Lui (Angelo Ilardo, ndr) è stato chiarissimo, è stato freddo. Se lo sono venduti lo Stato, ma non potendolo fare loro l’omicidio lo hanno fatto fare tramite appartenenti a Cosa nostra. Nel 2001 non si sapeva chi aveva ucciso Ilardo. Questo mi disse in sintesi”. Secondo Riggio, Angelo Ilardo avrebbe ospitato a Caltanissetta il cugino, raccogliendone le confidenze (“Mi raccontava che lo ospitava e che non lo vedeva sereno”). Sull’argomento è tornato con maggior precisione anche durante il controesame dell’avvocato Basilio Milio (difesa Mori) “Della morte di Luigi Ilardoparlai con il cugino, Angelo, con Carmelo Barbieri ed il boss catanese Alfio Mirabile. Seppi che l’ordine di uccidere Ilardo partì da una fonte istituzionale del tribunale di Caltanissetta che la diede ai carabinieri del Ros di Caltanissetta e che a sua volta la fecero sapere in giro. Ci fu un’azione ben precisa da parte del colonnello Mori che incaricò un suo uomo, un capitano che era in servizio in una caserma dei carabinieri di Catania e che era direttamente collegato a boss Zuccaro, della famiglia Santapaola, che da sempre era stato confidente dei carabinieri. Venne passata la notizia a lui affinché si facesse l’omicidio che non poteva essere più ritardato in nessuna maniera. Questo io lo apprendo da fonte mafiosa diretta: Alfio Mirabile. Quando venne dato l’ordine? Tra il gennaio e il maggio 1996″.
Gioé e la lettera scomparsa Rispondendo ad una domanda specifica del sostituto Pg Barbiera, Riggio ha poi ribadito di aver saputo che la morte di Nino Gioé non è ascrivibile alla voce “suicidi”. In quel tragico anno del 1993 Riggio si sarebbe trovato molte volte a Roma in quanto membro della Commissione paritetica per i trasferimenti presso il ministero della Giustizia. Ed è in quella veste che sarebbe venuto a conoscenza di una serie di azioni effettuate all’interno delle carceri. “C’era un modus operandi a dir poco barbaro – ha detto intervenendo in video conferenza – i detenuti venivano picchiati sistematicamente con metodi quasi nazisti. Io lo so che la polizia penitenziaria aveva delle direttive ben precise e so che lo Stato copriva in quel momento la polizia penitenziaria qualsiasi cosa fosse accaduta. A Roma ho avuto modo da raccogliere le lamentele dei colleghi di Rebibbia e di quelli che avevano avuto a che fare con questo. Una sera parlando con un mio collega, Gianfranco Di Modugno, un pari corso mio, parlai anche della morte di Gioé. Tutti sapevano che non si era suicidato. Mi racconta Di Modugno che Gioé, il giorno in cui decise di voler collaborare, aveva fatto una lettera. Non la lettera che fu ritrovata, ma un’altra ben precisa in cui accusava e faceva dei nomi; dove parlava di stragi e dei contatti con servizi segreti con cui lui aveva avuto a che fare”. Alla richiesta di approfondimento da parte del Presidente Pellino sulla lettera scomparsa di Gioé ha poi aggiunto: “Da quel che mi fu riferito la seconda era falsa o comunque meno importante della prima. Era comunque scritta da Gioé”. Riggio ha spiegato che in quell’occasione sarebbe stato chiamato il colonnello Ragosa: “Lui era quello che se c’era un problema veniva investito. Lui andava e con le sue metodologie, buone o cattive, doveva risolvere un problema. E così avvenne con Gioé”. Nello specifico il pentito nisseno ha riferito l’esistenza di una vera e propria squadra di agenti “persone fidate, in mimetica, che arrivano all’interno delle sezioni, si prendono le chiavi e mandano tutti fuori. I miei ex colleghi devono avere il coraggio di dire che sono stati mandati via e sono entrate altre persone e si sono appropriate della sezione. Devono avere la dignità di parlare, perché è il momento di poter parlare. Loro sono stati esautorati e nessuno sa cosa è successo là dentro”. Rivolgendosi alla Corte ha anche raccontato l’esistenza del cosiddetto metodo ‘della scala’. “In poche parole – ha spiegato – per far parlare un detenuto o minacciarlo, loro mettevano una corda al collo del detenuto e tiravano dal basso verso l’alto e non il contrario, come si può pensare quando il detenuto si impicca e va dall’alto verso il basso. E per non legargli le mani e lasciargli dei segni, usavano dare dei pugni nel costato in modo che il detenuto, o chi si trovava in quei frangenti, non poteva tenersi per divincolarsi nella corda, perché tendeva a pararsi nel costato mentre loro tiravano con la corda. Un metodo che usavano sin dal 1980, come mi fu riferito dall’ispettore Lo Brutto Antonio, nel carcere militare. Questi erano i metodi da Gestapo usati in quel periodo”.
Il cellulare di Riina Altro argomento approfondito ha riguardato anche il mancato trasferimento di Totò Riina dal carcere di Roma a quello di Firenze-Sollicciano e la presunta dotazione di un cellulare da parte del Capo dei capi. “Io mi trovavo in servizio a Firenze-Sollicciano e facevo parte dell’ufficio Comando – ha detto ancora – ed ero uomo di fiducia del direttore Paolo Quattrone che mi mandò a verificare lo stato del reparto M, per controllare se tutto era a posto, spiegandomi che avrebbero dovuto mandarci qualche detenuto importante. Qualche giorno dopo mi disse che volevano portare Totò Riina“. Il teste ha dunque spiegato che Quattrone non voleva avere problemi, per cui preparò una relazione riservata in cui si diceva che sotto il profilo sanitario non era in grado di gestire il detenuto. Anni dopo, in occasione di una cena, avrebbero ripreso il discorso e che in quella occasione “lui mi raccontò che a Rebibbia avevano scoperto che Riina aveva in uso un telefono cellulare”. Altro aspetto singolare riferito dal teste è lo scambio di parole che ebbe con Elio Ciolini(il depistatore noto per i suoi legami con l’estrema destra e servizi segreti, nonché per aver tentato di inquinare le indagini sulla strage alla stazione di Bologna del 1980) che nel marzo 1992 previde l’inizio “nuova strategia della tensione”che si sarebbe realizzata da lì a poco. “Ebbi modo di prelevare Ciolini, che era detenuto nella ottava sezione, la sezione protetta, e accompagnarlo all’interrogatorio con la Procura di Bologna. Ed ho avuto modo di scambiare delle parole con lui. Era frastornato al ritorno e mi raccontò di aver parlato con la Procura di Bologna e che aveva detto che da lì a poco sarebbero morti due giudici. Disse ‘Questi qua né mi ascoltano e né mi sentono. Vedremo come andrà a finire. Queste sono notizie devastanti, specie quando vedo quel che accadde a maggio e luglio”. Rispondendo ad una domanda del Presidente Pellino ha poi aggiunto che, pur non avendo mai sentito parlare del “Protocollo farfalla” era a conoscenza che “dentro le carceri entravano sempre persone particolari, senza avvisare l’autorità giudiziaria” e che di queste cose “non si lasciava traccia”.
Di Maggio, Curioni e Fabbri davanti alla casa di Scalfaro La scorsa volta Riggio ha raccontato dell’invito ricevuto da Francesco Di Maggio, ex vice capo del Dap, di occuparsi con il sindacato delle rimostranze degli agenti della polizia penitenziaria in servizio a Pianosa e l’Asinara per giungere ad una chiusura di quelle carceri. Oggi il collaboratore ha riferito un altro episodio: “Un giorno, davanti all’abitazione del Presidente Oscar Luigi Scalfaro, ho visto Di Maggio, monsignor Fabbri e Curioni. Di questi ultimi due ero venuto a conoscenza dei problemi che avevano avuto con il vecchio capo del Dap, in quanto furono sfrattati da dove vivevano, in via Giulia”.
Il mancato blitz a Mezzojuso Nel corso dell’esame il teste ha ribadito di aver appreso dai due marescialli Vincenzo Parrella e Pino Del Vecchio, conosciuti nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, alcuni particolari rispetto al mancato blitz per la cattura di Provenzano nelle campagne di Mezzojuso. Del Vecchio gli avrebbe riferito come loro fossero “pronti a catturarlo”, ma che in quella mattina del 31 ottobre 1995, “mancavano le minime direttive”. Unica cosa che fu permessa furono dei rilievi fotografici che “furono fatti, ma senza poi spingerci oltre”. “Lui – ha ricordato il teste – era rammaricato perché, diceva, ‘quel lavoro fatto era divenuto un boomerang’ in quanto non solo non avevano catturato Provenzano, ma nel tempo, nel momento in cui fecero delle rimostranze, subirono procedimenti per calunnia presso il tribunale di Torino. Se non erro loro avevano fatto il nome dell’allora responsabile del Ros in Sicilia, il colonnello Mori, che aveva vietato in tutte le sue forme che Bernardo Provenzano venisse catturato, e autorizzato solo un rilievo fotografico (va ricordato che Mori, nel processo per il mancato blitz, è stato assolto in via definitiva perché “il fatto non costituisce reato”, ndr)”. I due marescialli, che nelle loro propalazioni avevano rivolto delle critiche anche nei confronti del loro superiore diretto, Michele Riccio (certamente va ricordato come lo stesso colonnello dei carabinieri sia stato uno dei primi, con coraggio e non senza conseguenze, a denunciare proprio lo scandalo del mancato blitz) gli riferirono anche che altri colleghi si erano rifugiati in Sud America per non avere problemi. Tra le domande dell’avvocato Milio anche una sulla nostra testata, citata da Riggio nella scorsa udienza: “Lei ha riferito che dopo il racconto di Del Vecchio ha letto ANTIMAFIADuemila ed ha visto le foto che vennero scattate in quel giorno a Mezzojuso. ANTIMAFIADuemila in questo articolo confermava il racconto che Del Vecchio aveva fatto a lei?”. “Avvocato io ho detto che non ero sicuro se era ANTIMAFIADuemila o un altro giornale. Ho detto ‘può essere che era ANTIMAFIADuemila’. Ho detto che in una di queste foto, se non erro, si riconosceva Ferro all’impiedi fuori dalla macchina, accostato allo sportello, lui mi indicò che conosceva bene questa foto”. Di fronte alla grande rilevanza delle dichiarazioni di Riggio, ovviamente, un peso importante lo avranno gli eventuali riscontri che potranno essere, o non essere, trovati. Ed è in questa direzione che l’audizione del 23 novembre, quando sarà sentita la dirigente della Squadra mobile nissena Marzia Giustolisi, che ha compiuto gli accertamenti sulle dichiarazioni. Prima però, il prossimo 9 novembre, saranno sentiti da remoto il prefetto Rossi e l’ex direttrice degli affari Penali, Liliana Ferraro. Aaron Pettinari 26 Ottobre 2020 ANTIMAFIA Duemila
- La SENTENZA di primo grado per capitoli
- La Lunga trattativa STATO – MAFIA nel tempo
- Gli incontri con Don Vito
Deposizione generale Mario Mori – VIDEO
- ‘Ndrangheta stragista, il pentito Nucera: ”Nel ’93 il Sisde voleva far evadere Riina”
- Mafia, massoneria e servizi. Virgiglio racconta il ”Potere” al processo ‘Ndrangheta stragista
- ‘Ndrangheta stragista, l’ispettore Provenzano e quel piano di morte per ucciderlo
- ‘Ndrangheta stragista, l’ispettore Zannino e i riscontri dei pentitDOSSIER a cura di Attilio Bolzoni
- Salvatore Borsellino: “mio fratello fu ucciso per la Trattativa”
- Articoli
- Documentazione di Antimafia Duemila
- Trattativa Stato mafia speciale Cosa Vostra – video
- FILM DOCUMENTARIO di Sabina Guzzanti
«Stato-mafia: al processo d’appello sarà sentito Pietro Riggio»L’ex agente di poliza penitenziaria Pietro Riggio. che di recente ha rilasciato una serie di dichiarazioni alle Procure di Caltanissetta e Firenze sulle stragi e le sue conoscenze con esponenti deviati dei servizi di sicurezza, sarà sentito nel processo d’appello sulla trattativa Stato-mafia. Lo ha deciso la Corte d’assise d’appello, presieduta da Angeli Pellino, che nella giornata di ieri si è espressa sulle nuove richieste istruttorie e di acquisizione di documenti presentate dalla Procura generale e dalle difese. Così come chiesto alla scorsa udienza dai sostituti Procuratori generali, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera, il pentito sarà sentito “nello specifico in riferimento alla cattura di Bernardo Provenzano e su quel che gli sarebbe stato riferito da un tale Peluso, ovvero ‘che i carabinieri non sono di fatto interessati alla cattura di Provenzano’”, ma anche sui fatti inerenti le stragi. Sentito in precedenti processi Riggio aveva raccontato che durante la sua detenzione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove si trovava assieme ad altri appartenenti di varie forze di polizia che avevano pendenze varie, venne coinvolto, in una prospettiva di successiva scarcerazione, per una attività parallela a quella delle forze di polizia ufficiali: un’attività di cattura latitanti. “Lui – aveva ricordato Fici – dice che tramite le sue conoscenze in ambito mafioso nisseno avrebbe potuto fornire informazioni per la cattura di Bernardo Provenzano. Una volta uscito avrebbe iniziato ad operare a riguardo. Questi soggetti reclutati tra appartenenti di forze di polizia iniziano a collaborare per la cattura. E Riggio dà notizie che portano effettivamente ad individuare un funzionario della cancelleria di Caltanissetta. E questa squadra diventa operativa. In questo contesto succedono, dice Riggio, circostanze diverse e più significative. Dice lui che lo avrebbero voluto coinvolgere in un progetto omicidiario nei confronti del giudice Guarnotta e sostiene di aver saputo da un appartenente di questo gruppo che questi era stato coinvolto nella strage di Capaci”. La Corte d’assise ha anche accolto la richiesta di audizione del funzionario di polizia Giustolisi, che ha collaborato ai riscontri del narrato del collaborante. Entrambi saranno sentiti il prossimo 19 ottobre. All’udienza successiva, invece, saranno sentiti l’ex prefetto Luigi Rossi, la dottoressa Liliana Ferraro e Cinzia Calandrino, al tempo coordinatrice dei servizi presso la segreteria generale del Dap e responsabile della sezione quarta. Saranno ascoltati a completamento del segmento di isturttoria inerente la vicenda del mancato trasferimento di Riina e dell’appunto del Sisde in cui si riferiva del possibile utilizzo di un cellulare da parte del Capo dei Capi quando questi era detenuto nel carcere Rebibbia di Roma. La Corte d’assise ha inoltre accolto la richiesta di acquisizione della sentenza di revisione con cui il 15 marzo del 2017 la Corte d’Appello di Perugia ha assolto Domenico Papalia per l’omicidio di Antonio D’Agostino. “La richiesta – ha letto Pellino – è accolta a completamento della documentazione già acuqisita sul tema relativo alla presunta prassi di accordi collusivi di settori deviati dei servizi di intelligence, o degli apparati di sicurezza, con esponenti di spicco di associazioni mafiose. Nello specifico per il ruolo, in tale contesto, di Domenico Papalia, personaggio menzionato nella lettera testamento Antonino Gioé proprio in riferimento all’omicidio D’Agostino”. Acquisiti anche i documenti sugli approfondimenti effettuati rispetto le dichiarazioni del pentito Armando Palmeri ed il verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore Francesco Di Carlo, recentemente deceduto. Tra i documenti acquisiti anche le audizioni dei magistrati sentiti davanti al Csm dopo la strage di via d’Amelio “per ricostruire i contrasti all’interno della Procura di Palermo e le divergenze di valutazione su mafia-appalti e le scelte investigative effettuate su quel versante giudiziario”. Sul fronte delle nuove prove acquisite vi è anche l’intercettazione telefonica captata il 20 luglio 2018 in cui l’avvocato Giancarlo Pittelli, ex senatore di Forza Italia arrestato nell’ambito dell’inchiesta Rinascita-Scott, commentava un articolo de Il Fatto Quotidiano in cui si parlava della sentenza trattativa Stato-mafia. Per la Corte è una “prova sopravvenuta” e nell’ottica accusatoria “potrebbe assumere rilevanza sull’imputato Dell’Utri nel punto relativo contestato in atto d’appello sul perfezionamento del reato di minaccia a corpo politico dello Stato in pregiudizio del governo presieduto da Silvio Berlusconi”. Nel’ordinanza sono state rigettate le acquisizioni inerenti gli approfondimenti della Procura generale sulla cosiddetta “vicenda Bianchi” tenuto conto che le “indicazioni in ordine a presunte o accertate collusioni di Marcello Dell’Utri con l’organizzazione mafiosa e Cosa nostra sono senza alcuna specifica connessione per i fatti per cui qui si procede a carico del medesimo imputato” e che lo stesso Alberto Maria Salvatore Bianchi, sentito dalla Procura generale, si avvalse della facoltà di non rispondere, dimostrando di “non avere volontà collaborativa”. Tra gli altri documenti acquisiti vi sono poi i verbali a sommarie informazioni di Vardaro, De Pascalis e Piercamillo Davigo. 6.10.2020 ANTIMAFIA 2000 di Aaron Pettinari
LE STRAGI MAFIOSE DEL 1993 E LA TRATTATIVA PER L’ALLEGGERIMENTO DEL 41-BISLa cattura del capo dei capi Totò Riina aprì ufficialmente la lotta alla successione al vertice della Commissione di Cosa Nostra. A contendersi il posto di comando dell’organizzazione criminale furono due corleonesi: Bernardo Provenzano, compagno di delitti di Riina fin dagli albori, e Leoluca Bagarella, fratello di Ninetta, la moglie del capo dei capi. A spuntarla fu proprio Bernardo Provenzano, il quale, diventato capo di Cosa Nostra, promise che prima di consultarsi con gli altri boss della Cupola si sarebbe interfacciato in via preliminare con Leoluca Bagarella. Come abbiamo raccontato, il primo era a capo di quella schiera di mafiosi che preferivano trattare con lo Stato italiano piuttosto che perseguire sulla via della strategia stragista; il secondo, invece, militava nell’ala più violenta della Cupola, che aveva sempre fatto riferimento a Totò Riina, propensa all’attacco frontale a uno Stato che, come provato dall’attivazione dei Carabinieri del Ros all’indomani della morte di Giovanni Falcone (atto che sancì l’inizio della “trattativa”), aveva già dato agli uomini d’onore l’impressione di essersi piegato di fronte al loro peso specifico.
Le due fazioni arrivarono ad un compromesso: la mafia avrebbe continuato a far esplodere le bombe, ma solo fuori dalla Sicilia. Infatti: Il 14 Marzo del 1993 i mafiosi fecero esplodere un’autobomba a Roma, in via Fauro, con l’obiettivo di uccidere Maurizio Costanzo, il quale stava uscendo dagli studi del Maurizio Costanzo Show. Il conduttore rimase illeso, poiché il mafioso Salvatore Benigno, aspettando Costanzo su un’automobile diversa da quella su cui viaggiava, azionò il telecomando con qualche istante di ritardo. Furono ferite ventiquattro persone. Il 26 Maggio del 1993 la mafia decise di colpire in via dei Georgofili, a Firenze, nei pressi della Galleria degli Uffizi. A cadere, questa volta, furono cinque persone: i coniugi Fabrizio Nencioni (39 anni) e Angela Fiume (36 anni), le loro figlie Nadia Nencioni (9 anni) e Caterina Nencioni (50 giorni di vita) e lo studente Dario Capolicchio (22 anni). Circa quaranta persone rimasero ferite per l’esplosione dell’autobomba. La sera del 27 Luglio del 1993 un’autobomba esplose in via Palestro (in foto), a Milano, presso la Galleria d’arte moderna e il Padiglione di arte contemporanea, uccidendo cinque persone: i Vigili del Fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l’Agente di Polizia Municipale Alessandro Ferrari e Moussafir Driss (immigrato del Marocco che stava dormendo su una panchina). Dodici i feriti. Poco dopo, nella notte tra il 27 e il 28 Luglio, vennero fatte esplodere due autobombe a Roma, precisamente davanti alle chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni Laterano. Ventidue persone rimasero ferite.
Il 4 Giugno del 1993,all’indomani delle bombe in Via Fauro e agli Uffizi, il Consiglio dei Ministri presieduto da Carlo Azeglio Ciampi e di cui, come Ministro della Giustizia, faceva parte Giovanni Conso, destituì Nicolò Amato (sostenitore della linea dura sul 41 bis) dalla carica di capo dell’Amministrazione penitenziaria. Al suo posto venne nominato il più “morbido” Adalberto Capriotti. Quale fu l’antefatto di questa delibera? Una lettera pervenuta nel Febbraio 1993 al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro da parte di Cosa Nostra, firmata da “un gruppo di familiari di detenuti”, che così recitava: “Siamo un gruppo di familiari di detenuti che, sdegnati e amareggiati da tante disavventure, ci rivolgiamo a Lei perché riteniamo che sia responsabile in prima persona, quale rappresentante e garante delle più elementari forme di civiltà. […] Non chiediamo indulgenze particolari o grazie ma soltanto il rispetto di dignità di persone che, nella disgrazia, stanno pagando, senza battere ciglio, i loro debiti giusti o ingiusti che siano. Per noi significa dare la possibilità ai detenuti tutti di sopportare la restrizione in maniera dignitosa, cioè avere la possibilità di incontrarsi con i familiari senza spendere un patrimonio, la possibilità di poter portare, almeno settimanalmente, la biancheria oltre al vitto ai detenuti; togliere gli squadristi al servizio del DITTATORE AMATO, dando dignità di detenuti ai detenuti. […] Al momento non crediamo che la volontà dello Stato che Lei rappresenta sia così civile nel dare una risposta adeguata. La sfidiamo a smentirci”. Insomma Cosa Nostra, per mezzo di questa missiva, si rivolse esplicitamente alla massima carica dello Stato per esigere la testa del capo dell’Amministrazione penitenziaria, i cui metodi erano per essa sconvenienti.
Nel 2003 don Fabio Fabbri, segretario particolare di Oscar Luigi Scalfaro, rivelerà ai magistrati che l’allora Presidente della Repubblica chiamò al Quirinale don Cesare Curioni, Cappellano delle carceri, dicendogli le seguenti parole: «Caro Monsignore, ho parlato ieri per telefono con il ministro Conso. La prego di dargli tutto il suo aiuto per individuare il nuovo direttore generale (dell’Amministrazione penitenziaria, ndr)». Insomma, occorreva destituire nel più breve tempo possibile Nicolò Amato. Il quale, nel suo libro “Gli amici senza volto di Corleone”, dice (senza peli sulla lingua) la sua in merito a questa vicenda: «Il 4 Giugno del 1993, il Consiglio dei Ministri, con la presenza (!), almeno formale, di Giovanni Conso, accontentò Scalfaro e mi mandò via. Era pure, ovviamente, indispensabile mettere al posto di un “dittatore” come me, persone accomodanti e sensibili all’accorato grido d’aiuto che la mafia aveva rivolto al Presidente Scalfaro, giustamente confidando nella sua carità cristiana. E la sostituzione fu perfetta. Non si sarebbero potuti accontentare di più e meglio i poveri, affranti familiari dei detenuti che avevano scritto la lettera del 17 Febbraio 1993. Così è un fatto che, in mia sostituzione, furono nominati Adalberto Capriotti, un anziano magistrato, quale formale direttore del DAP e già gratificato per questo, e Francesco Di Maggio, quale vice direttore, ma non scelto dal direttore generale, bensì a lui imposto d’autorità, nonostante, essendo solo magistrato di tribunale, non ne avesse il titolo – sicché fu necessario nominarlo, con una bizzarra prepotenza istituzionale, dirigente generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -, e messo lì perché amico del Capo della Polizia e assai vicino agli onnipresenti e onnipotenti Servizi segreti, con l’incarico di dirigere di fatto il DAP». Nel 1993, inoltre, verranno sostituiti i ministri firmatari del cosiddetto “Decreto Falcone”, ovvero Claudio Martelli (Ministro della Giustizia) e Vincenzo Scotti (Ministro della Difesa), rimpiazzati rispettivamente da Giovanni Conso e Nicola Mancino. Lo stesso anno, proprio Giovanni Conso scelse di non rinnovare il 41-bis a 334 mafiosi sottoposti al carcere duro, restituendoli al carcere ordinario. Interrogato sulle motivazioni di questa scelta, Conso sosterrà davanti alla Commissione antimafia di averlo fatto per «frenare la minaccia di altre stragi” ANTIMAFIA DUEMILA 5.10.2020 STEFANO BAUDINO
L’INVITO AL DIALOGO CHE I CARABINIERI FECERO ARRIVARE AL BOSS TOTÒ RIINA DOPO LA STRAGE DI CAPACI INDUSSE COSA NOSTRA E IL SUO CAPO DELL’EPOCA, TOTÒ RIINA, AD ACCELERARE I TEMPI DELL’ELIMINAZIONE DI PAOLO BORSELLINO. LO SOSTENGONO I GIUDICI DELLA CORTE D’ASSISE DI PALERMO che nel dicembre 2018 hanno depositato le motivazioni della sentenza sulla cosiddetta “trattativa Stato-mafia”. “Ove non si volesse prevenire alla conclusione dell’accusa che Riina abbia deciso di uccidere Borsellino temendo la sua opposizione alla `trattativa´ conclusione che peraltro trova una qualche convergenza nel fatto che secondo quanto riferito dalla moglie, Agnese Piraino Leto, Borsellino, poco prima di morire, le aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle istituzioni e mafiosi, in ogni caso non c’è dubbio che quell’invito al dialogo pervenuto dai carabinieri attraverso Vito Cianciminocostituisca un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino, con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato e di lucrare, quindi, nel tempo dopo quell’ulteriore manifestazione di incontenibile violenza concretizzatasi nella strage di via d’Amelio, maggiori vantaggi rispetto a quelli che sul momento avrebbero potuto determinarsi in senso negativo”. La corte ha poi negato che Borsellino sia stato ucciso per l’accelerazione dei tempi dell’indagine mafia-appalti che il magistrato stava effettuando e anche alla possibilità di una sua nomina a Procuratore Nazionale Antimafia. E ha spiegato che il ruolo di Marcello Dell’Utri sarebbe stato decisivo: “Con l’apertura alle esigenze dell’associazione mafiosa Cosa nostra, manifestata da Dell’Utri nella sua funzione di intermediario dell’imprenditore Silvio Berlusconi nel frattempo sceso in campo in vista delle politiche del 1994, si rafforza il proposito criminoso dei vertici mafiosi di proseguire con la strategia ricattatoria iniziata da Riina nel 1992″. E ancora: “Se pure non vi è prova diretta dell’inoltro della minaccia mafiosa daDell’Utri a Berlusconi, perché solo loro sanno i contenuti dei loro colloqui, ci sono ragioni logico-fattuali che inducono a non dubitare che Dell’Utri abbia riferito a Berlusconi quanto di volta in volta emergeva dai suoi rapporti con l’associazione mafiosa Cosa nostra mediati da Vittorio Mangano“.
Strage Borsellino, c’è un nuovo indagato: il dottore Cinà. Era il medico di Totò Riina, l’uomo del “papello” Il gip rigetta la richiesta di archiviazione dei pm nisseni. Il professionista palermitano è stato già condannato al processo Trattativa Stato-mafia Non si ferma l’inchiesta della procura di Caltanissetta per provare a dare un nome ai mandanti delle bombe del 1992. I magistrati hanno messo sotto inchiesta per la strage Borsellino il dottore Antonino Cinà, il medico di Totò Riina, l’uomo che avrebbe preso in consegna il “papello” scritto dal capo dei capi, con le sue condizioni per fermare la stagione delle stragi. “Papello” poi consegnato all’ex sindaco mafioso di Palermo, Vito Ciancimino, che nell’estate 1992 intratteneva un dialogo segreto con alcuni carabinieri del Ros. Cinà è stato già condannato a 12 anni nel processo “Trattativa Stato-mafia”, la stessa condanna hanno avuto gli ex ufficiali Mario Mori e Antonio Subranni, protagonisti con l’allora capitano Giuseppe De Donno (ha avuto 8 anni) degli incontri con Ciancimino. Del nuovo filone d’indagine sulle stragi, riguardante Antonino Cinà ,si apprende solo adesso, perché il gip di Caltanissetta Valentina Balboha rigettato la richiesta di archiviazione presentata dal pool nisseno coordinato dal procuratore Amedeo Bertone e dall’aggiunto Gabriele Paci. Il giudice delle indagini preliminari ha fissato un’udienza per discutere del caso, si terrà il 28 ottobre, al palazzo di giustizia di Caltanissetta. Il magistrato potrebbe disporre nuovi approfondimenti. Dice l’avvocato Fabio Repici, parte civile nei processi delle stragi al fianco di Salvatore Borsellino, il fratello del giudice Paolo: “Con il rigetto della richiesta di archiviazione formulata dalla procura di Caltanissetta, si prospetta la preziosa opportunità di un ulteriore importante approfondimento nella ricostruzione dei tempi e delle ragioni della strage di via D’Amelio e dell’accelerazione nella sua esecuzione. Sulla posizione di Cinà, infatti, possono trovare un formidabile punto di saldatura gli scenari illustrati dalla corte di assise di Caltanissetta nella sentenza del processo Borsellino quater e dalla corte di assise di Palermo nella sentenza sulla trattativa Stato-mafia”. I giudici del processo Trattativa hanno ipotizzato che Borsellino sia stato ucciso perché aveva scoperto il dialogo segreto fra un pezzo dello Stato e i vertici di Cosa nostra. Cinà, di certo, conosce il segreto della Trattativa. Ma è sempre rimasto un irriducibile, da anni ormai è detenuto al carcere duro, con una condanna all’ergastolo, in quanto ritenuto mandante dell’omicidio di un giovane capomafia palermitano non rispettoso delle regole dell’organizzazione. di SALVO PALAZZOLO La Repubblica
3.10.2019 PROCESSO STATO-MAFIA, DI PIETRO: “FALCONE MI DISSE, CONTROLLA GLI APPALTI IN SICILIA”L’ex pm di Man Pulite rievoca l’inizio dell’indagine su Tangentopoli. Borsellino mi confidò: “Bisogna fare presto”. Un pezzo della tangente Enimont arrivata in Sicilia, a Salvo Lima Precisa: “Con i dottori Falcone e Borsellino ho avuto rapporti di lavoro all’epoca in cui ero sostituto procuratore a Milano, non posso dire di essere stato loro amico, ma ci incontravamo”. Antonio Di Pietro, ex pubblico ministero di “Mani Pulite”, rievoca i contatti con Giovanni Falcone all’inizio del 1992: “Dopo l’arresto di Mario Chiesa c’era bisogno di fare alcune rogatorie in Svizzera. Volevamo trovare la provvista per le tangenti. Falcone era direttore degli affari penali del ministro della Giustizia: mi fece da insegnante in una materia di cui sapevo poco, mi mise anche in contatto con la collega svizzera Carla Del Ponte“. Al processo d’appello per la “Trattativa Stato mafia”, il legale del generale Mario Mori, l’avvocato Basilio Milio, ha convocato l’ex senatore per chiedergli di parlare delle indagini sulle tangenti attorno alle opere pubbliche, di cui anche i carabinieri del Ros si erano occupati in quella stagione. “Falcone mi disse, guarda negli appalti in Sicilia – dice Di Pietro – Il giorno del funerale di Falcone, ne parlai con Borsellino. Che mi sussurrò: ‘Bisogna fare presto’. Era un riferimento a coordinare le indagini sul territorio nazionale”. Di Pietro parla anche della maxitangente Enimont, 150 miliardi delle vecchie lire: “In parte, quei soldi provenienti dall’imprenditore Raul Gardini, in Cct, arrivarono pure in Sicilia, a Salvo Lima. Sarebbero arrivati attraverso Cirino Pomicino“. “Dopo la morte di Borsellino rimasi scosso – prosegue l’ex pm – avevo capito la diffusione del sistema, mi chiusi in me e continuai a indagare. Intanto, era arrivata una segnalazione del Ros, per una minaccia di attentato nei miei confronti. E con un ufficiale del Ros, di cui non ricordo il nome, andai a parlare in carcere con l’ex capo area della Rizzani De Eccher in Sicilia, il geometra Giuseppe Li Pera“. Quell’ufficiale era l’allora capitano Giuseppe De Donno, rivela in aula il suo legale, l’avvocato Francesco Romito. Anche De Donno è stato condannato in primo grado nel processo “Stato-mafia”. “Disse che Li Pera poteva parlare di tanti appalti in Sicilia. Aggiunse che a Palermo non volevano sentirlo”. Il racconto di Antonio Di Pietro si fa appassionato quando rievoca i suoi colleghi uccisi nel 1992: “Falcone mi disse che in Sicilia bisognava fare i conti con un terzo soggetto. Accanto ai politici e agli imprenditori, i mafiosi. Ne parlai con Borsellino, che però non mi disse quello che stava facendo, non mi disse che stava lavorando sul rapporto mafia e appalti, e che stava ascoltando il pentito Mutolo. Mi disse però che dovevamo tornare a incontrarci, era convinto che in Italia ci fosse un sistema di spartizione nazionale attorno agli appalti”. Il discorso torna sulla maxi tangente Enimont: “L’avvocato di Gardini, all’epoca latitante, mi assicurò che si sarebbe consegnato. Io volevo sapere che fine avessero fatto i soldi della maxi tangente. La notte prima dell’interrogatorio, l’imprenditore tornò nella sua abitazione, che tenevamo sotto controllo. La polizia giudiziaria mi chiese se doveva scattare l’arresto. Dissi di aspettare”. La mattina seguente, Gardini si suicidò. “E’ il dramma che mi porto dentro”, dice Di Pietro. Che poi, però, sbotta: “Questo che c’azzecca con la trattativa?”. Ma dice: “Sono convinto che la morte di Paolo Borsellino sia legata alle indagini sugli appalti che voleva avviare. Io sono stato invece fermato con la delegittimazione, attraverso un’attività di dossieraggio messo in atto da uomini dei servizi segreti. Su questo bisognerebbe indagare per capire perché è finita l’inchiesta Mani Pulite”. di SALVO PALAZZOLO 03 ottobre 2019 LA REPUBBLICA
19.9.2019 – TRATTATIVA STATO-MAFIA, PENTITO: «DELL’UTRI SVELÒ AI GRAVIANO IL COVO DI CONTORNO» La rivelazione è del pentito catanese Francesco Squillaci che ha deposto in videoconferenza nel processo d’appello sulla presunta trattativa “Tra il 1998 e il 2000 mio padre era nel carcere di Spoleto dove ha stretto amicizia con i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. Mio padre mi ha raccontato che i Graviano gli dissero che avevano individuato il collaboratore Totuccio Contorno a Roma e che non erano riusciti ad ucciderlo per poco. Sempre i fratelli Graviano, che si vantavano di avere una amicizia stretta, intima con Dell’Utri, dissero che sarebbe stato proprio lui che attraverso servizi segreti deviati, avrebbe fatto sapere dove si trovava Contorno“. Lo ha detto il collaboratore di giustizia Francesco Squillaci, continuando la sua deposizione, in videoconferenza al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e mafia davanti alla seconda sezione della corte d’assise di appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellin. Tra gli imputati del processo, accusato di minaccia a corpo politico dello Stato, c’è anche l’ex senatore di Fi Marcello Dell’Utri che in primo grado è stato condannato a 12 anni. LA SICILIA
20.05.2019 TRATTATIVA STATO-MAFIA, IL PG CHIEDE DI ACQUISIRE I VERBALI DEL PENTITO BISCONTI SU MANNINO La procura ha messo a disposizione della corte i verbali chiedendo, qualora fossero acquisiti, la riapertura del dibattimento e l’esame del pentito. In primo grado l’ex ministro Dc era stato assolto Trattativa Stato-mafia, il PG chiede SEGUE
A POCO PIÙ DI UN ANNO DI DISTANZA DALLA STORICA SENTENZA DI PRIMO GRADO,che ha portato alla condanna, con l’accusa di attentato a corpo politico dello Stato, dei boss SEGUE
- ADNKRONOS 29.4.2019
- RAI NEWS 29.4.2019
- LA REPUBBLICA 29.4.2019
- IL FATTO QUOTIDIANO 29.4.2019
- MERIDIO NEWS 29.4.2019
- ADNKRONOS 28.4.19
- LIVE SICILIA 28.4.19
- STRETTO WEB 28.4.2019
La lunga trattativa Stato-mafia
Stato-mafia, chiesti approfondimenti su detenzione di Riina nel ’93
Ci fu un patto con Cosa Nostra?Le argomentazioni difensive riferite sul punto,secondo le quali si riteneva che il latitante non conservasse cose di rilievo nella propria abitazione, perché “il mafioso” non terrebbe mai cose che possono mettere in pericolo la famiglia, appaiono fondate su una massima di esperienza elaborata dagli stessi imputati ma non verificata empiricamente ed anzi contraddetta dalla risultanza offerta proprio dal materiale rinvenuto indosso al boss.
Pertanto, già il 15.1.93, sussisteva la concreta e rilevante probabilità che esistesse altra documentazione in via Bernini; probabilità che è stata confermata in dibattimento dal Brusca e dal Giuffré, secondo cui Salvatore Riina era solito prendere appunti, teneva una contabilità dei proventi criminali, annotava le riunioni e teneva una fitta corrispondenza sia con il Provenzano che con altri esponenti mafiosi, per la “messa a posto” delle imprese e la gestione degli affari.
Accertare se tali documenti effettivamente esistessero, se fossero custoditi all’interno della villa e quale sorte abbiano avuto, non può avere alcuna refluenza – ad avviso del Collegio – sulla sussistenza del reato contestato, atteso che il dato certo del ritrovamento indosso al Riina di materiale cartaceo, unito ad indizi di carattere logico, pienamente confermati dalle deposizioni testimoniali acquisite, già di per sé consente di ritenere che l’omessa perquisizione della casa e l’abbandono del sito sino ad allora sorvegliato abbiano comportato il rischio di devianza delle indagini che, difatti, nella fattispecie si è pienamente verificato, stando alle manifestazioni di sollievo e di gioia manifestate da Bernardo Provenzano e da Benedetto Spera al Giuffré (i quali ebbero a dichiarare che per fortuna le forze dell’ordine non avevano potuto trovare “nulla” con ciò intendendo riferirsi proprio a documenti) ed, ancora, alla soddisfazione espressa, durante le fasi dello svuotamento della casa, da parte del Sansone, e condivise dal La Barbera, dal Gioè, dal Brusca, dal Bagarella per il fatto che stava procedendo tutto “liscio” (cfr. in particolare le dichiarazioni di Gioacchino La Barbera).
D’altronde, appare evidente che l’ambito di un’indagine per il delitto di cui all’art. 416 bis C.P. si presenta particolarmente ampio, potendo ricomprendere una molteplicità di condotte e dispiegare i suoi effetti in relazione ad una pletora di personaggi, quali altri correi indagati in diversi filoni di inchiesta, per cui l’omessa perquisizione e la disattivazione del dispositivo di controllo di un luogo di pertinenza di un affiliato, e qui si trattava del capo di “cosa nostra”, appare condotta astrattamente idonea ad integrare non solo il favoreggiamento aggravato, ma lo stesso concorso nel reato associativo, ove si dimostri la sussistenza degli altri presupposti in punto di dolo e di efficienza causale del contributo di cui agli artt. 110 e 416 bis C.P..
Ne deriva che – ad avviso del Collegio – il punto nodale per la ricostruzione della vicenda in esame non può essere ricercato – contrariamente a quanto prospettato dalle difese – sul piano oggettivo, occorrendo invece indagare anche il “perché” siano accaduti gli avvenimenti che ci occupano.
Richiamata la narrazione degli accadimenti fattuali già esposta nella prima parte di questa sentenza, si osserva, sinteticamente, che la prospettiva accusatoria rimane ancorata ai seguenti elementi indiziari:
il giorno dell’arresto del Riina Sergio De Caprio chiese insistentemente, con l’appoggio di Mario Mori, che la perquisizione già predisposta sul complesso di via Bernini, non venisse eseguita, garantendo l’osservazione sul sito;
il pomeriggio alle ore 16.00 il furgone, con a bordo l’app.to Coldesina ed il Di Maggio, fu fatto rientrare ed il servizio non venne più predisposto;
tale decisione non fu oggetto di alcuna comunicazione;
il ROS non svolse più alcuna attività di indagine;
il 20.1.93 il De Caprio chiese che si effettuasse una perquisizione al cd. “fondo Gelsomino” come attività diversiva di depistaggio, nel presupposto che via Bernini fosse sotto osservazione;
in una riunione in data 27.1.93 Mario Mori accennò al fatto che il servizio era stato sospeso da tempo, decidendosi a rivelarlo solo il 30.1.93;
già a dicembre 1992 Mario Mori, con la consapevolezza del Di Caprio, aveva intavolato una trattativa segreta con “cosa nostra” tramite Vito Calogero Ciancimino, per ottenere una resa dei latitanti;
il ROS non poteva conoscere il sito di via Bernini, in quanto non era tra quelli indicati dal Di Maggio, dunque il Riina fu “consegnato” dalla stessa associazione criminale, ed in particolare da Bernardo Provenzano, in ossequio ad un patto di “non belligeranza” stipulato con il Mori. capitolo tratto da “Il grande mistero del covo” – stralci di sentenza . A. BOLZONI, S. BORTOLETTO, F. TROTTA – LA REPUBBLICA
Il silenzio sulla Trattativa Stato-Mafia, Roberto Scarpinato e l’urlo di Pasolini. Quando (il 1° febbraio 1975, sul Corriere della Sera) Pier Paolo Pasolini volle indicare lo stravolgimento della politica italiana, che introdusse il definitivo e radicale spartiacque con “i valori traditi” della Resistenza”, ponendo le basi, a suo dire, per un nuovo e più totale fascismo in Italia, ricorse all’immagine della “scomparsa delle lucciole”. Immagine poetica, espediente suggestivo, poco razionale, ma che aveva il merito indiscusso di sintetizzare, in maniera fulminea, ciò che era accaduto. Erano trascorsi esattamente trent’anni dalla Liberazione dal nazifascismo. E appena tre mesi da quell’altro proverbiale articolo (14 novembre 1974, ancora sul Corriere della Sera) in cui, enumerando le prime stragi di Stato dell’epoca (Milano, Brescia e Bologna), rimaste senza colpevoli – cioè senza esecutori e senza mandanti -, Pasolini aveva sintetizzato, altrettanto efficacemente: “Cos’è questo golpe? Io so”. Specificando poi, nel corpo dell’articolo: “Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi”. Dall’analisi pasoliniana sono trascorsi – adesso – altri quarantacinque anni. Verrebbe da dire che l’urlo pasoliniano è rimasto inascoltato. Le stragi di Stato – e i delitti di Stato – si sono susseguiti, con macabra cadenza. Lo stragismo sfociò persino nel delitto Moro; con Leonardo Sciascia che, volendone scrivere poliziescamente nel libro “L’affaire Moro”, come cioè avrebbe dovuto fare – ma non fece – la polizia di allora, iniziò il suo ragionamento proprio dalla scomparsa delle lucciole di pasoliniana memoria. Questo breve riepilogo (che tornerà utile fra un po’), ci porta sin dentro le parole pronunciate qualche giorno fa da Roberto Scarpinato, procuratore generale a Palermo, che ha descritto in maniera tranchant – in un dibattito pubblico – il filo d’acciaio che si è dipanato dalla strage di Portella della Ginestra (1947) sino a Capaci, via d’Amelio, Roma, Milano e Firenze. Due, per Scarpinato, i collanti comuni di questo stragismo apparentemente oscuro: il ruolo dei servizi segreti, civili e militari a seconda dei casi, nella gigantesca opera di depistaggio dell’attività della magistratura per impedirle di scoprire la verità; l’eliminazione, con delitti e finti “suicidi”, di tutti coloro i quali avevano offerto la loro compartecipazione criminale a quella strategia che, sempre per Scarpinato, è stata la caratteristica del potere politico italiano. Un potere che, quanto a ferocia – ha aggiunto – non ha mai avuto uguali in nessun paese d’Europa. Le parole di Scarpinato, sia detto per inciso, andrebbero ascoltate senza pregiudizio, come dovrebbe accadere in un Paese che fosse intenzionato per davvero, ora che il sangue di migliaia di morti si è inevitabilmente asciugato, a fare i conti con il suo passato. Se no – ma questo lo diciamo noi – non se ne esce, né se ne uscirà mai. Ma dove porta il filo d’acciaio che parte da Portella (a non volerlo retroattivamente prolungare, questo filo, sino al delitto Notarbartolo, o, più indietro ancora nel tempo, al delitto Petrosino)? A questa altra constatazione di Scarpinato: che “ci sono dei poteri, che sono ancora poteri, che hanno una capacità di intervento e di intimidazione tale da impedire che la verità venga accertata, per cui chi sa non parla”. Il Potere – verrebbe da dire – è ben più longevo di Cosa Nostra. Scarpinato non ne fa una questione di memoria negletta, o poco coltivata, di quanto è accaduto. Infatti aggiunge: “questo non è soltanto un dramma della conoscenza e della memoria, questo diventa un dramma della democrazia. Il gioco grande non è mai finito”, Parole pesanti. Solo illusi visionari potrebbero, oggi, dire che si stia tornando all’epoca d’oro delle lucciole. A ben guardare, infatti, il filo d’acciaio di cui sopra arriva intatto sino ai nostri giorni. Il potere italiano, in altre parole, non ha mai fatto una grinza. Ha scavalcato, a suon di bombe e depistaggi, il mezzo secolo che data dalla scomparsa di Pasolini. Ma che prezzi enormi ha dovuto pagare, se persino un capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha ritenuto più opportuno, per il bene della Patria, il silenzio, in luogo della parola. Ormai nove italiani su dieci “sanno”, esattamente come “sapevano” Pasolini e Sciascia. Sanno che non fu mai “sola Mafia”. Con in più – e questo non andrebbe nascosto -, le oltre 5000 pagine di sentenza del primo grado del processo di Palermo, sulla trattativa Stato-Mafia, presieduto da Alfredo Montalto, giudice a latere, Stefania Brambille, che si è concluso con condanne per uomini politici, rappresentanti dello Stato, boss mafiosi. Sono pagine che fanno rabbrividire chi tenta di capire, senza pregiudizio, cosa è stata l’Italia degli ultimi decenni. Scarpinato non poteva parlarne – né toccava a lui farlo – in considerazione del ruolo che ricopre a capo della Procura generale, e in vista proprio della imminente sentenza di appello di quel processo. Ma gli altri sì, che potrebbero parlarne. E dovrebbero parlarne tanto, e ad altissima voce. Ma non se la sentono. Certi intellettuali, certi notisti politici, certi esponenti politici, certi direttori di giornali e storici di mafia, persino certi parenti delle vittime, che restano invece in imbarazzato silenzio, certe televisioni di Stato e televisioni private, danno l’ impressione di voler nascondere la polvere sotto il tappeto. E non si accorgono che altri (i poteri ai quali si riferisce Scarpinato), nel frattempo, ne approfittano per nascondere, sotto il tappeto, la polvere da sparo (che può sempre tornare utile), con buona pace per il ritorno delle lucciole. ANTIMAFIA 2000 06 Settembre 2020. di Saverio Lodato
PROCESSO DI PRIMO GRADO
6.12.2018“LA TRATTATIVA ACCELERÒ VIA D’AMELIO E ATTIVÒ LE ALTRE STRAGI DEL ’93” “PADRINI FONDATORI” – La Corte di Assise di Palermo afferma che i vertici del Ros e i loro mandanti (purtroppo occulti, ma riferibili temporalmente al primo governo di Giuliano Amato) hanno sulla coscienza gli omicidi di Borsellino… LEGGI TUTTO
PROCESSO TRATTATIVA STATO-MAFIA: arrivata la sentenza – 19 Luglio 2018 – In coincidenza con il 26° Anniversario della Strage di Via D’Amelio, sono state depositate le oltre 5 mila pagine che compogono la Sentenza dello scorso 20 Aprile 2018
- Indice
- Lettura della Sentenza
- Il Patto sporco fra Stato e mafia
- Capitolo – LA TRATTIVA STATO-MAFIA accellerò l’esecuzione di Paolo Borsellino
- Capitolo – IL PAPELLO
- Capitolo – LA MANCATA PERQUISIZIONE AL COVO DI RIINA
- Capitolo – MAFIA e APPALTI
- AUDIO UDIENZE
Le tappe del processo Le motivazioni della sentenza emessa il 20 aprile scorso dalla corte d’assise di Palermo. I giudici condannarono Mori, De Donno, Subranni e Dell’Utri, assoluzione per Mancino
- Intercettazione telefonica tra Lors D’Ambrosio, Consigliere giuridico del Presidente della Repubblica Napolitano e Nicola Mancino, ex Ministro dell’Interno
- Intercettazione telefonica tra gli ufficiali dei Carabinieri Mori e De Donno
- Mori, De Donno e la Signora Borsellino
- La signora Borsellino e le confidenze di suo marito – dalla “Sentenza Trattativa”
- Archivio Antimafia
- Archivio Antimafia Duemila
“L’IMPROVVISA ACCELERAZIONE CHE EBBE L’ATTENTATO A PAOLO BORSELLINO” fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo – ed in sostanza, di cedimento Cosa Nostra culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Amelio”. Per i giudici del processo Trattativa Stato-mafia, “non vi è dubbio” che i contatti fra gli ufficiali dei carabinieri Mori e De Donno con Vito Ciancimino, unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l’avvicendamento di quel ministro dell’Interno che si era particolarmente speso nell’azione di contrasto alle mafie, in assenza di plausibili pubbliche spiegazioni) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Salvatore Riina già come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa nella misura in cui quegli ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato”. I giudici scrivono ancora: “Ove non si volesse prevenire alla conclusione dell’accusa che Riina abbia deciso di uccidere Borsellino temendo la sua opposizione alla trattativa, conclusione che peraltro trova una qualche convergenza nel fatto che secondo quanto riferito dalla moglie, Agnese Piraino Leto, Borsellino, poco prima di morire, le aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle istituzioni e mafiosi, in ogni caso non c’è dubbio che quell’invito al dialogo pervenuto dai carabinieri attraverso Vito Ciancimino costituisca un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino, con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato e di lucrare, quindi, nel tempo dopo quell’ulteriore manifestazione di incontenibile violenza concretizzatasi nella strage di via d’Amelio, maggiori vantaggi rispetto a quelli che sul momento avrebbero potuto determinarsi in senso negativo”.
Il 28 ottobre 2014 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano viene ascoltato al Quirinale dalla Corte da Assise di Palermo.
Verbale d’udienza deposizione Napolitano 28/10/2014
18.10.2018. INTERVENTO DI ANTONINO DI MATTEO
- 26 ANNI DOPO VIA D’AMELIO, PALERMO RICORDA BORSELLINO – ASKANEWS
- A 26 ANNI DALL’ASSASSINIO DI PAOLO BORSELLINO. DOVE SI ANNIDA OGGI COSA NOSTRA? – SENSO COMUNE
- ACCELERAZIONE SUL PROCESSO TRATTATIVA – IL FOGLIO
- ACCORDO STATO-MAFIA E LA FINE DI BORSELLINO – TV SVIZZERA.IT
- BERLUSCONI SAPEVA DEI RAPPORTI DELL’UTRI-MAFIA” – L’HUFFPOST
- BORSELLINO QUATER E TRATTATIVA: “NELLE SENTENZE PAROLE INCREDIBILI DI DELL’UTRI A BERLUSCONI” – IL SICILIA
- BORSELLINO QUATER E TRATTATIVA STATO-MAFIA, PARLA INGROIA «IL GOVERNO – MERIDIO NEWS
- BORSELLINO, I GIUDICI E VIA D’AMELIO: “IL DIALOGO TRA STATO E MAFIA ACCELERÒ QUELLA STRAGE” RISTRETTI ORIZZONTI
- BORSELLINO, I GIUDICI: «LA TRATTATIVA STATO-MAFIA ACCELERÒ LA SUA MORTE» – CORRIERE DELLA SERA
- BORSELLINO, LA TRATTATIVA E QUELLA «PREMURA» DI UCCIDERLO. RIINA: «NON ERA STUDIATO DA MESI, STUDIATO ALLA GIORNATA» – MERIDIO NEWS
- BORSELLINO, MATTARELLA: “NON SMETTERE DI CERCARE LA VERITÀ SULLA STRAGE – IL FATTO QUOTIDIANO
- BORSELLINO -MACCHÉ DEPISTAGGI, FU VITTIMA – IL SUSSIDIARIO.NET
- BORSELLINO: “BERLUSCONI SAPEVA ”TRATTATIVA STATO-MAFIA ACCELERÒ LA MORTE DEL GIUDICE – IL SUSSIDIARIO.
- CORCIANO: NEL RICORDO DI PAOLO BORSELLINO LE AGENDE ROSSE INCONTRANO I CAPIGRUPPO – UMBRIA NOTIZIE
- DA BERLUSCONI SOLDI A COSA NOSTRA – IL FATTO QUOTIDIANO
- I GIUDICI DI PALERMO: “TRATTATIVA STATO-MAFIA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO” | LAPRESSE
- I GIUDICI DI PALERMO: “TRATTATIVA STATO-MAFIA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO” – YAHOO NOTIZIE
- I GIUDICI DI PALERMO: LA TRATTATIVA STATO-MAFIA ACCELERÒ LA MORTE DI PAOLO – RAI NEWS
- I GIUDICI: LA ‘TRATTATIVA’ STATO-MAFIA ACCELERÒ L’ATTENTATO A BORSELLINO – VENTI4ORE
- I GIUDICI: LA ‘TRATTATIVA’ STATO-MAFIA ACCELERÒ L’ATTENTATO A BORSELLINO – ANSA
- IN PRIMO PIANO
- LA CONSAPEVOLEZZA DI MANNINO E LE PROVE DI RICCIO – ANTIMAFIA DUEMILA
- LA SCELTA DELLO STATO DI TRATTARE CON RIINA CONDANNÒ A MORTE BORSELLINO: LA VERITÀ DEI GIUDICI DI PALERMO – ULTIME NOTIZIE
- LA STAMPA – «LA TRATTATIVA TRA LO STATO E LA MAFIA
- LA TRATTATIVA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO. DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA SULLA COSIDDETTA TRATTATIVA STATO-MAFIA – LA VOCE COSENTINA
- LA TRATTATIVA STATO-MAFIA ACCELERÒ LA MORTE DEL GIUDICE PAOLO BORSELLINO – TP24
- LA TRATTATIVA STATO-MAFIA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO – MOBI NEWS
- LA TRATTATIVA STATO-MAFIA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO. A 26 …
- LA TRATTATIVA STATO-MAFIA ACCELERÒ L’ATTENTATO AL GIUDICE PAOLO – IL MANIFESTO
- ‘LA TRATTATIVA CON RIINA ACCELERÒ IL DELITTO BORSELLINO’. MOTIVAZIONE CHOC – TG LA7
- L’ANALISI] LA SCELTA DELLO STATO DI TRATTARE CON RIINA CONDANNÒ A MORTE – TISCALI NEWS
- MAFIA: LA TRATTATIVA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO – QUOTIDIANO DI SICILIA
- MARCO TRAVAGLIO, LA VERGOGNA IN PRIMA PAGINA: IL CAV E BORSELLINO UCCISO, DOVE ARRIVA IL FATTO QUOTIDIANO – LIBERO QUOTIDIANO
- MARIO MORI, DAL SID A PROVENZANO
- MATTARELLA: ONORARE MEMORIA BORSELLINO SIGNIFICA NON SMETTERE DI CERCARE LA VERITÀ RAI NEWS
- NINO DI MATTEO COMMENTA LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA SULLA TRATTATIVA STATO-MAFIA: “UN PEZZO DI STATO PIEGATO AI BOSS” – HUFFINGTON POST
- PALERMO RICORDA PAOLO BORSELLINO: TARGA IN SUA MEMORIA E “AGENDE – GIORNALE DI SICILIA
- PAOLO BORSELLINO: ISOLATO DALLA MAGISTRATURA, AMMAZZATO DALLO STATO-MAFIA.. – ATUTTADESTRA.NET
- PAOLO BORSELLINO: MANIFESTANTI CON AGENDE ROSSE PER LA VERITÀ – BLASTING NEWS
- PER I GIUDICI LA TRATTATIVA STATO-MAFIA ACCELERÒ L’ESECUZIONE DI BORSELLINO – ULTIMA NOTIZIA
- PER I GIUDICI LA TRATTATIVA STATO-MAFIA ACCELERÒ L’ESECUZIONE DI BORSELLINO- AGI
- PERCHÉ TOTO RIINA DECISE DI CONCENTRARSI NELL’UCCISIONE DI BORSELLINO? – DAGOSPIA
- QUELLO CHE NON TORNA DELLA SENTENZA SULLA “TRATTATIVA” STATO-MAFIA SPIEGATO IN DIECI PUNTI – IL FOGLIO
- RADIO ONDA D’URTO TRATTATIVA STATO-MAFIA: LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.
- RASSEGNA STAMPA DEL 20 LUGLIO 2018 – PRIMA PAGINA – RAI RADIO 3 – RAIPLAY RADIO
- SALVATORE BORSELLINO: PAOLO ASSASSINATO PERCHÈ SI ERA MESSO DI TRAVERSO – RAI NEWS
- SENTENZA STATO-MAFIA, DI MATTEO: UN PEZZO DI STATO SI ERA PIEGATO AI BOSS – TG LA7
- SENTENZA STATO-MAFIA, DI MATTEO: UN PEZZO DI STATO SI ERA PIEGATO AI BOSS – TG LA7
- STATO MAFIA I GIUDICI LA TRATTATIVA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO – CERRETO LAZIALE – VIRGILIO
- STATO- MAFIA: TSUNAMI SUI ROS ( SCENARIO OPPOSTO AL BORSELLINO- – IL DUBBIO
- STATO-MAFIA, “BERLUSCONI SAPEVA” – RSI RADIOTELEVISIONE SVIZZERA
- STATO-MAFIA, “LA TRATTATIVA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO”. E DELL’UTRI – LA REPUBBLICA
- STATO-MAFIA, GIUDICI DI PALERMO: TRATTATIVA ACCELERÒ MORTE BORSELLINO – SKY TG24
- STATO-MAFIA, I GIUDICI: “DELL’UTRI FAVORÌ PIANI DI RIINA E LA TRATTATIVA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO”. AZIONE DEL QUIRINALE CORRETTA | RADIO24
- STATO-MAFIA, I GIUDICI: “LA TRATTATIVA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO” – AGENZIA DIRE
- STATO-MAFIA, I GIUDICI: “LA TRATTATIVA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO” – L’ECO VICENTINO
- STATO-MAFIA, I GIUDICI: “LA TRATTATIVA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO” – NEWS GO
- STATO-MAFIA, I GIUDICI: “LA TRATTATIVA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO” – AFFARI ITALIANI”
- STATO-MAFIA, I GIUDICI: “LA TRATTATIVA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO” – POLIZIA PENITENZIARIA
- STATO-MAFIA, I GIUDICI: ‘LA TRATTATIVA ACCELERÒ LA MORTE DI BORSELLINO’ – DIRE –
- STATO-MAFIA, MANCINO: “DEL PATTO NON SO NULLA, MA NON LO ESCLUDO” IRPINIANEWS.IT
- STATO-MAFIA: “TRATTATIVA ACCELERÒ MORTE BORSELLINO –IL SUSSIDIARIO.NET
- STATO-MAFIA: AVEVAMO RAGIONE. MOTIVAZIONI SENTENZA DIMOSTRANO QUANTO ABBIAMO SOSTENUTO COSTITUENDOCI PARTE CIVILE | RIFONDAZIONE COMUNISTA
- STATO-MAFIA: AVEVAMO RAGIONE. MOTIVAZIONI SENTENZA DIMOSTRANO QUANTO ABBIAMO SOSTENUTO COSTITUENDOCI PARTE CIVILE | R.C.
- STATO-MAFIA: DELL’UTRI INTERMEDIARIO E SOLDI DI BERLUSCONI A COSA NOSTRA – PRIMADANOI.IT
- STATO-MAFIA: PRESIDENTE CENTRO LA TORRE, SI APRANO ARCHIVI – ANTIMAFIA DUEMILA
- STRAGE DI VIA D’AMELIO, LE IMMAGINI DELLA FIACCOLATA | VIDEO – PALERMO TODAY
- SULLA TRATTATIVA ECLATANTI DIMENTICANZE DI STATO. SOTTO ACCUSA VIOLANTE, MARTELLI, CONSO, FERRARO E CONTRI – REPUBBLICA PALERMO
- ‘TRATTATIVA’ ACCELERÒ MORTE BORSELLINO – ANSA
- TRATTATIVA STATO MAFIA, LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA – TG LA7
- TRATTATIVA STATO-MAFIA ACCELERÒ LA MORTE DI PAOLO BORSELLINO – THE TODAY WORLD
- TRATTATIVA STATO-MAFIA, I GIUDICI: ACCELERÒ MORTE BORSELLINO | VIDEO SKY
- TRATTATIVA STATO-MAFIA, SALVATORE BORSELLINO: “DEPISTAGGIO? O DOLO O INCOMPETENZA DEI MAGISTRATI”. SCARPINATO: “COSTITUIRE POOL NAZIONALE PER TROVARE … IL FATTO QUOTIDIANO
- TRATTATIVA STATO-MAFIA, SALVINI: ”FORZE DELL’ORDINE INFEDELI DEVONO PAGARE DOPPIO” – VIDEO CORRIERE DELLE ALPI
- TRATTATIVA STATO-MAFIA. FAVA: “DA CHI È PARTITO L’ORDINE?” – SICILIA INFORMAZIONI
- TRATTATIVA STATO-MAFIA: DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE DI ASSISE DI PALERMO – GIURISPRUDENZA PENALE
- TRATTATIVA STATO-MAFIA: I ROS E LE STRANE DIMENTICANZE DI CHI SAPEVA – CORRIERE DELLA SERA
- VIA D’AMELIO, UNA STRAGE ANCORA SENZA VERITÀ – ARTICOLO – TGR SICILIA – RAI NEWS
PALERMO, 20.4.2018 – LA CORTE DI ASSISE DI PALERMO, PRESIEDUTA DA ALFREDO MONTALTO, HA COMMINATO OGGI DIVERSE CONDANNE PESANTI NEL PROCESSO PER LA COSIDDETTA TRATTATIVA STATO-MAFIA, CHE GIUNGE DOPO QUASI CINQUE ANNI DI PROCESSO, CIRCA 220 UDIENZE E OLTRE 200 TESTIMONI.
LA LETTURA DELLA SENTENZA – VIDEO
AGNESE BORSELLINO: “MIO MARITO MI DISSE DELLA TRATTATIVA STATO-MAFIA…”
- ARLACCHI: LA TRATTATIVA
- BERLUSCA U‘BRAVISSIMO
- BERLUSCONI E LA MAFIA
- BOLZONI RACCONTA LA TRATTATIVA
- BORSELLINO É STATO LASCIATO SOLO
- BORSELLINO SACRIFICATO SULL’ALTARE DELLA TRATTATIVA
- BORSELLINO SAPEVA DELLA TRATTATIVA
- BORSELLINO TRADITO DA UN CARABINIERE
- BORSELLINO: CHI ERA VITTORIO MANGANO
- BORSELLINO: PAOLO UCCISO PER NASCONDERE LA TRATTATIVA
- BRUSCA DEPONE
- BRUSCA: CONFERMA LA TRATTATIVA
- BRUSCA: IL PAPELLO È FINITO A MANCINO
- BRUSCA: RIINA MI FECE IL NOME DI MANCINO COME DESTINATARIO DEL PAPELLO
- CAFIERO DE RAHO: “CONFERMA CHE LA MAFIA FU LEGITTIMATA”
- CANALI DI COMUNICAZIONE TRA RIINA, DELL’UTRI E BERLUSCONI
- CIANCIMINO: LETTERA DELLA MAFIA A BERLUSCONI 1P
- CIANCIMINO: LETTERA DELLA MAFIA A BERLUSCONI 2P
- CIANCIMINO: QUESTA MATTANZA DEVE FINIRE
- CINQUE COSE DA SAPERE SU TRATTATIVA STATO-MAFIA
- CLAUDIO MARTELLI: “VI RACCONTO COSA C’É DIETRO”
- CONDANNATI BOSS E CARABINIERI. ASSOLTO MANCINO
- CONDANNATI MORI E DELL’UTRI. ASSOLTO MANCINO
- CONDANNATI MORI, DE DONNO DELL’UTRI E BAGARELLA. ASSOLTO MANCINO
- CONSEGNATO AI MAGISTRATI
- CONTRADA
- DA CAPACI E VIA D’AMELIO
- DE DONNO E MORI FRA SILENZI E RISPOSTE A METÀ
- DE DONNO IL COLONNELLO DEI MISTERI
- DELL’UTRI ANDÒ DAI BOSS PRIMA DI FARE FORZA ITALIA
- DELL’UTRI: TRATTATIVA GIUSTA SE PER EVITARE GUAI PEGGIORI
- DEPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NAPOLITANO
- DEPOSIZIONE PENTITO FRANCESCO ONORATO 2
- DEPOSIZIONE PENTITO FRANCESCO ONORATO
- DI MATTEO: “IL QUIRINALE ASSECONDÒ IL TENTATIVO DI MANCINO DI CONDIZIONARE I GIUDICI”
- DI MATTEO: “SCALFARO HA DETTO IL FALSO”
- DI MATTEO: “TRA I VERTICI DEI ROS E COSA NOSTRA CI FU TRATTATIVA POLITICA”
- DI MATTEO: “MANCINO HA SCELTO L’OMERTÀ ISTITUZIONALE”
- DI MATTEO: NON SI VUOLE LA VERITÀ
- DOPO 201 UDIENZE PROCESSO IN CHIUSURA
- DOPO 5 ANNI DI PROCESSO ARRIVA LA SENTENZA
- FERRERO: MISTIFICAZIONI MEDIATICHE SULL TRATTATIVA
- FIAMMETTA BORSELLINO: “COINVOLTI SOGGETTI DELLO STATO”
- FIAMMETTA BORSELLINO: “MIO PADRE ELIMINATO PERCHÉ SCOMODO”
- FIAMMETTA BORSELLINO: “MIO PADRE UCCISO PERCHÉ OSTACOLAVA LA TRATTATIVA”
- FIAMMETTA BORSELLINO: “STATO COINVOLTO AI MASSIMI LIVELLI”
- FIAMMETTA BORSELLINO: “TRATTATIVA STATO-MAFIA POSSIBILE MOTIVAZIONE DELL’ACCELERAZIONE DELL’OMICIDIO”
- FIAMMETTA BORSELLINO: ”ISTITUZIONI COINVOLTE“
- FIAMMETTA BORSELLINO: ”RIINA UCCISE MIO PADRE MA FECE UN FAVORE ANCHE AD ALTRI”
- GRASSO: LO STATO RICATTATO TRATTÓ
- GRASSO: MANCINO MI CHIESE D’INTERVENIRE
- I CONTI CHE NON TORNANO DELLA SENTENZA
- I PEZZI MANCANTI
- I PUNTI ANCORA OSCURI
- I SEGRETI DEL PAPELLO
- IL DIALOGO DELLE STRAGI
- IL PAPELLO
- IL PAPELLO DI MASSIMO CIANCIMINO – STORIA DI UNA FOTOCOPIA
- IL PAPELLO DI RIINA RITROVATO NEL 2005
- IL PAPELLO: UNA GROSSOLANA MANIPOLAZIONE DI MASSIMO CIANCIMINO
- INGROIA RACCONTA LA TRATTATIVA
- INGROIA RACCONTA LA TRATTATIVA
- INGROIA RACCONTA LA TRATTATIVA 2
- INTERCETTAZIONI DELLA DIA
- ISTITUZIONI TRADITE
- LA CRONOLOGIA DELLA TRATTATIVA
- LA DOCUMENTAZIONE PROCESSUALE
- LA TRATTATIVA
- LA TRATTATIVA – ANTONIO INGROIA
- LA TRATTATIVA CI FU
- LA TRATTATIVA E LA MORTE DI PAOLO BORSELLINO – VIDEO
- LA TRATTATIVA- FILM
- LA TRATTATIVA IN SETTE PUNTI
- LA TRATTATIVA NEL TESTAMENTO DI AGNESE BORSELLINO
- LA TRATTATIVA STATO-MAFIA E LA MORTE DI PAOLO BORSELLINO
- LA VERITÀ FA PAURA
- LA VERSIONE DEL PENTITO FRANCESCO ONORATO
- LA VERSIONE DEL PENTITO FRANCESCO ONORATO 2
- LO STATO HA TRATTATO PER FERMARE LE BOMBE
- LO STATO SCENDE A PATTI CON LA MAFIA
- MANCINO: ” NESSUNA TRATTATIVA”
- MANCINO: TRATTATIVA STATO-MAFIA INSINUAZIONI SU MIO INCONTRO CON BORSELLINO
- MARTELLI: LA TRATTATIVA CI FU
- MEMORIA PM RINVIO A GIUDIZIO
- MORI MI BLOCCÒ MENTRE STAVO PER ARRESTARE PROVENZANO
- MORI: IL PAPELLO NON È MAI ESISTITO
- MORTE DI BORSELLINO: COLOSSALE DEPISTAGGIO ALL’OMBRA DELLA TRATTATIVA
- MUTOLO: BORSELLINO OSTACOLAVA LA TRATTATIVA
- MUTOLO: BORSELLINO SAPEVA
- PAPELLO DOPO PAPELLO
- PAPELLO E TRATTATIVA STATO-MAFIA
- PENE COMPRESE FRA GLI 8 E I 28 ANNI
- PISANU: TACITA E PARZIALE INTESA FRA LE PARTI
- PROCESSO DELL’UTRI
- PROCESSO DELL’UTRI – GRAVIANO
- PROCESSO DELL’UTRI – SPATUZZA
- PROCESSO-TRATTATIVA; A PALERMO È COMINCIATO IL REDDE RATIONEM. MA QUALE?
- RAFFICA DI CONDANNE
- SALVATORE BORSELLINO: “FELICE MA MANCA LA POLITICA”
- SCELLERATA TRATTATIVA…
BORSELLINO LA OSTACOLAVA - SI CHIUDE IL PROCESSO
- STATO-MAFIA ECCO IL PAPELLO
- TARTAGLIA: “DELL’UTRI È L’OPZIONE POLITICA INDIVIDUATA A ROMA”
- TELEFONATA BERLUSCONI-DELL’UTRI
- TELEFONATA CINÁ-DELL’UTRI
- TESTIMONIANZA MAR. SAVERIO MASI
- TRATTATIVA STATO MAFIA ECCO IL PAPELLO
- TRATTATIVA STATO-MAFIA
- TRATTATIVA: PRIMA UDIENZA A PALERMO
- TUTTE LE TAPPE DELLA TRATTATIVA
- VENT’ANNI DI TRATTATIVA STATO-MAFIA
- VERBALI INTERROGATORI
- Oltre la trattativa – documentazione
- La cosiddetta trattativa – documentazione
- Rassegna stampa
- Audio processo Bagarella – presunta trattativa Stato mafia
- 25 anni alla ricerca di una scomoda verità – video
- La trattativa – film
- Le TRATATIVE di Pietro Ingroia
Il primo a parlare di “trattativa” attraverso un “papello di richieste” è stato il pentito Giovanni Brusca, nel 1996, all’inizio della sua collaborazione con la giustizia: disse di averne sentito parlare a Totò Riina, fra le stragi Falcone e Borsellino. Da queste dichiarazioni sono ripartiti i pm di Palermo e Caltanissetta nel 2009, dopo aver raccolto le parole di Massimo Ciancimino, il figlio dell’ex sindaco di Palermo condannato per associazione mafiosa.
Le indagini di Palermo La Procura ha chiamato Massimo Ciancimino a deporre nel processo che vede imputati il generale Mario Mori e il colonnello Mauro Obinu di favoreggiamento aggravato nei confronti di Bernardo Provenzano. Nell’estate 1992, Mori incontrò più volte il padre di Massimo Ciancimino, Vito: “Per tentare di indurlo alla collaborazione e fermare le stragi mafiose”, ha sempre sostenuto Mori; “per intavolare una trattativa con Cosa nostra”, è la tesi della Procura di Palermo. Massimo Ciancimino ha accusato in particolare Mori di avere incontrato il padre già prima della strage di via d’Amelio, circostanza sempre negata da Mori. Ciancimino junior, che si attribuisce un ruolo di intermediario fra il padre e gli ufficiali dell’Arma, sostiene pure che fu consegnato a Mori un “papello” con le richieste di Riina (anche questa circostanza smentita da Mori). Nella ricostruzione di Ciancimino, la trattativa Stato-mafia condotta nell’estate 1992 tramite il padre sarebbe proseguita dopo il gennaio 1993 (ovvero dopo l’arresto di Totò Riina) attraverso il “nuovo canale” Bernardo Provenzano–Marcello Dell’Utri.
22.4.2018 Trattativa, Fiammetta Borsellino: “Soggetti dello Stato hanno esposto mio padre alla mafia come bersaglio da eliminare”. Il primo pensiero di Fiammetta Borsellino, dopo aver saputo delle condanne per il generale Antonio Subranni e per gli altri, è stato per la madre Agnese Piraino, scomparsa nel 2013 dopo una lunga malattia. Sua madre riferì ai pm quel che suo padre le aveva detto poco prima di morire sul comandante del Ros Angelo Subranni: che era punciuto, cioè in qualche modo legato alla mafia. Allora fu attaccata duramente e poi Subranni fu prosciolto a Caltanissetta per concorso esterno in associazione mafiosa. Ora è stato condannato per la Trattativa a 12 anni. Mia madre raccontò ai magistrati solo quello che mio padre le aveva detto. Fece il suo dovere ma fu attaccata duramente. Mi fa fatica anche ricordare. Il generale Subranni, 80 anni, nel 1992 era il capo del Ros. Venerdì scorso è stato considerato colpevole di avere veicolato con il generale Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno, la minaccia della mafia allo Stato. Sua madre potrebbe essere stata ritenuta attendibile? Bisogna aspettare le motivazioni però ricordo le parole di Subranni. Disse che mia madre era malata di alzheimer e non era vero. Né lui né gli avvocati né alcuni commentatori ebbero la minima forma di rispetto verso di lei. Questa sentenza è importante? Certo che è importante. Attesta il coinvolgimento a un altissimo livello di soggetti dello Stato con comportamenti che hanno esposto mio padre davanti alla mafia quale bersaglio da eliminare. Pensa che ci possa essere stata una relazione tra la trattativa avviata dal Ros dei carabinieri dopo la strage di Capaci e la strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992? C’è un intero capitolo del processo Borsellino quater dedicato alla Trattativa come possibile movente dell’accelerazione dell’uccisione di papà. Non sono solo io a pensarlo. Pensa che suo padre sia stato eliminato perché era un ostacolo per il dialogo tra pezzi dello Stato e la mafia? Certamente Totò Riina era determinato a uccidere mio padre, ma penso che l’accelerazione sia stata utile anche per altri apparati non appartenenti a Cosa Nostra che avevano interesse a eliminarlo. Il depistaggio, che è ormai acclarato, delle indagini sulla strage di via D’Amelio, potrebbe essere letto come la continuazione di un modo di operare che si intravede già nella Trattativa. E poi rimane il grande dubbio sulla sparizione dell’agenda rossa. Non dimentichiamo che a prendere la borsa di mio padre, il 19 luglio in via D’Amelio, sono state sempre persone appartenenti ai carabinieri. La Procura di Caltanissetta sta valutando se sia il caso di riaprire le indagini sulle stragi del 1992 e sui “mandanti esterni” alla mafia. Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi sono già indagati a Firenze per le intercettazioni in carcere del boss Graviano. Secondo i pm e la Dia di Palermo, Graviano in carcere parlerebbe di qualcuno che gli ha chiesto una “cortesia” e in quel contesto nominerebbe Berlusconi. La condanna di Dell’Utri potrebbe spingere a riaprire l’inchiesta anche a Caltanissetta? La sentenza sulla Trattativa condanna Dell’Utri perché avrebbe avuto un ruolo nei riguardi del governo Berlusconi nel 1994 e anche io ho letto le intercettazioni in carcere di Giuseppe Graviano che sembra fare riferimenti a Dell’Utri e Berlusconi. Anche su questo punto penso che debbano essere fatte tutte le verifiche del caso. Penso che dopo tanto tempo è stato sistemato solo un primo tassello. È importante ma deve essere letto insieme agli altri per comprendere il quadro complessivo. Certo una cosa è sicura: lo Stato esce a pezzi da questa sentenza. La sentenza fotografa uno Stato che ha trattato con la mafia, però a fare la foto oggi c’è uno Stato che ha avuto il coraggio di fare un processo difficile… C’è uno Stato che ha fatto il proprio dovere. Questo processo non è una cosa strana. In uno Stato normale, fondato sul principio di legalità, questa sentenza dovrebbe essere considerata normale. Un grande esperto di diritto penale come il professor Fiandaca ha sostenuto che i carabinieri del Ros, anche se avessero cercato il contatto con la mafia per far cessare le stragi, potrebbero avere agito nell’ambito del lecito se non addirittura del “doveroso”. Lei che ne pensa? Non credo affatto che questo modo di porsi rispetto alla mafia sia lecito. Uomini come mio padre ritenevano di doversi opporre alla mafia fermamente. Non avrebbe mai accettato una cosa simile. Dopo la lettura del verdetto, il procuratore Vittorio Teresi ha dedicato questa sentenza a Paolo Borsellino e a Giovanni Falcone. Sono morti per il loro alto senso di fedeltà allo Stato, si meritavano questo e altro. Però questa sentenza è un punto di partenza, non di arrivo. Mi auguro che i magistrati continuino a lavorare per giungere a una verità non solo storica ma anche giudiziaria. Non ci voleva una sentenza per capire che questi comportamenti erano riprovevoli moralmente. Questa sentenza è il primo passo per stabilire che sono anche reati gravi. di MARCO LILLO | 22 APRILE 2018 IL FATTO QUOTIDIANO
La deposizione di Massimo Ciancimino al processo Mori
Udienze:
1/2/2010
2/2/2010
8/2/2010
2/3/2010
Queste sono tutte le dichiarazioni rilasciate da Massimo Ciancimino ai magistrati di Palermo tra il 2008 e il 2009, alcune intercettazioni, e le sue udienze al processo Mori:
Verbali:
- 08.04.07 PDF DOC ODT
- 08.05.15 PDF DOC ODT
- 08.06.06 PDF DOC ODT
- 08.06.18 PDF DOC ODT
- 08.06.21 PDF DOC ODT
- 08.10.02 PDF DOC ODT
- 08.12.12 PDF DOC ODT
- 09.01.23 PDF DOC ODT
- 09.04.02 PDF DOC ODT
- 09.05.21 PDF DOC ODT
- 09.06.12 PDF DOC ODT
- 09.06.30 PDF DOC ODT
- 09.07.01 PDF DOC ODT
- 09.07.16 PDF DOC ODT
- 09.07.30 PDF DOC ODT
- 09.08.04 PDF DOC ODT
- 09.09.18 PDF DOC ODT
- 09.09.29 PDF DOC ODT
- 09.10.19 PDF DOC ODT
- 09.10.29 PDF DOC ODT
- 09.11.20 PDF DOC ODT
- 09.12.22 PDF DOC ODT
fonte ARCHIVIO ANTIMAFIA
Oggetto del processo Mori è il mancato blitz del 31 ottobre 1995, che secondo il colonnello Michele Riccio avrebbe potuto portare all’arresto di Bernardo Provenzano a Mezzojuso (centro della provincia di Palermo) grazie alle rivelazioni del boss confidente Luigi Ilardo. La vicenda è ricostruita nel provvedimento con cui il gip Maria Pino ha archiviato la denuncia per calunnia nei confronti di Riccio presentata da Mori e Obinu (i due ufficiali hanno presentato ricorso per Cassazione).
Il decreto di archiviazione del gip Maria Pino
Le indagini di Caltanissetta
Una prima organica ricostruzione delle vicende legate alla trattativa Stato-mafia è contenuta nel “capitolo secondo” della richiesta di misura cautelare presentata dalla Procura nissena per la strage Borsellino. Il capitolo si intitola: “Le nuove indagini sul movente del delitto, la cosiddetta trattativa”.
L’indice del documento, e i relativi link:
2. Le indagini precedenti. L’attivismo di Mori e De Donno nella sentenza di Firenze. Gli ulteriori incontri del dott. Borsellino nel giugno-luglio 1992: gli incontri con l’on. Mancino, con il capo della Polizia Parisi, con quello della Criminalpol Rossi, con Bruno Contrada, con gli stessi Mori e De Donno e con il R.O.S.
2.1. La Sentenza di Firenze: la trattativa Mori-Ciancimino.
2.2. Le indagini svolte negli anni ’90 da questa Procura sui contatti del dott. Borsellino nel giugno/luglio 1992 con collaboratori di giustizia e personalità istituzionali.
2.2.1. Incontro/i con Parisi (capo della Polizia) e Rossi (capo della Criminalpol)
2.2.2. Incontro col Ministro Mancino
2.2.3. Incontri con Contrada
2.2.4. Incontri del dott. Borsellino con appartenenti al R.O.S.
2.2.5. Conclusioni sugli incontri del dott. Borsellino.
3. Le nuove risultanze: le dichiarazioni di Ciancimino Massimo e Brusca Giovanni.
4. Le conferme di Giovanni Ciancimino e dell’avv. Ghiron. Le dichiarazioni di alcuni testi che rivestivano, all’epoca, importanti ruoli istituzionali: l’on. Martelli, l’on. Violante, l’avv. Contri, la dott.ssa Ferraro.
5. I “nuovi” documenti raccolti: il c.d. “papello”, e le lettere di Provenzano a Ciancimino: loro non utilizzabilità probatoria, sulla base anche della relazione tecnica in atti. Le lettere autografe di Vito Ciancimino, ed i riscontri nelle stesse contenuti alla c.d. “trattativa”. I documenti su “Franco/Carlo” e la loro inattendibilità. L’inqualificabile comportamento processuale di Massimo Ciancimino sull’identificazione dell’agente segreto, e la conseguente integrale inutilizzabilità delle sue dichiarazioni al riguardo.
6. Le “ombre” sugli apparati dello Stato: il “traditore”. Le dichiarazioni di Pino Arlacchi, Alessandra Camassa e Massimo Russo. Le ulteriori dichiarazioni di Mutolo Gaspare. Le incertezze di Di Matteo, l’intercettazione del colloquio con la moglie, e le dichiarazioni di Brusca al processo d’appello Borsellino. Le parole della vedova del dott. Borsellino.
7. Le dichiarazioni degli on.li Mancino, Scotti e Rognoni. Le dichiarazioni di Mori e De Donno. Le provocazioni di Riina, ed il suo brusco voltafaccia maturato tra il 2009 ed il 2010.
8. L’ombra della trattativa del 1992 nell’anno delle stragi di Firenze, Milano e Roma: il contrasto al D.A.P. e nei Ministeri tra due strategie ugualmente tese a disinnescare la “bomba carceri” concedendo a Cosa Nostra un drastico arretramento del 41 bis O.P. Le ricadute sui riscontri all’esistenza della trattativa nel 1992.
La richiesta di misura cautelare presentata dalla Procura di Caltanissetta (il testo integrale)
Scarica l’indice del documento
Decreto di archiviazione del gip di Caltanissetta Tona per Bruno Contrada per le stragi PDF
CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA:
Sentenza di primo grado PDF
Sentenza di secondo grado PDF
Sentenza di rigetto della Cassazione PDF
Sentenza di rinvio della Cassazione PDF
Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo PDF
Bruno Contrada, ex funzionario, agente segreto è stato dirigente generale della Polizia di Stato, numero tre del Sisde, capo della Mobile di Palermo, e capo della sezione siciliana della Criminalpol. Il suo nome è associato ai presunti rapporti tra servizi segreti italiani e criminalità, culminati nella strage di via d’Amelio dove morì in un attentato il giudice Paolo Borsellino che in quel periodo indagava sui collegamenti tra mafia e Stato, e alla cosiddetta “zona grigia” tra legalità e illegalità. Contrada si è dichiarato collaboratore e amico di Borsellino, ma i familiari del magistrato assassinato hanno smentito fermamente. Anche Giovanni Falcone pareva non si fidasse di lui da tempo. In gioventù fu amico e collaboratore di Boris Giuliano, la cui moglie ha espresso invece perplessità sulla colpevolezza di Contrada. Arrestato il 24 dicembre 1992, Contrada, che si è dichiarato estraneo al reato, è stato condannato in via definitiva nel 2007 a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Nel 2011-12 venne respinta la richiesta di revisione del processo e sempre nel 2012 finì di scontare la pena. L’11 febbraio 2014 la Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha condannato lo Stato italiano poiché ha ritenuto che la ripetuta mancata concessione degli arresti domiciliari a Contrada, sino al luglio 2008, pur se gravemente malato e malgrado la palese incompatibilità del suo stato di salute col regime carcerario, fosse una violazione dell’art. 3 Cedu (divieto di trattamenti inumani o degradanti). Il 13 aprile 2015 la stessa Corte europea dei diritti umani ha condannato lo Stato italiano stabilendo un risarcimento per danni morali da parte dello Stato italiano perché non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa dato che, all’epoca dei fatti (1979-1988), il reato non era ancora previsto dall’ordinamento giuridico italiano (principio di nulla poena sine lege), e nella sentenza viene affermato che «l’accusa di concorso esterno non era sufficientemente chiara». In seguito a ciò, nel giugno 2015 è iniziata la revisione del processo di Contrada, poi respinta il 18 novembre. Gli avvocati di Contrada hanno presentato istanza di revoca della condanna, respinta dalla corte d’appello di Palermo, e infine accolta nel 2017 dalla corte di Cassazione, che ha dichiarato “ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza di condanna”.
LA TRATTATIVA NON E’ PRESUNTA L’ESISTENZA DI UNA VERA E PROPRIA TRATTATIVA DI TIPO POLITICO CON LA MAFIA, BASATA E FINALIZZATA SUL CONCETTO DEL DO UT DES E’ COSTITUITA DALLE STESSE PAROLE PRONUNCIATE DA MORI E DA DE DONNO, SENTITI NEL PROCESSO DINANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI FIRENZE. E NON SOLO IN QUEL PROCESSO.
PM Di Matteo – dalla requisitoria 15 dicembre 2017 processo Trattativa Stato-mafia “Rispetto a quella che viene definita sempre la “fantomatica” trattativa, la messinscena della trattativa, la pseudo trattativa e quant’altro, andiamo ad esaminare tutti quegli elementi che ci inducono ad affermare che quei dialoghi, quegli incontri riservati, nella casa di Roma, costituirono il terreno privilegiato di una vera e propria trattativa politica. E non certo come vogliono far credere gli odierni imputati, di una ordinaria, se pure eventualmente temeraria e spregiudicata iniziativa investigativa. Non c’entra nulla. Su questo processo si è detto e si continua a dire tutto. Non soltanto per criticare, che sarebbe ovviamente perfettamente comprensibile, ma per delegittimare, ridicolizzare il lavoro del Pubblico Ministero e l’onestà concettuale del Pubblico Ministero. Siamo abituati non solo a sentire parlare di presunta trattativa , ma a leggere ed ascoltare quotidianamente giudizi impietosi che definiscono l’ipotesi della trattativa una messinscena, una bufala, un teorema di magistrati politicizzati privo di qualsiasi appiglio probatorio completo. Questa continua, costante, pressante attuale ricostruzione mediatica stride clamorosamente con dati di fatto di solare evidenza e di dirompente forza dimostrativa E voglio partire da ciò che tutti dimenticano o fingono di dimenticare. Al di là e ancor prima di dichiarazioni di pentiti e dichiaranti, delle ricostruzioni di Massimo Ciancimino, delle affermazioniazioni di Brusca o di Cancemi, c’è ed assume oggi una forza incredibile nella sua chiarezza indiscutibile ed inequivocabile un elemento di prova acquisito quando nessuno ancora aveva nemmeno semplicemente ipotizzato di poter aprire un’indagine sui vertici del Ros e sui loro rapporti con Vito Ciancimino. Quell’elemento di prova, quella confessione dell’esistenza di una vera e propria trattativa di tipo politico con la mafia, basata e finalizzata sull’elementare concetto del do ut des, è costituita dalle stesse parole pronunciate da Mori e da De Donno allorquando vennero sentiti nel processo Bagarella + 25 dinanzi alla Corte di Assise di Firenze. Parole molto chiare, inequivoche assolutamente antitetiche rispetto a quelle rese in questa sede con le spontanee dichiarazioni. Parole e ricostruzioni che recuperiamo attraverso il testuale riferimento nelle sentenze alla Corte di Firenze che non lasciano spazio e dubbi ad interpretazioni diverse da quelle di un’ammissione di una vera e propria trattativa con i capi di Cosa Nostra attraverso Vito Ciancimino. Andiamo a leggere alcuni passaggi di queste dichiarazioni rese all’udienza pubblica in Corte di Assise a Firenze del 27 gennaio 1998. Leggo alcuni passaggi virgolettati. Teste Mori “Andammo da Ciancimino e dicemmo “Signor Ciancimino, che cos’è questa storia qui. Ormai c’è un muro contro muro . Da una parte c’è Cosa Nostra, dall’altra parte c’è lo Stato. Ma non si può parlare con questa gente?“. Guardate, basterebbero queste parole per dire: Ma quale attività investigativa? Ma quale pseudo trattativa? Il rappresentante del Comando Operativo del reparto di eccellenza dei Carabinieri del Ros va da un soggetto che sa essere in contatto con Riina e Provenzano e e gli dice “Ma cos’è questo muro contro muro?” come se fosse strano che ci sia muro contro muro tra l’organizzazione mafiosa più pericolosa al mondo e che poco tempo prima aveva fatto saltare in aria un pezzo di autostrada a Capaci e lo Stato. Che cos’è questa Signori Giudici Popolari se non già proprio subito una proposta di metterci d’accordo per fare venire meno il muro contro muro? Altro che Scotti alle Camere che dice che non ci può essere nessuna ipotesi di mediazione, di compromesso… Ha ragione Riina quando dice “Mi hanno cercato loro”. La sentenza Tagliavia ha perfettamente ragione quando dice che il dialogo con la mafia è stato cercato …non dallo Stato, lo Stato è un concetto molto più alto, ma da alcuni esponenti deviati dello Stato. Che cos’è questo muro, non si può parlare con questa gente? Non lo dice un pentito, lo dice Mori. Poi vedremo perché in quel momento, fra virgolette, se lo lascia scappare. Il 27 gennaio 98 in una Corte di Assise che giudicava i responsabili degli eccidi di Roma, Firenze e Milano, davanti alle parti civili, davanti ai parenti dei morti. “Ciancimino mi chiedeva se io rappresentavo solo me stesso o anche altri. Gli disse lei non si preoccupi, lei vada avanti. Lui capì e RESTAMMO D’ACCORDO CHE VOLEVAMO SVILUPPARE QUESTA TRATTATIVA” La trattativa non esiste, la trattativa è il frutto avvelenato di giudici politicizzati…la presunta trattativa, la pseudo trattativa…la bufala della trattativa, la patacca della trattativa… MORI IL 27 GENNAIO 1998 (la Corte si sbaglierà -dopo leggo alcuni passi della sentenza- dicendo che di quella trattativa ha parlato solo De Donno) DI TRATTATIVA HA PARLATO MORI E NON SOLO IN QUESTO PASSAGGIO, NE LEGGERO’ ALTRI, E LEGGERO’ ANCHE SCRITTI IN CUI MORI DEFINISCE QUESTA COSA UNA TRATTATIVA. C’è un altro passaggio molto importante che Mori sottolinea che i giudici della Corte di Assise annotano: la richiesta di Ciancimino di avere un passaporto. Testuali parole del Colonnello Mori. QUANDO PARLA DEL PASSAPORTO MORI DICE “CE LO CHIESE PER SEGUIRE ALCUNE FASI DELLA TRATTATIVA ALL’ESTERO.“ CAPITANO DE DONNO, sempre lo stesso giorno, 27 gennaio 98 “GLI PROPONEMMO DI FARSI TRAMITE PER NOSTRO CONTO DI UNA PRESA DI CONTATTO CON GLI ESPONENTI DELL’ORGANIZZAZIONE MAFIOSA COSA NOSTRA AL FINE DI TROVARE UN PUNTO DI INCONTRO, UN PUNTO DI DIALOGO finalizzato -De Donno è ancora più esplicito- alla immediata cessazione di queste attività di contrasto netto e stragista nei confronti dello Stato.” Troviamo un punto di dialogo, finitela con questo contrasto netto e stragista nei confronti dello Stato, si capovolgono i termini della questione. Signori giudici popolari, questo significa acquisire informazioni? Questo significa fare un’attività investigativa? O questo significa, come qui diciamo, condurre in maniera spregiudicata una scellerata e spregevole trattativa con i vertici della mafia mentre c’era ancora il sangue dei morti in terra? Proseguo nel citare alcune delle affermazioni rese sotto giuramento da De Donno “Successivamente Ciancimino ci fece sapere che VOLEVA INCONTRARCI E CI DISSE CHE L’INTERLOCUTORE, E CIOE’ LA PERSONA CHE FACEVA DA MEDIATORE FRA LUI E SALVATORE RIINA (quindi sapevano già tutto, sapevano che Ciancimino parlava con Riina) VOLEVA UNA DIMOSTRAZIONE, UNA PROVA CONCRETA DELLA NOSTRA CAPACITA’ DI INTERVENTO. QUESTA PROVA CONSISTEVA NELLA SISTEMAZIONE DELLE VICENDE GIURIDICHE PENDENTI DEL CIANCIMINO E NELLA CONSEGUENTE CONCESSIONE DI PASSAPORTO AL CIANCIMINO.“ Quindi De Donno dice ai giudici della Corte di Assise di Firenze che, avendo parlato con Riina, per capire fino a che punto fossero affidabili interlocutori istituzionali, affidabili dal punto di vista mafioso, Riina chiese “vediamo fino a che punto si spingono: dategli un passaporto a Ciancimino”. Ciancimino a sua volta aveva detto “mi può essere utile per proseguire la trattativa all’estero, perché poi nel frattempo, aveva spiegato bene Vito Cianciminoche il suo interlocutore principale era Provenzano e che forse poteva essere utile anche qualche incontro all’estero. Io mi permetto per l’ultima volta di sottolineare che, veramente, i primi a spiegare cosa fosse la trattativa, e che quella che loro hanno fatto è stata una trattativa con i vertici della mafia, sono stati proprio Mori e De Donno il 27 gennaio 1998. Io mi permetto di leggere solo alcuni passaggi della sentenza definitiva del 6 giugno 1998, quindi non c’era ancora praticamente nulla su quello che è il quadro probatorio oggi gravante nei confronti degli imputati carabinieri Alcuni passaggi delle valutazioni della Corte di Assise di Firenze: L’esame congiunto di ciò che hanno detto testi e collaboratori dimostra in maniera indiscutibile che nella seconda metà del 1992 vi fu un contatto fra i Ros dei Carabinieri e i capi di Cosa Nostra attraverso Vito Ciancimino. Andiamo alle parti maggiormente significative. Vanno dette senz’altro alcune parole non equivoche L’iniziativa del Ros, perché di questo organismo si parla, posto che vide coinvolto un capitano, il vicecomandante e lo stesso comandante del reparto, aveva tutte le caratteristiche per apparire come una trattativa. L’effetto che ebbe sui mafiosi fu quello di convincerli definitivamente che la strage era idonea a portare vantaggi all’organizzazione. Questo è scritto in una sentenza definitiva pronunciata da una Corte di Assise in nome del popolo italiano. Sotto questi profili, proseguono i giudici, non possono esservi dubbi di sorta, non solo perché di trattativa, dialogo, ha espressamente parlato il capitano De Donno, ma soprattutto perché non merita nessuna qualificazione diversa la proposta, non importa con quali intenzioni formulate, di contattare i vertici di Cosa Nostra PER CAPIRE COSA VOLESSERO IN CAMBIO DELLA CESSAZIONE DELLE STRAGI. Qui la logica si impone con tanta evidenza che non ha bisogno di essere spiegata. Quanto agli effetti che ebbe sui capi mafiosi, soccorrono assolutamente logiche, tempestive, congruenti le dichiarazioni di Brusca, poi ci torneremo. Intanto la conclusione. IL CONVINCIMENTO DI UNO STATO CHE VA A CERCARE, VA IN GINOCCHIO A DIRE “CHE COSA VOLETE PER FINIRE LE STRAGI?” rappresenta anche il frutto più velenoso dell’iniziativa in commento che al di là delle intenzioni con cui fu avviata, ebbe sicuramente un effetto deleterio per le Istituzioni, confermando il delirio di onnipotenza dei capi mafiosi e mettendo a nudo l’impotenza dello Stato. Si deve dire quindi che alla fine del 1992 si erano verificate le tre condizioni fondamentali per l’esplosione di violenza dei mesi successivi giacché metodo ed oggetto così come le finalità erano già presenti con sufficiente precisione alla mente di coloro che muovevano le fila di Cosa Nostra. Il disinganno susseguente alla stasi della trattativa e all’arresto di Riina faranno da detonatore ad una miscela già pronta e confezionata. E allora, altro che processo fondato sulle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, altro che presunta trattativa, altro che teoremi accusatori di magistrati mossi da intenti politici. L’elemento di base, la piattaforma conoscitiva sulle quali si innesteranno le numerose successive acquisizioni per affermare che trattativa ci fu, è costituito proprio da quello che SOLO QUANDO DOPO LE PRIME DICHIARAZIONI DI GIOVANNI BRUSCA, GLI UFFICIALI VENNERO CHIAMATI AL PROCESSO DI FIRENZE, ESSI STESSI IN QUELLA SEDE AFFERMARONO , IN UN MOMENTO IN CUI CON LA TRACOTANZA CHE CON DIVERSI ASPETTI E’ CARATTERISTICA DI ENTRAMBI, ERANO CONVINTI DELLA LORO ASSOLUTA IMPUNITA’. E avevano anche in quel momento una giustificazione, avevano ragione in quel momento a sentirsi intoccabili, non a sentirsi rispettosi della legge e delle prerogative di un ufficiale giudiziario, ma SENTIRSI INTOCCABILI. Quella convinzione trovava ragione d’essere nella incredibile inerzia della magistratura fronte a quello di cui quelle persone, Mori in particolare, si era già reso protagonista con la vicenda della mancata perquisizione del covo di Riina e con l’inganno alla Procura di Palermo circa la prosecuzione del servizio di osservazione sull’abitazione del Riina, con l’incredibile vicenda della mancata cattura di Nitto Santapaola a Barcellona, con il tragico epilogo della vicenda Ilardo dopo che il confidente aveva portato con mano il Ros alla possibilità non sfruttata di catturare Bernardo Provenzano… Quando il 27 gennaio 1998 Mori e De Donno si siedono davanti alla Corte di Assise di Firenze sono forti di tutto questo. Sono forti della vicenda che non era successo niente nei loro confronti sostanzialmente, neppure all’emergere della doppia refutazione sulla questione mafia-appalti. E in quel momento, forti di quel convincimento di impunità, seppur ovviamente omettendo il particolare decisivo della ricezione della trasmissione dell’elenco delle richieste di Riina, Mori e De Donno in quel momento forti del loro convincimento avevano parlato di trattativa per porre fine alle stragi e al muro contro muro tra lo Stato e la mafia. La verità è che in quel momento con l’instaurarsi dell’interlocuzione con Ciancimino si è venuta a determinare una situazione che dal punto di vista mafioso viene plasticamente descritta da ciò che Provenzano riferisce a Nino Giuffrè: Vito Ciancimino è in missione per conto di Cosa Nostra. Dal punto di vista chiamiamolo istituzionale, Mori e De Donno con l’avvallo e la copertura decisiva del comandante del Ros generale Subranni erano a loro volta in missione segreta per conto non del Governo, non dello Stato, ma di quella parte del potere rappresentato anche da uomini che rivestivano incarichi istituzionali, che deviando dagli interessi e dai comportamenti istituzionali VOLEVA ABBANDONARE LA LINEA DELLA CONTRAPPOSIZIONE FRONTALE SENZA SE E SENZA MA CON COSA NOSTRA PER ABBRACCIARNE UNA DI SEGRETA MEDIAZIONE. Erano in missione in funzione di porre fine o comunque ammorbidire quella strategia di Cosa Nostra che proprio la parte trattatista dello Stato aveva fatto finta di non comprendere quando il ministro Scotti era andato a riferire in Parlamento.
E QUELLA SEGRETA E INDECENTE MEDIAZIONE VENNA AUSPICATA, IDEATA, ORGANIZZATA E IN CONCRETO COLTIVATA DIETRO LE QUINTE SFRUTTANDO LA SPREGIUDICATEZZA DI UN UFFICIALE, COME IL COLONNELLO MORI, DA SEMPRE ABITUATO A MUOVERSI PIU’ NELL’OTTICA DI ESPONENTE SENZA SCRUPOLI DEI SERVIZI DI SICUREZZA ED IN SOSTANZIALE DISPREZZO DI QUEI PRINCIPI DI OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI CODICI, DI SUBORDINAZIONE FUNZIONALE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IL CUI RISPETTO INCOMBE o dovrebbe incombere su ogni ufficiale di polizia giudiziaria. Mori dopo avere lasciato il servizio, da ufficiale dei Carabinieri ha continuato a muoversi in quell’ottica propria del periodo in cui era ai servizi. L’ufficiale di polizia giudiziaria è un’altra cosa. Non si comporta a prescindere dall’autorità giudiziaria, nascondendo le cose all’autorità giudiziaria, ingannando l’autorità giudiziaria. C’è un episodio emblematico. Una frase riferita dal Dottor Canali in quest’aula. Il dottor Canali dopo la sparatoria del 6 aprile 93 aveva necessità di avere un colloquio con i superiori di quegli ufficiali, Sergio De Caprio e De Donno, che avevano esploso i colpi di pistola giusto giusto il giorno dopo si era avuta la notizia della presenza di Santapaola. Canali aveva chiesto un incontro tramite il maresciallo Scibilia con il colonnello Mori per cercare di capire meglio la situazione. Dopo più rifiuti Scibilia gli riferisce che Mori gli ha risposto dicendo che non ha tempo da perdere per parlare con il magistrato. Il totale disprezzo, la totale ritenuta indifferenza, rispetto delle regole. Lì c’era stata una sparatoria, c’era un procedimento per tentato omicidio nei confronti di Imbesi Salvatore. L’INTOCCABILITA’. IL MUOVERSI AL DI SOPRA E AL DI FUORI DELLA LEGGE PER SCOPI POLITICI QUALI ERANO QUELLI DI PORRE FINE AL MURO CONTRO MURO FRA LO STATO E LA MAFIA. Una conferma indiretta ma ulteriormente significativa del fatto che il rapporto con Ciancimino non fosse finalizzato ad acquisire notizie bensì a trattare con la mafia, è costituito dalle risultanze dell’acquisizione che nel 2009 scaturì dall’ordine di esibizione che congiuntamente noi PM di Palermo e di Caltanissetta nello stesso giorno notificammo senza preavviso ai servizi. Andammo direttamente al Ros dei Carabinieri. Noi chiedevamo di consultare con quell’ordine di esibizione da una parte tutto quanto fosse contenuto negli archivi, rispettivamente dei servizi e del Ros sulla persona di Vito Ciancimino dei suoi stretti congiunti, e dall’altra parte sulla strage di Via D’Amelio. Ogni tipo di documentazione.
Un passo indietro. Della sentenza Tagliavia sulle stragi di Firenze, Roma e Milano, più recente, un’altra Corte, un altra istruzione dibattimentale, altri Pubblici Ministeri, voglio leggervi questo passaggio “Una trattativa ci fu e venne quantomeno inizialmente impostata su un do ut des -si mettano il cuore in pace coloro che continuano a parlare sempre di pseudo trattativa, potranno continuare a farlo legittimamente però avessero almeno l’onestà concettuale di dire che una sentenza definitiva afferma che una trattativa ci fu e venne inizialmente impostata su un do ut des- L’iniziativa fu presa dai rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini di mafia. l’obiettivo era trovare un terreno di intesa con Cosa Nostra per far cessare la sequenza delle stragi. Vito Ciancimino corleonese amico di gioventù di Riina e Provenzanofu ritenuta la persona più adatta a far giungere il messaggio alla cupola. La trattativa si interruppe con l’attentato di Via D’Amelio di fronte al persistere del programma stragista. Proprio per queste ragioni l’uccisione di Borsellino è nelle motivazioni e nella tempistica una variante anomala. Per tutto il resto del ’92 Cosa Nostra restò in attesa di riaprire i canali di comunicazione e sospese l’iniziativa offensiva per stimolare la riapertura dei contatti e dare prova di determinazione anche per reazione contro l’arresto di Riina. DAL ’93 SU DECISIONE DELL’ALA OLTRANZISTA RAPPRESENTATA DA BAGARELLA, GRAVIANO, MESSINA DENARO, FU AVVIATA LA STAGIONE DEGLI ATTENTATI. ESSENDOSI ORAMI ATTESO TROPPO TEMPO PER DARE ULTERIORE SMOSSA, SI PENSO’ DI DARE IL COLPO DI GRAZIA SECONDO L’IDEA DI GIUSEPPE GRAVIANO RIPORTATA NEL PROCESSO DA SPATUZZA. LA SCELTA DI COLPIRE DEI CARABINIERI ORIGINO’ ANCHE DAL RANCORE PER L’ABBANDONO DEL NEGOZIATO INTAVOLATO DAI CARABINIERI MORI E DE DONNO, INIZIATIVA ACCOLTA ENTUSIASTICAMENTE DA RIINA. TRATTATIVA, NEGOZIATO, INIZIATIVA DEI CARABINIERI E NON DI RIINA, TERMINI UTILIZZATI E CONSACRATI DA UNA SENTENZA DEFINITIVA. Per quello che qui ci interessa di più, siamo andati al Ros centrale a Roma. e ci è stato messo a disposizione tutto quanto c’era agli atti del Ros su Vito Ciancimino. E anche quello che in gergo viene definito fascicolo P, dove P sta per personale, fascicolo che non riguarda una vicenda processuale in particolare ma riguarda e raccoglie tutto quello che su un determinato soggetto è archiviato dalla struttura investigativa. Nella nostra esperienza abbiamo apprezzato la meticolosità estrema che ogni reparto dei Carabinieri mette nell’archiviare le notizie, anche quelle apparentemente più inutili. Qualsiasi cosa viene molto diligentemente, normalmente, conservata e archiviata nel fascicolo personale, soprattutto se quel fascicolo si riferisce ad una persona che, come Vito Ciancimino, nel ’92, era già una persona assolutamente nota, con una proiezione politica importante ma più volte arrestato e sotto processo per fatti di mafia. L’esame della documentazione è importante nella misura in cui consente di verificare ciò che non esiste. Ciò che era talmente segreto e fuorilegge da non potere essere nemmeno consacrato in un riservato appunto interno da contrarre agli atti quantomeno per lasciare una traccia di ciò che era stato fatto. Non c’è nulla. Una riga. Un’annotazione. Una relazione di servizio. Nulla che si riferisce ai rapporti, agli incontri fra mori, De Donno e Ciancimino nel 1992 a Roma. Vedremo che c’è un’annotazione postuma, si capisce fatta da Mori, anche se non è firmata, ma è postuma perché fa già riferimento agli interrogatori di Ciancimino resi nel ’93 all’autorità giudiziaria, che è una ricostruzione postuma, che si capisce perfettamente essere di molto successiva e probabilmente postuma rispetto alle dichiarazioni di Brusca nel ’97 al processo di Firenze. Ma nel ’92 quando per loro stessa ammissione si incontravano a casa di Vito Ciancimino dopo averlo intercettato per vedere di far venire meno il muro contro muro tra la mafia e lo Stato i carabinieri non lasciano nulla, non lasciano una traccia di quegli incontri. Di quegli incontri andavano a dire non certo ai magistrati, non certo alla DIA, non ai carabinieri. Andavano a dire a politici come Ferraro, Fernanda Contri, Luciano Violante e quant’altro. Ed è un dato che dobbiamo valutare appieno nella sua significatività volta a tutelare la segretezza di un rapporto illecito, alla luce delle prassi antitetiche normalmente seguite dal Ros. Il silenzio, il non lasciare traccia scritta, lo possiamo interpretare solo ed esclusivamente nell’ottica di una vicenda di cui non doveva restare alcuna traccia né in quel momento né per il futuro. E ciò proprio nella consapevolezza di una condotta, quella di trattare con il nemico, completamente estranea e contraria alla legge. Confrontate per cortesia il silenzio sul ’92 con la restante parte del fascicolo di Ciancimino con quello che è annotato rispetto agli anni 91, rispetto al periodo dal gennaio 93 in poi fino a quando Vito Ciancimino il 18 dicembre 92 torna in carcere. Vedrete che prima e dopo il 92 vengono conservate, archiviate anche le notizie più insignificanti. Tutto. Nel ’92 agli atti del Ros Vito Ciancimino non esiste. Veramente sembra rievocare quello che in quest’aula quel coraggioso e valoroso ufficiale, il colonnello Giraudo, ci ha detto circa il cosiddetto protocollo fantasma. C’è un appunto di Mori oggetto contatti con Vito Ciancimino fascicolo P che si capisce essere assolutamente postumo. Anche in quello che c’è, c’è qualcosa di interessante. Cosa scrive Mori riferendosi ai tempi passati. Ciancimino disse che i suoi interlocutori avevano accettato il dialogo che si sarebbe dovuto sviluppare con la sua mediazione partendo dalle seguenti irrinunciabili condizioni: trattativa da tenersi all’estero e quindi restituzione al Ciancimino che ne era stato privato, del passaporto. Mori, come dicevo, non solo ha parlato di trattativa ma lo ha anche scritto. Ci sono altri atti allegati dai quali si evince l’importanza del canale Ghiron. Con l’avvenuto arresto (Ciancimino venne arrestato per ordine della Corte di Assise di Palermo il 19 dicembre 92) ritenni che il dialogo con Ciancimino si fosse definitivamente interrotto. Invece nel gennaio 93, non ricordo se prima o dopo la cattura di Riina,ecco fui contattato dall’avvocato Giorgio Ghiron, difensore di Vito Ciancimino, il quale mi comunicò che il suo cliente desiderava incontrare me e il capitano De Donno. Abbiamo ancora degli allegati, importanti perché testimoniano che questo contatto Ciancimino Vito-Carabinieri, a prescindere dall’autorità giudiziaria di Palermo che invece nel febbraio 93 aveva iniziato gli interrogatori, si protrae nel tempo. Nel 95 Vito Ciancimino manda un telegramma al colonnello Mario Mori “urge incontrare lei insieme al capitano De Donno possibilmente in presenza procuratore Caselli oppure soli”. Con l’annotazione di Mori “informato l’avvocato Ghiron dell’intendimento dottor Caselli di incontrare il signor Ciancimino” Ancora, per dimostrare la possibilità di accedere al carcere nel quale era detenuto Vito Ciancimino da parte di Mori e De Donno al di là e al di fuori delle occasioni degli interrogatori con i magistrati vi segnalo un allegato dell’8 marzo 1994 conservato agli atti del Ros a firma Procuratore Caselli “A seguito mia nota del 25 gennaio 94 e successiva del 18 febbraio 94, mentre confermo autorizzazione a colloqui di personale del vostro ufficio con il signor Vito Ciancimino nonché la consegna al medesimo della documentazione oggetto della nota 25 gennaio 94, prego riferire allo stato degli atti con trasmissione al mio ufficio di copia del materiale da inoltrare o già inoltrato a Vito Ciancimino”. Da qui si deduce che comunque anche, non solo prima del primo interrogatorio, il colloquio investigativo che avevano fatto, ma anche nella costanza degli interrogatori fatti alla Procura di Palermo Mori e De Donno avevano perfettamente la possibilità di interloquire con Vito Ciancimino, di consegnare a lui materiale, di farsi consegnare materiale attraverso l’autorizzazione che il Procuratore Caselli gli aveva fatto. Qualche cenno ulteriore sul contenuto degli atti acquisiti al Ros nei fascicoli stavolta concernenti la strage di Via D’Amelio. Agli atti di quel fascicolo riservato spicca la presenza di annotazioni di notizie confidenziali su un attentato ritenuto imminente a Paolo Borsellino. Spicca la presenza di annotazioni relative a segnalazioni confidenziali fatte ai Carabinieri circa il coinvolgimento nella preparazione nell’esecuzione della strage di Pietro e Gaetano Scotto. Spicca la presenta di un’annotazione concernente notizie, leggo testualmente, informalmente acquisite a Palermo circa l’andamento e le prese di posizione dei singoli sostituti nel corso della prima riunione della DDA successiva alla strage, quindi c’è di tutto, pure quello che erano riusciti ad orecchiare sul contenuto di colloqui riservati e interni tra i magistrati di Palermo dopo la strage di Via D’Amelio.
Agli atti del Ros c’è tutto questo. MANCA COMPLETAMENTE OGNI, ANCHE GENERICO, RIFERIMENTO ALL’INCONTRO DEL 25 GIUGNO 1992 ALLA CASERMA CARINI DI PALERMO TRA IL DOTTOR BORSELLINO, MORI E DE DONNO. Del quale incontro l’autorità giudiziaria e in particolare per prima quella di Caltanissetta, venne a conoscenza dall’annotazione nell’agenda grigia del giudice, quella che non è scomparsa. Allora, voglio riflettere un attimo per quello che può riguardare questo processo e quello che è stato detto in questo processo, sul significato di questa assenza. Noi riteniamo che se, come gli imputati dicono, ma lo dicono dal 1997 in poi, quell’incontro avesse avuto come oggetto l’intenzione di Paolo Borsellino di approfondire il tema delle indagini di mafia-appalti dei Carabinieri, quell’assenza non si spiega. Se realmente il 25 giugno il colloquio tra Paolo Borsellino, Mori e De Donno avesse avuto ad oggetto l’interesse del giudice all’approfondimento di quell’inchiesta, Mori e De Donno avrebbero avuto non soltanto il dovere ma anche l’interesse professionale personale di rappresentare immediatamente il dato ai magistrati che si occupavano dell’indagine sulla strage e che quindi per determinarne la causale dovevano minuziosamente ricostruire le attività del Dottor Borsellino nel periodo immediatamente precedente. Se veramente Paolo Borsellino avesse detto “voglio approfondire l’indagine mafia-appalti, per favore consentitemi di farlo perché non mi fido di quello che stanno facendo i colleghi di Palermo”, il 20 luglio di mattina i Carabinieri si dovevano presentare ai magistrati di Caltanissetta per dire: attenzione giudici che Paolo Borsellino stava facendo questo. Tanto più che loro a quell’indagine attribuivano, giustamente, importanza. Niente. Silenzio. Nonostante gli ottimi rapporti con la Procura della Repubblica di Caltanissetta, perché poi ogni tanto esce fuori ma noi siamo stati zitti perché con la Procura di Palermo non c’erano buoni rapporti o per questo o per quell’altro motivo… no qui non c’è nessun tipo di dubbio. Avrebbero potuto e dovuto presentarsi per dire questo. Stanno zitti fino a quando nel 1997 dopo che si pente Siino e viene fuori nuovamente la polemica sulla famosa consegna abusiva del rapporto mafia-appalti sul possibile coinvolgimento di magistrati di Palermo, Mori e De Donno, De Donno in particolare, alla Procura di Caltanissetta chiamato per sapere cosa ne sapeva di quella cosa dice: guardate che Paolo Borsellino il 25 giugno ci ha detto di questa cosa di mafia-appalti. Come si fa a giustificare l’assenza di un’annotazione, se fosse stato questo il vero oggetto del dialogo o il vero scopo di Paolo Borsellino ammesso che abbia potuto fare riferimento al dialogo, mafia-appalti… E’ possibile che delle cose che assumono un rilievo importante non venga lasciata traccia? Voi potete mai credere -ora sta diventando quasi una moda dire io non ho detto niente allora perché nessuno mi chiamò- ma voglio dire, il vertice del Ros con il rapporto che avevano, anche di natura stretta, almeno fino ad un certo punto, almeno alcuni, con Paolo Borsellino, è possibile che se fosse stata vera quella versione dell’oggetto del colloquio del 25 giugno non lasciano una traccia scritta e soprattutto non si presenta l’indomani ai procuratori di Caltanissetta a riferire questa cosa?
Allora io ribadisco. La verità è un’altra su quell’incontro del 25 giugno 1992.
Che ci fu. Poi nelle ore pomeridiane Paolo Borsellino andò a Casa Professa e PROBABILMENTE SEGNO’ ULTERIORMENTE LA SUA CONDANNA DICENDO CHE SI SAREBBE RECATO ALLA PROCURA DI CALTANISSETTA PER RIFERIRE FATTI CHE RITENEVA GRAVI E DOVEVA RIFERIRE. SPECIFICHERA’ POI AL GIORNALISTA DAVANZO CHE LO INTERVISTAVA SU QUESTO E CHE GLI CHIEDEVA MA LEI DOTTOR BORSELLINO ANDRA’ A CALTANISSETTA PER RIFERIRE LA SUA VERSIONE, PER RIFERIRE COSA PENSA DELLA CAUSALE DELL’OMICIDIO DEL GIUDICE FALCONE, E BORSELLINO RISPONDERA’ “NO. IO SONO UN MAGISTRATO E SO CHE UNA PERSONA INFORMATA DEI FATTI DEVE RIFERIRE FATTI. IO ANDRO’ A CALTANISSETTA PER RIFERIRE FATTI DI CUI SONO VENUTO A CONOSCENZA.”
Il 25 giugno del 1992 i Carabinieri del Ros non potevano certo riferire ai PM di Caltanissetta quale era stato l’oggetto vero, l’oggetto principale dell’interlocuzione con Borsellino, perché quell’oggetto prendeva spunto dal famoso anonimo Corvo due e quindi LAMBIVA TROPPO PERICOLOSAMENTE L’ARGOMENTO DELLA TRATTATIVA CHE MORI E DE DONNO AVEVANO GIA’ INTRAPRESO CON VITO CIANCIMINO. Perché quell’anonimo in sostanza nel suo nucleo centrale PARLAVA DI UN DIALOGO E DI UNA TRATTATIVA IN CORSO TRA UN’ALA DELLA DC IN PARTICOLARE RAPPRESENTATA COME ELEMENTO DI PUNTA DA MANNINO E SALVATORE RIINA.
Io vi prego di rileggere con attenzione le dichiarazioni, utilizzabili solo parzialmente, di uno dei testi i cui verbali sono stati prodotti, e per fortuna prodotti, anche questo signore poi è venuto ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Mi riferisco a Carmelo Canale. Così come capiterà anche per Giovanni Ciancimino. Le dichiarazioni del 22 febbraio 2011, non c’è possibilità nemmeno di poter pensare che Canale sia stato suggestionato nelle sue risposte dalle domande perchè veniva chiamato come teste della difesa e rispondeva alle domande dei difensori degli imputati in quel processo. A proposito del 25 giugno Carmelo Canale dice “Un giorno eravamo al Tribunale, alla Procura. Dottor Borsellino mi chiese nella circostanza di incontrare ma molto riservatamente e all’interno non della Procura, ma della sezione anticrimine di Palermo l’allora colonnello Mori e il capitano De Donno, perché secondo quello che io ricordo e che mi riferì Dottor Borsellino, vi era una voce all’interno da parte dei colleghi suoi, -quindi dei magistrati, non mi ha detto il nome altrimenti lo avrei pure rivelato – una voce che dava il capitano De Donno come il compilatore di un anonimo, perché girava un anonimo. E allora io chiesi tramite un mio comandante della sezione di interpellare il colonnello Mori e di fissare un appuntamento con il Procuratore Borsellino. L’appuntamento ci fu poi Borsellino si guardò bene, né io gli chiesi, di dire di cosa avevano parlato. Ma il motivo per il quale il dottor Borsellino vuole incontrare riservatamente Mori e De Donno, non è certo il motivo dell’approfondimento dell’indagine mafia-appalti. Ma è il motivo relativo all’anonimo.
E’ L’ANONIMO NELLA CRUDA SOSTANZA FACEVA RIFERIMENTO AD UNA TRATTATIVA – Questi sono fatti. Questa è una versione, parziale, per carità, perché nessuno era presente all’interlocuzione tra il dottor Borsellino e gli ufficiali Mori e De Donno, ma noi sappiamo da un teste assolutamente -di cui non si può sospettare una vicinanza alla Procura, se non altro perché era stato processato dalla Procura di Palermo- il fatto è questo; borsellino chiede a Canale di attivarsi per l’incontro riservato con Mori per cercare di capire chi avesse compilato l’anonimo. E l’anonimo aveva ad oggetto sostanzialmente i contatti assolutamente impropri, fuorilegge rappresentati in questo modo, per trovare una soluzione al problema di politici -guarda caso Mannino e la mafia. Il 25 giugno 1992 si incontrano Mori e De Donno con Paolo Borsellino e si può ritenere sulla base di quello che dice Canale abbiano parlato anche dell’anonimo, mentre nello stesso momento, al di là dei teoremi fantasiosi dei Pubblici Ministeri, l’agenda di Contrada ci dice che Subranni e Contrada vanno a trovare il ministro Mannino nelle ore serali per discutere di Anonimo Corvo Due e situazione Sicilia
“L’’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino ha detto il falso”, esordisce il pubblico ministero Nino Di Matteo. La requisitoria del processo “Trattativa Stato-mafia” affronta uno dei capitoli più delicati. Il titolare del Viminale nel 1992 è accusato di falsa testimonianza. “Ha scelto la menzogna, l’omertà istituzionale”, accusa Di Matteo. “Le affermazioni di Nicola Mancino sull’incontro con il giudice Paolo Borsellino al Viminale nel giorno del suo insediamento sono state oscillanti e contraddittorie”. In un primo tempo, Mancino negò di aver visto il magistrato. Ma sono soprattutto le parole dell’allora ministro della Giustizia Claudio Martelli ad aver messo nei guai l’esponente politico. “Mi lamentai con lui del comportamento del Ros”, ha messo a verbale l’ex ministro della Giustizia. “Mi sembrava singolare che i carabinieri volessero fare affidamento su Vito Ciancimino“. Martelli ha affermato senza mezzi termini di aver chiesto conto e ragione a Mancino dei colloqui riservati fra gli ufficiali del Ros e l’ex sindaco mafioso di Palermo. Mancino ha sempre negato: ha detto di non avere mai parlato del Ros e di Ciancimino con Claudio Martelli. “Dice il falso”, accusa Di Matteo. In aula, vengono lette le intercettazioni fra Mancino e Loris D’Ambrosio, allora consigliere giuridico del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. “In quelle intercettazioni – dice Di Matteo – risulta il tentativo da parte del privato cittadino Mancino di influire e condizionare l’attività giudiziaria e addirittura le scelte di un collegio dei giudici”. Mancino non voleva essere messo a confronto con Martelli. “Quel tentativo – prosegue Di Matteo – invece di essere stoppato, venne alimentato e assecondato dal Quirinale”. Il pubblico ministero cita l’allora presidente Napolitano: “Fu irrituale il suo suggerimento, esternato da D’Ambrosio al telefono, di fare un confronto fra Mancino e Martelli, soluzione che lo stesso Mancino scartò subito”. Per Di Matteo, Mancino aveva “una vera e propria ossessione” e “fece un pressing costante nei confronti della presidenza della Repubblica, per ostacolare le indagini della procura di Palermo”. Dopo una lettera del segretario generale della presidenza della Repubblica, l’allora procuratore generale della Cassazione Esposito convocò il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso. Che dichiarò, senza mezzi termini: “Non c’è stata alcuna violazione del protocollo sul coordinamento fra le procure di Palermo e Caltanissetta (che indagavano sulla trattativa – ndr), non ci sono gli estremi per l’avocazione dell’inchiesta”. Dice oggi Di Matteo: “Il procuratore nazionale fu convocato oralmente, Grasso invece pretese di dare una risposta scritta. Il comportamento di Grasso fu intransigente e corretto”. Nella sua risposta, Grasso mise in oggetto: relazione onorevole Mancino. “Grasso riportò tutto alla cruda realtà”, dice Di Matteo. “Qualcuno avrebbe voluto aiutare il privato cittadino Mancino. Grasso, invece, respinse al mittente ogni pressione”.” Fonte : Gruppo FB FraternoSostegno ad Agnese Borsellino 14.11.2018
TRATTATIVA STATO-MAFIA – PARZIALI AMMISSIONI DI MANNINO che ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante l’udienza del 22 marzo Il 18 dicembre era stato notificato un decreto di citazione a De Mita a comparire come teste sulla trattativa Stato-mafia, il 21 (la notizia non era stata data dai giornali) Mannino si preoccupa di mandare Gargani da De Mita per dare la stessa versione. Affermazioni utili anche alla difesa di Sandra Amurri.
ORA MANNINO SI TRADISCE: “SI’, PARLAMMO DI DE MITA” -TRATTATIVA, L’EX MINISTRO AMMETTE L’INCONTRO SULLA DEPOSIZIONE DELL’EX LEADER L’incontro al bar Giolitti del 21 dicembre 2011? “Con Garganici scambiammo le informazioni che quella mattina erano sui giornali, che De Mita sarebbe stato sentito dai pm di Palermo, e gli dissi: ricorda a De Mita il congresso di Agrigento, quello in cui isolai Ciancimino”.
Lo aveva definito “il delirio di una mitomane”, ma giovedì scorso, nel processo di appello per lo stralcio della Trattativa in cui è imputato dopo l’assoluzione in primo grado, Calogero Mannino ha ammesso che l’incontro narrato in aula dalla giornalista del Fatto Sandra Amurri, nel quale, allarmato e preoccupato, avrebbe detto a Giuseppe Gargani “questa volta questi qui (i pm di Palermo, ndr) ci fottono”, c’è stato e che i due parlarono proprio della convocazione di De Mitacome teste sulla trattativa Stato-mafia. Mannino per la prima volta ammette l’incontro, continua a negare che l’oggetto fosse la sostituzione di Scotti con Mancino al Viminale nella stagione delle stragi, ma inciampa in un ricordo sbagliato: la notizia della convocazione di De Mita, che dice di avere appreso dai giornali di quella mattina, in realtà non era stata pubblicata, come ha ricordato il pm Nino Di Matteo nella requisitoria dell’11 gennaio 2018: “Il colloquio al bar Giolitti avviene il 21 dicembre – ha detto nell’aula bunker – era stato notificato un decreto di citazione a comparire a De Mita il 18 dicembre. Il 21 Mannino sa della citazione, che non era comparsa su nessun giornale, e si preoccupa di mandare l’avellinese Gargani dall’avellinese De Mita per dare la stessa versione che conviene a noi: cioè che Scotti fu sostituito per l’incompatibilità, altrimenti i pm di Palermo ci fottono’’. L’ex ministro chiede la parola negli 11 minuti finali dell’udienza, e dopo avere rivendicato “la scelta di campo” democristiana nella lotta alla mafia (e negato di avere fatto pressioni sul vice direttore del Dap Francesco Di Maggio “che neanche conoscevo” per attenuare il 41 bis), ammette che l’incontro al bar Giolitti di Roma era finalizzato a “ricordare” a De Mita, convocato tre giorni prima dai pm di Palermo, un pezzo di storia della Dc in Sicilia. Non la sostituzione di Scotti con Mancino dell’estate delle stragi, nel ’92, come sostengono i pm, ma il congresso di Agrigento di nove anni prima, quello in cui su iniziativa dello stesso Mannino la Dc isolò per la prima volta Vito Ciancimino, divenuto troppo ingombrante e imbarazzante Le ammissioni di Mannino, sia pure parziali, si interrompono qui. Il resto, per lui, è riportato in modo “farneticante” dalla Amurri, compreso l’accenno a Ciancimino(“Massimo dice un sacco di bugie, ma su di noi ha detto la verità”), che Mannino continua a negare perché il figlio di don Vito “non ha mai parlato di me nei suoi verbali”. E però Ciancimino jr è stato citato dal pm come teste (e ammesso) proprio per il ruolo centrale attribuito dall’accusa all’accertamento del “nesso di causalità” su cui si regge buona parte dell’accusa, e cioè il collegamento tra l’iniziativa del Ros di interloquire con Vito Ciancimino e il presunto accordo tra Mannino e Cosa nostra, “per salvarsi e attuare un programma politico favorevole ad una trattativa, volta a condizionare, partecipando alla volontà ricattatoria stragista della mafia, le scelte del governo”. L’inedita ammissione di Manninoservirà anche alla difesa della collega Amurri, già condannata dal tribunale a pagare 15 mila euro di spese e ora impegnata nell’appello del processo in cui aveva querelato Mannino per averla definita tra l’altro “agente volontaria della Stasi o del Kgb” e “mitomane”, espressioni che il giudice di primo grado ha ritenuto “riconducibili all’esercizio del diritto di critica… proporzionate e strettamente collegate alle accuse mossegli nell’articolo”. Ritenendo quell’ascolto casuale, seduta a un bar una fredda mattina di dicembre, un’ “indebita interferenza in una conversazione privata”. Come se denunciando un fatto processualmente rilevante, ascoltato fortuitamente, la giornalista avesse invaso la privacy di Mannino e Gargani. – di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza Il Fatto Quotidiano | 25 marzo 2018
LA COSIDDETTA TRATTATIVA Documento in cui compaiono le dichiarazioni ufficiali della signora Agnese Borsellino rese durate l’indagine sul Borsellino quater. Si tratta del capitolo secondo della richiesta di misura cautelare presentata dalla Procura nissena per la strage Borsellino. Il capitolo si intitola: “Le nuove indagini sul movente del delitto, la cosiddetta trattativa”.
“LE OMBRE” SUGLI APPARATI DELLO STATO: IL “TRADITORE”. Le dichiarazioni di Pino ARLACCHI, Alessandra CAMASSA e Massimo RUSSO. Le ulteriori dichiarazioni di MUTOLO Gaspare. Le incertezze di DI MATTEO, l’intercettazione del colloquio con la moglie, e le dichiarazioni di BRUSCA al processo d’appello Borsellino. Le parole della vedova del dott. BORSELLINO.Sempre nel campo delle indagini svolte, e per completezza, devono essere riportate tutte quelle ulteriori acquisizioni che hanno consentito di far ulteriore luce sugli ultimi giorni del dott. BORSELLINO, e di acquisire elementi circa la sua scoperta – avvenuta proprio nell’ultimo periodo – di un “tradimento”.Un tradimento, è bene chiarire sin dall’inizio, di cui il dott. BORSELLINO venne a conoscenza seguendo da vicino le indagini sulla strage di Capaci dopo che il dott. BORSELLINO venne trasferito alla Procura di Palermo nel febbraio 1992 continuò a frequentarlo perché a sua volta applicata alla DDA di Palermo per le indagini sulla mafia di Partanna (TP);in una delle occasioni in cui si trovava a Palermo per lavoro, nel corso di una discussione riguardante le indagini sulla strage di Capaci (durante la quale i due giovani magistrati lo mettevano in guardia su possibili rischi che lo riguardavano per la sua intenzione, palesata all’esterno, di indagare su quell’eccidio) il dott. BORSELLINO si era disteso sul divano e, piangendo (fatto assolutamente insolito) aveva detto loro che un amico l’aveva tradito; nel corso di un successivo incontro, di saluto alla Procura di Marsala, il mar. CANALE le aveva confidato che il dott. BORSELLINO si fidava troppo del ROS, ed in specie di MORI e SUBRANNI, che invece erano “pericolosi“; in effetti, alla teste risultavano “ottimi rapporti” esistenti tra BORSELLINO e SUBRANNI, che esulavano anche i semplici rapporti lavorativi: l’impressione che ebbe fu che il “traditore” fosse un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, persona anziana ed “autorevole“
Gli incontri con don Vito A Roma, all’indomani della strage di Capaci, il cap. Giuseppe De Donno aveva, difatti, chiesto a Massimo Ciancimino, che aveva conosciuto in occasione delle inchieste da lui stesso avviate sul padre Vito Calogero Ciancimino, di procurargli un incontro con quest’ultimo, al fine di avviare un colloquio che potesse fornire utili informazioni per le indagini in corso, nonché per la cattura dei latitanti Riina e Provenzano, e che potesse anche offrire una qualificata “chiave di lettura” sulle dinamiche interne a “cosa nostra” e sugli obiettivi che l’organizzazione intendeva perseguire con l’attacco allo Stato. Questi tentativi di approccio furono in un primo tempo respinti dal Ciancimino, che poi invece, a fine luglio, dopo la strage di via D’Amelio, mutò opinione, acconsentendo ad incontrare il cap. De Donno. Per ricostruire questa complessa e per molti versi, “prima facie”, anomala vicenda è necessario richiamare il contesto nell’ambito del quale essa maturò: è evidente che gli assassinii di Salvo Lima (il 12 marzo), dei giudici Falcone (il 23 maggio) e Borsellino (il 19 luglio) ponevano lo Stato italiano, nelle persone dei rappresentanti delle sue istituzioni e dei responsabili del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico, di fronte alla gravissima emergenza costituita dalla volontà stragista inequivocabilmente manifestata da “cosa nostra”, e dunque di fronte alla necessità di reperire, con ogni iniziativa utile, informazioni od elementi capaci di decifrare ed auspicabilmente neutralizzare la strategia dell’organizzazione.
Vito Ciancimino, per il ruolo di “dominus” degli appalti che aveva rivestito ed all’epoca ancora in parte rivestiva, come accertato dallo stesso cap. De Donno titolare delle investigazioni sfociate nel cd. rapporto “mafia-appalti”, costituiva senz’altro una cerniera con l’organizzazione e poteva fungere da canale privilegiato di collegamento con il gotha mafioso, sia per i sicuri contatti in suo possesso, che lo collocavano vicino al clan corleonese ma anche al Provenzano, sia perché, in attesa degli esiti definitivi di un procedimento a suo carico, versava in condizioni di particolare “fragilità psicologica” che potevano indurlo a rendersi disponibile ad una collaborazione, al fine di evitare il rischio di una nuova carcerazione (che invece di lì a pochissimo, in piena “trattativa”, sarebbe giunta) che, dal punto di vista umano e per le sue condizioni di salute, non si sentiva più in grado di sopportare, essendo già stato duramente provato dall’esperienza del carcere subita con il primo arresto del 3 novembre 1984.
Il predetto De Donno ed il col. Mori erano ben consapevoli di questa superiorità psicologica ed agirono decisi a sfruttarla (v. dichiarazioni rese dallo stesso Mori nel verbale di ud. del 16.1.03 innanzi al tribunale di Milano, acquisite al giudizio il 9.5.05 e deposizione resa all’ud. del 11.7.05 dal cap. De Donno).
I contatti – per come riferito in termini assolutamente coincidenti dal Ciancimino nel suo manoscritto “I carabinieri”, sequestrato il 17 febbraio 2005 nell’ambito di un procedimento avviato nei confronti del figlio Massimo ed acquisito in copia all’ud. del 9.5.05, e dai due ufficiali coinvolti – si articolarono nei seguenti punti: al primo incontro con il cap. De Donno, Vito Ciancimino si dichiarò disponibile a collaborare ma richiese di parlare ad un “livello superiore”; il cap. De Donno fece il nome del col. Mori e tutti e tre si incontrarono a Roma, in agosto 1992, nella casa del Ciancimino, il quale si disse pronto a cercare un contatto con l’associazione mafiosa per avviare un dialogo, chiedendo l’autorizzazione a spendere i loro nomi; una volta trovato questo interlocutore, che viene definito nel manoscritto “l’ambasciatore” (e che solo successivamente identificherà in Antonino Cinà, medico della famiglia Riina, legato anche al Provenzano), ilCiancimino gli rivelò i nomi dei due esponenti dell’Arma con cui era in contatto, ma avrebbe ottenuto una reazione di iniziale diffidenza, in quanto l’intermediario gli avrebbe risposto che i due ufficiali avrebbero dovuto prima pensare a risolvere le sue vicende giudiziarie; in un secondo momento, “l’ambasciatore” avrebbe invece superato tale diffidenza, decidendosi a ricontattarlo per rilasciargli una sorta di “delega” a trattare; il Ciancimino convocò allora il col. Mario Moried il cap. De Donno per un altro incontro nella sua casa di Roma a fine settembre 1992, nel quale finalmente precisare i termini di quell’inconsueto “negoziato”, termini che tuttavia gli si rivelarono deludenti e tali da non consentire margini di trattativa. Difatti, come testualmente annotato dal Ciancimino e confermato dai protagonisti in dibattimento, “i Carabinieri mi dissero di formulare questa proposta: consegnino alla giustizia alcuni latitanti grossi e noi garantiamo un buon trattamento alle famiglie”, proposta che venne ritenuta totalmente inadeguata dal Ciancimino stesso e come tale neppure comunicata all’ “ambasciatore”, con il quale si voleva mantenere comunque aperto un canale di dialogo. Per questo motivo, scriveva il Ciancimino nel proprio manoscritto, egli avrebbe riferito una proposta “bluff”, secondo cui un noto esponente politico si sarebbe prestato a garantire la salvezza del circuito imprenditoriale di interesse dell’organizzazione, minacciato da “tangentopoli”, che però non avrebbe avuto alcun seguito. A questo punto il Ciancimino – si legge negli appunti – avrebbe realizzato che non c’erano margini per alcuna trattativa, alla quale, tra l’altro, neppure “l’ambasciatore” aveva dimostrato vero interesse, per cui decise – come da sua annotazione testuale – di “passare il Rubicone”, ovvero intraprendere una reale collaborazione con i carabinieri, proponendo di infiltrarsi nell’organizzazione per conto dello Stato, intenzione che esplicitò ai nominati Mori e De Donno nel corso di un successivo incontro avvenuto a dicembre 1992, chiedendo in cambio che i suoi processi “tutti inventati” si concludessero con esito a lui favorevole ed il rilascio del passaporto. Nella medesima occasione, domandò – come si legge nel manoscritto e confermato dagli ufficiali – che gli fossero esibite le mappe di alcune zone della città di Palermo ed atti relativi ad utenze Amap, in quanto, essendo a suo dire a conoscenza di alcuni lavori che erano stati eseguiti anni addietro da persone vicine al Riina, avrebbe potuto fornire qualche elemento utile alla sua localizzazione. Immediatamente dopo, il 19.12.92, il Ciancimino venne nuovamente tratto in arresto.
VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI DI CAMASSA ALESSANDRA DEL 14 LUGLIO 2009 Effettivamente tra me ed il dott. BORSELLINO esisteva un rapporto di fraterna amicizia e confidenza (…). Paolo Borsellino fu applicato alla DDA di Palermo verso la fine del 1991 e formalmente trasferito intorno a febbraio del 1992; io continuai a frequentarlo anche per ragioni d’ufficio, poiché ero stata a mia volta applicata ad un procedimento della DDA di Palermo relativo alla mafia del Belice; in altri termini, poiché Paolo aveva seguito quel procedimento quando era ancora a Marsala, io sovente riferivo a lui sugli sviluppi delle indagini, tanto che ricordo di aver suscitato il malcontento del Procuratore GIAMMANCO, il quale mi fece sapere, tramite Paolo, che voleva essere informato direttamente. In uno degli incontri, avvenuto in un giorno compreso tra il 22 ed il 25 giugno 1992, si verificò un episodio che mi impressionò, poiché per la prima volta in vita mia, a prescindere dal giorno della morte del dott. FALCONE – vidi Paolo piangere, cosa che non aveva mai fatto essendo un “uomo all’antica”. Preciso che ero in compagnia del dott. Massimo RUSSO, che seguiva con me il processo contro la mafia di Partanna, ed entrammo nella stanza di Paolo sita al secondo piano della Procura di Palermo una mattina in cui Paolo si trovava in Ufficio ed io avrei dovuto incontrare il Procuratore GIAMMANCO, anche perché alla fine di Giugno, se mal non ricordo, sarebbe scaduta la mia applicazione al procedimento per la mafia di Partanna (…). Ricordo che Paolo – anche questo era insolito – si distese sul divano e, mentre gli sgorgavano delle lacrime dagli occhi , disse: “non posso pensare … non posso pensare che un amico mi abbia tradito”. Non chiesi spiegazioni perchè ero molto turbata per il pianto di Paolo e perché compresi che era molto addolorato e stupito per il tradimento di un amico, del quale, però, si comprendeva non aveva intenzione di rivelare l’identità. In altri termini, si trattava di uno sfogo piuttosto che dell’esigenza di effettuare delle confidenze Lo sfogo di Paolo fu susseguente ad alcune domande che io e Massimo gli avevamo posto sui pericoli cui si esponeva tra l’altro interessandosi alle indagini relative alla strage di Capaci, per le quali era spesso in contatto con il collega VACCARA della Procura di Caltanissetta. Circostanza, questa, che avevo personalmente constatato e che era stata oggetto di confidenza da parte di Paolo in precedenti occasioni, essendo egli convinto che fosse doveroso, da parte sua, fornire ogni possibile contributo per l’utile svolgimento delle indagini Escludo categoricamente che in tale occasione il dott. BORSELLINO abbia parlato di trattative tra Stato e Cosa Nostra e ribadisco che io ed il collega RUSSO non avevamo la più pallida idea di chi fosse la persona da cui si sentiva tradito, e le ragioni di tale tradimento. Tuttavia ebbi la netta impressione che l’episodio che aveva determinato la reazione emotiva di Paolo fosse recentissimo. Non escludo, altresì, che tale incontro sia avvenuto nella tarda mattinata del giorno in cui ero andata a conferire con il Procuratore GIAMMANCO, che mi aveva ricevuta dopo qualche ora di attesa. Quella fu l’ultima volta in cui vidi Paolo in un’occasione privata ed infatti, prima della strage del 19 luglio, lo incontrai nuovamente, per l’ultima volta, in un’occasione pubblica e , segnatamente, il 4 luglio 1992, allorché organizzai una cerimonia di saluto presso la Procura di Marsala in onore di Paolo. Ricordo, in particolare, che in quest’ultima occasione incontrai il Maresciallo CANALE in quale, come del resto aveva fatto in precedenza, ebbe a confidarmi che a suo avviso il dott. BORSELLINO si fidava troppo dei vertici del ROS, facendo il nome dell’allora col. MORI e del Gen. SUBRANNI, sostenendo egli che si trattava di personaggi “pericolosi”, senza precisare altro. La cosa mi colpì perchè, parlando con Paolo in recedenti occasioni, avevo maturato la convinzione che egli avesse ottimi rapporti con il generale SUBRANNI; intendo dire rapporti che esulavano le semplici relazioni d’ufficio. Ciò naturalmente costituiva una mia impressione basata sulle parole di Paolo, poiché non ho mai conosciuto il generale SUBRANNI. Posso tuttavia confermare che Paolo nutriva sensi di stima ed affetto nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, tanto che aveva rapporti di amicizia con molti di loro, tra i quali ricordo Giovanni ADINOLFI, Raffaele – credo che questo sia il nome – DEL SOLE, un ufficiale di cognome OBINU, nonché il colonnello GENTILE. Tale era l’ammirazione di Paolo nei confronti di appartenenti dell’Arma che persino nelle indagini preferiva fare riferimento agli organismi investigativi dei carabinieri piuttosto che ad altri organismi investigativi. Altra vicenda che ricordo è la seguente. Agli interrogatori espletati insieme a Paolo presso l’Ufficio dell’Alto Commissariato era spesso presente una persona che avevo pensato fosse un poliziotto, mentre poi seppi, a distanza di anni, trattarsi di un appartenente ai Servizi Segreti, distaccato presso l’Ufficio dell’Alto Commissario: si trattava di Ninni SINESIO, persona con la quale il dott. BORSELLINO aveva rapporti confidenziali (…)il dott. BORSELLINO l’aveva segnalato ai vertici della Polizia, tra cui anche il dott. PARISI ed il dott. CONTRADA, perché fosse trasferito nella città di Catania (…) Ricordo che il 20 luglio 1992 ebbi modo di apprendere, parlando con il dott. INGROIA e con il mar. CANALE che il collaboratore di giustizia Gaspare MUTOLO aveva informalmente anticipato a Paolo BORSELLINO, con il quale aveva cominciato a collaborare,che avrebbe reso dichiarazioni accusatorie nei conrfronti del dott. Domenico SIGNORINO e del dott. Bruno CONTRADA (…) La sera stessa o il giorno successivo ricevetti una telefonata di Ninni SINESIO che, insistentemente, mi chiedeva di incontrarlo (…) SINESIO mi fece moltissime domande sulle indagini più recenti di Paolo, chiedendomi se, in particolare, si fosse interessato di un personaggio agrigentino che io ritenni potesse essere Calogero MANNINO (…) SINESIO chiese anche di SALAMONE (…) In questo contesto, fidandomi del SINESIO (…) gli riferii delle anticipazioni fatte da MUTOLO a Paolo su CONTRADA e SIGNORINO. Mi colpì il fatto che SINESIO, immediatamente dopo, si mise a tossire , lasciando intendere che era stato colto da un malore, e si allontanò ritornando dopo circa un quarto d’ora, palesemente sconvolto (…) Non ritengo che SINESIO possa identificarsi nell’amico da cui Paolo si sentiva tradito perché egli era troppo giovane; viceversa, la mia impressione fu che Paolo si fosse sentito tradito da una persona più adulta ed autorevole, con la quale vi era anche un rapporto d’affetto. Pensai che potesse trattarsi di un ufficiale dei carabinieri, ma ciò esclusivamente perché ero a conoscenza del grande rispetto e della grande riconoscenza che Paolo nutriva verso l’Arma Dunque, le parole della dott.ssa CAMASSA – pur fornendo molteplici elementi utili e preziosi – non ci consentono di identificare con certezza né il c.d.traditoredi BORSELLINO, né quale fosse stato “il contenuto” del suo tradimento. Quanto alla prima questione, comunque, le parole del dott. RUSSO, anche lui presente all’incontro con il dott. BORSELLINO descritto dalla dott.ssa CAMASSA, ci consentono di restringere il cerchio, individuando, con ragionevole probabilità in un appartenente all’Arma dei carabinieri (dal dott. BORSELLINO così tanto amata e rispettata) il c.d. “traditore”. (…)”