
VIDEO
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Seduta n. 17 di Mercoledì 18 ottobre 2023
Bozza non corretta TESTO DEL RESOCONTO STENOGRAFICO
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Salvatore Borsellino che saluto e che è collegato da remoto, e del suo legale, avvocato Fabio Repici, in presenza, a cui do il benvenuto.
Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell’audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta degli auditi o dei colleghi. In tal caso non sarà più consentita la partecipazione da me da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web-tv.
Do direttamente la parola al dottor Borsellino, che ringrazio a nome di tutta la Commissione per la sua presenza.
SALVATORE BORSELLINO. Buongiorno. Chiedo scusa a questa Commissione per non avere potuto assicurare la mia presenza fisica ma purtroppo le mie condizioni di età e di salute non mi permettono di affrontare delle trasferte di questo tipo. Ho chiesto di essere audito dalla Commissione, insieme con il mio avvocato difensore di parte civile Fabio Repici, che è anche avvocato dei sette figli della mia defunta sorella, Adele, nipoti di Paolo Borsellino, per fare sentire anche la mia voce, di fratello di Paolo, dopo quella dei figli di mio fratello.
Poiché sono l’ultimo ancora in vita della famiglia di origine di Paolo Borsellino, lo faccio anche a nome delle mie sorelle Adele e Rita, che non ci sono più, e soprattutto lo faccio a nome di nostra madre, Maria Pia Lepanto, che, come tante altre mamme, a cui troppo presto sono stati strappati i figli, ha dovuto chiudere gli occhi per sempre senza potere vedere né verità né giustizia per l’assassinio di suo figlio. Sono stati questi lunghi anni, anni di depistaggi, di mancate indagini, di sentenze spesso contraddittorie, in cui, se sono state assicurati alla giustizia forse alcuni di quelli che materialmente hanno ucciso Paolo Borsellino, la stessa cosa non è avvenuta per quelli che hanno agito nell’ombra, che hanno voluto la sua morte.
Non sono stati neanche messi alla luce i veri motivi dell’accelerazione di questa strage che, se fosse stata messa in atto soltanto dall’organizzazione mafiosa, non sarebbe avvenuta soltanto 57 giorni dopo l’altra strage, quella di Capaci, che alla strage di via D’Amelio io credo sia indissolubilmente legata.
Paolo, mio fratello, ha cominciato a morire il 23 maggio del 1992. Ma se da un lato ai figli di Paolo mi lega il terribile dolore per questa morte annunziata e l’insopprimibile esigenza di verità su una strage nella quale è stata stroncata la vita del loro padre e di mio fratello, da essi è emersa una posizione processuale che si è venuta a differenziare nel corso dei tanti processi, arrivando purtroppo, e con mio grande dolore, a influire anche sui rapporti personali. Devo dire, da parte mia, che ho ascoltato con sconcerto le dichiarazioni fatte in questa sede nei confronti dei due magistrati o meglio di un magistrato e di un ex magistrato, oggi senatore della Repubblica. Mi riferisco a Nino Di Matteo e a Roberto Scarpinato ai quali mi sento invece di dover manifestare pubblicamente e in questa stessa sede la mia stima e la mia gratitudine per avere in questi lunghi anni ricercato con tutte le loro forze quella verità e quella giustizia per le quali continuo a combattere in nome di quell’agenda rossa che ho scelto a simbolo della mia lotta. Sono ben altri i magistrati verso i quali bisognerebbe puntare il dito.
Quel Giovanni Tinebra che avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere di aver avallato un evidente depistaggio nel corso di ben due processi e quel Pietro Giammanco che Paolo Borsellino così come Giovanni Falcone ha ostacolato in ogni modo, fino a concedergli la delega per indagare sui fatti di mafia a Palermo soltanto quando la macchina carica di esplosivo che avrebbe dovuto ucciderlo era già pronta davanti al portone di via D’Amelio.
Questo, devo dire, è stato evidenziato anche nella deposizione di mia nipote Lucia, ma questi magistrati – e mi pesa chiamarli così – avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere del loro operato finché erano in vita e invece, per quanto mi risulta, è stato solo il mio avvocato, Fabio Repici, a chiamare in aula, inserendolo nella sua lista dei testimoni, nel corso del Borsellino-quater, Pietro Giammanco, che poi in realtà non si presentò adducendo motivi di salute.
Eppure contro Pietro Giammanco io il dito lo avevo già puntato, ma rimasi inascoltato, in un pezzo che scrissi in una domenica del settembre del 2008, e che fu pubblicato anche sulla rivista MicroMega nel 2010. Si intitolava «Lampi nel buio» e in esso immaginavo via D’Amelio come un set teatrale, completamente immerso nelle tenebre, dove però ogni tanto uno squarcio di luce dal cielo illuminava le scene di quella tragedia.
Questo è il pezzo in cui quasi quindici anni fa e quando era ancora in vita, parlavo di Pietro Giammanco. Ve lo leggo. «Ecco, un altro lampo che squarcia le tenebre. Sono le sette del mattino del 19 luglio in via Cilea e a casa del giudice, che è in piedi dalle cinque, arriva una telefonata dal suo capo, Pietro Giammanco.
Non gli ha mai telefonato a quell’ora e di domenica. Non lo ha avvisato di un rapporto del ROS in cui si rivelava che era arrivato a Palermo un carico di esplosivo per l’attentato al giudice, che ha potuto conoscere la circostanza per caso, all’aeroporto, incontrando il ministro Scotti (?) e che sui motivi di questa omissione con il suo capo ha avuto un violento alterco. Non gli ha ancora concesso, da quando è rientrato da Marsala, prendendo le funzioni di procuratore aggiunto a Palermo, la delega per condurre le indagini in corso sulle cosche palermitane e in conseguenza la possibilità di interrogare, senza una sua espressa autorizzazione, pentiti-chiave come Gaspare Mutolo e Leonardo Messina.
Ora, il 19 luglio quando la macchina per l’attentato è già posteggiata davanti al numero 19 di via D’Amelio gli telefona per dirgli che gli concede quella delega e gli dice una frase che oggi suona in maniera a sinistra: Così si chiude la partita. La moglie del giudice, Agnese, lo sente urlare al telefono e dire: No, la partita comincia adesso.
Lo stesso giudice, qualche tempo prima, aveva confidato al maresciallo Canale, che lo affiancavano nelle indagini, che in estate avrebbe fatto arrestare Giammanco, perché dicesse cosa sapeva sull’omicidio Lima, dal recarsi ai funerali del quale lo stesso Giammanco venne dissuaso solo all’ultimo momento da un altro procuratore».
Perplesso mi ha lasciato anche nella ricostruzione dell’avvocato dei figli di Paolo il diverso peso dato ad alcune parole di Paolo e ad altre parole e circostanze riferite da sua moglie Agnese.
Sono state messe quasi sullo stesso piano parole per me evidentemente ironiche, come quelle: «Quei due non me lo raccontano giusta» con parole pesanti, terribili come quelle riferite di aver appreso che il generale Subranni era punciutu, o sulla raccomandazione di chiudere le finestre perché qualcuno da una postazione situata nel castello Utveggio poteva spiarlo.
Proprio da quel castello Utveggio, dal quale forse è stata condotta la regia dell’operazione concertata, insieme con l’attuazione della strage, del furto dell’agenda rossa. Forse è da quest’agenda rossa, la scatola nera della strage di via D’Amelio, che si dovrebbe ripartire per arrivare alla verità. Dal furto di quell’agenda compiuto, ne sono certo, proprio da quelle stesse mani che hanno voluto la morte di mio fratello.
Non sto parlando della mafia, ma di pezzi deviati dello Stato perché è certo che non siano state mani di mafiosi a portare a compimento quel furto. È proprio da questo che si dovrebbe ripartire, e non da un dossier mafia-appalti che se può essere considerato una concausa, non è sicuramente la vera causa dell’improvvisa accelerazione di una strage che a quel punto non poteva essere più rimandata.
Occorreva eliminare, e in fretta, chi rappresentava un ostacolo insormontabile per un disegno criminoso teso con l’ausilio anche dell’organizzazione mafiosa e della eversione nera a cambiare gli equilibri di questo nostro disgraziato Paese che da queste stragi, che io ho chiamato e continuerò sempre a chiamare stragi di Stato, è stato sempre segnato.
La chiave di questa accelerazione va cercata semmai nelle parole pronunciate da Paolo alla Biblioteca comunale di Palermo il 25 di giugno, nel suo ultimo discorso pubblico. Paolo chiede di essere sentito dalla Procura di Caltanissetta per dire quello che sa e che ha scoperto sulla strage di Capaci e da quella strage sono ormai passati più di trenta giorni senza che Paolo sia stata ancora chiamato. Paolo dice: «Questi elementi che porto dentro di me debbo per prima cosa assemblarli e riferirli all’autorità giudiziaria che è l’unica in grado di valutare quanto queste cose che io so possano essere utili alla ricostruzione dell’evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone.
Per prima cosa ne parlerò all’autorità giudiziaria poi, se è il caso, ne parlerò in pubblico». Ebbene, dopo queste parole, la convocazione di Paolo a Caltanissetta non può essere più rimandata.
C’è il rischio che Paolo riveli in pubblico quello che i giudici non vogliono ascoltare. Paolo viene convocato a Caltanissetta per la settimana successiva al 19 luglio, ma intanto parte il conto alla rovescia per l’attuazione della strage, per la sua eliminazione. Paolo non arriverà mai a testimoniare in quella Procura in cui a collaborare alle indagini verrà poi irritualmente chiamato quel Bruno Contrada sul quale Paolo sta raccogliendo le rivelazioni di Mutolo.
Verrà chiamato soltanto quando la sua morte è stata ormai decisa, quando il suo tempo è ormai arrivato. E qui io penso che bisogna cercare i motivi dell’improvvisa accelerazione della strage, e non in un incontro alla caserma Carini che Paolo non annota neppure nella sua agenda grigia e di cui anche il ROS ha parlato soltanto 5 anni dopo e facendo affermazioni che soltanto Paolo – che però ormai non c’è più – potrebbe confermare o smentire. E a fermare le stragi non poteva essere certo la quantomeno improvvida iniziativa di chi è andato a bussare a certe porte richiedendo a un tramite di Salvatore Riina del perché di questo muro contro muro. È servita anzi a rafforzare l’idea che la strategia stragista pagava, se era in grado di mettere in ginocchio lo Stato, di spingerlo a farsi avanti, a scendere a patti, è servita solo a scatenare altre stragi, a causare altre vittime innocenti, questa volta sul continente, e ad attentare, per aumentare il livello del ricatto, anche al patrimonio artistico dello Stato.
Sulla sparizione di quell’agenda rossa non si è mai veramente indagato, non c’è stato mai un vero processo, tranne quello in cui, in fase addirittura di udienza preliminare, e quindi senza alcun dibattimento, è stato assolto dall’accusa di aver sottratto l’agenda quel capitano Arcangioli che è stato ripreso e fotografato, mentre si allontana dalla macchina di Paolo ancora in fiamme, portando in mano la borsa di Paolo in cui sicuramente l’agenda era contenuta.
Ma a chi è stata consegnata quella borsa, prima di essere rimessa sul sedile della macchina che intanto continuava a bruciare? Nel corso di questi anni abbiamo studiato a fondo ogni singolo fotogramma, ogni ripresa che ci è stato possibile ottenere, girata in via D’Amelio nell’immediatezza della strage. Abbiamo ascoltato e confrontato le diverse testimonianze, spesso discordanti, costellate di «non ricordo» di chi è venuto in qualche maniera in contatto con la borsa di Paolo che conteneva l’agenda. Abbiamo individuato i fotografi e gli operatori, richiesti i rullini.
Alcuni ci sono stati dati, altri, specie quelli in possesso di grandi organi di informazione, ci sono stati inspiegabilmente negati.
Siamo andati ogni 19 luglio a rilevare le ombre del sole all’ora della strage sui palazzi per mettere le foto e le riprese nella giusta sequenza. Abbiamo ricostruito i movimenti di che è entrato in contatto con la borsa, abbiamo individuato i personaggi presenti che non sono nemmeno mai stati sentiti come testimoni.
Abbiamo studiato le relazioni di servizio, spesso prodotte soltanto tardivamente.
Abbiamo individuato a chi, presente in via D’Amelio subito dopo la strage, il capitano Arcangioli può avere portato la borsa, dopo averla prelevata dalla macchina di Paolo e questo ufficiale, oggi generale, Borghini, non è stato mai sentito nemmeno come testimone.
Il risultato di tutto questo lavoro è stato inserito in un documento audiovisivo che è stato presentato in udienza alla Corte nel Borsellino-quater il giorno dell’arringa finale del mio avvocato per dare il nostro contributo alle indagini che altri, e con ben altri mezzi, avrebbero dovuto portare avanti. Il risultato di tutto questo è stato che i PM presenti in aula, all’inizio dell’udienza, appena cominciata la proiezione del documento, si sono alzati e sono andati via, senza poi tornare in aula nel corso dell’intera giornata.
Della raccomandazione della Corte, contenuta nella sentenza, di approfondire le indagini sulla sparizione dell’agenda rossa non è stato dato fino ad oggi alcun seguito. Voglio ricordare che in quel processo è stata soltanto la mia parte civile, insieme con il difensore dell’imputato, a chiedere l’assoluzione di quel Vincenzo Scarantino, anche lui, seppure in forma diversa, vittima della strage di via D’Amelio, processato per calunnie a cui era stato costretto con torture fisiche e psicologiche in un carcere dello Stato e da funzionari dello Stato, troppo tardivamente processati.
Così come sono stato soltanto io in tutta la mia famiglia a rifiutare di firmare nei primi due processi la richiesta di un impossibile risarcimento comminato nei confronti di chi, a causa di quel depistaggio, era stato condannato per un delitto che non aveva commesso.
Voglio precisare che in quei due processi, viziati da quello che è stato definito nel Borsellino-quater il più grande del depistaggio della storia, il mio avvocato non era quello di oggi, Fabio Repici, che in quel dibattimento questo depistaggio non avrebbe sicuramente sostenuto e neppure avallato.
Il Borsellino-quater era stata una svolta, aveva fatto sperare di vedere finalmente almeno un barlume di verità, un miraggio di giustizia, ma poi sono arrivate una serie di sentenze contraddittorie, per l’ultima delle quali aspettiamo ancora una motivazione, le quali hanno fatto quasi del tutto svanire questa mia speranza.
Nella prima, quella d’appello, si assolvono gli imputati dello Stato perché il fatto non costituisce reato. Nell’altra, quella in Cassazione, si assolvono tutti per non avere commesso il fatto.
Ma il fatto c’è, la strage c’è stata, Paolo e i suoi ragazzi sono stati uccisi! Dopo quella strage, altre ce sono state e altre vittime innocenti hanno perso la vita. Quelle che mancano, e ormai sono quasi sicuro di non vedere nel corso di quel destino di vita che mi resta, sono una verità e una giustizia che forse pochi, troppo pochi, in questo Paese vogliono davvero.
Io ho finito e lascio la parola al mio avvocato, grazie.
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. Ringrazio con grande sincerità il presidente e i componenti della Commissione antimafia. Capirete, dopo aver ascoltato Salvatore Borsellino, quanto sia stato un carico morale enorme quello di sostenere la difesa di un uomo che ha fatto della parresia la sua scelta di vita. Proprio per rispetto della Commissione – so che parlando alla Commissione sto parlando al Parlamento della Repubblica – io che sostengo pressoché quotidianamente che le aule di giustizia siano il luogo dove la parresia debba essere coltivata, in questa sede credo che ancora di più questo sia massimamente doveroso ed è con questo spirito che proverò a riferire alla Commissione antimafia ciò che ritengo possa essere utile.
Come già detto da Salvatore Borsellino, ho assunto la sua difesa per la prima volta nel processo denominato Borsellino-quater.
Quel processo prese avvio dalla epifania del depistaggio, avvenuto con le menzogne fate sottoscrivere a Vincenzo Scarantino.
La prima cosa che ritengo debba essere tenuta in considerazione è che l’epifania del depistaggio la nostra nazione la deve non a un uomo o una donna dello Stato, ma a un uomo di Cosa nostra, che si chiama Gaspare Spatuzza.
L’avvio del disvelamento di ciò che era successo attraverso le losche manovre che avevano condotto, dopo un lungo inseguimento, alla accettazione del ruolo di falso collaboratore di giustizia da parte di Vincenzo Scarantino è avvenuta solo grazie a Gaspare Spatuzza il quale iniziò a collaborare nel giugno del 2008.
A onor del vero va ricordato alla Commissione che, mentre si trovava detenuto in carcere e non aveva ancora inteso collaborare con la giustizia, Gaspare Spatuzza già nel giugno del 1998, audito in sede di colloquio investigativo in carcere dall’allora Procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna e dall’allora sostituto procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, aveva detto delle cose che contraddicevano in modo ufficiale il depistaggio Scarantino.
Basta solo riportare quello che nel colloquio investigativo Gaspare Spatuzza disse a proposito del furto della FIAT 126, in relazione al quale si era autoaccusato Vincenzo Scarantino. Gaspare Spatuzza riferì a quei due magistrati più o meno la seguente frase: «Guardate, io non so se davvero Vincenzo Scarantino abbia rubato la FIAT 126 utilizzata in via D’Amelio, ma se per caso lui l’avesse rubata io vi posso dire una cosa certa e cioè che a lui poi è stata rubata». Quello che riferiva quelle parole era il vero ladro della FIAT 126, su incarico di Giuseppe Graviano, che è il regista della fase esecutiva per Cosa nostra della strage di via D’Amelio.
Nel giugno del 2008, finalmente Gaspare Spatuzza decide di collaborare con la giustizia e firma un contratto con lo Stato.
Da lì parte il ribaltamento degli accertamenti che avevano portato a delle sentenze irrevocabili e la prima volta in cui questi accertamenti arrivarono a un risultato di pubblica conoscibilità avvenne nel marzo del 2012, allorché fu eseguita una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il tribunale di Caltanissetta, in relazione a due personaggi in quel momento indagati per la strage di via D’Amelio che non erano mai stati processati.
Si tratta di Salvatore Mario Madonia, uno della genia dei Madonia di Resuttana Palermo, che è stato il mandamento che ha avuto la funzione di pilastro per l’arrivo della egemonia di Salvatore Riina e dei corleonesi in occasione della seconda guerra di mafia, e di Vittorio Tutino. Con la misura cautelare del marzo del 2012, tutti coloro che non erano impegnati nello svolgimento delle indagini conobbero per la prima volta il depistaggio Scarantino.
Di lì a poco fu celebrato un incidente probatorio, qui a Roma, nell’aula bunker del carcere di Rebibbia, in fase di indagini, come è ovvio per ogni incidente probatorio, per l’audizione di alcuni collaboratori di giustizia, le cui rivelazioni erano ritenute dalla Procura della Repubblica particolarmente rilevanti ai fini del futuro processo.
In quell’occasione – questo è il motivo per cui lo ricordo – tanto è l’anelito di verità che muove Salvatore Borsellino che, pur ancora in fase di indagini e quindi in fase in cui le persone offese dal reato – in questo caso i familiari delle vittime della strage – non hanno possibilità di costituirsi parte civile, perché come i giuristi presenti sanno è necessario l’esercizio dell’azione penale, la persona offesa dal reato, Salvatore Borsellino, chiese, naturalmente ottenendolo perché previsto dalla legge, di poter partecipare all’incidente probatorio. Così, il primo difensore di parti private che poté muovere domande ai collaboratori di giustizia, dopo la scoperta del depistaggio Scarantino, fui proprio io.
Da lì venne poi il dibattimento del processo Borsellino-quater e l’impegno che a me fu dato da Salvatore Borsellino è quello che, nella sua cifra morale e giuridica, si può trarre da quel suo scritto che vi ha letto poco fa, intitolato «Lampi nel buio». L’incarico che mi fu dato fu quello di fare ogni possibile sforzo al fine di accertare quanta più porzione di verità possibile dopo i cumuli di menzogne che avevano calpestato la giustizia e soprattutto il desiderio e la necessità di verità da parte dell’intera Nazione.
Fu per questo motivo, come ricordava Salvatore Borsellino, che nel formulare le richieste di prova, al momento del deposito della lista testimoniale, cercammo di colmare lacune che ancora nel 2013 – questa è la data dell’inizio del dibattimento del processo Borsellino-quater – erano rimaste tali.
Questo lo dico perché lo spirito di parresia impone che non si possa riscrivere la storia a cagione degli anni che passano e degli sfumati ricordi che possono essere provocati dal tempo che passa.
Quando nel 2013 depositammo la lista testimoniale, indicammo come testimone per la prima volta innanzi a un giudice di Caltanissetta il dottor Giovanni Tinebra, indicammo per la prima volta come testimone innanzi a un giudice di Caltanissetta il dottor Pietro Giammanco, indicammo – e questa è cosa che non è abbastanza ricordata – come testimoni per la prima volta i figli di Paolo Borsellino.
Il dottor Manfredi Borsellino e la dottoressa Lucia Borsellino per la prima volta hanno testimoniato innanzi all’autorità giudiziaria, rendendo dichiarazioni importantissime che hanno trovato adeguato spazio nella motivazione della sentenza della Corte d’assise di Caltanissetta del 20 aprile 2017.
Per la prima volta dunque il dottor Manfredi Borsellino e la dottoressa Lucia Borsellino furono convocati come testimoni innanzi all’autorità giudiziaria di Caltanissetta.
Il dottor Giammanco non fu poi sentito perché i tempi del processo e l’ordine di assunzione delle prove implica che i testimoni delle parti civili vengano sentiti una volta terminata l’assunzione delle prove richieste dalla pubblica accusa.
Quindi, quando arrivò il nostro turno – eravamo già nella seconda metà del 2015 – e convocai il dottor Giammanco, egli si trovava già in condizioni di salute che non gli consentivano di presentarsi a Caltanissetta in udienza e quindi la sua audizione saltò. Certo è che noi ce l’avevamo messa tutta, come avrebbero potuto sicuramente fare le altre parti e anche la Procura della Repubblica, sia quella del passato sia quella del processo Borsellino-quater.
Non era avvenuto: infatti la prima volta che il dottor Giammanco fu sentito da un magistrato della Procura di Caltanissetta avvenne nel 2017, con un’audizione a domicilio perché egli non era più in grado di deambulare e questo implicò che la sua audizione avvenisse in quella forma.
Quando nel 2013 depositai la lista testimoniale, io chiesi alla Corte che il dottor Giammanco venisse chiamato a rispondere sui suoi rapporti con il dottor Paolo Borsellino nel periodo successivo alla strage di Capaci, sulle sue interlocuzioni con il dottor Paolo Borsellino sull’assegnazione della delega della DDA di Palermo per gli affari relativi al territorio di Palermo, con specifico riferimento anche alla raccolta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, su quanto a lui eventualmente riferito dal dottor Paolo Borsellino circa informali rivelazioni a lui fatte da Gaspare Mutolo, poi naturalmente – come io faccio e come tanti miei colleghi fanno in ogni processo – su quanto a sua conoscenza sui fatti di cui ai capi d’imputazione e sulle persone a vario titolo coinvolte. Questo lo faccio presente per dire che già nel 2013 c’era chi aveva indicato l’importanza di quella audizione che naturalmente sarebbe stata un’audizione non propriamente di comodo per il dottor Giammanco e di questo eravamo ben consapevoli.
A quel processo è seguito – non solo sostanzialmente, ma anche formalmente – come conseguenza il processo che convenzionalmente è stato denominato «processo sul depistaggio», a carico di tre appartenenti alla Polizia di Stato Bo, Mattei e Ribaudo, nel quale per uno dei tre imputati c’è stata sentenza di primo grado di assoluzione e per gli altri due imputati di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. La sentenza è stata impugnata dalla Procura della Repubblica e quindi il giudizio di secondo grado avrà inizio il prossimo 31 ottobre.
Anche in quel processo ho operato nell’interesse e su spinta di Salvatore Borsellino sempre nella stessa linea di colmare i vuoti nella ricostruzione dei fatti ed è questo il motivo per cui, dopo aver consentito ai due figli maggiori di Paolo Borsellino di testimoniare al processo Borsellino-quater, indicai in lista testimoniale anche la terza figlia, cioè la dottoressa Fiammetta Borsellino, che già da qualche anno aveva assunto un attivismo nel dibattito pubblico, proprio manifestando grande pulsione alla ricerca della verità. Indicammo dunque in quell’occasione in lista anche Fiammetta Borsellino, poi, in corso di dibattimento, sul punto, cioè sull’audizione dei figli di Paolo Borsellino, confrontandomi con il difensore dei tre figli di Paolo Borsellino cioè l’avvocato Vincenzo Greco – come è ovvio, per garbo processuale e umano e per ragioni sostanziali di condivisione dello spirito nel quale ci si muoveva – ho chiesto se ci fosse un interesse a quella deposizione. Alla fine concordammo che non c’era ragione di chiamare a testimoniare la dottoressa Fiammetta Borsellino perché negli ultimi giorni della vita di suo padre, come tutti voi sapete, non era presente, sollecitazione che era venuta in realtà dal padre stesso per cercare, in quei giorni in cui quella famiglia visse l’inferno, di dare la possibilità a uno dei tre figli di poter vivere qualche momento di maggiore serenità.
Questo è lo spettro processuale nel quale mi sono mosso. Devo però fare una segnalazione alla Commissione.
Ho potuto, con le mie modestissime, davvero misere capacità, provare a dare un contributo nel processo Borsellino-quater e in quello successivo, nell’esclusivo obiettivo della ricerca della verità, grazie al fatto che, nell’esercizio della mia professione, che purtroppo ormai data da 25 anni, ho tutelato professionalmente le posizioni processuali di altri familiari di vittime di gravissimi delitti di mafia.
Quelle sedi processuali mi hanno consentito di avere cognizioni ulteriori rispetto a quelle limitate alla esclusiva ricostruzione della strage del 19 luglio del 1992.
In ordine cronologico della commissione di quei delitti di cui mi sono occupato faccio riferimento: all’omicidio del procuratore della Repubblica di Torino Bruno Caccia, commesso il 26 giugno del 1983, all’omicidio di una diciassettenne in provincia di Messina, che si chiamava Graziella Campagna, uccisa il 12 dicembre del 1985, all’omicidio del poliziotto Antonino Agostino, ucciso insieme alla moglie Ida Castelluccio, il 5 agosto del 1989, all’omicidio dell’educatore penitenziario Umberto Mormile, ucciso a Carpiano il giorno 11 aprile del 1990, all’omicidio del giornalista Beppe Alfano, ucciso in provincia di Messina, a Barcellona Pozzo di Gotto, in un luogo particolarmente importante negli equilibri nazionali di Cosa nostra e di altri poteri criminali.
Beppe Alfano è l’ultimo giornalista in ordine di tempo assassinato da Cosa nostra e in realtà è l’ultimo giornalista assassinato dalle mafie in Italia.
Infine l’omicidio di un urologo barcellonese ucciso fra l’11 e il 12 febbraio del 2004 a Viterbo, il dottor Attilio Manca.
È solo grazie alle cognizioni che ho raccolto in quest’ampia fascia di delitti, tutti connaturati dalla presenza operativa della criminalità organizzata e dalla compartecipazione, in alcuni casi, o dalla cointeressenza, di soggetti estranei a Cosa nostra e, alle volte, di soggetti appartenenti ad apparati istituzionali. È stato grazie a ciò che ho potuto dare un contributo anche nel processo per la strage di via D’Amelio e questo mi porta a fare una affermazione.
La strage di via D’Amelio ha sicuramente delle peculiarità sue, come ogni crimine ha, tanto più un crimine eccellente, ma più della strage di via D’Amelio è difficile pensare in Italia.
Ce ne sono stati altrettanto gravi, ma fare una classifica tra delitti più o meno gravi che hanno portato alla morte di esponenti delle istituzioni, esponenti delle forze di polizia, comuni cittadini, come nelle stragi del 1993 o nelle stragi della strategia della tensione, naturalmente non è possibile fare.
Però, se pure ha delle peculiarità sue, la strage di via D’Amelio non è un delitto fuori dalla storia.
Sarebbe il più aberrante degli errori che si possano commettere quello di considerare la strage di via D’Amelio un delitto fuori dalla storia.
Quel delitto è parte di un percorso che risale almeno al 1989, nella sua fase minima che si può individuare, e che sicuramente si completa nel 1994, ma si completa quanto alla esecuzione di delitti, di progetti esecutivi di stragi propriamente intesi, ma, in realtà, quel percorso vede ulteriori effetti anche nei decenni successivi, almeno fino alla cattura di Bernardo Provenzano, avvenuta, come sapete, nel 2006, e perfino in epoca recente con i tentativi di ricatto operati da una cella al 41-bis, da parte di colui che è stato il regista per conto di Cosa nostra della esecuzione della strage di via D’Amelio, e naturalmente faccio riferimento a Giuseppe Graviano.
La strage di via D’Amelio quindi va vista nei suoi dettagli di unicità, ma va vista in un quadro più largo, perché altrimenti la verità non la si trova.
C’è un’altra cosa che mi preme dire per ossequio a quello spirito di parresia, evocato all’inizio.
È da qualche tempo intorno alla strage di via D’Amelio in particolare, ma anche intorno ad altri delitti ai quali hanno partecipato in modo possente Cosa nostra o altre organizzazioni criminali, che si avverte la pratica di un pericolosissimo fenomeno a mezza via fra il negazionismo e il revisionismo.
È un tentativo di riscrivere la storia in un’ottica pan-mafiosa che vorrebbe portare alla conclusione per cui certi delitti, e in particolare la strage di via D’Amelio, siano frutto esclusivamente delle azioni poste da uomini d’onore di Cosa nostra, con la esclusione categorica di ogni apporto esterno a quella strage.
Al riguardo, è emblematico un fatto procedimentale, nemmeno processuale, che è proprio in corso. Come qualcuno di voi sicuramente sa, è in corso un procedimento presso l’autorità giudiziaria di Caltanissetta, derivato dalle dichiarazioni di un dichiarante, che sarebbe eccessivo oggi chiamare collaboratore di giustizia.
Si chiama Maurizio Avola. È stato un killer del clan Santapaola, uomo d’onore di Cosa nostra catanese, Maurizio Avola, che aveva cominciato a collaborare con la giustizia nel marzo del 1994. Senonché, Maurizio Avola, a partire dal 2017, cominciò a rendere nuove dichiarazioni alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, in una sostanziale terza vita da pentito, con una terza versione delle storie che raccontava.
Questa terza vita ha dato luogo a un procedimento che ha il numero di notizia di reato 372 del 2020 e come titolo di reato ha proprio le due stragi, quella commessa a Capaci il 23 maggio 1992 e quella commessa in via D’Amelio il 19 luglio del 1992. Il procedimento vede indagati, insieme a Maurizio Avola, i mafiosi, perché tali sono, Aldo Ercolano, Marcello D’Agata ed Eugenio Galea, tutti uomini importanti del clan Santapaola, un tempo, e dell’articolazione catanese di Cosa nostra.
Perché dico che questa vicenda è emblematica? Perché la Procura di Caltanissetta, nel concludere con la richiesta di archiviazione su quel procedimento, è arrivata alla conclusione che le dichiarazioni rese da Maurizio Avola avevano una portata oggettivamente falsa e calunniosa.
Qualcuno di voi ricorderà che addirittura queste dichiarazioni false e calunniose hanno trovato spazio in una trasmissione in prima serata, non troppo tempo fa, con l’intervento in video a mezzo intervista proprio di Maurizio Avola.
La Procura di Caltanissetta ha spiegato in questa richiesta di archiviazione che la finalità che ha mosso le calunnie propalate da Maurizio Avola era unicamente quella di escludere la responsabilità di esponenti esterni a Cosa nostra. Quella vicenda è quindi emblematica per questo motivo, è la plastica operatività dell’attività negazionista e revisionista.
Voi sapete che ci sono degli altri processi in corso in Italia in cui alle volte sono imputati soggetti che con Cosa nostra hanno avuto a che fare.
Addirittura, uno di questi soggetti, che si chiama Paolo Bellini, si trova imputato e condannato in primo grado a Bologna per la strage del 2 agosto del 1980, del quale però sappiamo con certezza essere stato un protagonista attivo delle mosse di Cosa nostra nel 1992, protagonista attivo di relazioni con personaggi importantissimi di Cosa nostra in quel momento, addirittura impegnati nella preparazione della strage di Capaci.
Faccio riferimento a Giovanni Brusca, a Gioacchino La Barbera e soprattutto a Nino Gioè, che, per conto di Brusca e dell’intera Cosa Nostra, incontrò, dal periodo precedente alla strage di Capaci in Sicilia, Paolo Bellini.
In realtà è stato accertato che Paolo Bellini ha avuto una presenza quasi fissa in Sicilia, a partire almeno dal dicembre del 1991 e fino a epoca successiva alla strage di via D’Amelio. Sappiamo con certezza che il suggerimento a Cosa nostra di colpire il patrimonio architettonico con delle stragi è provenuto proprio da Paolo Bellini.
C’è una contestualità temporale davvero allarmante fra il suggerimento di Paolo Bellini e la messa in opera delle azioni mirate a colpire il patrimonio architettonico della Nazione.
Faccio solo riferimento alla collocazione a opera di Santo Mazzei, uomo d’onore catanese legatissimo proprio nel periodo stragista al gruppo corleonese di Cosa nostra, nella seconda metà del mese di ottobre del 1992, di un proiettile di artiglieria reperito a Torino, con l’intervento di un’importante gruppo che era all’epoca la proiezione del capo mandamento di Cosa nostra di Mazara del Vallo, il capomafia e massone Mariano Agate.
A Torino il referente di Mariano Agate era un altro importante mafioso e massone, di nome Giovanni Bastone, ma di questo in realtà sarà il caso di dire quando parlerò delle indagini del dottor Germanà. Il punto è che è ormai pacificamente accertato che le strade dello stragismo esecutivamente commesso da Cosa nostra nella fase iniziata con l’omicidio Lima del 12 marzo 1992, poi proseguita a Capaci e a via D’Amelio, si saldarono con l’intervento di soggetti che avevano tutt’altra provenienza.
Naturalmente non devo essere io a ricordare a voi che la provenienza criminale di Paolo Bellini è quella della eversione neofascista, come risulta da una sentenza certamente non irrevocabile, ma molto significativa quanto alla ricostruzione della biografia criminale di Paolo Bellini, emessa dalla Corte d’Assise di Bologna nell’anno 2022.
Quel richiamo a certe pulsioni negazioniste e revisioniste, perfino in sede giudiziaria, a proposito dello stragismo di Cosa nostra, mi porta a dire che, oggi, credo per la prima volta dal 1992, si è creata una saldatura con certe pulsioni negazioniste e revisioniste sulle stragi della strategia della tensione, ivi compresa la strage di Bologna del 2 agosto del 1980.
Questo avviene proprio quando almeno fra la strage di Bologna e le stragi del 1992-1993 vengono in rilievo i collegamenti esistenti, addirittura i protagonisti condivisi, su entrambi i versanti.
Per questo la vicenda che riguarda Paolo Bellini – che oggi è all’attenzione, per quel che so da notizie giornalistiche, anche della Procura distrettuale di Firenze, che procede per le stragi del 1993, oltre che della Procura distrettuale di Caltanissetta che procede per quelle del 1992 – a me pare emblematica.
In questo scenario nel quale ci muoviamo, ritengo che sia allora importante evitare di introdurre nella ricerca, parlamentare in questo caso, elementi che creino confusione piuttosto che utilità per l’accertamento della verità, che creino buio, piuttosto che luce che illumini quel percorso di ricerca della verità.
Bisogna in tutti i modi evitare di rimettere in gioco elementi che sono oggettivamente depistanti per chi vuole esclusivamente muovere alla ricerca della verità.
Occorre muovere da dati consolidati, dati sui quali si può fare sicuro affidamento, non solo perché contenuti in sentenze che hanno il sigillo del giudicato, ma perché pacificamente accertati, e muovere da lì.
È un’operazione complessa, che sicuramente mette davanti a una grandissima difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi. Però – e questo lo dico per mia esperienza professionale – la difficoltà non è impossibilità, perché questo è dimostrato da ciò che sta avvenendo anche in questo tempo in importanti processi in alcuni dei quali io mi trovo.
Non solo nell’anno 2023 ci si trova davanti a due incombenti giudizi d’appello per la strage alla stazione di Bologna di 43 anni fa, ma anche in Sicilia è in corso il processo per il duplice omicidio Agostino-Castelluccio – il poliziotto Nino Agostino e la moglie – che ha avuto sentenza di secondo grado per il capomafia Antonino Madonia, solo poco più di dieci giorni fa, e che ha un dibattimento in primo grado in giudizio ordinario che sta arrivando a conclusione e il 6 novembre prossimo vedrà l’avvio della requisitoria da parte della Procura generale.
La requisitoria in primo grado da parte della Procura generale è dovuta al fatto che, così come è avvenuto a Bologna nel processo Bellini, a esercitare l’azione penale a Palermo, nei confronti di Antonino Madonia e Gaetano Scotto, è stata la Procura generale di Palermo dopo l’avvenuta avocazione delle indagini, da me peraltro sollecitata nel 2017, e nell’occasione, per dovere di parresia, mi tocca dirlo, grazie, non dico esclusivamente, ma con grandissima proporzione, all’impegno del senatore Scarpinato, all’epoca Procuratore generale di Palermo.
Per poter dare un contributo diretto a indicare elementi da ulteriormente acquisire o spunti sui quali operare alla ricerca di ulteriori tasselli di verità, partiamo dai dati certi. Sicuramente, per partire dai dati certi, bisogna partire dalla sentenza emessa dalla Corte d’assise di Caltanissetta il 20 aprile del 2017, all’esito del dibattimento del processo Borsellino-quater.
Quello è indubitabilmente l’arresto giudiziario più importante sulla strage di via D’Amelio, sia per la quantità di attività istruttoria svolta in quel dibattimento sia per la qualità delle conclusioni raggiunte con quella sentenza, che poi ha trovato conferma quasi integrale nei successivi gradi di giudizio fino alla irrevocabilità.
In questo senso è doveroso secondo me rendere merito ai magistrati che hanno composto quella Corte d’assise nelle persone del presidente Balsamo e del giudice a latere Barlotti.
È il provvedimento giudiziario dal quale bisogna muovere.
La prima cosa su cui è importante, a mio modo di vedere, centrare l’attenzione a partire da quella sentenza l’ha già preannunciata Salvatore Borsellino.
Riguarda la vicenda della collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo.
Si tratta di un fatto decisivo nello svolgimento dei fatti che portarono il 19 luglio alla uccisione di Paolo Borsellino e dei cinque poliziotti che gli facevano da scorta, ed è un fatto importante perché trova avvio in un momento vicinissimo rispetto alla esecuzione della strage, e cioè il primo luglio del 1992.
Quella è la data nella quale Paolo Borsellino per la prima volta interroga Gaspare Mutolo.
Sul punto la sentenza del processo Borsellino-quater ricostruisce acutamente alcune sfumature. Gaspare Mutolo aveva deciso di collaborare con la giustizia in epoca abbondantemente precedente rispetto a quel primo luglio del 1992 e di questo c’è prova in un incontro che nel carcere di Spoleto, nel dicembre del 1991, Gaspare Mutolo ebbe con Giovanni Falcone.
Giovanni Falcone, come tutti voi sapete, a dicembre del 1991 era un dirigente del Ministero allora chiamato di grazia e giustizia, e non era un magistrato, tanto meno un pubblico ministero che poteva svolgere attività di indagine.
Però, su richiesta di quel detenuto, andò a incontrarlo.
L’incontro di Falcone con Gaspare Mutolo ebbe una conclusione e cioè che a Gaspare Mutolo, che aveva segnalato al dottor Falcone che solo di lui si poteva fidare quale pubblico ministero al quale riversare le sue rivelazioni, il dottor Falcone disse che c’era un altro magistrato, che era ancora in servizio, e che di lì a breve sarebbe arrivato in servizio alla procura di Palermo, il dottor Paolo Borsellino. Gaspare Mutolo raccolse positivamente l’invito del dottor Falcone a indirizzare la sua volontà collaborativa proprio presso il dottor Borsellino.
Gaspare Mutolo, per ragioni della sua vita, aveva conoscenza di episodi criminali occorsi in Toscana e questo è il motivo per cui, detenuto, chiese di poter rendere delle dichiarazioni e fu sentito per la prima volta dall’allora Procuratore distrettuale antimafia di Firenze, il dottor Pierluigi Vigna, alla fine del mese di maggio del 1992.
Fu il dottor Vigna a informare della intrapresa collaborazione di Mutolo la Procura di Palermo e si arrivò all’interrogatorio del primo luglio del 1992.
Quell’interrogatorio è uno dei fatti più rilevanti dell’ultimo periodo di vita di Paolo Borsellino, per vari motivi. Intanto Paolo Borsellino cominciava a raccogliere le dichiarazioni di un importante esponente di Cosa Nostra.
Era dal 1989, cioè dal momento in cui aveva iniziato a collaborare con la giustizia Francesco Marino Mannoia, che dall’interno di Cosa nostra non arrivava alcun importante collaboratore di giustizia.
In più, Gaspare Mutolo aveva avuto una sua vicinanza anche umana, personale con Salvatore Riina, cioè con il capo di quella Cosa nostra a guida corleonese che, e richiamo le parole pronunciate da Paolo Borsellino il 25 giugno del 1992, sicuramente era stata coinvolta nella strage di Capaci.
In quell’occasione, mi piace ripeterlo proprio per la denuncia del negazionismo che ho fatto prima, Paolo Borsellino disse: «A Capaci sicuramente è stata la mafia, ma – precisò – vedremo se non è stata solo la mafia, ma la mafia è stata sicuramente». Questa è l’intuizione che pubblicamente formulò Paolo Borsellino il 25 giugno del 1992.
Non conta nulla, ma forse serve a un po’ capire qual era lo spirito del tempo. All’epoca ero uno studente di giurisprudenza e vivevo in provincia di Messina, quindi Palermo non era propriamente mia zona di frequentazione, ma il 25 giugno del 1992, io, avendo saputo che a una conferenza organizzata da MicroMega avrebbe partecipato il dottor Paolo Borsellino, presi un treno e mi recai a Palermo per andare a sentire Paolo Borsellino.
Rimasi colpito in un modo che naturalmente non posso più dimenticare, della crudezza con cui quell’uomo, in quel momento, stava dedicando quelle che poi scoprimmo essere le ultime sue forze, nell’interesse di tutti noi cittadini. Mutolo quindi era un pentito importantissimo e questo è il motivo per cui Paolo Borsellino fa di tutto per poter essere lui a raccogliere le dichiarazioni di Mutolo, posto che era stato proprio Mutolo a chiedere il suo intervento e quindi era necessario, a fini di giustizia e di verità, eliminare l’ostacolo derivante dall’assegnazione al procuratore aggiunto Paolo Borsellino, nella organizzazione interna della Procura di Palermo, della delega per i fatti di mafia delle province di Agrigento e di Trapani.
Per fortuna Paolo Borsellino andò a interrogare Gaspare Mutolo, però quell’interrogatorio fu interrotto, anzi, fu caratterizzato da due fatti enormi, giganteschi.
Il primo è che, fuori dal verbale, Gaspare Mutolo rivelò a Paolo Borsellino che era a conoscenza dell’esistenza di soggetti istituzionali che avevano avuto un ruolo di supporto e di contiguità con Cosa nostra.
Fece i due nomi e i due nomi erano: il dottor Bruno Contrada e il dottor Domenico Signorino.
Il dottor Bruno Contrada era un importante dirigente del SISDE in quel momento e il dottor Domenico Signorino era un magistrato della Procura generale di Palermo. Il dato era ovviamente enorme.
Il secondo fatto enorme è che quell’interrogatorio fu sospeso per una telefonata giunta a Paolo Borsellino dal Viminale, con la convocazione di Paolo Borsellino al Viminale. Paolo Borsellino si reca al Viminale.
È il momento di insediamento del neo ministro dell’Interno, Nicola Mancino, ma nella sua visita al Viminale accade un fatto impressionante. Che ciò sia accaduto il primo luglio del 1992 lo attesta la sentenza del processo Borsellino-quater, grazie alla testimonianza di un collega del dottor Borsellino e cioè il dottor Gioacchino Natoli, che apprese la circostanza già il giorno successivo. Quello che avvenne è che Paolo Borsellino, non solo incontrò l’appena insediato Ministro dell’Interno, ma si imbatté nei corridoi del Viminale anche nel dottor Bruno Contrada cioè proprio dell’uomo del quale gli aveva appena parlato, come uomo in relazioni con Cosa nostra, Gaspare Mutolo.
Perché il dato è fondamentale? Perché noi sappiamo quanto Paolo Borsellino diede rilievo a quella circostanza e lo sappiamo per il fatto che, oltre che al dottor Natoli, lo riferì anche ad altri colleghi che lo hanno testimoniato dopo la strage di via D’Amelio, ma è importante per una ulteriore ragione.
La ragione è che quella circostanza – cioè che Mutolo aveva rivelato al dottor Borsellino che Contrada era uomo contiguo a Cosa nostra – fu riferita il 20 luglio del 1992 al procuratore Tinebra.
La legge vigente sui servizi segreti in quel momento era la legge del 1977, che aveva istituito il SISDE e il SISMI, ma in realtà anche la successiva legge del 2007, che ha istituito AISI e AISE, sul punto non ha modificato nulla, e cioè che è vietato dalla legge che esponenti dei servizi di sicurezza possano collaborare alle indagini della magistratura inquirente.
E ciò, a chi ha un minimo di cognizione di diritto, è chiaro ed è stabilito dalla nostra Costituzione.
La Costituzione prevede che la magistratura sia autonoma e indipendente. All’articolo 101 prevede che i giudici sono soggetti soltanto alla legge – in realtà nella votazione in Assemblea costituente era che i magistrati fossero soggetti soltanto alla legge, non solamente i magistrati giudicanti. Comunque l’articolo 112, con il principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale in capo ai pubblici ministeri, rende vincolati e soggetti soltanto alla legge anche i pubblici ministeri.
Questo è tutelato dall’articolo 109 della Costituzione che impone un vincolo funzionale per la polizia giudiziaria rispetto ai pubblici ministeri.
È vero che la polizia giudiziaria è fatta da poliziotti, carabinieri, esponenti delle forze dell’ordine che sono in qualche modo incasellati in un Ministero, ma, grazie all’articolo 109 della Costituzione, devono agire in modo esclusivamente vincolato al pubblico ministero che delega le indagini per consentire un accertamento che non sia succube di interferenze di tipo politico-amministrativo. L’appartenente ai servizi segreti, non essendo ufficiale di polizia giudiziaria, non ha la tutela data agli ufficiali di polizia giudiziaria dall’articolo 109 della Costituzione ed è vincolato al potere amministrativo non genericamente, ma addirittura specificamente alla Presidenza del Consiglio, presso cui sono incardinati i servizi di informazione e sicurezza.
Quando il 20 luglio del 1992 il dottor Tinebra chiede per le indagini l’aiuto del dottor Bruno Contrada, commette un atto illegale, ma quel che è più sconvolgente è che affida l’incarico di supportare le indagini sulla strage di via D’Amelio a un funzionario del SISDE sul quale Paolo Borsellino voleva indagare, grazie alle rivelazioni di Gaspare Mutolo, e poi i risultati si sono visti.
Il paradosso è che le indagini sull’uccisione di Paolo Borsellino furono almeno in parte affidate a uno che sarebbe stato indagato da Paolo Borsellino in un corto circuito che non ha precedenti nella storia.
La cosa è ancora più grave per un ulteriore fatto: l’effetto intimidatorio.
Quelle dichiarazioni su Bruno Contrada Gaspare Mutolo non le verbalizzò né il 20 luglio, né il 21 luglio, né il 22 luglio, né nel mese di agosto, né nel mese di settembre. Sono convinto che l’effetto intimidatorio non fu solo nei confronti di Gaspare Mutolo, ma fu pure nei confronti dei magistrati.
Quelle dichiarazioni su Bruno Contrada furono fissate in un verbale di interrogatorio solo il 23 ottobre del 1992, quindi oltre tre mesi dopo la strage di via D’Amelio.
Nel corso degli anni abbiamo avuto alcune testimonianze non solo dei colleghi di Paolo Borsellino, ma anche di persone che avevano acquisito con lui un rapporto di amicizia o che per ragioni contingenti si erano trovati a frequentarlo per ragioni private. Il dottor Diego Cavaliero è un magistrato che iniziò il suo lavoro di magistrato alla Procura di Marsala, in coincidenza con l’arrivo alla guida della stessa procura del dottor Paolo Borsellino, all’inizio del 1987.
Egli intrattenne con Paolo Borsellino, come testimoniato dalla moglie e dai figli di Paolo Borsellino, un rapporto di così tale vicinanza che non ha eguali fra tutti i colleghi di Paolo Borsellino.
Nacque un rapporto quasi paterno di Paolo Borsellino nei confronti del dottor Cavaliero, tanto che in quel triennio 1987-89, quando Paolo Borsellino tornava a Palermo per il fine settimana, portava con sé il giovane suo sostituto il quale dormiva a casa di Paolo Borsellino.
È lo stesso amico di Paolo Borsellino che nel luglio del 1992 gli chiede di fare da padrino di battesimo al proprio figlio ed è lo stesso amico di Paolo Borsellino che ospita, dopo la strage, nel mese di agosto 1992, i figli e i familiari più stretti di Paolo Borsellino. Perché dico questo? Perché il dottor Cavaliero ha testimoniato su un episodio apparentemente minimale, ma che ha un grande significato alla luce di quello che avvenne.
Si trovava a casa del dottor Borsellino e stavano pranzando, davanti alle immagini del telegiornale. La televisione era accesa ed era presente il figlio di Paolo Borsellino, che all’epoca era minorenne e che aveva la curiosità di qualunque ragazzo, tanto più in relazione al lavoro del padre. Poiché in quel momento il telegiornale, che stava parlando della strage dell’Addaura, dell’attentato fallito ai danni del dottor Falcone del giugno 1989, aveva fatto il nome del dottor Bruno Contrada, il dottor Manfredi Borsellino chiese chi fosse questo Contrada.
Il dottor Cavaliero ha riferito ai magistrati come la reazione del dottor Borsellino fu impressionante ai suoi occhi perché reagì con una brutalità che non gli aveva mai visto nel dire a suo figlio di evitare perfino di pronunciare quel nome.
Si trattava di cose così pericolose delle quali non si doveva minimamente fiatare.
La cosa è stata riferita anche da un poliziotto, che aveva rapporti con Paolo Borsellino fino al momento della sua uccisione, per ragioni assolutamente private.
Era il fidanzato della figlia maggiore di Paolo Borsellino, di Lucia Borsellino. Il poliziotto Bartolo Iuppa fu fidanzato con Lucia Borsellino fra il 1990 e il 1997 e nel 1992 frequentava assiduamente la casa della fidanzata. In una occasione anch’egli, vedendo il volto di Contrada in televisione, rivolse al dottor Borsellino la fatidica domanda su cosa pensasse del dottor Contrada. Anche in quella occasione la reazione era stata particolarmente dura.
Il dato ha un altro rilievo. È noto a tutti, ed è attestato in sentenze, il rapporto umano e professionale inscindibile che legò Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Giovanni Falcone, come tutti sappiamo, fu vittima di quell’attentato nel giugno del 1989. Sappiamo anche che il 10 luglio del 1989, sul quotidiano «L’Unità», uscì un’intervista a Giovanni Falcone.
Vi invito a rileggere quell’intervista perché Giovanni Falcone, alla luce di ciò che ho potuto studiare sugli atti processuali, ma anche alla luce di ciò che ho potuto sapere da parte di chi lo ha conosciuto, era persona particolarmente riservata e non era certo un gran chiacchierone su vicende di mafia e su vicende particolarmente delicate.
In quella intervista, quindi in una dichiarazione pubblica, parlando dell’attentato ai suoi danni, Giovanni Falcone fece riferimento a menti raffinatissime che sono in grado di indirizzare le azioni di Cosa nostra. «È in questo scenario che dobbiamo guardare per cercare di capire chi ha voluto la mia uccisione con l’attentato all’Addaura».
In anni recenti il giornalista che intervistò Giovanni Falcone ha testimoniato, pubblicamente – ma in realtà lo ha fatto sotto giuramento anche al processo per il duplice omicidio Agostino-Castelluccio su mia espressa domanda – ha testimoniato che il dottor Falcone nell’occasione fece il nome del dottor Bruno Contrada e gli chiese di evitare la pubblicazione di quel nome per la delicatezza della circostanza.
Richiamando il legame intenso che teneva insieme Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, tanto che a dicembre del 1991 il dottor Falcone suggerisce a Gaspare Mutolo di fidarsi esclusivamente di Paolo Borsellino, noi abbiamo certezza di quale fosse il pericolo che Paolo Borsellino vedeva nel ruolo del dottor Bruno Contrada, quale elemento di apparati istituzionali che colludevano con Cosa nostra ed è il motivo per cui, a proposito della accelerazione che portò alla strage di via D’Amelio, dato di fatto accertato per bocca di alcuni dei soggetti che hanno partecipato alla strage, la sentenza del processo Borsellino-quater indica anche la collaborazione di Gaspare Mutolo.
Aggiungo un dato, proprio nell’ottica che dicevo prima per cui non bisogna guardare il singolo fatto perché altrimenti si rischia di vedere un solo albero, pur stando davanti a un enorme bosco.
Se si guardano gli atti del processo per la strage all’Addaura, si coglie a piene mani come già nel sostenere l’accusa contro i mafiosi esecutori della strage all’Addaura, furono fatti accertamenti mirati a verificare se una delle causali di quella strage non fosse il rischio che venisse fuori giudiziariamente il rapporto di collusione fra il dottor Bruno Contrada e Cosa nostra.
Come tutti voi sapete, in quel processo ha testimoniato una magistrata svizzera che si chiama Carla Del Ponte, che giusto il 20 giugno del 1989 aveva in progetto, insieme al dottor Falcone, di fare il bagno davanti alla villa in uso al dottor Falcone in quel momento.
La dottoressa Del Ponte testimoniò circa il fatto che un testimone, o meglio un imputato, industriale bresciano di nome Oliviero Tognoli, dopo anni di latitanza sostanzialmente consegnatosi alla autorità giudiziaria svizzera e alla dottoressa Del Ponte in particolare, incontrando il dottor Falcone in occasione di una rogatoria, presente la dottoressa Del Ponte, aveva rivelato che la notizia che gli aveva consentito di fuggire e darsi alla latitanza per sottrarsi a un provvedimento restrittivo nei suoi confronti gli era venuta proprio dal dottor Bruno Contrada.
Questo fu rivelato informalmente a Giovanni Falcone e a Carla Del Ponte, esattamente come informalmente Gaspare Mutolo il primo luglio del 1992 rivelò la collusione del dottor Contrada con Cosa nostra.
Però in quella occasione Oliviero Tognoli si era poi rifiutato di metterlo a verbale ed è il motivo per il quale si sospettò che il progetto di uccisione nell’attentato all’Addaura, giusto il 20 giugno del 1992, fosse finalizzato a colpire non solo Giovanni Falcone, ma anche la dottoressa Carla Del Ponte che in quei giorni era a Palermo e che quel giorno sarebbe stata ospite di Giovanni Falcone all’Addaura.
Corre peraltro l’obbligo, l’ha già fatto Salvatore Borsellino, di citare le parole di Agnese Piraino Borsellino. Noi sappiamo una cosa – la sappiamo perché lo ha verbalizzato la signora Borsellino a partire dal 2009 e negli anni successivi davanti ai magistrati, ma in realtà lo ha fatto anche nelle sue conversazioni con un giornalista che hanno portato alla pubblicazione di un libro edito pochissimo tempo dopo la morte di Agnese Borsellino perché morì prima che il giornalista Salvo Palazzolo riuscisse a completare il lavoro.
Quel libro contiene anche le rivelazioni di Agnese Borsellino, in relazione a certe piccole confidenze che il riservatissimo marito si era sentito in animo di farle nelle ultime settimane di vita. Una di quelle piùimpressionanti è che Paolo Borsellino negli ultimi giorni di vita disse alla moglie che aveva respirato aria di morte.
Senonché quell’aria di morte Paolo Borsellino disse di averla respirata non nell’incontrare magari per qualche interrogatorio dei mafiosi, ma disse di averla respirata al Viminale, cioè al palazzo della polizia, nello stesso palazzo della polizia presso il quale, del tutto a sorpresa, si imbatté un giorno nel dottor Bruno Contrada, il quale, ed è la cosa più grave, fece mostra a Paolo Borsellino di sapere già che Gaspare Mutolo aveva iniziato a collaborare con la giustizia.
Il dato è senz’altro gravissimo, è gravissimo senz’altro che quella circostanza fosse conosciuta da uno dei soggetti che sarebbe stato accusato da Gaspare Mutolo ma io ho prova documentale della gravità di ciò che accadde.
Su mia sollecitazione, la Procura generale di Palermo, nel processo sul duplice omicidio Agostino-Castelluccio, ha acquisito le agende del dottor Bruno Contrada dal 1976 al 1992. Sono le agende che gli furono sequestrate al momento del suo arresto, avvenuto il 24 dicembre del 1992.
Quelle agende sono quindi diventati atti giudiziari e sono un patrimonio – le notizie che emergono da quelle agende – che io invito la Commissione antimafia a utilizzare in questo difficile percorso alla ricerca della verità.
Alla pagina del 27 luglio 1992 il dottor Bruno Contrada scrive di una cena a cui partecipò con dottor A. De Luca – il dottor Antonio De Luca come molti sanno in quel momento era un funzionario di polizia in servizio al SISDE – e dottor Angelo Sinesio, ufficio Alto commissariato.
C’è una parentesi: «discusso questione Mutolo». Quindi otto giorni dopo la strage di via D’Amelio già il dottor Contrada preparava la propria difesa dalle accuse di Gaspare Mutolo che ancora non avevano trovato verbalizzazione. È un caso unico nella storia giudiziaria di questo Paese.
Ma c’è una cosa che è ancora più impressionante, perché se si va avanti si arriva al 31 luglio, quattro giorni dopo.
Si legge: visita al dottor D. Signorino.
Ricorderete che il dottor Domenico Signorino è il magistrato della Procura generale di Palermo in quel momento, era stato il pubblico ministero che aveva sostenuto l’accusa nel primo maxi processo dinnanzi alla Corte d’Assise di Palermo, ma era soprattutto il secondo nome istituzionale fatto da Gaspare Mutolo nelle confidenze del primo luglio 1992 al dottor Borsellino, come soggetto colluso con Cosa nostra.
Nella pagina del 31 luglio dell’agenda del dottor Contrada si legge: «Visita al dottor D. Signorino a casa» – c’è l’indirizzo di casa – e, fra parentesi, «questione Mutolo».
Vi ho già detto che le dichiarazioni su Gaspare Mutolo trovano ufficializzazione solo il 23 ottobre del 1992. Capite voi cosa accadde in quei giorni, in quelle settimane e in quei mesi?
C’era un uomo che sarebbe stato sicuramente indagato da Paolo Borsellino.
Difficile che gli esiti sarebbero stati diversi da quelli che lo colpirono il 24 dicembre del 1992, sarebbe stato arrestato su richiesta di Paolo Borsellino, evidentemente.
Quell’uomo, prima che quelle accuse trovino ingresso in un verbale, con un ritardo derivato dalla strage di via D’Amelio, quando aveva già ricevuto l’incarico di collaborare con il Procuratore di Caltanissetta per la strage di via D’Amelio, nel frattempo tramava sulla questione Mutolo, cosa che – consegnerò alla Commissione l’agenda del 1992 del dottor Contrada insieme ad altri documenti – voi vedrete farà sostanzialmente fino ai giorni precedenti al 24 dicembre del 1992 allorché è attestato che continuava in particolar modo a tenere i contatti con alti esponenti del ROS dei carabinieri, oltre che con importanti esponenti politici.
La sentenza del processo Borsellino-quater assegna anche molta attenzione a un episodio che aveva visto la testimonianza di due magistrati, la dottoressa Camassa e il dottor Russo, due magistrati di prima nomina alla Procura di Marsala, che erano stati sostituti del Procuratore della Repubblica Paolo Borsellino e che erano stati sostanzialmente cresciuti come dei giovani colleghi da accudire e far crescere, come egli già aveva fatto con il dottor Cavaliero, con il quale addirittura era nato un rapporto personale, e come fece anche con altro giovane magistrato in quel momento di prima nomina, arrivato alla Procura di Marsala, cioè il dottor Antonio Ingroia.
La testimonianza della dottoressa Camassa e del dottor Russo viene affrontata a proposito di un episodio occorso nel giugno del 1992 quando quei due magistrati si erano recati a Palermo e avevano incontrato nella sua stanza il dottor Paolo Borsellino.
Nell’occasione, in un frangente drammatico nel comportamento del dottor Borsellino – ed era stata una cosa che lo aveva portato addirittura alle lacrime – aveva pronunciato una frase qualcosa di simile a questa: «Non posso credere che un amico mi abbia tradito», ma è un’espressione che non era una negazione era un’espressione intesa nel senso che un amico lo aveva tradito, ed era cosa che egli non si aspettava.
I due magistrati testimoni non hanno saputo riferire a chi Paolo Borsellino alludesse con la locuzione dell’amico che aveva tradito. Noi però abbiamo conoscenza di alcuni fatti e ne abbiamo conoscenza grazie all’istruttoria del processo Borsellino-quater.
Il dottor Diego Cavaliero in più occasioni quando gli è stato chiesto chi fossero gli ufficiali di polizia giudiziaria in assoluto più vicini a Paolo Borsellino, ha fatto sempre ed esclusivamente due nomi.
Per intenderci nessun ufficiale o sottufficiale del ROS, ma un carabiniere che era in quel momento il comandante della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Marsala, il maresciallo Carmelo Canale, che accompagnò il dottor Borsellino fino agli ultimi giorni di vita.
Il secondo era un funzionario di polizia, il dottor Calogero Germanà.
Abbiamo appreso, ed è un dato certo, che Paolo Borsellino, dopo la strage di Capaci, aveva espresso, anche in sede istituzionale, il desiderio di ottenere la collaborazione investigativa del dottor Rino Germanà.
Chiunque abbia letto le parole del discorso pronunciato a Casa Professa il 25 giugno del 1992 ha chiaro quale fosse in quel momento l’atteggiamento di Paolo Borsellino e quindi ha chiaro di cosa potesse significare per Paolo Borsellino desiderare la collaborazione investigativa di un uomo specifico, un funzionario di polizia specifico con nome e cognome, al di là di quale era il ruolo che in quel momento aveva.
Il desiderio accertato di Paolo Borsellino è che il dottor Rino Germanà venisse aggregato alla Criminalpol di Palermo.
La Criminalpol in quel momento era l’organismo della polizia di Stato tipicamente destinatario delle deleghe di indagini sui più gravi fatti di mafia e sui più gravi fatti criminali.
Il dottor Germanà però, fino a poco prima della strage di Capaci, era stato impegnato in una indagine che gli era stata delegata dalla Procura di Marsala proprio dalla dottoressa Alessandra Camassa.
L’indagine era partita da un fatto gravissimo che si era verificato a margine di un processo in corso presso la Corte di assise di appello di Palermo, il processo per l’omicidio del capitano Basile.
Era accaduto che uno o due giorni prima che la Corte si ritirasse in camera di consiglio, un notaio massone, Pietro Ferraro, si era presentato a casa del presidente della Corte d’assise d’appello e aveva di fatto sollecitato una risoluzione bonaria del processo in favore degli imputati.
Gli imputati in quel momento erano i componenti della commissione provinciale di Palermo di Cosa nostra e gli esecutori materiali del delitto. Il processo aveva avuto un provvedimento di riunione, come dice il codice, fra il giudizio celebrato nei confronti dei componenti della commissione provinciale e il giudizio, arrivato alla Corte d’assise d’appello di Palermo in sede di rinvio, su annullamento da parte della Corte di Cassazione della precedente condanna.
I tre imputati che erano divenuti tali grazie al lavoro del giudice istruttore Paolo Borsellino, erano accusati di aver ucciso nella sera fra il 3 e il 4 maggio 1980 il capitano dei carabinieri Emanuele Basile.
Dei tre imputati, in realtà, in vita sappiamo oggi era rimasto uno solo, perché Vincenzo Puccio era stato ufficialmente ucciso, nel senso che risultava ovviamente la sua uccisione, l’11 maggio del 1989, in una cella del carcere dell’Ucciardone.
Armando Bonanno, un altro dei tre componenti della pattuglia di killer, era stato ucciso, anche se risultava latitante. Il terzo era ancora vivo e si tratta di Giuseppe Madonia, fratello di Antonino Madonia e figlio di Francesco Madonia, capo mandamento di Resuttana.
Quella visita del notaio Ferraro al presidente della Corte d’assise d’appello fu da quest’ultimo, il dottor Scaduti, segnalata al dottor Borsellino che gli consigliò di fare una relazione di servizio e di far poi sapere alla persona incontrata che egli aveva fatto una relazione di servizio. Così avvenne.
Nella relazione di servizio del dottor Scaduti si fece riferimento a un personaggio che era stato evocato dal notaio Ferraro, quale soggetto che aveva attivato il suo interessamento e aveva indicato questa persona in un esponente politico della corrente manniniana a nome Vincenzo, qualificandolo come trombato politicamente nel recente passato.
La vicenda, dopo la relazione di servizio del presidente Scaduti, era stata oggetto di indagini da parte della Procura di Palermo. Delle indagini fu titolare l’allora procuratore aggiunto Vittorio Aliquò.
Consiglio vivamente alla Commissione antimafia di acquisire tutta l’attività di indagine svolta dal procuratore aggiunto Aliquò in conseguenza di quella relazione di servizio, attività di indagine che naturalmente aveva come bersaglio il notaio Pietro Ferraro e il personaggio che aveva sollecitato l’attivismo del notaio Ferraro.
Furono disposte anche delle intercettazioni dalle quali risultarono i contatti dei soggetti con i quali il notaio Ferraro in quel momento operava. Emersero due nomi di persone chiamate Vincenzo in contatto con il notaio Ferraro, entrambi esponenti politici. Si trattava di tal Vincenzo Culicchia che in quel momento era, credo, sindaco del comune di Partanna, ed era comunque originario di quel comune e di un soggetto all’epoca quasi sconosciuto alla grande platea ma che era stato assessore al comune di Palermo e consigliere comunale. Si chiama Vincenzo Inzerillo.
Si tratta di persona che alle elezioni del 5 aprile del 1992 aveva fatto ingresso in Parlamento.
Non solo aveva fatto ingresso in Parlamento, ma, grazie alle indagini del dottor Germanà, abbiamo scoperto che la qualifica di trombato atteneva al fatto che nel 1991 il suo partito, la Democrazia cristiana, lo aveva scartato nella scelta dei candidati per le elezioni regionali del giugno del 1991. Però forse fu una cosa fortunata per lui perché trovò ingresso nelle liste per le elezioni politiche del 1992 e fu eletto al Senato se non ricordo male. Anni dopo abbiamo scoperto che il senatore Vincenzo Inzerillo, come da condanna irrevocabile per concorso esterno in associazione mafiosa, era personaggio a disposizione, secondo quella sentenza, di un preciso capo mandamento di Cosa nostra, Giuseppe Graviano, cioè proprio l’uomo che ha gestito la fase esecutiva della strage di via D’Amelio.
Siamo in un periodo precedente alla strage di Capaci e si può arrivare a un politico che è in contatto con uno degli stragisti di via D’Amelio.
Senonché accade che il procuratore aggiunto Vittorio Aliquò trasmette il fascicolo per una parte a Caltanissetta, in relazione alla posizione del notaio Ferraro, perché l’eventuale suo ruolo di contiguità con Cosa nostra da qualificare giuridicamente atteneva però a una condotta che vedeva sostanzialmente come persona offesa dal reato un magistrato del distretto di Palermo, cioè il presidente della Corte d’assise d’appello e quindi il fascicolo per quella parte andò a Caltanissetta.
La parte relativa al Vincenzo politico manniniano, anziché essere trattata dalla Procura di Palermo in relazione alla posizione di Vincenzo Inzerillo, fu assegnata alla Procura di Marsala perché fu ritenuto che il Vincenzo fosse l’onorevole Vincenzo Culicchia, sindaco di Partanna, e la competenza territoriale su Partanna spettava alla Procura di Marsala.
Il dottor Germanà concluse le sue indagini delegategli per la individuazione del Vincenzo mandante del notaio Ferraro con una informativa del 19 maggio 1992 – che io vi lascerò – alla cortese attenzione della dottoressa Camassa.
Questa informativa è di epocale importanza perché le indagini del dottor Germanà individuarono il Vincenzo manniniano nella persona di Inzerillo Vincenzo, nato a Palermo il 24 luglio del 1947, ma aggiunse dell’altro.
Aggiunse anche alcuni accertamenti sia sul notaio Ferraro sia sui contatti del notaio Ferraro, attraverso suo padre, con la massoneria di piazza del Gesù palermitana. Emerse un ristorante di Palermo che veniva utilizzato sostanzialmente come camera di contatto fra il mandamento di Mazara del Vallo, il capo mandamento Mariano Agate ed esponenti della massoneria.
In quella informativa emerge un nome veramente clamoroso, il nome di Luigi Savona.
Luigi Savona, come risulta dai processi denominati Grande Oriente, era stato indicato dal confidente, che non ebbe il tempo di diventare collaboratore di giustizia, Luigi Ilardo, come il soggetto originario della Sicilia, ma trapiantato a Torino, che aveva curato l’ingresso della massoneria in Cosa nostra.
Nelle confidenze di Luigi Ilardo era il soggetto che aveva avviato l’indirizzo di Cosa nostra verso una strategia stragista in contatto con esponenti di apparati istituzionali ed esponenti del mondo massonici
In anni successivi, gli accertamenti giudiziari diedero conferma alle parole di Luigi Ilardo.
Abbiamo chiamato il dottor Germanà a testimoniare al processo Borsellino-quater.
Egli ha testimoniato che il giorno in cui depositò alla procura di Marsala questa informativa, non ebbe neanche il tempo di tornare al proprio ufficio che ricevette una telefonata dal vicecapo della polizia, il dottor Luigi Rossi, che lo convocò immantinente al Viminale e nella stessa giornata si dovette adoperare per recarvisi.
Al Viminale fu sottoposto a domande dal vicecapo della polizia. L’esito di quelle domande fu che il dottor Germanà non si era occupato della posizione del ministro Mannino – era ciò che interessava al vicecapo della polizia. Però, tornato in ufficio il giorno dopo, fu costretto a telefonare di nuovo al dottor Rossi per riferirgli che l’unico accenno al ministro Mannino non riguardava un’indagine che interessava il ministro ma riguardava proprio la informativa sul Vincenzo che aveva mandato il notaio Ferraro presso il presidente Scaduti.
Di lì a poche settimane, la polizia, anziché assecondare il desiderio manifestato dal dottor Borsellino di aggregare il dottor Germanà alla Criminalpol di Palermo perché collaborasse con il procuratore aggiunto di Palermo Borsellino, fu sostanzialmente retrocesso, essendo mandato a dirigere il commissariato di Mazara del Vallo che egli aveva diretto già addirittura nel 1984, come se la sua carriera in quel momento dovesse regredire di otto anni di onorato servizio prestato in polizia con risultati assolutamente ammirevoli.
Perché segnalo questa circostanza? Perché in realtà quelle indagini, come ho detto, avrebbero potuto portare alla individuazione di un grumo operativo di Cosa nostra che in quel momento stava lavorando per la strage di via D’Amelio.
Forse non è un caso che il 14 settembre del 1992, proprio sul lungomare di Mazara del Vallo il dottor Germanà fu bersaglio di una squadra di killer mai vista nella storia di Cosa nostra.
A condurre l’autovettura era Matteo Messina Denaro e a sparare, anche con un kalashnikov, all’indirizzo del dottor Germanà, erano addirittura Giuseppe Graviano e Leoluca Bagarella, cioè i due soggetti di vertice assoluto – solo Totò Riina in quel momento era superiore a loro – al centro dell’ala stragista di Cosa nostra, per commettere un omicidio in un territorio del quale non era mafiosi operativo nessuno dei tre componenti della squadra di killer.
Il conducente dell’auto infatti era facente funzioni di capo mandamento di Castelvetrano, per conto del padre, Francesco Messina Denaro, che era ben vivo – morì da latitante solo nel 1998 – Giuseppe Graviano era il capo mandamento di Brancaccio e Leoluca Bagarella, che era il cognato di Totò Riina, era uno degli esponenti di vertice del mandamento di Corleone. Eppure, per uccidere il dottor Germanà, vengono mandati tre capi mandamento esterni. Forse questa fu la fortuna del dottor Germanà che riuscì, con grande abilità e con grande prontezza, a sfuggire all’attentato, lasciando l’auto, correndo verso la spiaggia e buttandosi in acqua, con i colpi delle armi da fuoco che rischiarono di colpire dei bagnanti.
È un tentato omicidio che evidentemente aveva ragioni particolarmente importanti se nel commetterlo, per assumersi una medaglia, sono tre personaggi della élite di Cosa nostra fuori dal loro territorio.
Il mandamento di Mazara del Vallo naturalmente aveva squadroni di killer utili da attivare e però ciò non avvenne. Di quella indagine del dottor Germanà era titolare la Procura di Marsala, proprio la procura della dottoressa Camassa e del dottore Russo, ed era un’indagine che era stata svolta da un funzionario di polizia che stava a cuore al dottor Borsellino.
Sappiamo che quei due giovani magistrati avevano in Borsellino il loro nume tutelare. Per chi ha pratica della vita dei palazzi di giustizia, non è difficile comprendere come i due giovani magistrati, che in quel momento si trovavano senza un procuratore capo, vedessero nel dottor Borsellino l’esponente di maggiore fiducia al quale fare riferimento per vicende così delicate.
Tanto più che quei due giovani magistrati erano in una condizione particolarmente scomoda perché, da un lato, in relazione a un procedimento penale, si trovavano – e ne avevano parlato con il dottor Borsellino – a dover chiamare come persona informata sui fatti un magistrato, e cioè il dottor Domenico Signorino, e quel magistrato addirittura, con decisione veramente ineffabile dell’allora Procuratore generale, era stato designato come facente funzioni di procuratore capo a Marsala.
Quindi quei due giovani magistrati si sarebbero trovati a dover interrogare come testimone colui che avrebbe fatto da capo a loro. Dall’altro lato, si trovavano a gestire questa attività sulla individuazione del Vincenzo politico manniniano, che aveva portato a quella informativa che aveva avuto quelle conseguenze così incredibili sul dottor Germanà, perché naturalmente il trasferimento del dottor Germanà alla guida del commissariato di Mazara del Vallo fu noto ai magistrati.
Fu evidentemente nota la connessione temporale fra il deposito di quella informativa, la convocazione quasi manu militari al Viminale e il successivo trasferimento disposto senza alcuna ragione.
Questo il motivo per cui io credo che nel momento in cui il dottor Borsellino fece riferimento all’amico che lo aveva tradito, il riferimento era non certo a un carabiniere o un ufficiale dei carabinieri, ma certamente a un suo collega.
Ci si è dovuti fermare nel Borsellino-quater davanti alla mancata conoscenza da parte della dottoressa Camastra e del dottor Russo circa il nome a cui si riferiva il dottor Borsellino.
Devo confessare che sembra abbastanza implausibile che un uomo come il dottor Borsellino si fosse aperto a una confidenza così forte tanto da portarlo addirittura alle lacrime, però mantenendo il riserbo su quel nome, ma queste sono le cose che sono risultate nel processo e a quelle bisogna attenersi. Penso che la vicenda dell’attività investigativa svolta dal dottor Germanà e del successivo attentato ai suoi danni sia uno di quei capitoli della storia di Cosa nostra intrinsecamente collegato all’attività del dottor Borsellino e anche alla strage di via D’Amelio.
Naturalmente il fuoco dell’attenzione della sentenza del processo Borsellino-quater è stato il depistaggio Scarantino.
PRESIDENTE. Chiedo scusa avvocato, solo per organizzare i lavori. Le chiedo se mi sa indicare di quanto tempo avrà ancora bisogno per capire se dobbiamo aggiornarci o se invece possiamo proseguire. Ciò ai fini dell’organizzazione dei lavori, anche a beneficio dei colleghi che hanno altri impegni.
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. Ne avrò ancora per circa un’ora.
PRESIDENTE. Bene, tenuto conto che lei stava affrontando il capitolo su Scarantino e delle domande che immagino i colleghi intenderanno porre, le chiedo se è disponibile a tornare nei prossimi giorni per concludere l’audizione.
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. In effetti lei ha compreso perfettamente che il capitolo Scarantino è forse l’argomento più complesso da trattare. Sono naturalmente a disposizione della Commissione.
PRESIDENTE. In una successiva seduta, come è stato fatto finora, ci sarà tutto il tempo per lei per concludere la sua relazione e per i colleghi per porre domande e richieste di chiarimento. Nel prossimo Ufficio di presidenza stabiliremo la data per il prosieguo dell’audizione.
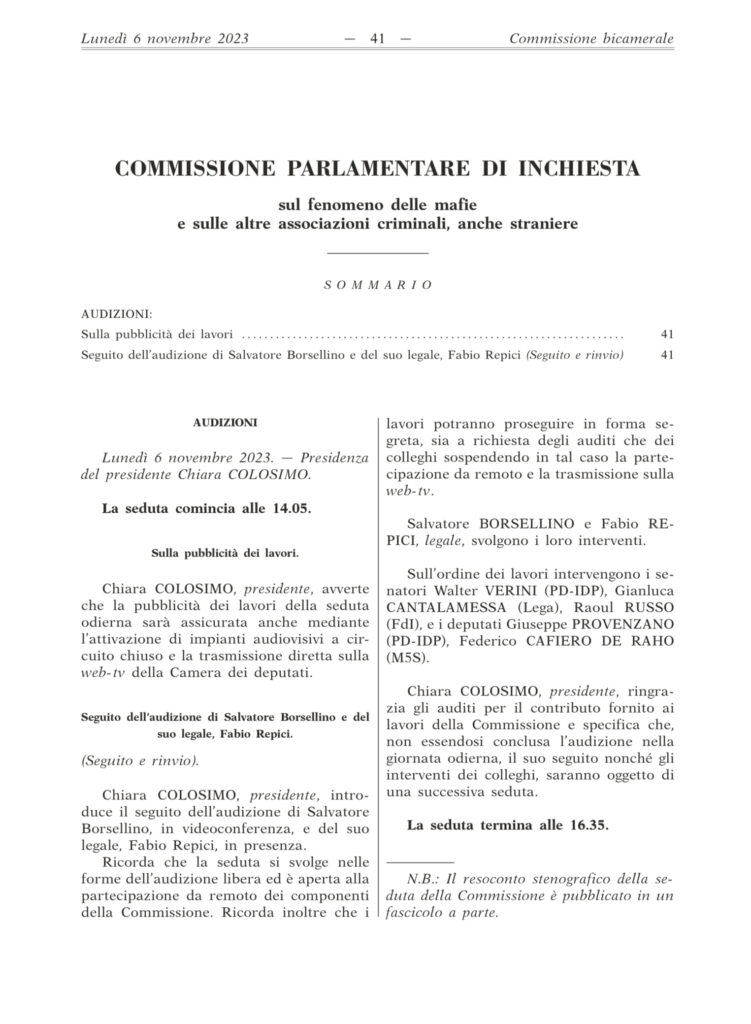
VIDEO
RESOCONTO STENOGRAFICO Seduta n. 19 di Lunedì 6 novembre 2023
La seduta comincia alle 14.05.
PRESIDENTE. Avverto che se non vi sono obiezioni la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso nonché via streaming sulla web-tv della Camera.
Seguito dell’audizione di Salvatore Borsellino e del suo legale, Fabio Repici.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione del dottor Salvatore Borsellino, collegato da remoto, e del suo legale, avvocato Fabio Repici, in presenza, che saluto e ringrazio ancora per la loro disponibilità.
Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell’audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta dell’audito o dei colleghi. In tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web-tv.
In apertura, darò la parola al dottor Borsellino e poi al suo legale.
SALVATORE BORSELLINO. Buongiorno, prendo brevemente la parola per fare una correzione in relazione a una mia dichiarazione fatta nel corso della precedente audizione del 18 ottobre. In quell’occasione, affermai che il generale Borghini, che ci risultava presente in via D’Amelio subito dopo la strage del 19 luglio, non fosse mai stato ascoltato dall’autorità giudiziaria in merito al furto dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. In realtà, ho potuto appurare che è stato ascoltato in due occasioni. La prima, l’8 settembre del 2005, presso la DIA di Caltanissetta come persona informata dei fatti. In quell’occasione, dichiarò di poter escludere che qualcuno, in particolare il capitale Arcangioli, gli avesse mai mostrato o parlato della borsa di cuoio appartenuta al dottor Borsellino.
Nel 2020, invece, nel corso del processo a Mario Bo e altri, alla domanda dell’avvocato Fabio Repici se avesse notato se il capitano Arcangioli avesse qualcosa in mano quando l’aveva incrociato in via D’Amelio, rispose: «No, questo non me lo ricordo», e, alla domanda se con lo stesso capitano Arcangioli si fosse in quell’occasione fermato o avessero avuto qualche tipo di interlocuzione, rispose: «No, assolutamente no, io non ho parlato con nessuno del personale operante».
Orbene, nel video e nelle foto che noi abbiamo esaminato, invece, i due vengono più volte ritratti insieme, anche nelle vicinanze della macchina di Paolo Borsellino, e non risulta quindi verosimile che possano non essersi parlati, tenendo presente che all’epoca della strage Borghini prestava servizio a Palermo nel grado di tenente colonnello con l’incarico di comandante del gruppo Carabinieri Palermo. Questa è la realtà.
Con l’occasione, ribadisco che una vera verità e una vera giustizia sulle stragi che hanno insanguinato la storia del nostro Paese non può prescindere dal fatto che vengano messi in luce quali apparati hanno sottratto l’agenda rossa di Paolo Borsellino, abbiano cancellato il contenuto dei dischi dal database di Giovanni Falcone e abbiano sottratto i documenti contenuti nella cassaforte di Carlo Alberto Dalla Chiesa.
A mio avviso è da questi fatti che bisogna partire se davvero si vuole una vera verità e una vera giustizia e non una verità di comodo, confezionata per nascondere all’opinione pubblica altre terribile verità che macchiano la storia del nostro Paese o per le esigenze di ripulire la storia del nostro Paese a vantaggio dell’una o dall’altra parte politica. Ecco, io mi auguro che questa Commissione voglia procedere in questo senso. Partire da questi fatti e appurare queste verità. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie a lei dottor Borsellino. Faremo del nostro meglio perché non ci siano più coni d’ombra.
Do la parola all’avvocato Repici.
FABIO REPICI. Grazie al presidente e a tutti i commissari. La volta scorsa ho cercato di esporre quanto ritenevo e ritengo utile ai lavori della Commissione e avevo interrotto appena prima di parlare del depistaggio delle indagini e poi dei processi sulla strage di via D’Amelio.
In realtà devo segnalare due cose in premessa. La prima è scaturita anche a seguito di una informale sollecitazione che mi è venuta dall’onorevole Orlando, che ho riconosciuto terminata l’audizione in quanto è stato ministro della Giustizia, e quindi a me volto noto, e che ho scoperto essere attuale componente della Commissione antimafia. Egli mi ha chiesto se avessi i documenti relativi alla vicenda riguardante le indagini delegate dalla Procura di Marsala al dottor Rino Germanà e che purtroppo hanno avuto come esito, come ritengo, l’attentato a suo danno, commesso il 14 settembre 1992.
Ho fatto una verifica e sono riuscito a recuperare tutta la documentazione e tutti gli accertamenti agli atti degli uffici giudiziari sulla relazione di servizio, redatta il 13 febbraio del 1992, dal presidente della Corte di assise di appello di Palermo, dottor Salvatore Scaduti, nella quale si segnalava l’allarmante visita, ricevuta dallo stesso dottor Scaduti appena prima della sentenza sull’omicidio del capitano Basile, del notaio Pietro Ferraro a lui indirizzato da un lato per il tramite del dottor Signorino, al quale si era rivolto per avere il contatto con il dottor Scaduti, e dall’altro su induzione di un politico indicato come esponente della corrente dell’allora ministro Calogero Mannino e a nome Enzo.
Ho recuperato tutti gli atti che ho provveduto a portare con me, insieme a ulteriore documentazione anche su altri temi di cui ritengo sia doveroso la Commissione antimafia entri in possesso, in modo che possa ulteriormente approfondire i propri lavori.
Riportandomi a quanto ho già detto, segnalo però alcuni dati che emergono proprio dai documenti che consegno. Faccio rinvio in particolare a una relazione che sul punto fu redatta dal dottor Massimo Russo, che era il giovane sostituto procuratore della procura di Marsala il quale, insieme alla dottoressa Camassa, si era occupato di quelle indagini, una relazione nella quale egli mette insieme i dati di propria esperienza, anche personale, in riferimento a ciò che avvenne durante quelle indagini, così che oggi possiamo attestare come certo che il dottor Paolo Borsellino fu personalmente portato a conoscenza di quell’attività di indagine delegata al dottor Germanà. Fu personalmente portato a conoscenza sia dai due magistrati della procura di Marsala, Camassa e Russo, sia dallo stesso dottor Germanà, a inizio giugno 1992.
Oltre a questo, possiamo definitivamente attestare che, nell’indagine conseguita alla relazione del dottor Scaduti presso la procura di Palermo, della quale fu titolare l’allora procuratore aggiunto dottor Aliquò, furono accertati mediante intercettazione telefonica i contatti fra il notaio Pietro Ferraro e l’allora non ancora senatore Vincenzo Inzerillo, dato che le indagini furono a cavallo delle elezioni del 5-6 aprile 1992.
Al riguardo di Vincenzo Inzerillo, va ricordato che si tratta di soggetto pregiudicato per concorso esterno in associazione mafiosa, quale – così è stato ritenuto dalla sentenza irrevocabile – esponente politico nelle mani della famiglia Graviano, in relazione, in particolare, con Giuseppe Graviano. È superfluo ricordare che Giuseppe Graviano è il coordinatore principale dell’attività di esecuzione della strage di via D’Amelio. Quelle intercettazioni che coinvolgevano il senatore Inzerillo intervengono addirittura prima della strage di Capaci.
Il dottor Russo fa notare – e dalla documentazione che ho portato c’è la prova documentale di questo – come il fascicolo che conteneva le intercettazioni fatte sulle utenze del notaio Ferraro e comprovanti i rapporti con il senatore Inzerillo, furono trasmesse dalla procura di Palermo alla procura di Caltanissetta, per un verso, e alla procura di Marsala, per un altro. In particolar modo è significativo come l’allora sostituto procuratore di Caltanissetta, dottor Polino, che ricevette la documentazione trasmessa da Palermo, già a fine marzo 1992, segnalava il probabile errore in cui era in corso il dottor Aliquò nell’identificare in Culicchia il Vincenzo indicato nella relazione del dottor Scaduti, che invece era da individuare nel senatore Vincenzo Inzerillo. Il dato è doppiamente significativo perché, per la parte di quella indagine rimasta a Palermo, essa fu chiusa – c’è una richiesta di archiviazione del dottor Aliquò del 20 maggio 1992 – esattamente in contemporanea con la convocazione, ad opera del vice capo della polizia, prefetto Rossi, del dottor Germanà, avvenuta in modo particolarmente irruento al momento del deposito della informativa del dottor Aliquò presso la procura di Marsala.
Dalla relazione del dottor Russo, ma anche da tutti gli atti che vi produco, vedrete che c’è una stretta connessione fra quell’indagine, riguardante la relazione di servizio del dottor Scaduti, e altre indagini che aveva la procura di Marsala sull’onorevole Gunnella, in relazione alla posizione del dottor Domenico Signorino, il cui nome sostanzialmente veniva fuori sia in relazione ai contatti tentati dal dottor Ferraro per «addomesticare» la sentenza sull’omicidio del capitano Basile sia in relazione ai contatti del dottor Signorino con l’onorevole Gunnella. Il dottor Signorino venne audito a sommarie informazioni dai due magistrati della procura di Marsala il 12 giugno 1992. Quelle due indagini erano strettamente intrecciate, erano assegnate alle stesse due persone, e cioè ai dottori Camassa e Russo, ed entrambe le vicende procedimentali furono portate dai due giovani magistrati all’attenzione di Paolo Borsellino. Perché segnalo il grossissimo rilievo che secondo me ha quella vicenda? I rapporti fra Vincenzo Inzerillo e Giuseppe Graviano non si interruppero prima della strage di Capaci, ma proseguirono fino a tutto il 1993 e possiamo dire fino a poco prima dell’arresto di Giuseppe e Filippo Graviano, avvenuto a Milano il 27 gennaio 1994. Il senatore Inzerillo, così come risulta dalla documentazione che produco, seguì le attività di Giuseppe Graviano sotto il versante delle ambizioni politiche di alcuni appartenenti a Cosa nostra, in primis Giuseppe Graviano, insieme a Leoluca Bagarella e Matteo Messina Denaro, di fondare una formazione politica che venne denominata «Sicilia Libera», sostanzialmente – nella idea degli artefici – la proiezione politica che doveva consentire a Cosa nostra di passare impunemente dagli equilibri della prima Repubblica a quelli della seconda. Sappiamo che poi, per decisione degli stessi boss di Cosa nostra, il progetto «Sicilia Libera» alla fine del 1993 fu sostanzialmente abortito con altra scelta – anche di ciò c’è traccia negli approfondimenti giudiziari che sono stati fatti, e ricordo le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, – che seguì i rapporti intercorsi fra Giuseppe Graviano e l’onorevole Marcello Dell’Utri al momento della nascita del nuovo partito politico con cui si sarebbe inaugurata la seconda Repubblica.
Il punto è che, dalle molteplici dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dalle risultanze investigative, i tre artefici di «Sicilia Libera» furono appunto Giuseppe Graviano Leoluca Bagarella e Matteo Messina Denaro. Non mancherà a voi di rilevare il dato particolarmente allarmante che si tratta dei tre esecutori del tentato omicidio Germanà. Quindi c’è la coincidenza non solo nei soggetti passivi, vittime o delle attenzioni o addirittura del fuoco di Cosa nostra, ma anche dei soggetti attivi, cioè di coloro che dentro Cosa nostra operavano, da un lato, in via direttamente criminale con le stragi e gli attentati e, dall’altro, anche elaborando progetti politici che ebbero concreti iniziali sviluppi e che ebbero anche contatti di notevole rilievo. Per questo motivo, proprio nel momento in cui scoppiò in lacrime davanti ai dottori Camassa e Russo, parlando di un amico da cui si sarebbe sentito tradito, trovo molto importante il dato che possiamo ritenere accertato che il dottor Borsellino fosse stato, da un lato, il terminale dei due giovani magistrati e, dall’altro, il terminale del dottor Germanà, cioè l’investigatore che se ne era occupato. Il dottor Germanà, sentito quale testimone dell’autorità giudiziaria, ha riferito anche che il dottor Borsellino aveva cognizione precisa degli ambienti che erano stati oggetto dei suoi accertamenti investigativi, in quanto lo stesso dottor Borsellino insieme al dottor Germanà si era occupato in passato proprio di un esponente particolarmente rilevante della massoneria nella storia d’Italia. Si tratta di uno dei soggetti che, a metà degli anni ’70, si occupò del progetto di riunificazione complessiva delle diverse obbedienze massoniche esistenti in Italia nonché dell’ingresso dei principali esponenti di Cosa nostra dentro le obbedienze massoniche, e cioè il dottor Luigi Savona, che è lo stesso che venne indicato da Luigi Ilardo quale personaggio al centro di quello scenario a più partecipazioni, e cioè mafia, massoneria, politica ed eversione neofascista, che secondo lo stesso Luigi Ilardo aveva replicato il proprio protagonismo con le stragi del 1992-1993.
Questo è il motivo per cui ritengo particolarmente rilevante quella documentazione, segnalando che dalla procura di Caltanissetta nel corso degli anni sono stati effettivamente fatti sforzi per cercare di approfondire questo tema. Ritengo però che in realtà l’impegno sui diversi ambiti di quella vicenda abbia sofferto di una certa parcellizzazione e di trattazione separata che forse non hanno consentito di cogliere appieno l’unicità del dato. Tanto più che, come emerse anche dalle attività svolte per il processo sulle stragi del 1993 dal dottor Gabriele Chelazzi, oggi sappiamo che il senatore Inzerillo partecipò addirittura a riunioni con esponenti di vertice di Cosa nostra nelle quali si parlò proprio delle stragi nel momento in cui l’attività stragista di Cosa nostra stava spostandosi dalla Sicilia al continente.
Per passare a un’altra questione di cui ho parlato, ma su cui ho reperito altra documentazione che è utile portare alla conoscenza della Commissione, avevo riferito della collaborazione avviata il primo luglio 1992 da Gaspare Mutolo proprio con il dottor Borsellino, collaborazione che aveva dovuto superare impacci di vario tipo, anche strettamente burocratici, da parte della procura di Palermo.
Segnalo un dato, proprio per assoluta chiarezza e perché non ci sia il rischio di scivolare in misunderstanding che portino ricostruzioni per via logica a contrastare con i dati documentali.
Il 5 novembre 1992, l’autorità giudiziaria di Caltanissetta, nella persona del pubblico ministero dottor Fausto Cardella, fece un’attività formale con la quale fu repertato il contenuto della borsa del dottor Borsellino, scomparsa dalla sua auto il 19 luglio 1992 e rinvenuta, non si capisce bene come, proprio nei giorni precedenti nell’ufficio del dottor Arnaldo La Barbera.
Dico questo e consegno anche il verbale redatto dal dottor La Barbera, per riferire che, naturalmente, nella borsa di Paolo Borsellino non venne rinvenuta l’agenda rossa, come noto, ma il dato in questo momento principale che mi permetto di segnalare è che è assolutamente un dato fuori dalla realtà, anzi contrario ai dati di realtà, il fatto che nella borsa di Paolo Borsellino ci fosse un fascicolo relativo a Gaspare Mutolo.
Questo è un dato assolutamente contrario alla realtà ed erroneamente, non so per quale motivo, riferito oralmente dal dottor Vittorio Aliquò in una qualche occasione.
Il contenuto della borsa del dottor Borsellino è quello che è stato repertato, nei reperti che sono stati lasciati dentro quella borsa e, per quello che sappiamo da fonti più che autorevoli, cioè dalla moglie e dai figli di Paolo Borsellino, l’unico elemento mancante era la agenda rossa.
Questo è un dato pacifico sul quale ritengo sia rischioso fare valutazioni o ricostruzioni su base non documentale, a distanza di oltre 31 anni.
Passiamo al depistaggio sulla strage di via D’Amelio. La sentenza della Corte di assise di Caltanissetta del 20 aprile 2017 sul processo Borsellino-quater, è assolutamente chiara e, a mio modo di vedere, apprezzabile sul punto. Quindi rimando a quella sentenza quanto alla evoluzione delle indagini, alla partecipazione abusiva alle indagini di esponenti del SISDE, con il coinvolgimento fin da subito del dottor Bruno Contrada da parte del procuratore Tinebra, e quanto all’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Vincenzo Scarantino ed eseguita il 26 settembre del 1992 e agli sviluppi, sotto forma di attività davvero persecutoria, in danno di Vincenzo Scarantino per convincerlo ad accettare il ruolo di falso collaboratore di giustizia sulla strage di via D’Amelio.
Questi sono dati pacifici e rinvio alla sentenza del Borsellino-quater. Mi permetto di segnalare un dato che riguarda Vincenzo Scarantino, il principale protagonista del depistaggio, cioè il dottor Arnaldo La Barbera, e un altro gravissimo delitto.
Come la Commissione sa, il 5 agosto 1989, a Villagrazia di Carini fu ucciso il poliziotto Antonino Agostino, insieme alla moglie, Ida Castelluccio. Le indagini furono indirizzate dal dottor La Barbera, in modo veramente imperdonabile, direi infame, su una incredibile pista passionale. Non entro nel merito, perché sarebbe veramente una caduta di dignità rispetto alle investigazioni e alla giurisdizione parlare della pista passionale sul duplice omicidio Agostino-Castelluccio.
Il dato però assolutamente rilevante e, a mio modo di vedere, enorme è che il 9 agosto 1990 fu sentito a sommarie informazioni il papà del poliziotto Agostino, il signor Vincenzo Agostino, perché potesse individuare con riconoscimento fotografico un personaggio particolarmente importante che, qualche settimana prima del delitto, si era presentato insieme ad altro uomo a Villagrazia di Carini per, ritengo, fare un sostanziale servizio di osservazione e verifica dei luoghi nei quali poi fu effettivamente commesso il delitto, soggetto che poi a febbraio 2016 il signor Vincenzo Agostino riconobbe nell’ex poliziotto Giovanni Aiello, convenzionalmente divenuto più famoso con la locuzione «Faccia da mostro».
Il 9 agosto 1990 per fare il riconoscimento di quell’uomo, poi individuato in «Faccia da mostro», presso la squadra mobile di Palermo furono sottoposte al signor Agostino alcune fotografie e fra queste, del tutto incredibilmente, vi era quella di Vincenzo Scarantino.
Tenete conto che siamo a due anni prima della strage di via D’Amelio, allorché Vincenzo Scarantino era un piccolo criminale di borgata che sicuramente nulla poteva avere a che fare con il duplice omicidio Agostino-Castelluccio.
Eppure la squadra mobile di Palermo aveva già il jolly pronto per coprire, con una figura il cui profilo era strettamente criminale, in realtà pure di bassa lega, la posizione di soggetti che invece avevano una particolare caratteristica, quella di non essere uomini di Cosa nostra. Nell’agosto del 1990 si tenta di indurre in errore il signor Agostino, facendogli abbinare la figura di «Faccia da mostro» al piccolo criminale Vincenzo Scarantino, poi sappiamo che nel 1992 sulla strage di via D’Amelio viene riesumato il jolly – non andato a buon fine nel 1990, grazie alla mancata caduta nel tranello da parte del signor Agostino. Nel 1992, invece, il depistaggio lo si deve fare per forza, perché su una strage di quelle dimensioni non si può lasciare la investigazione senza alcun risultato, e quindi si decide di procedere contro Vincenzo Scarantino.
Sappiamo della collaborazione di Vincenzo Scarantino. In anni recenti, e cioè dalla fase immediatamente successiva alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza che hanno per fortuna disinnescato ex post quel depistaggio, abbiamo appreso varie versioni sulla partecipazione di magistrati alla attività di ricerca e di ottenimento di risultati sulla scorta delle false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino. Nel processo Borsellino-quater, e se ne dà conto anche nella sentenza, io mi adoperai per far entrare nel fascicolo del dibattimento la registrazione di una conferenza stampa. I primi arresti avvenuti con le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, iniziate nel carcere di Pianosa il 24 giugno 1994, furono eseguiti il 18 luglio 1994. Nel secondo anniversario della strage di via D’Amelio, il 19 luglio, nel palazzo del Viminale, cioè proprio nella sede sociale del depistaggio, fu svolta una conferenza stampa alla quale parteciparono anche i magistrati della procura di Caltanissetta.
L’audio è ancora reperibile sul mai abbastanza ringraziato archivio di Radio Radicale. Chiunque possa ascoltare quella conferenza stampa sentirà che a parlare, a elogiare i risultati ottenuti con le false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, furono solo due magistrati: il Procuratore della Repubblica del tempo, dottor Giovanni Tinebra, e la sostituta applicata a Caltanissetta dottoressa Ilda Boccassini. Sono questi i soggetti che rivendicarono i risultati ottenuti con le false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino.
Ciò detto, ci sono ulteriori questioni riguardanti il depistaggio.
A mio modo di vedere, la principale è quella relativa proprio alla sparizione, o meglio, più che alla sparizione, alla sottrazione dell’agenda rossa del dottor Borsellino.
Come avete sentito da Salvatore Borsellino, questa è stata la principale spinta all’impegno di Salvatore Borsellino e di chi ha collaborato con lui nel tentativo di sottrarre elementi importanti al buio delle investigazioni.
Sulla agenda rossa io posso dire, avendo partecipato come difensore di parte civile al processo Borsellino-quater, che si tratta della frazione degli accertamenti sulla strage maggiormente vittima di trascuratezza e omissione da parte degli uffici giudiziari. Si è arrivati al punto che tutto quello che sappiamo sulla sparizione dell’agenda rossa per puro paradosso, lo sappiamo per iniziativa di privati cittadini. Il primo fu un giornalista, Lorenzo Baldo, della testata «Antimafia 2000», che nel 2005 ricevette una comunicazione anonima con la quale gli veniva segnalata l’esistenza di una o più immagini di un ufficiale dei carabinieri che si allontanava dal teatro della strage avendo in pugno la borsa del dottor Borsellino.
Egli riferì all’autorità giudiziaria e furono rinvenute le fotografie e poi alcuni video raffiguranti il capitano Giovanni Arcangioli il quale, senza avere mai lasciato alcuna traccia, alcuna relazione di servizio, alcuna annotazione, cioè furtivamente – perché è l’unico modo in cui si può descrivere quella azione – mentre c’erano le fiamme in via D’Amelio, mentre c’erano ancora i feriti da soccorrere, ebbe quale sua prima e forse esclusiva pulsione quella di impossessarsi della borsa di Paolo Borsellino e allontanarsi dal teatro della strage per l’esattezza in direzione di via dell’Autonomia siciliana. Su quella condotta del capitano Arcangioli è stato impossibile avere un accertamento processuale, nel senso di una verifica dibattimentale, perché egli fu prosciolto in udienza preliminare sull’imputazione di furto dell’agenda rossa.
Quella sentenza fu confermata dalla Corte di cassazione a cui aveva fatto ricorso la procura di Caltanissetta. C’è però da dire che nel processo Borsellino-quater ci si è nuovamente occupati di quella vicenda e in particolar modo è stato proprio mio impegno, in ossequio al fedele patrocinio della posizione di Salvatore Borsellino, quello di fare luce il più possibile sulla sottrazione della agenda rossa. Anche grazie al nostro impegno la Corte di assise di Caltanissetta segnalò alla procura, trasmettendo integralmente gli atti del processo Borsellino-quater, che andavano ulteriormente sviluppati gli accertamenti sulla sottrazione dell’agenda rossa.
Mi ero permesso anche di segnalare un dato che ritenevo significativo: il capitano Arcangioli, che era stato sottoposto a processo solo a partire dal 2005, poiché il delitto di furto era nel frattempo coperto dalla prescrizione, nella sua sede processuale aveva rinunciato alla prescrizione, cosa che a mio modo di vedere consentiva ulteriori attività che potevano essere svolte anche dopo la sentenza del Borsellino-quater.
Non abbiamo avuto notizia in nessun modo di alcuna attività utile sulla sottrazione dell’agenda rossa.
In riferimento alla supplenza che privati cittadini hanno dovuto prestare alle omissioni istituzionali, di cui parlavo prima, il miglior accertamento fatto sulla sparizione dell’agenda rossa o meglio sull’impossessamento da parte del capitano Arcangioli della borsa del dottor Borsellino, la migliore attività è stata svolta dalla associazione fondata da Salvatore Borsellino, chiamata proprio per questo «Agende rosse» e in particolar modo da un bravissimo operatore informatico che si chiama Angelo Garavaglia.
Ho prodotto alla Corted’Assise un video realizzato da Angelo Garavaglia nel quale egli è riuscito a fare tutti gli accertamenti possibili, anche con la individuazione del momento esatto e del minuto esatto dell’apprensione della borsa, grazie alla parziale raccolta di documentazione video da parte degli operatori televisivi che ne avevano il possesso e dai quali riuscì a ottenere alcuni video. Mi consta, e questo lo affermo con grado di certezza, che in realtà l’attività svolta privatamente da Angelo Garavaglia non ha avuto analogo sviluppo in sede istituzionale e quindi il paradosso oggi è che, a distanza di trentun anni dalla strage di via D’Amelio, non è stata effettuata una integrale acquisizione presso tutti gli operatori televisivi del Paese, come doveroso, a mio modo di vedere, di tutta la documentazione in archivio relativa a video raffiguranti i minuti e le ore successive alla strage di via D’Amelio.
Se perdonate questa attività di sollecitazione da parte mia, mi permetto di segnalare questo come un fattore particolarmente rilevante che dovrebbe accendere la vostra attenzione, cioè proprio potreste essere voi forse la prima istituzione del Paese a riuscire a raccogliere in modo integrale tutta la documentazione video su via D’Amelio, cosa che non è ancora avvenuta. Questo lo dico con cognizione di causa perché Angelo Garavaglia, del quale produssi nel processo Borsellino-quater quel preziosissimo lavoro fu addirittura convocato lui dall’autorità giudiziaria perché riferisse dei documenti video sui quali aveva impostato il suo lavoro. Quindi la sollecitazione è duplice. Da un lato appunto l’attività di raccolta di quel materiale video e dall’altro l’audizione del signor Angelo Garavaglia che molto meglio di me sul punto può aiutare i vostri lavori.
Il processo Borsellino-quater ha avuto un seguito, come a tutti noto, perché, all’esito di quella sentenza del 20 aprile 2017, la cui motivazione fu depositata il 30 giugno 2018, la procura di Caltanissetta ha attivato un procedimento che poi si è tradotto in un processo tuttora pendente presso la Corte d’appello di Caltanissetta, a carico di tre esponenti della polizia di Stato, Bo, Mattei e Ribaudo. Poiché il dovere di rispetto del principio di realtà, nel senso della parresia di cui vi dissi l’altra volta, ritengo sia cogente anche in questo momento, devo segnalare che la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Caltanissetta nei confronti di Bo e degli altri due poliziotti, come voi sapete, ha avuto quale conclusione la sentenza di assoluzione per l’imputato Ribaudo e di proscioglimento per prescrizione per gli imputati Mattei e Bo.
Vi segnalo un dato rilevante. L’imputazione a carico dei tre poliziotti era in concorso con Vincenzo Scarantino. Vincenzo Scarantino per quelle ipotesi di reato era stato imputato nel processo Borsellino-quater, perché era stato chiamato a rispondere di calunnia aggravata. Come voi sapete, la sentenza di primo grado riconobbe a Vincenzo Scarantino la prescrizione, solo perché gli fu riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’articolo 114 del codice penale, di essere stato determinato a compiere quelle condotte dai soggetti che ne avevano la gestione, e cioè gli uomini della polizia di Stato del gruppo diretto dal dottor La Barbera.
Questo lo dico perché se a Scarantino non fosse stata riconosciuta alcuna attenuante egli, nella ricostruzione della Corte d’assise di Caltanissetta, avrebbe ricevuto una sanzione, sarebbe stato anch’egli condannato. Perché vi dico questo? perché nel processo Borsellino-quater, come voi sapete, non furono imputati poliziotti.
I poliziotti furono imputati nel processo che ha trovato definizione solo nell’anno 2022, con la sentenza di prescrizione che vi ho detto. Poiché spesso nella narrazione pubblica delle vicende giudiziarie l’effetto di propaganda prevale sul rispetto della realtà, mi permetto di segnalare una circostanza e cioè che alla prescrizione per i poliziotti imputati delle calunnie esecutivamente commesse da Vincenzo Scarantino, si è arrivati solo per il tempo perso dalla procura di Caltanissetta non nel 1992 – per intenderci quella guidata dal dottor Tinebra – ma quella che ha trattato anche il processo Borsellino-quater. Di questo negli atti che vi produco vi do prova documentale, perché, parallelamente al processo Borsellino-quater, era stato aperto un fascicolo dalla procura di Caltanissetta nei confronti dei poliziotti, in particolar modo del dottor Mario Bo, oltre che di due altri funzionari. Quel procedimento fu definito con provvedimento di archiviazione su richiesta della procura di Caltanissetta. Questo avvenne in costanza del dibattimento a carico di Scarantino per le stesse calunnie.
Il punto è che a quella definizione si era arrivati nel 2015 con il provvedimento di archiviazione del GIP, su richiesta della procura di Caltanissetta, ma tale procura aveva segnalato che la richiesta non era dovuta alla scadenza dei termini delle indagini preliminari, che erano già cessati credo nel 2011, ma perché non aveva potuto fare uso di atti successivamente acquisiti. Senonché questo avvenne solo nel 2015. In questo senso bisogna prendere atto di come alle volte l’intervento dei soggetti politici può avere effetti positivi anche in relazione alla giurisdizione, perché era avvenuto che nell’estate del 2015 era stata rilasciata dall’allora procuratore di Caltanissetta un’intervista con la quale egli aveva riferito che il fascicolo a carico dei poliziotti sarebbe rimasto in fase di sospensione, in attesa della sentenza del processo Borsellino-quater.
Avvenne poi che, anche in conseguenza di quelle dichiarazioni del procuratore Lari, venne formulata un’interrogazione parlamentare da una deputata del tempo, l’onorevole Giulia Sarti, al ministro della Giustizia.
Non è un caso che, immediatamente dopo quella interrogazione parlamentare che lamentava i ritardi nella definizione di quel procedimento e la irragionevolezza di aspettare e di sospendere gli accertamenti in attesa di altri processi, la procura di Caltanissetta arrivò a concludere l’indagine con la richiesta di archiviazione.
Lo fece, ottenne l’archiviazione, ma dimenticò di chiedere l’autorizzazione alla riapertura delle indagini, visto che c’erano stati degli elementi che la stessa procura aveva dichiarato nella sua richiesta di archiviazione di non poter utilizzare perché acquisiti solo dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari.
Quel tempo perso fra il 2015 e il 2018, è il motivo per cui il processo Bo più due si è concluso con una sentenza di prescrizione, il che naturalmente non vuol dire nulla sul merito, nel senso che uno dei tre imputati sappiamo essere stato assolto nel merito. Certo è che però la impossibilità di pronunciare sentenza prima dell’estinzione del reato per prescrizione è derivata dalle ragioni che vi ho segnalato. Come ho detto, il processo a carico dei tre poliziotti è ancora in corso. C’è stata udienza il 31 ottobre scorso, cioè la settimana scorsa, proseguirà a fine mese e quindi sul punto nulla posso dire di valutazioni conclusive su quella vicenda.
Ritengo invece doveroso approfondire un tema che nel corso degli anni, a partire all’incirca dal 1998, è stato tirato fuori o sottolineato da più parti come una delle possibili ragioni che portarono alla strage di via D’Amelio.
Mi riferisco alla vicenda diventata famigerata con la locuzione «mafia-appalti», cioè all’attività di indagine che i carabinieri del gruppo 1 di Palermo nel 1989 e poi i carabinieri del ROS svolsero sostanzialmente su delega della procura della Repubblica di Palermo.
Mi permetto di segnalarvi il mio convincimento a conclusione dell’analisi di una mole di documenti significativa che ho portato alla vostra attenzione e che oggi mi consente serenamente di dire che la causale mafia-appalti ipotizzata per la strage di via D’Amelio la possiamo definire come una sorta di pista palestinese su via D’Amelio, se vogliamo richiamare il tentativo di depistaggio avvenuto per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.
Sappiamo poi che sulla strage di Bologna in realtà la attività di elaborazione di piste assolutamente mistificatorie continua a progredire con una velocità che non consente di stare dietro agli artefici, perché, proprio nei giorni scorsi, mi è capitato di leggere che addirittura alla pista palestinese ora è sopravvenuta una pista ancora più psichedelica che mi viene da definire israelo-palestinese, in relazione a elaborazioni e produzioni letterarie che ho visto trovano sponda o sostegno sempre negli stessi ambienti della eversione neofascista e, in particolar modo, nel caso ultimo che vi citavo, anche da parte di esponenti di Ordine Nuovo.
Perché dico che la causale mafia-appalti è un po’ la pista palestinese su via D’Amelio? Circa le indagini su mafia e appalti – nel senso delle indagini condotte dai carabinieri perché naturalmente sulle ingerenze delle mafie negli appalti in Italia ritengo ci siano state indagini in ogni distretto giudiziario del Paese – per limitare la nostra valutazione a quelle più famose, le indagini iniziarono nel 1989. Sappiamo che ebbero un primo esito con il deposito di un rapporto giudiziario al dottor Giovanni Falcone il 13 febbraio 1991. Si dice: ma c’è stata una doppia refertazione sulle risultanze di quelle indagini?
Alcuni arrivano a sostenere che ciò non sia avvenuto, muovendo guerra ai dati documentali. Noi sappiamo che quel rapporto giudiziario del 13 febbraio 1991 fu oggetto di procedimento penale trattato dalla procura di Palermo.
Sappiamo che per una parte quel procedimento arrivò a misura cautelare già nell’estate del 1991 con imputazioni, in quel momento provvisorie, ma che poi portarono a un dibattimento e quindi diventarono formalmente imputazioni, che prevedevano anche la contestazione di associazione mafiosa nei confronti di alcuni imputati, tra gli altri Angelo Siino.
Sappiamo un altro dato, e cioè che il 3 settembre 1992 fu redatto un ulteriore rapporto da parte del ROS, avente lo stesso identico oggetto.
Due rapporti, con lo stesso oggetto, aventi uno la data del 13 febbraio 1991 e uno la data del 3 settembre 1992, Se non è doppia refertazione questa, io non so cosa sia la doppia refertazione.
Il punto è che nel documento depositato alla procura di Palermo il 5 settembre del 1992 erano inserite intercettazioni e riferimenti ad attività investigativa riguardanti esponenti politici primari della Sicilia e del Paese, che erano stati raccolti dal ROS nel 1990 e 1991, in epoca precedente al rapporto 13 febbraio 1991.
Quindi, per precisa scelta di coloro che si occuparono della redazione di quel documento, le risultanze del 1990 furono tenute fuori da quel rapporto e inserite solo nel settembre 1992. Il dato significativo non è solo questo, perché si è potuto apprendere dalle dichiarazioni non processuali – quasi mai – ma soprattutto pubbliche da parte dei due ufficiali del ROS che principalmente si occuparono, uno come coordinatore e l’altro come diretto investigatore di quelle indagini, e cioè Mario Mori e Giuseppe De Donno, si è potuto apprendere il loro convincimento che quell’attività sia stata sostanzialmente la causa principale della strage di via D’Amelio, ma lo si è potuto apprendere solo per via di dichiarazioni del dibattito pubblico e non in sede processuale. Ciò per un motivo, perché in realtà il generale Mori e il colonnello De Donno nelle occasioni in cui si sono trovati imputati nel processo denominato trattativa, De Donno in quel processo, e in altri due processi il generale Mori, chiamati a rendere esame davanti ai giudici si sono sempre avvalsi della facoltà di non rispondere, com’era loro legittima facoltà. Certo è che questo è il crisma dei soggetti che dobbiamo tenere in considerazione per valutare le loro dichiarazioni. Questo lo dico perché se davvero quei due ufficiali il 20 luglio 1992 pensarono che la strage appena avvenuta in via D’Amelio fosse stata causata dall’interessamento del dottor Paolo Borsellino alle loro attività di indagine, noi siamo davanti a una omissione in atti d’ufficio perpetrata dal 1992 fino almeno al 1997-1998, perché ci sono due ufficiali di polizia giudiziaria che, pur convinti di quello, avevano tenuto nascosta quella circostanza, che solo a loro nella loro versione risultava, rifiutando di mettere a conoscenza l’autorità giudiziaria che procedeva sulla strage di via D’Amelio, cioè la procura di Caltanissetta, con la quale pure quei due ufficiali, durante la guida del dottor Tinebra, ebbero eccellenti rapporti. Allora come si fa a spiegare questa continuata omissione? La si spiega con un solo motivo, che è quello banale: è una menzogna che da quella vicenda fosse derivata la strage di via D’Amelio. Qui mi permetto perfino, con l’affetto che egli mi conosce, di dissentire dal mio assistito, Salvatore Borsellino, il quale, nella precedente audizione, secondo me più per spirito di bonomia e per evitare di tenere posizioni spigolose, ha detto che al più la vicenda mafia-appalti può essere stata una delle concause. Mi permetto di dissentire da lui con cognizione di causa, dicendo che non è stata neanche una concausa e questo lo dico per una ragione, cioè che non è solo il tempo della omissione della narrazione di Mori e De Donno per sei anni che è una cosa impensabile: pensare che un generale e un tenente colonnello dei Carabinieri si siano tenuti questo segreto fino al 1998 è davvero una cosa inenarrabile. Il punto è un altro, cioè quando per la prima volta Mario Mori e Giuseppe De Donno tirarono fuori il discorso delle indagini mafia-appalti, lo fecero spontaneamente o lo fecero per interessi difensivi? Questa è la domanda. E la risposta a questa domanda è una e una soltanto: lo fecero per interessi difensivi propri, legittimi, ma interessi difensivi. Dico questo perché il 13 ottobre 1997, in un momento in cui ancora, mai nessuno – mai nessuno – aveva riferito nulla all’autorità giudiziaria a proposito di questa questione, il 13 ottobre 1997 vennero convocati come testimoni dalla procura di Palermo il generale Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno. Il colonnello Giuseppe De Donno – vi produco il documento – venne sentito a sommarie informazioni dal procuratore Caselli e dai sostituti procuratori Prestipino e De Lucia. Gli vennero poste domande proprio sulla gestione di quei rapporti giudiziari e del contenuto di quelle indagini. Gli vennero poste domande non nel senso degli sviluppi che avevano avuto quelle indagini, ma delle possibilità che, anche per iniziativa di personaggi a loro vicini, quelle investigazioni fossero state conosciute da esponenti di Cosa nostra. Era avvenuto che nel luglio, a memoria direi il 5, ma non ci metto la mano sul fuoco, luglio del 1997, su iniziativa della procura di Palermo, era stato per l’ennesima volta arrestato Angelo Siino. Angelo Siino, raggiunto dal provvedimento di custodia cautelare, decide di collaborare con la giustizia e comincia a parlare dei suoi rapporti con esponenti del ROS. Da un lato di rapporti che difficilmente si possono ritenere legittimi in relazione ad alcuni sottufficiali, grazie all’operato dei quali nel racconto di Angelo Siino Cosa nostra aveva conosciuto il contenuto di quelle investigazioni, ma anche i rapporti che lo stesso Angelo Siino aveva avuto quale confidente fino a prima della sua collaborazione proprio con gli ufficiali del ROS che quelle indagini avevano curato. Il 13 ottobre 1997 – rimando al verbale, fatto da persone che non sono mai state qualificate come magistrati spinti da pulsioni politiche – il dottor Prestipino e il dottor De Lucia cioè l’attuale procuratore aggiunto di Roma e l’attuale procuratore della Repubblica di Palermo a brutto muso contestano al colonnello De Donno le circostanze a loro riferite dal collaboratore di giustizia Angelo Siino. Siamo a 5 anni e 2 mesi circa dopo la strage di via D’Amelio. Non mi si dirà che è un caso che la settimana dopo, il 20 ottobre del 1997, il colonnello Giuseppe De Donno scrive una nota al procuratore Tinebra, con la quale segnala che ha circostanze da mettere a conoscenza di quella procura per competenza motivata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, cioè in relazione a condotte asseritamente illecite di magistrati della procura di Palermo. Poiché quelle circostanze erano note al colonnello De Donno nel 1992 e negli anni successivi e poiché c’è un articolo del codice penale che punisce il pubblico ufficiale che, avendone avuto notizia, omette o ritarda di denunciare un fatto di reato – e direi che cinque anni è, più che un ritardo, una omissione – quella condotta del colonnello De Donno è la confessione del reato di cui all’articolo 361 del codice penale, se fosse vero ciò che egli riferì. Effettivamente – vi ho prodotto anche il documento – il 29 ottobre 1997 il colonnello De Donno fu sentito a sommarie informazioni dalla procura di Caltanissetta nella persona del PM, dottor Leopardi, cioè del magistrato in quel momento più vicino in senso assoluto al procuratore Tinebra, come è noto anche da vicende giudiziarie che coinvolsero direttamente il dottor Leopardi e indirettamente anche il dottor Tinebra in relazione al cosiddetto «Protocollo farfalla», un processo che si è celebrato innanzi all’autorità giudiziaria di Roma. Questo è il quadro oggettivo dei fatti. Ci si sveglia dopo oltre cinque anni e dopo essere stati messi quasi in stato d’accusa in quel verbale del 13 ottobre 1997, ci si ricorda che ci sono asserite condotte indebite di magistrati della procura di Palermo da segnalare a Caltanissetta. Mente chi avesse il coraggio di dire che non c’è una diretta correlazione fra la convocazione di De Donno dalla procura di Palermo e la sua segnalazione alla procura di Caltanissetta.
Quelle che vi riferisco sono le mie valutazioni. Io però vi ho prodotto tutti i documenti. La documentazione è veramente notevole. Ho avuto davvero difficoltà in ordine di tempo da dedicarvi, insieme agli impegni professionali e anche a quelle minime porzioni di vita privata che uno dovrebbe sempre mantenere. Spero di essere riuscito a produrvi tutto e se dovessi accorgermi di qualcosa di mancante, vi molesterò con ulteriori documentazioni. Il punto è che c’è stata una sede giudiziaria sulla quale è stato fatto un accertamento rispetto alle tesi propugnate dal generale Mori e dal colonnello De Donno. Vi segnalo subito che quella sede giudiziaria non è il procedimento dell’autorità giudiziaria di Caltanissetta definito con un’ordinanza di archiviazione che in quanto tale non è un provvedimento suscettibile di assumere autorità di cosa giudicata. In realtà quell’accertamento è stato effettuato dalla Corte di assise di appello di Palermo, nel processo cosiddetto «trattativa», nel quale la Corte, assumendo una posizione difforme da quella dei giudici di primo grado, ammise le difese dei generali Subranni e Mori e del colonnello De Donno di poter provare a loro difesa la veridicità di quelle tesi che essi propugnavano, proprio in relazione a quello che sostenevano e cioè che le loro funeste esperienze da imputati presso l’autorità giudiziaria di Palermo fossero conseguenza dei conflitti che avevano avuto, in ragione delle indagini di mafia-appalti, con la stessa procura di Palermo. La Corte di assise di appello di Palermo li ammessi a tentare di dare prova di ciò che asserivano e alla fine, valutate tutte le prove offerte, tutta la documentazione offerta – è la stessa documentazione che vi consegno – la Corte di assise di appello arriva una conclusione assolutamente tranciante che posso elencarvi andando con l’accetta. Ci fu una doppia refertazione, furono tenute nascoste risultanze di indagine del 1990 e furono tirate fuori solo nel 1992. Falsi furono gli addebiti a taluni magistrati della procura di Palermo di avere insabbiato quelle indagini, anzi, l’intreccio o il parallelismo che si creò per iniziativa dello stesso ROS fra un’attività di indagine della procura di Palermo e un’attività di indagine della procura di Catania, non era stata motivata dal fatto che alla procura di Palermo non ci fosse volontà di procedere su quella vicenda, a differenza della procura di Catania. Questo lo dico perché la Corte di assise di appello di Palermo tiene in considerazione anche la vicenda della collaborazione con la giustizia di quel geometra, Giuseppe Li Pera, che era un dipendente di una grossa società, la società Rizzani De Eccher, coinvolta in quelle indagini. Il punto è che, nella tesi propugnata da Mori e De Donno, la collaborazione del geometra Li Pera con l’autorità giudiziaria nella persona del sostituto procuratore di Catania, dottor Felice Lima, addirittura ho sentito dire essere stata quasi la causa, il detonatore per la strage di via D’Amelio. Devo fare una premessa, per non essere sospetto di occultare ragioni che potrebbero portarmi a valutazioni soggettive. Ho grandissima ammirazione e sono onorato della conoscenza del dottor Felice Lima, che uno dei magistrati più ragguardevoli che oggi sono presenti nell’ordine giudiziario, quindi il punto non è il dottor Felice Lima, il punto è ciò che fecero gli ufficiali del ROS in quella vicenda anche andando a condurre il dottor Lima in una situazione oggettiva di conflitto procedimentale con parallela attività che era presso il tribunale di Palermo che nel frattempo aveva già fissato l’udienza dell’avvio del dibattimento del processo a carico di Angelo Siino più altri. Nella versione propugnata da Mori e De Donno e dai loro epigoni, c’è che la collaborazione del geometra Li Pera è decisiva, viene rivolta alla procura di Catania nella persona del dottor Lima per il rifiuto, anzi il contrario interesse della procura di Palermo. Se uno va a leggere i verbali non di interrogatorio, ma di assunzione di sommarie informazioni che il geometra Li Pera rese alla procura di Catania nella persona del dottor Lima e li legge come li ha letti la Corte di assise d’appello di Palermo si accorge di una cosa che colpisce quasi traumaticamente l’osservatore. Cioè il geometra Li Pera al procuratore di Catania nasconde la presenza di Cosa nostra nella gestione degli appalti, cioè la realtà è l’esatto contrario della narrazione che da anni ci tempesta, perché l’idea che è stata lanciata con grossi mezzi di propaganda è che la collaborazione di Li Pera consentiva di asseverare definitivamente il protagonismo di Cosa nostra nella gestione degli appalti. Voi considerate che in un momento in cui lo stesso geometra Li Pera era imputato di associazione mafiosa davanti al tribunale di Palermo, insieme ad Angelo Siino, anch’egli imputato di associazione mafiosa, il geometra Li Pera di sé disse che era estraneo a ogni collegamento con ambienti mafiosi, ma lo disse addirittura di Angelo Siino, che poi è passato alla storia come il ministro dei lavori pubblici di Cosa nostra. Quindi la versione offerta da Li Pera alla procura di Catania fu che la mafia nel sistema mafia-appalti non esisteva e parlò del protagonismo di tre entità che indicò specificamente: politici, imprenditori e burocrati della burocrazia regionale. Questo è il quadro offerto da Li Pera che, secondo la vulgata degli ufficiali del ROS, avrebbe scatenato la strage di via D’Amelio. Sul punto ritengo che sia superfluo aggiungere altro, se non segnalarvi che il geometra Li Pera, proprio per effetto delle condotte degli ufficiali del ROS che tennero aperte due partite diverse, una presso la procura di Palermo e una presso la procura di Catania, il geometra Li Pera, che a Palermo era imputato a dibattimento di associazione mafiosa, sui fatti per i quali era imputato di associazione mafiosa alla procura di Catania, collaborata dall’allora capitano De Donno, venne sentito come persona informata sui fatti. Qui fra voi ci sono giuristi, ma anche coloro che non lo sono hanno ben chiaro come sia una circostanza che la dice tutta. La Corte di assise d’appello di Palermo conclude che è falsa la prospettazione fatta legittimamente dagli imputati Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, tesa a sostenere che la causale mafia-appalti fosse la vera ragione che aveva portato Cosa nostra e altri a decidere e a eseguire la uccisione di Paolo Borsellino e dei cinque poliziotti che quel 19 luglio lo accompagnavano.
La vicenda mafia-appalti ebbe poi un ordinario seguito presso l’autorità giudiziaria di Palermo nel senso che, già prima della strage di via D’Amelio, fu avviata dalla procura di Palermo attività finalizzata alla confisca dei beni di Antonino Buscemi. Furono avviate altre attività. Nel prosieguo furono emesse altre ordinanze di custodia cautelare, furono celebrati altri processi, in una prosecuzione che cronologicamente è assolutamente priva di ogni rallentamento o possibilità di sospetto. Alla vicenda mafia-appalti è legato come una sorta di totem che non ci si può permettere di contraddire, l’incontro del 25 giugno del 1992 avuto dal dottor Paolo Borsellino con il generale Mario Mori, allora colonnello, con l’allora capitano Giuseppe De Donno, per il tramite dell’allora maresciallo Carmelo Canale. Anche su quello ci sono dati oggettivi che non consentono di cadere nella suggestione tentata dai fautori di quella tesi. Il primo è che nell’agenda grigia del dottor Paolo Borsellino quell’incontro non trova alcuna annotazione alla pagina del 25 giugno 1992. C’è l’annotazione relativa al convegno organizzato dalla rivista MicroMega, nella serata del 25 giugno 1992, l’occasione in cui io vi dissi che andai ad ascoltarlo, ma non c’è traccia di quell’incontro. Io do per scontato che quell’incontro c’è stato perché è stato testimoniato anche dall’allora maresciallo Carmelo Canale. Quanto però al rilievo di quell’incontro, oltre che alla durata, se ci fermiamo alle indicazioni testimoniali di Carmelo Canale nell’epoca in cui le fece – perché poi nel processo trattativa, essendo indagato in procedimento ritenuto connesso si avvalse della facoltà di non rispondere – fermandoci appunto alle prospettazioni dell’allora maresciallo Carmelo Canale abbiamo appreso un’altra circostanza.
Cioè è vero che quell’incontro ci fu, è vero che era stato Paolo Borsellino ad attivare quell’incontro, ma la motivazione che aveva spinto Paolo Borsellino ad attivare quell’incontro non era il dossier mafia-appalti, ma era un documento molto più inquinante del dossier mafia-appalti, ovvero l’anonimo che circolò nel giugno 1992, convenzionalmente ridenominato «Corvo-bis», del quale più fonti sostenevano che possibile redattore fosse l’allora capitano De Donno. Vi segnalo peraltro che Paolo Borsellino, insieme agli altri procedimenti dei quali era assegnatario, fu assegnatario pure del fascicolo relativo al documento anonimo del «Corvo-bis». Cosicché non è proprio un fuor d’opera ciò che dice il maresciallo Canale perché era proprio ciò di cui, tra le tante altre cose, il dottor Borsellino si stava occupando. D’altronde ci furono i silenzi avuti con il dottor Borsellino in quell’occasione dagli ufficiali del ROS: considerate che in quell’occasione al dottor Borsellino gli ufficiali del ROS nascosero l’avvio dei contatti con Vito Ciancimino e considerate che già il 28 giugno 1992, cioè tre giorni dopo, Paolo Borsellino seppe dalla dottoressa Liliana Ferraro all’aeroporto di Fiumicino che ella era stata informata dal capitano De Donno che egli aveva avviato, in accordo con il colonnello Mori, contatti con Vito Ciancimino per attività che nelle loro parole poi fu indicata come quella di tentare in qualche modo una mediazione con i vertici di Cosa nostra. «Che cos’è questo muro contro muro?», sono le parole riferite da due ufficiali del ROS. Bene, se questo è il tenore dei rapporti e della sincerità dei rapporti fra gli ufficiali del ROS e il dottor Borsellino, è evidente che non si può che dare credito alla testimonianza del maresciallo Canale. Considerate un’altra cosa.
L’anonimo del «Corvo-bis» cita testualmente l’indagine mafia-appalti e anche quello fu uno dei motivi per i quali il capitano De Donno fu sospettato di esserne il manuale estensore. Quell’anonimo faceva riferimento a contatti fra il capo di Cosa nostra e un personaggio politico che in quel momento era ministro, e cioè il ministro Calogero Mannino, e faceva riferimento a vicende di assoluta gravità. Per questo motivo è una riduzione minimalista parlare di mafia-appalti in relazione a quell’incontro. Quell’incontro riguardava qualcosa di molto più grave, attraverso l’anonimo del «Corvo-bis», ovvero gli equilibri che stavano trovando o si stava cercando di trovare fra Cosa nostra e nuove entità che avrebbero preso il posto con posizioni predominanti nella prima Repubblica. Dato che in quel momento nel 1992 il comandante del ROS era il generale Antonio Subranni, la vulgata Mori-De Donno ha dovuto pure affrontare un problema serio e cioè le parole di Agnese Borsellino, sulle quali, mi sia perdonata la nettezza, a nessuno – proprio a nessuno – è consentito di fare mistificazioni. Vi ho prodotto nei documenti che vi consegno non solo il verbale riassuntivo delle dichiarazioni di Agnese Borsellino alla procura di Caltanissetta, ma la trascrizione integrale della registrazione della sua audizione, quindi quelle sono le parole di Agnese Borsellino. Agnese Borsellino, nel riferire la confidenza fattale dal marito circa il fatto che egli aveva appreso da fonte non indicata alla moglie che il generale Subranni era sostanzialmente un mafioso, Paolo Borsellino su questa circostanza era certo, l’aveva assunto come un dato certo e di tale gravità proprio da indurlo, come riferì la vedova, a conati di vomito. Il primo punto è che le parole di Agnese Borsellino sono quelle e non è possibile interpretarle diversamente. Poiché vi ho riferito la grande ammirazione che ho per la Corte di assise di Caltanissetta che ha emesso la sentenza del processo Borsellino-quater, non è un caso che nella sentenza del 20 aprile 2017, il presidente Balsamo ha inserito non le parole del verbale riassuntivo ma ha inserito leparole di Agnese Borsellino prese dalla registrazione.
C’è un’altra questione che veramente riguarda un fatto così tragico che impedisce qualunque altra reazione, ma nel racconto che viene fatto, viene fatta scadere sostanzialmente a una gag. Perché? Agnese Borsellino venne sentita nel 2009 e nel 2010. Le dichiarazioni erano coperte dal segreto investigativo. Trovarono pubblica notorietà con la esecuzione della misura cautelare del procedimento Borsellino-quater, a inizio marzo 2012, misura cautelare emessa nei confronti di Salvatore Madonia e altri. Ci fu quindi conoscenza di quelle gravissime dichiarazioni di Agnese Borsellino sul generale Subranni, sul Castello Utveggio, sulla trattativa in corso fra Cosa nostra e parti infedeli dello Stato, sull’aria di morte respirata al Viminale e ciò che sapete e che comunque risulta dalla sentenza. Non ci si vuole fidare delle parole di Agnese Borsellino? Io vi dico fidatevi della interpretazione autentica, dal suo punto di vista, del generale Antonio Subranni. Il 10 marzo 2012, divenute ufficiali le dichiarazioni di Agnese Borsellino su di lui, il generale Subranni rese un’intervista, pubblicata dal Corriere della Sera, in cui ebbe l’ardire, non trovo altra parola, di riferire che bisognava prestare poca credibilità alle dichiarazioni di Agnese Borsellino perché si sapeva che era malata di Alzheimer, così disse. La reazione fu un lancio dell’Ansa, che vi ho prodotto, reperito in una testata, dello stesso 10 marzo 2012. Agnese Borsellino disse pubblicamente, con quello spirito di parresia che ebbe, che le parole del generale Subranni non meritavano commento. Guardate che non è un caso che proprio in quel momento, per effetto di quelle parole riprovevoli del generale Subranni, offensive per la vedova di Paolo Borsellino, sui social network – che io non frequento oggi e tanto meno frequentavo a quei tempi, perché sono un po’ passatista – nacque un gruppo Facebook «Fraterno sostegno ad Agnese Borsellino». Uno dei fondatori di quel gruppo era uno dei magistrati che aveva audito Agnese Borsellino, il dottor Domenico Gozzo. Capite bene quindi che chi dice che Agnese Borsellino è stata travisata, le sue parole sono state misinterpretate, dice il falso. Ad affermarlo è lo stesso generale Subranni. Vi ho già detto che i figli di Paolo Borsellino non erano mai stati sentiti come testimoni dall’autorità giudiziaria. Lo fecero solo su mia iniziativa nel processo Borsellino-quater e quando vennero sentiti – vi produco la trascrizione delle loro deposizioni – Lucia Borsellino, in particolare, riferì due cose significative. La prima era lo scoramento, il dissenso morale se non il disprezzo per quelle dichiarazioni del generale Subranni e la seconda è ancora più significativa, perché Lucia Borsellino, come anche il fratello, riferirono che per tutti i primi anni successivi alla strage di via D’Amelio la mamma aveva avuto quale principale impegno della propria vita quello di proteggere la vita dei suoi figli e che solo una volta preso atto che essi erano cresciuti e avevano assunto le loro determinazioni e posizioni di vita ormai fuori dalla necessità della protezione da parte della mamma, in quel momento, la signora Agnese Borsellino decise di riferire all’autorità giudiziaria tutto ciò che aveva ricevuto quali confidenze negli ultimi giorni di vita dal marito. Questa cosa è riferita in quella deposizione da Lucia Borsellino che aggiunge, commentando le parole del generale Subranni, «No, il generale Subranni si sbagliava proprio, perché la persona più lucida nella nostra famiglia, figli compresi, in tutti questi anni è sempre stata nostra madre». Aggiunse un’altra cosa, perché purtroppo il sonno, se non della ragione, della memoria, rischia alle volte di far perdere pezzi nella ricostruzione della storia. Poco dopo la morte della signora Borsellino, che avvenne nel maggio 2013, venne pubblicato un libro da parte di un noto giornalista, di nome Salvo Palazzolo. Questo libro pubblicò le conversazioni avute con Agnese Borsellino negli ultimi mesi di vita della signora, e anche in quel libro vennero riportate le parole sul generale Subranni. E anche su quelle feci espressa domanda a Lucia e Manfredi Borsellino, i quali mi confermarono l’autenticità del contenuto di quel libro che addirittura aveva anche una introduzione, credo, di Manfredi Borsellino e che era stato conosciuto da Lucia Borsellino in relazione ai rapporti che la madre aveva avuto con il giornalista Salvo Palazzolo. Dico questo perché la personalità di Subranni è ovviamente una pietra d’inciampo nella proposizione di quella che vi ho denominato la pista palestinese perché come si fa a sostenere che Paolo Borsellino avesse quale ultima pulsione professionale della sua vita quella di indagare sul rapporto mafia-appalti, che era stato redatto dai subordinati dell’uomo che egli riteneva mafioso? È un non senso assoluto. Questo è il motivo per cui si è dovuto cercare, da parte di Mori e De Donno, di trovare quell’altra soluzione che però si scontra con i dati di realtà. Vi ho anche prodotto la deposizione al processo Borsellino-quater del generale Mori e del colonnello De Donno i quali, fra una e l’altra delle occasioni in cui si avvalevano della facoltà di non rispondere alle specifiche domande, in realtà hanno dovuto riferire alcune circostanze che hanno un rilievo in relazione all’anonimo del «Corvo-bis» e ai sospetti di Paolo Borsellino a proposito di chi fosse il redattore. Concludo sul punto segnalando una questione. La storia non può essere calpestata e ciascuno di noi, io per primo, ha i meriti e i demeriti di tutto ciò che ha fatto o non fatto nella propria esistenza, ma ciascuno di noi ha un percorso, così come ciascuno di quegli ufficiali del ROS, così come quella stessa struttura investigativa. Bene. Voi sapete che, legato a quella struttura investigativa e anche a certi riverberi dell’indagine mafia-appalti, era il maresciallo Guazzelli, ucciso ad Agrigento il 4 aprile 1992. A partire dall’epocain cui collaborò con la giustizia Giovanni Brusca, si apprese che l’omicidio Guazzelli era stato voluto ed eseguito da Cosa nostra. Le indagini fatte dal ROS nell’immediatezza, cioè dagli uomini che erano stati a stretto contatto con Guazzelli, avevano indirizzato l’autorità giudiziaria su un’altra causale e cioè che l’omicidio era stato voluto e commesso da esponenti della Stidda, antagonisti di Cosa nostra. È una circostanza che a me ha indotto riflessioni perché sembra un replay di altre attività. Omicidio del colonnello Russo, 19 agosto 1977. Furono svolte dai suoi uomini, dai suoi subordinati, fra cui l’allora maggiore Subranni. Incredibilmente per l’omicidio del colonnello Russo e del professore Costa, per vent’anni marcirono in galera tre innocenti, individuati dai collaboratori del colonnello Russo come i responsabili dell’assassinio di quell’ufficiale. Quei tre pastori furono scarcerati solo nel 1996, a seguito della collaborazione con la giustizia di Giovanni Brusca. Solo in quel momento fu aperto un processo di revisione e solo in quel momento fu individuato, anche dall’autorità giudiziaria, il killer di Russo nella persona di Leoluca Bagarella. C’è un qualche motivo per sospettare che ci fosse stata una copertura a Leoluca Bagarella e ai suoi correi in quell’occasione? No, io non credo che sia questo, io credo che si dovesse occultare la ragione di quel delitto, esattamente come avvenne per l’omicidio del maresciallo Guazzelli ed esattamente come avvenne per la strage cosiddetta di Alcamo Marina, il duplice omicidio nel gennaio 1976 di due carabinieri nella casermetta di Alcamo Marina, indagini svolte dal colonnello Russo e dai suoi collaboratori, fra i quali noti soggetti che diventarono la spina dorsale del ROS nei decenni successivi, e che portarono all’arresto di altre persone che dopo vent’anni di carcerazione o di latitanza, solo a partire dagli anni 2000, se non 2010, ottennero sentenze di revisione. Una, la principale, fu emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria – e io vi invito a leggerla, sebbene non si trovi nella mole di documenti che ho portato. In quella sentenza si fa cenno ai rapporti, perfino societari, economici, fra alcuni degli esponenti di quel gruppo dei Carabinieri e i cugini Salvo. È scritto in una sentenza passata in giudicato e questo in fondo non fa altro che confermare le plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Vi ho allegato quelle del collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo, che parlarono dei rapporti fra il generale Subranni e i cugini Salvo. È superfluo ricordarlo alla Commissione antimafia, perché codesto organismo ha avuto il grande merito nel dicembre 2000 di stilare e approvare una relazione sul depistaggio sull’omicidio Impastato, che è uno dei migliori documenti della storia della Commissione antimafia. In quella relazione erano documentati i depistaggi fatti dai Carabinieri, guidati dall’allora maggiore Antonio Subranni, sull’omicidio Impastato. La vittima di quell’omicidio era stata fatta passare per un terrorista, che si era causato la morte da sé. Allora tirando insieme tutti i fili, i protagonisti della vicenda mafia-appalti nell’Arma dei carabinieri erano i soggetti che avevano quella storia e a questo punto io aggiungo un solo ultimo dato e qui ve lo riferisco per come l’ho conosciuto io. Ebbi contezza pubblica della figura dell’allora colonnello Mario Mori presumo nel 1992 o sicuramente nel 1993, il giorno dell’arresto di Salvatore Riina, 15 gennaio 1993. Fu ritenuto il grande colpo contro Cosa nostra e in tutte le televisioni e su tutti i giornali vedemmo l’immagine del colonnello Mario Mori. Naturalmente nelle cronache di quegli anni quotidianamente la figura del colonnello Mario Mori ricorreva e ricorreva quale vice comandante del ROS e capo di quel gruppo di investigatori che aveva portato a quei risultati. Non credo di essere stato un lettore distratto, però fra il 1992 e il 1993 io non ho mai letto sui giornali un dato della carriera del generale Mario Mori che, da giovane capitano dei Carabinieri, fu in servizio al SID, guidato dal generale piduista Miceli, e vice diretto dal generale piduista Maletti. Questa circostanza con la scolorina era stata occultata nel racconto pubblico in diretta del 1992-1993. Perfino io, sprovveduto studente di giurisprudenza, lettore dei giornali, mi sarei un po’ allarmato nel sapere che uno degli uomini di punta del ROS fosse un collaboratore del generale Miceli e del colonnello Marzollo. Rimando alle sentenze sulle stragi della strategia della tensione per valutare chi sono i soggetti dei quali sto parlando. Per completare: la propaganda mistificatoria della realtà nell’anno 2023, nell’anno 2022 e in quelli precedenti su mafia-appalti è la stessa che nel 1992-1993 nascondeva la completa informazione sui curricula di quegli uomini. Come vedete vado a chiudere quasi in modo circolare. Qual è la cosa che mi ha lasciato veramente impressionato? Sarà una suggestione, però vi confesso che per me è stato davvero quasi traumatico. Nel 2018 o nel 2019, appresi che un noto geometra, credo della provincia di Caltanissetta, tale Giuseppe Li Pera, il quale, dopo la collaborazione con la giustizia era tornato a svolgere attività imprenditoriali, era stato destinatario di un sequestro di beni arrivato a provvedimento conclusivo di confisca credo nel 2022 o forse addirittura nel 2023 – dalle rassegne stampa lo si trova, dunque in epoca recentissima. La cosa che mi ha impressionato è che in quegli anni appresi la notizia, forse proprio nel 2018 al momento del sequestro, che il geometra Li Pera aveva avviato collaborazione, non so a che titolo, con un’altra società, fondata dall’ex colonnello Giuseppe De Donno, che ha avuto quale principale collaboratore l’ex generale Mario Mori. Sono davvero rimasto traumatizzato nel vedere come percorsi che in origine avevano avuto un indirizzo, mutati i propri ruoli e mutata perfino l’Italia, trovavano una nuova connessione a decenni di distanza. È un po’ la stessa cosa che ho avvertito quando ho scoperto della collaborazione, con quegli stessi soggetti e con quella stessa entità imprenditoriale, dell’ex brigatista Valerio Morucci. Bisogna fare attenzione a non trascurare i fatti della storia, anche quelli che appaiono minimi, hanno sempre una ragione le sottrazioni e soprattutto producono degli insani effetti.
Nella precedente audizione avevo riferito di una vicenda che, a mio modo di vedere, è un depistaggio dell’attualità, che dimostra interessi ancora in circolo per occultare la verità sulla strage di via D’Amelio, e avevo fatto riferimento alle dichiarazioni rese, a partire dal 2020, da Maurizio Avola all’autorità giudiziaria di Caltanissetta. Nelle more fra quella e questa audizione, ho avuto accesso al fascicolo presso l’autorità giudiziaria di Caltanissetta. Nel frattempo, doverosamente, vi segnalo che la richiesta di archiviazione, della quale avevo parlato, formulata dalla procura di Caltanissetta nei confronti di Maurizio Avola più tre, per le stragi di Capaci e di via D’Amelio, ha trovato il rigetto, con ordinanza emessa dal GIP di Caltanissetta un paio di settimane fa. Come produssi la richiesta di archiviazione produco anche la ordinanza di rigetto di quella archiviazione. Ho però avuto accesso a quegli atti e ne ho tratto la convinzione che la vicenda sia particolarmente grave. La vicenda ha degli aspetti che possono essere trattati in forma pubblica. Io ne scrissi e ne dissi pubblicamente, per una parte, e da questa comincio.
Si apprese dagli organi di informazione, io come tanti cittadini, che più o meno a partire dal 2017 il collaboratore di giustizia Maurizio Avola, che aveva avviato la sua collaborazione il 9 marzo 1994, quindi in un’altra epoca, aveva iniziato a rendere nuove dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Tra le altre cose, aveva riferito circostanze assolutamente inedite in relazione a gravi delitti. Vedo qui l’oggi deputato Cafiero De Raho, che ho conosciuto come Procuratore nazionale antimafia e, prima, come procuratore distrettuale di Reggio Calabria, e che naturalmente ha conosciuto, per ragioni del suo ufficio, la vicenda dell’omicidio del dottor Scopelliti, ucciso il 9 agosto 1991, quando era stato designato come rappresentante dell’accusa al maxiprocesso a Cosa nostra in Cassazione, ucciso in provincia di Reggio Calabria. Si apprese pubblicamente, perché trovarono pubblica notorietà in ragione, credo, di attività di perquisizione – spero di non sbagliarmi, ma è certo che comunque ci fu un deposito di atti che consentì ai giornali di scriverne – si apprese dunque che Maurizio Avola aveva, con qualche decennio di ritardo, confessato di avere partecipato proprio alla esecuzione del delitto, di aver avuto un ruolo e anche di avere, a distanza di decenni, indicato all’autorità giudiziaria il fucile con il quale erano stati sparati i colpi che avevano ucciso il magistrato Scopelliti. Fucile che – questa circostanza mi parve un po’ strana – fu ritrovato credo in provincia di Catania, cosicché bisognava pensare che i killer di Scopelliti, dopo l’omicidio, avessero preso il traghetto fra Villa San Giovanni e Messina, portando con loro l’arma del delitto, salvo pensare quegli stessi killer essere saliti a bordo di una imbarcazione che li avesse portati riservatamente in Sicilia. Il punto è che quelle dichiarazioni lasciarono grosse perplessità a me, che conoscevo il collaboratore di giustizia Avola per varie ragioni e tra queste per il fatto di essere il difensore dei familiari del giornalista Beppe Alfano, delitto sul quale Avola in passato aveva reso dichiarazioni. Per questo mi erano note più o meno tutte le dichiarazioni che Maurizio Avola aveva reso in ordine ai rapporti fra la famiglia catanese di Cosa nostra e ambienti esterni a Cosa nostra. In particolare, aveva riferito, anche in sede di pubblici dibattimenti, e quindi non c’è nessuna segretezza, in relazione alle stragi di Capaci e via D’Amelio e in relazione a un presunto progetto di attentato ai danni del dottor Di Pietro che aveva trovato elaborazione in una riunione tenutasi presso l’Hotel Excelsior di Roma nel settembre del 1992 alla quale avrebbero partecipato esponenti del clan Santapaola, uomini a mezza via fra Cosa nostra e apparati di polizia, e perfino esponenti politici e imprenditori. Uno dei soggetti sui quali Maurizio Avola aveva riferito circostanze particolarmente gravi è un mafioso importantissimo della provincia di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Rosario Pio Cattafi. Questo personaggio ha avuto sentenza di condanna definitiva per mafia incredibilmente solo nel maggio del 2023, cioè pochi mesi fa, nonostante i fatti che gli sono stati contestati risalissero all’inizio degli anni ’70 fino agli anni 2000. Maurizio Avola aveva riferito circostanze molto gravi su Rosario Cattafi.
Avuto conoscenza delle dichiarazioni che Maurizio Avola aveva cominciato a rendere nel 2017 mi accorsi di una curiosa fenomenologia, cioè che insieme alla aggiunta di fatti e di nomi per decenni tenuti nascosti all’autorità giudiziaria – in particolar modo Avola riferiva della partecipazione di Matteo Messina Denaro a gravissimi delitti di molto tempo fa, addirittura accusandolo pure dell’omicidio del magistrato Giacomo Ciaccio Montalto, avvenuta a gennaio 1983 in provincia di Trapani – mi accorsi che, insieme all’innesto di nuovi nomi e nuovi fatti, nel racconto di Avola c’era una sottrazione. La sottrazione riguardava proprio il nome di Rosario Pio Cattafi. Poiché di quel personaggio mi ero occupato e mi occupo anche in relazione all’omicidio del giornalista Beppe Alfano, la cosa mi colpì particolarmente. La cosa mi colpì particolarmente anche per un altro motivo, perché nel racconto di Avola, al riguardo delle sue conoscenze su Cattafi, che egli aveva definito come uomo di collegamento fra la famiglia Santapaola e apparati deviati dello Stato, servizi di sicurezza, nella versione negazionista di quelle conoscenze, da ultimo Avola riferì che egli in realtà aveva saputo di un personaggio di cui aveva conosciuto solo il nome «Saro» ma che il cognome gli era stato sprovvedutamente indicato da un pubblico ministero che lo aveva interrogato, un pubblico ministero della procura di Messina, così riferì. In realtà, ho cercato documentalmente tutti i verbali di interrogatorio di Avola alla procura di Messina e la circostanza riferita da Maurizio Avola non esiste, semplicemente, è un fatto fuori dal mondo reale. Quindi non c’era stata alcuna occasione in cui alcun pubblico ministero di Messina potesse avere, in modo davvero ingenuo – gravissimamente ingenuo, però – suggerito ad Avola che quel Saro, trait d’union fra Santapaola e i servizi segreti fosse Saro Cattafi. Avola si attestò su quella posizione. Egli nulla aveva mai saputo di Rosario Cattafi e non poteva dire che fosse Rosario Cattafi il personaggio del quale lui stesso aveva parlato. La circostanza mi allarmò e mi condusse a fare delle verifiche. Dal 1994 il difensore di Maurizio Avola era stato lo stesso fino a oggi, fino al momento della terza vita da collaboratore di giustizia assunta da Maurizio Avola. Mi sono adoperato a trovare dei documenti, non di natura giudiziaria in questo caso, ma ancor più significativi, proprio perché non di natura giudiziaria, che dimostrano la falsità di quella giustificazione data da Avola su Cattafi, sulle ragioni per cui aveva fatto venire meno il nome di Cattafi nelle sue rivelazioni. Perché ho trovato dei documenti che sono più interessanti degli atti giudiziari? Ho trovato e vi ho prodotto una intervista pubblicata dal settimanale del Corriere della Sera «Sette» nel giugno 1998 dove Avola, in quel momento detenuto, rese intervista a due giornalisti, Pietro Suber e Roberto Gugliotta. Quest’ultimo giornalista, Gugliotta, a me era noto per essere il migliore amico del difensore di Avola, cosicché è assolutamente impensabile che quella pubblicazione possa essere in qualche modo stato un tranello ai danni di Avola. D’altronde quei giornalisti avevano intervistato un detenuto e quindi non solo avevano dovuto ricevere l’autorizzazione del DAP, ma avevano dovuto sicuramente ricevere il consenso dell’intervistato. Vi ho prodotto quella intervista perché in essa Avola, senza alcuna possibilità di dubbio, parla di Rosario Cattafi. Parla di Rosario Cattafi quale importante esponente, anzi testualmente disse: «Per noi era più importante dei normali mafiosi perché in realtà per noi rappresentava in qualche modo lo Stato, rappresentava i servizi segreti e quindi era un uomo, per il gruppo Santapaola, decisivo». Con questo peraltro andandosi le dichiarazioni di Avola a fondersi alla perfezione con dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia sia provenienti dalla famiglia Santapaola sia di altra provenienza criminale.
Nell’aprile del 2019, Avola fu sentito a dibattimento dalla Corte di assise di Caltanissetta che procedeva nei confronti di Matteo Messina Denaro per le stragi di Capaci e di via D’Amelio. Anche in quell’occasione Avola occultò nel racconto il nome di Cattafi. Senonché ho avuto modo di vedere – e la circostanza ha avuto pubblico rilievo in epoca più recente – che il revisionismo nella narrazione di Avola ha riguardato anche la strage di Capaci con un fatto particolarmente impressionante, perché insieme alla novità nella ricostruzione dei fatti con l’indicazione di un esponente di Cosa nostra americana, uomo del clan Gotti, in realtà la nuova versione di Maurizio Avola sulla strage di Capaci contrasta con le sentenze irrevocabili sulla strage stessa. Se c’è un dato pacifico negli accertamenti giudiziari su Capaci è quello relativo al cosiddetto artificiere. Tutti coloro che si sono in qualche modo accostati alla vicenda di Capaci sanno che l’artificiere della strage di Capaci ha un nome e un cognome ben preciso e peraltro ben significativo: si tratta del mafioso Pietro Rampulla, esponente di Cosa nostra della provincia di Messina, Mistretta in particolare, con legami stretti però con la mafia catanese, il clan Santapaola e anche con il gruppo di Caltagirone, guidato da tale La Rocca. È un dato accertato giudizialmente che Pietro Rampulla fu l’esperto di Cosa nostra che si occupò di minare, per così dire, di imbottire di esplosivo, il canale sotto l’autostrada in territorio di Capaci. Dalle nuove dichiarazioni di Avola emerge che nella sua nuova versione non è stato Pietro Rampulla l’artificiere della strage di Capaci, aggiungendo una circostanza, che Pietro Rampulla in realtà non aveva le competenze tecniche per poter provvedere a quella attività, così smentendo la sentenza irrevocabile. A chi non conosca bene i personaggi può non essere chiaro, senonché anche Pietro Rampulla ha un suo curriculum. Il curriculum di Pietro Rampulla è quello di uomo d’onore di Cosa nostra, con pregressa militanza neofascista all’Università di Messina. C’è una sentenza della Corte di appello di Messina che, per un episodio avvenuto a dicembre del 1971, condannò alcuni fascisti e mafiosi, siciliani e calabresi, per l’aggressione ad alcuni studenti nella facoltà del Magistero. Fra i due condannati in concorso ci furono Rosario Cattafi e Pietro Rampulla. Pietro Rampulla fu anche indicato da Luigi Ilardo come l’artificiere per Capaci in epoca in cui non era ancora stato raggiunto alcun accertamento dall’autorità giudiziaria. Luigi Ilardo, nelle sue rivelazioni all’Arma dei carabinieri, aveva riferito di come aveva conosciuto Pietro Rampulla, proprio anche all’epoca della sua frequentazione quale studente dell’Università di Messina. Luigi Ilardo aveva fatto al colonnello Riccio, insieme al nome di Pietro Rampulla, anche quello di Rosario Cattafi. Questo lo riferisco per dire che c’è una coerenza nella sottrazione del protagonismo, nel periodo stragista, di Pietro Rampulla e di Rosario Cattafi. C’è quindi un chiaro indirizzo evidentemente assunto in questa direzione da Maurizio Avola. Il punto è che se si vanno a rileggere le pregresse dichiarazioni di Maurizio Avola a proposito di Pietro Rampulla, si può vedere come egli aveva qualificato testualmente quest’ultimo come «terrorista», grande esperto di esplosivi e personaggio pericoloso proprio per questa sua caratteristica. La circostanza in realtà non era un inedito per l’autorità giudiziaria.
Voi sapete che nel 1987 decise di collaborare con la giustizia un importante uomo d’onore di Cosa nostra catanese, Antonino Calderone, fratello del capo di Cosa nostra catanese del tempo e uno dei leader della cabina di regia di Cosa nostra negli anni ’70, Giuseppe Calderone. Antonino Calderone collaborò con la giustizia nella persona di un magistrato che poi divenne suo malgrado ancora più famoso di quanto lo fosse stato in vita, cioè Giovanni Falcone, e cominciò a rendere dichiarazioni a Falcone mentre si trovava ancora in Francia, dove era stato arrestato nel territorio di Nizza. Antonino Calderone riferì a Giovanni Falcone, fra gli uomini d’onore da lui conosciuti, anche il nome di Pietro Rampulla – siamo nel 1987 – e indicò a Falcone una particolare caratteristica di Rampulla, quella di essere un esperto in materia esplosivistica, come lui stesso aveva potuto verificare in occasione di un attentato che aveva visto vittima predestinata proprio il fratello, Giuseppe Calderone. Nell’occasione, in un verbale di interrogatorio del quale vi faccio produzione, Antonino Calderone riferì al dottor Falcone che Pietro Rampulla aveva ricevuto gli insegnamenti in materia esplosivistica durante la sua militanza neofascista e aggiunse una frase che immagino fece un po’ sobbalzare il dottor Falcone, perché nel verbale si legge: «e con questo non credo di dover aggiungere altro a chi mi interroga». Quindi il Maurizio Avola degli anni 2020, non solo smentisce il Maurizio Avola dei decenni precedenti, ma smentisce perfino assodate acquisizioni che risalgono agli anni ’80 e risalgono all’operato di magistrati che non hanno avuto eguali nell’attività di indagine su Cosa nostra. Allora mi sono dovuto chiedere quale potesse essere la ragione di quella ritrattazione pubblica e allarmante da parte di Maurizio Avola sui nomi di Rosario Cattafi e Pietro Rampulla. Vi ricordo soltanto che nella sentenza passata in giudicato sulla strage di Capaci, che riporta anche le dichiarazioni di Giovanni Brusca – uno degli esecutori – e di Santino Di Matteo – un altro degli esecutori – abbiamo appreso che il telecomando adoperato da Giovanni Brusca il 23 maggio 1992 gli era stato ho fornito dalla famiglia mafiosa barcellonese, cioè proprio quella di Rosario Cattafi, e gli era stato spedito da uno dei capi di quell’organizzazione mafiosa, cioè Giuseppe Gullotti, capomafia condannato con sentenza irrevocabile quale organizzatore dell’omicidio del giornalista Beppe Alfano. Considerate che su Capaci numerosi esponenti del gruppo che si occupò dell’esecuzione hanno collaborato con la giustizia: Giovanni Brusca, Santino di Matteo e anche Gioacchino La Barbera. Il dato pacificamente riferito da tutti e pacificamente accertato, è che l’uomo decisivo di Cosa nostra per la strage di Capaci, una strage che non ha uguali nella storia d’Italia per la difficoltà della sua esecuzione, l’uomo decisivo, dicevo, era Pietro Rampulla. Tanto che molti dubbi e molte perplessità sollevò la stessa dichiarazione di Giovanni Brusca – tra l’altro riferita in vari dibattimenti – a proposito del fatto che egli il 23 maggio 1992 per la prima volta si era trovato a utilizzare quel telecomando per fare la strage del secolo nonostante in tutti gli esperimenti precedenti alla esecuzione della strage di Capaci, in tutte le prove che erano state fatte, ad adoperare il telecomando fosse stato Pietro Rampulla. Nel chiedergli come mai Pietro Rampulla il 23 maggio 1992 non si trovasse insieme a lui e a Nino Gioè, sulla collinetta sopra Capaci, Brusca riferì che Pietro Rampulla non aveva potuto presenziare adducendo motivi di famiglia. Chi conosce la storia di Cosa nostra ha difficoltà a credere a una giustificazione che forse può essere utile per uno studente a scuola. Solitamente la mancata partecipazione a evenienze così delicate viene fatta pagare con la morte. Noi invece sappiamo che nei giorni successivi alla strage di Capaci, al brindisi alla presenza di Salvatore Riina, fra coloro che sbattevano il calice contro quelli dei sodali, c’era Pietro Rampulla. Quindi in tanti ci interrogammo su quale fosse stata la ragione di quella assenza o se quella fosse solo una apparente assenza e che non significasse invece la presenza di Rampulla non sulla collinetta, ma magari in altro ruolo impegnato. Il protagonismo di Pietro Rampulla per Capaci era però pacifico, era pacifico fino a questa novità derivante dalla nuova vita di pentito di Maurizio Avola. Sul punto ho potuto fare delle ulteriori verifiche, però si tratta di circostanze che non mi è possibile riferire in pubblica seduta.
PRESIDENTE. Avvocato le chiedo un chiarimento sui tempi. Possiamo passare anche adesso in seduta segreta, ma ciò significherebbe scollegare tutti i commissari che seguono i lavori da remoto e ricollegarli successivamente per porre eventuali domande sarebbe complicato. Quindi le chiedo quale sia la sua tempistica in modo da poter organizzare i lavori in modo ottimale.
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. La vicenda Avola è l’ultima grossa vicenda sulla quale devo riferire tranne un accenno ad altro, che riguarda sia l’aspetto che ho preannunciato sia anche via D’Amelio.
PRESIDENTE. Le chiedevo di quanto tempo avesse ancora bisogno.
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. Se fosse stato solo quello che ho preannunciato, allora sarebbe bastata una decina di minuti ma poiché bisogna parlare, ed è questa la sede precipua per farlo, della strage di via D’Amelio, posso dire che avrò bisogno di almeno mezz’ora, quaranta minuti.
PRESIDENTE. A questo punto, farei due proposte. O rinviamo subito l’audizione ad altra seduta, in cui svolgere sia la parte segreta sia il momento delle domande dei colleghi, oppure procediamo ora con la parte segreta, rinviando il prosieguo su via D’Amelio e le domande dei commissari a un’altra seduta. Essendo già le 16.30, i commissari hanno seguito l’avvocato da due ore e mezza e non credo che riusciremo a terminare tutto in giornata.
WALTER VERINI. Quanto durerebbe la parte segreta?
PRESIDENTE. Una mezz’ora, senatore Verini.
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. Se mi consentite questo intervento sull’ordine dei lavori, io vi consegnerei già tutta la documentazione, in modo che possa essere esaminata.
PRESIDENTE. Avvocato, intervenire sull’ordine dei lavori spetta ai commissari, però senz’altro la documentazione ci sarà utile. Do la parola al vicepresidente Cafiero De Raho.
FEDERICO CAFIERO DE RAHO. L’audito sta riferendo di cose di cui evidentemente non ha mai parlato. Poiché parliamo di temi delicatissimi, proporrei che possa riferirne nella prossima mezz’ora per poi rinviare il seguito ad un’altra seduta, perché ogni volta che si deve acquisire qualche cosa di particolare sopraggiunge qualche problema.
PRESIDENTE. Guardi onorevole, non è questo il motivo. Il senso è che, come vede, i commissari sono quasi tutti collegati da remoto. Se dovessimo passare ora in seduta segreta priverei i commissari della possibilità di seguirla. Invece, sospendendo ora, i colleghi potrebbero partecipare in presenza nella prossima seduta e ascoltare anche questa parte. È solo questo il motivo.
La parola all’onorevole Provenzano.
GIUSEPPE PROVENZANO. Sempre sull’ordine dei lavori, a beneficio anche degli altri commissari, presidente. Diversi auditi hanno annunciato il deposito di una copiosa documentazione sui temi di queste audizioni, e immagino che ne sia pervenuta altra da parte di terzi che si sono sentiti chiamati in causa nel corso delle stesse. Ci dobbiamo rivolgere direttamente a lei per avere accesso a questa documentazione?
PRESIDENTE. Tutti i commissari hanno accesso all’archivio. I documenti liberi sono liberamente consultabili, senza il mio consenso. Per quelli che sono formalmente segretati o riservati, autorizzo i commissari a visionarli ovvero, qualora consentito, a trarne copia.
GIUSEPPE PROVENZANO. La domanda è questa. Abbiamo già acquisito una documentazione da parte degli auditi o di terzi?
PRESIDENTE. Sì. Come più volte detto nelle audizioni precedenti, l’avvocato Trizzino e la dottoressa Borsellino hanno depositato della documentazione e, come riferito in Ufficio di presidenza, è pervenuta da parte di terzi una nota, che è stata acquisita agli atti.
La parola al senatore Verini.
WALTER VERINI. L’aggiornamento, che a questo punto mi sembra inevitabile anche per i motivi illustrati, potrebbe essere auspicabilmente ravvicinato?
PRESIDENTE. Verificheremo le disponibilità di ciascuno, perché immagino che anche Salvatore Borsellino intenda essere presente. Nell’Ufficio di presidenza di domani provvederò a proporvi un calendario dei lavori concordato.
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. Chiedo scusa, presidente. Io posso già dare una mia disponibilità per la prossima settimana. Naturalmente sarà la Commissione a valutare.
PRESIDENTE. Grazie avvocato. Ha chiesto la parola il senatore Cantalamessa, collegato da remoto.
GIANLUCA CANTALAMESSA. Grazie presidente, grazie avvocato. Visti e considerati l’importanza degli argomenti e il fatto che l’avvocato abbia chiesto anche una parte segretata, poiché gran parte di noi il lunedì ha impegni sul territorio, chiederei di rinviare il seguito dei lavori ad altra seduta, per dare la possibilità di una più ampia partecipazione.
PRESIDENTE. La parola al senatore Russo.
RAOUL RUSSO. Mi associo alla richiesta del collega Cantalamessa perché, essendo la parte segretata particolarmente delicata, ritengo si debba garantire la presenza del maggior numero di commissari, anche per definire meglio le domande da porre dopo questa lunga audizione.
PRESIDENTE. Ringrazio l’avvocato Repici e il dottor Borsellino, collegato da remoto.
La data del seguito dell’audizione verrà stabilita dall’Ufficio di presidenza di domani, tenuto conto delle disponibilità degli auditi.
La seduta termina alle 16.35.
15 novembre 2023
VIDEO
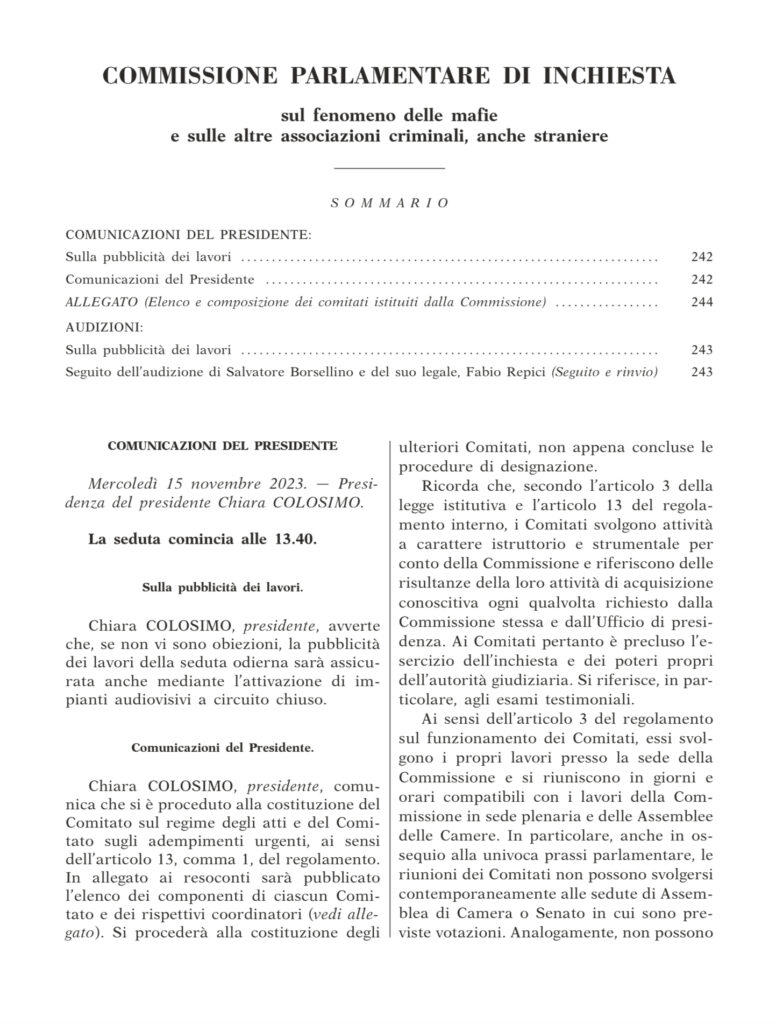
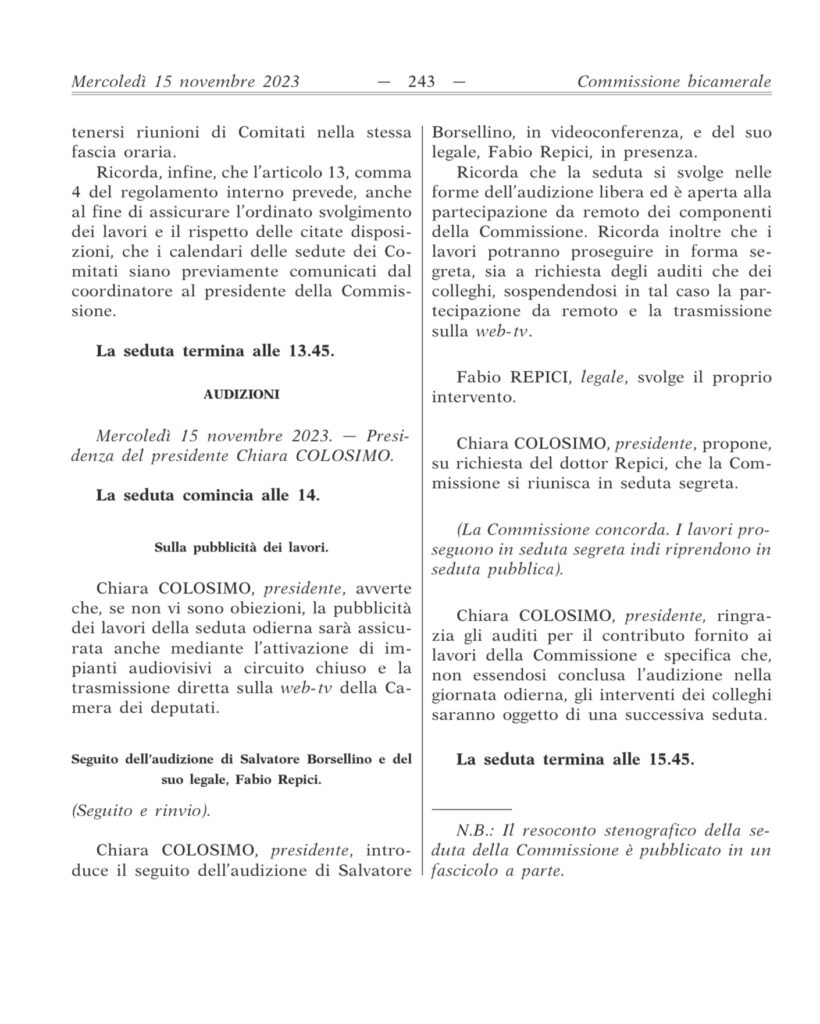
XIX LEGISLATURA.
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
RESOCONTO STENOGRAFICO Seduta n. 21 di Mercoledì 15 novembre 2023 Bozza non corretta
La seduta comincia alle 14 – Seguito dell’audizione di Salvatore Borsellino e del suo legale, Fabio Repici.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione di Salvatore Borsellino e del suo avvocato, Fabio Repici, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità.
Ricordo che nella scorsa seduta l’avvocato Repici ha chiesto di proseguire la sua audizione in forma segreta. Dunque, dopo una prima parte in seduta pubblica, quando l’avvocato formalizzerà la richiesta di segretazione, procederemo alla sospensione dei collegamenti da remoto e della trasmissione via streaming sulla web-tv. Intanto ci tengo a salutare e ringraziare per la presenza il dottor Borsellino, che ci segue da remoto.
Con riguardo alle fase successiva degli interventi dei colleghi, propongo che vengano poste prima le domande sulle questioni svolte in seduta segreta, in modo da poter poi riprendere i collegamenti da remoto e la trasmissione sulla web-tv.
Prima di dare la parola all’avvocato, ricordo a tutti che i lavori di Assemblea di Camera e Senato riprenderanno alle 16.
Do la parola all’avvocato Repici.
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. Grazie a lei, presidente, e grazie alla Commissione intera.
Nelle precedenti audizioni avevo detto cose sulle quali non tornerò.
Prima di chiedere la segretazione della seduta, desidero però fare alcune precisazioni aggiuntive.
Ho portato con me della ulteriore documentazione che, per mia colpa, nella precedente occasione ho depositato in modo non completo, nella fretta di mettere insieme tutti gli allegati.
Quindi ho portato ulteriore documentazione che riguarda in primo luogo la questione mafia-appalti in relazione alla quale ho ritenuto doveroso consegnare alla Commissione anche le copie delle agende del generale Mario Mori, dall’anno 1991 all’anno 1994.
Come ho già riferito a proposito del dottor Bruno Contrada, ci sono documenti che, siccome hanno provenienza assolutamente insospettabile rispetto a ciò che possono provare, anche dalle agende del generale Mori troverete la prova della assoluta contrarietà al reale delle circostanze affermate sul dossier mafia-appalti.
Preciso peraltro che presso la procura di Palermo negli anni dal 1991 a seguire, non furono fatte indagini sugli appalti solo sulla scorta delle informative del ROS, ma naturalmente ce ne furono anche tante altre.
Il punto però è che, a mio modo di vedere, sulla base dei documenti che vi produco, è assolutamente irragionevole – e se era irragionevole nel 1992 lo è a maggior ragione a 31 anni di distanza – considerare in un certo modo le investigazioni mafia-appalti curate dalle persone del generale Subranni, del colonnello Mori e del capitano De Donno.
Li cito perché anche gli aspetti soggettivi sono importanti e la santificazione che oggi si tende a fare di alcuni personaggi è semplicemente una forma di guerra mossa alla realtà.
Stiamo parlando del soggetto indicato da Paolo Borsellino come mafioso, del soggetto responsabile dei depistaggi sull’omicidio Impastato, stiamo parlando di un altro soggetto che è stato ritenuto responsabile, seppure non punito per ritenuta assenza del dolo, per la mancata cattura di Bernardo Provenzano il 31 ottobre 1995 – parlo di Mario Mori.
Il fatto è stato accertato con sentenza irrevocabile, la formula assolutoria è stata «il fatto non costituisce reato», fra di voi ci sono molti giuristi e lascio a loro la interpretazione di quel dato assolutorio.
Il generale Mori è stato assolto perché il fatto non costituisce reato anche per la mancata comunicazione alla procura della Repubblica di Palermo, nel gennaio 1993, della avvenuta disattivazione del servizio di video-osservazione su via Bernini, dove, in costanza del servizio di video-osservazione, era partito Salvatore Riina, nella mattina del 15 gennaio 1993, per essere arrestato all’altezza della rotonda del Motel Agip sulla circonvallazione di Palermo.
Oggi, continuare a sostenere quella come possibile causale o concausale delle stragi del 1992 e non so se anche di quelle del 1993 – perché pure su questo bisognerebbe riflettere – è assolutamente una ulteriore guerra mossa alla realtà, come separare le stragi commesse in Sicilia nel 1992 e quelle commesse in continente, non solo nel 1993-1994: ricordo infatti che il proiettile al giardino di Boboli a Firenze fu piazzato da Santo Mazzei a ottobre del 1992, con il tentativo di rivendicare quell’atto delittuoso a nome della Falange armata.
Ciò posto, io però vi segnalo una cosa, limitando l’analisi alla strage di via D’Amelio.
Un dato è pacifico e indiscutibile e chiunque dicesse una cosa contraria direbbe semplicemente il falso. Cioè, che per quanto riguarda l’organizzazione criminale Cosa nostra, la parte esecutiva della strage di via D’Amelio non c’è dubbio che è stata supervisionata, controllata ed eseguita da Giuseppe Graviano, al tempo capo mandamento di Brancaccio, e dai suoi uomini.
Ora se voi prendete tutti i nomi possibili dei soggetti, i cui nomi vengono tirati fuori a proposito della teoria secondo cui l’indagine mafia-appalti sarebbe la causale della strage di via D’Amelio, vi segnalo che rapporti fra Giuseppe Graviano e i Buscemi, Bini, Gardini, gli stessi politici che, con colpevole ritardo, il ROS segnalò alla procura di Palermo nel 1992 come coinvolti in quei giri di affari, bene, rapporti di questo tipo non ne sono mai stati documentati.
Aggiungo un’altra cosa: per voce unanime di tutti i collaboratori di giustizia, non solo siciliani, che hanno riferito sulle stragi, in generale del biennio 1992-1994, ma, in particolare, le stragi del 1992, non ce ne è stato uno solo, uno, che abbia segnalato all’autorità giudiziaria che quelle stragi avrebbero avuto funzione stabilizzatrice del sistema di potere.
La verità è un’altra. Le stragi di Capaci e di via D’Amelio, e anche le altre – mi permetto di dire con una affermazione può sembrare brutale ma che è, a mio modo di vedere, assolutamente un dato storico accertato, anche dalle sentenze – hanno visto come vittime non solo i magistrati, i poliziotti, i comuni cittadini che hanno perso la vita, non solo le loro famiglie, ma anche, aggiungo, la prima Repubblica. Le stragi del 1992 e del 1993 sono state stragi per abbattere la prima Repubblica.
Qui siamo in sede politica e mi auguro di non fare affermazioni in qualche modo politicamente inappropriate, ma, nel mio modo di vedere, l’uomo che ha incarnato la prima Repubblica si chiamava Giulio Andreotti e non c’è dubbio che sentenze passate in giudicato hanno attestato che la strage di Capaci ha avuto quale primo e immediato effetto la impossibilità per Giulio Andreotti di ascendere al Quirinale, cosa che invece era nei fatti operazione, non dico solo possibile, ma probabilmente già in atto.
Su questo rimando alle dichiarazioni di chi, secondo le sentenze irrevocabili, è stato il principale esecutore della strage di Capaci, e cioè Giovanni Brusca.
Per ciò che riguarda i soggetti coinvolti nelle investigazioni del ROS o i soggetti – vedi il procuratore Giammanco – coinvolti nelle fughe di notizie su quelle attività investigative, in realtà sappiamo, e ve l’ho dimostrato documentalmente con i documenti che vi ho prodotto, che i principali protagonisti delle fughe di notizie su quelle indagini in realtà furono appartenenti al ROS, come contestato dai PM di Palermo Giancarlo Caselli, Michele Prestipino e Maurizio De Lucia, il 13 ottobre del 1997, in un verbale di sommarie informazioni reso dal capitano Giuseppe De Donno.
Tutti i soggetti in qualche modo coinvolti o coinvolgibili nelle vicende in negativo di mafia-appalti sono soggetti che in realtà all’avvio della prima Repubblica erano o defunti o dei fantasmi rispetto al sistema di potere che nel frattempo aveva raggiunto nuovi equilibri. Aggiungo che il più grande depistaggio della storia giudiziaria d’Italia, come riconosciuto dalla sentenza della Corte d’assise di Caltanissetta del 20 aprile 2017 sulla strage di via D’Amelio, ha avuto quale momento direi di più plastica evidenza le false dichiarazioni messe in bocca al falso pentito Vincenzo Scarantino da esponenti della polizia di Stato.
Il primo verbale falso di Vincenzo Scarantino reca la data del 24 giugno 1994. Segnalo alle signorie vostre di valutare quale fosse il ruolo di Raul Gardini il 24 giugno del 1994: si era suicidato l’anno prima; quale fosse il ruolo dell’onorevole Salvo Lima: era stato ucciso il 12 marzo 1992; quale fosse il ruolo dell’onorevole Nicolosi, che era presidente della Regione Siciliana al momento delle indagini e che nel frattempo era forse perfino finito in carcere; quale fosse il ruolo dell’onorevole Mannino; quale fosse il ruolo dei tanti politici i cui nomi emersero, non nella prima informativa del 13 febbraio 1991, ma nella seconda informativa del ROS del 3 settembre 1992. Bene, se voi ne trovate uno che, al 24 giugno 1994, fosse ancora in sella nelle stanze del potere, dovrò rimediare a questa mia affermazione.
Vi assicuro che non ne troverete uno. D’altronde riguardo a tutti i protagonisti della lista di soggetti da eliminare da Cosa nostra, per come da noi conosciuta in ragione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sappiamo che quella lista si divideva più o meno in due schieramenti: i nemici da abbattere, perché erano persone che avevano lottato contro Cosa nostra, e i primi due nomi che mi vengono in mente sono naturalmente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e gli amici da abbattere, perché non più in grado o non più volenterosi di dare il supporto che avevano dato fino a quel momento a Cosa nostra.
Bene, quelli erano tutti stati o abbattuti fisicamente o eliminati dalle stanze del potere. Poiché si tratta del più grande depistaggio della storia giudiziaria d’Italia, io vorrei capire come il più grande depistaggio costruito con le false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, abbia avuto quale scopo quello di tutelare dalle investigazioni soggetti che non esistevano più fisicamente o che non esistevano più quanto ai ranghi del potere.
È ovvio che questa è, anche per via logica, l’ulteriore dimostrazione di come oggi, a 31 anni di distanza dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, sostenere quell’ipotesi significhi davvero portare ulteriori ostacoli alla già faticosa, mai abbastanza faticosa, ricerca della verità.
Segnalo un’altra questione in relazione alla vicenda del tentato omicidio del vicequestore Germanà e delle investigazioni che stava facendo su una materia che toccava particolarmente gli interessi professionali del dottor Paolo Borsellino.
Oggi vi produrrò degli ulteriori documenti.
Tra essi c’è una consulenza, svolta su incarico della procura di Palermo – vado a memoria, credo dell’allora procuratore aggiunto Luigi Croce e dell’allora sostituto procuratore Antonio Napoli – relativa a un’indagine che riguardava uno dei più famigerati esponenti della storia della massoneria italiana, cioè Pino Mandalari, un soggetto che, oltre che essere esponente della massoneria, è stato anche uno dei riciclatori dei soldi fin dai tempi dei sequestri di persona fatti dagli uomini di Luciano Liggio negli anni Settanta.
In questa relazione sono ripresi e richiamati numerosissimi fondamentali atti di indagine che diventano fonti di conoscenza.
In particolar modo, in quella relazione, emerge il ruolo di quel Luigi Savona, che era stato al centro dell’informativa del vicequestore Germanà e delle confidenze di Luigi Ilardo al colonnello Riccio.
Qual è il dato che aveva fornito Ilardo? «Guardate che il fenomeno stragista di questi anni» lui parla nel 1994 fino al 10 maggio 1996 «non è altro che la ripetizione dello schema che si è purtroppo posto in essere nei decenni precedenti» e fece proprio il nome di Luigi Savona al riguardo.
In quella consulenza, troverete non solo la storia di Luigi Savona, ma anche le connessioni con Cosa nostra nelle persone, in modo specifico, – e questo è il dato di assoluta gravità – del capo mandamento di Mazara del Vallo, Mariano Agate, mafioso e massone al contempo, e del suo affiliato Giovanni Bastone, mafioso e massone al contempo, soggetto che teneva le relazioni fra la frazione massonica di Torino e il mandamento di Mazara del Vallo nei decenni fra gli anni Settanta e gli anni Novanta.
In relazione a questo, troverete documentazione che ulteriormente conferma la gravità delle investigazioni che stava svolgendo il vice questore Rino Germanà e i motivi per i quali tre esponenti di vertice di Cosa nostra, a settembre del 1992, lo bersagliarono sul lungomare di Mazara del Vallo.
Ripeto i nomi, nessuno dei tre collegabili alla vicenda mafia-appalti. Si tratta di Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro.
Aggiungo un altro aspetto. Ho reperito un’ordinanza di custodia cautelare, della quale si è parlato nei mesi scorsi sugli organi di stampa, emessa dal GIP di Caltanissetta, nei confronti dell’avvocato Menicacci e di tal Domenico Romeo.
Non occorre segnalare che si tratta di due soggetti che hanno fatto la storia della eversione neofascista nel nostro Paese, eversione neofascista molto legata all’eversione stragista nel nostro Paese.
Segnalo due dati che sono ai miei occhi molto significativi. Il primo riguarda il tentativo che si è fatto, in costanza delle investigazioni che hanno portato a quella misura cautelare, di sminuire se non addirittura annichilire il fondamento delle investigazioni che era partito dalle dichiarazioni di un soggetto che prima era stato un confidente dell’Arma dei carabinieri e poi era divenuto un collaboratore di giustizia. Questo soggetto si chiamava – perché è defunto – Alberto Lo Cicero.
Alberto Lo Cicero era uomo di un importante esponente di Cosa nostra del mandamento di San Lorenzo che si chiamava Mariano Tullio Troia.
Il punto che vi voglio segnalare è che il confidente, non ancora collaboratore di giustizia, Alberto Lo Cicero, veniva sentito da carabinieri, tra i quali se non erro il maresciallo Giustini, della sezione di polizia giudiziaria di Palermo.
I carabinieri, come risulta dall’ordinanza, quando incontravano questo confidente, registravano i colloqui e quindi noi abbiamo la documentazione cristallina della esattezza delle informazioni che Alberto Lo Cicero riferiva.
Siamo all’8 aprile 1992 ad esempio, cioè un mese e mezzo prima di Capaci. Bene, da quell’ordinanza, voi verificherete che l’8 aprile 1992, Alberto Lo Cicero, che poi è stato fatto passare quasi come un falso pentito, aveva riferito ai carabinieri del ruolo importante di Salvatore Biondino.
Salvatore Biondino è l’uomo arrestato il 15 gennaio 1993 insieme a Totò Riina, ma non solo questo, è un uomo decisivo nella strage di Capaci ed era il facente funzioni di capo del mandamento di San Lorenzo, all’interno del quale rientrava il territorio di Capaci.
Aggiungo che l’8 aprile 1992 Alberto Lo Cicero fece riferimento anche a un mafioso di Capaci, un tale Antonino Troia, parente di Mariano Tullio Troia. Dovete sapere che Antonino Troia è stato il basista, come accertato con sentenza irrevocabile, della strage di Capaci del 23 maggio 1992, cioè di un mese e mezzo dopo le dichiarazioni di Alberto Lo Cicero, ma vi aggiungo anche un dato che è veramente sconvolgente ai miei occhi e che riguarda l’omicidio di un informatore del SISDE, Emanuele Piazza.
Conosco la vicenda dell’omicidio Piazza, perché è strettamente collegato all’omicidio del poliziotto Agostino e io sono il difensore dei familiari del poliziotto Agostino, parti civili in un processo che ha visto poche settimane fa la conferma della condanna all’ergastolo del capomafia Nino Madonia.
Fino al 1996 l’autorità giudiziaria non aveva idea di che fine avesse fatto Emanuele Piazza. Addirittura si sosteneva la possibilità che fosse scomparso per sua volontà e si parlava della sua iniziativa di trasmigrare in Tunisia.
Nel 1996 iniziano a collaborare Giovanbattista Ferrante e subito dopo Francesco Onorato, cioè due degli esecutori materiali.
Nel 1996 partono le indagini che portano a una misura cautelare eseguita, se non ricordo male, nel 1998 e il procedimento poi instauratosi ha portato all’arresto e alle condanne definitive dei responsabili dell’omicidio Piazza tra i quali Antonino Troia, perché Emanuele Piazza fu strangolato nel sotterraneo del mobilificio del mafioso Antonino Troia. Risulta dall’ordinanza di custodia cautelare, che vi allego, che nel 1992 Alberto Lo Cicero riferì ai carabinieri che Emanuele Piazza non era scomparso, ma era stato ucciso ed era stato strangolato, cosa che era sconosciuta, non solo all’autorità giudiziaria, ma a qualunque inquirente d’Italia.
Questo per dirvi come bisognerebbe prestare un po’ di attenzione nella valutazione delle risultanze che via via emergono.
Questo ve lo dico in aggiunta in relazione alle vicende delle stragi e in particolar modo della strage di via D’Amelio perché leggendo quell’ordinanza di custodia cautelare ho scoperto un dato che a me era sconosciuto, e cioè che il 15 giugno 1992, quindi fra Capaci e via D’Amelio, quindi negli ultimi 57 giorni di vita di Paolo Borsellino – e noi sappiamo cosa sono stati quei giorni – il 15 giugno del 1992 ci fu una riunione di coordinamento di indagine fra le procure di Palermo e di Caltanissetta in relazione al confidente collaboratore di giustizia – perché nel frattempo era diventato collaboratore di giustizia – Alberto Lo Cicero. A quella riunione di coordinamento investigativo, scopro da questa ordinanza, ha partecipato Paolo Borsellino.
Il punto è che questa ordinanza mi ha dato la plastica dimostrazione di quanto ancora oggi noi, portati fuori strada da false piste e dai depistaggi compiuti con il nascondimento di elementi di prova, dobbiamo perfino scoprire su tutto ciò che ha fatto – non su ciò che non ha fatto, ma su tutto ciò che ha fatto – Paolo Borsellino negli ultimi 57 giorni di vita.
Qui io vi do una testimonianza diretta: non c’è un processo nel quale si sia fatta una cosa che penso che a ognuno di noi sembrerebbe banale e cioè accertare che cosa abbia fatto Paolo Borsellino dal 23 maggio 1992, alle ore 17.57, fino al 19 luglio 1992, alle ore 16.58, cosa che ritengo possa competere anche alla illustre Commissione presso la quale io sto riferendo.
A questo punto, fatte queste premesse, chiedo al presidente di poter disporre la segretazione della seduta.
PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, passerei alla seduta segreta. Saluto chi è collegato da remoto, perché da questo momento non ci potrà più ascoltare.
Dispongo la disattivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e della web-tv.
(La Commissione prosegue in seduta segreta).
PRESIDENTE. Dispongo la riattivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e della web-tv.
(La Commissione riprende in seduta pubblica).
PRESIDENTE. Ringrazio e saluto il dottor Borsellino e l’avvocato Repici. Il seguito dell’audizione con gli interventi dei colleghi è rinviato a una successiva seduta.
La seduta termina alle 15.45.
28.2.2024 TESTO DEL RESOCONTO STENOGRAFICO PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHIARA COLOSIMO
Seguito dell’audizione di Salvatore Borsellino e del suo legale Fabio Repici.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione di Salvatore Borsellino e del suo legale avvocato FabioRepici, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità a tornare in Commissione per rispondere ai quesiti dei colleghi che intendono intervenire.
Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell’audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta degli auditi o dei colleghi. In tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web-tv.
Rinnovo i ringraziamenti per la disponibilità. Sono felice di vedere anche Salvatore Borsellino. A questo punto io ho iscritto a parlare certamente il senatore Scarpinato e aspetto le altre prenotazioni.
ROBERTO MARIA FERDINANDO SCARPINATO. Avvocato, le chiedo se può indicare i fatti accertati processualmente dai quali si desume la partecipazione di soggetti esterni alla mafia alla strage di via D’Amelio.
Secondo domanda. Lei ha attribuito grande rilevanza al depistaggio del collaboratore Maurizio Avola. Le chiedo se le risultano rapporti tra questo collaboratore o i suoi avvocati e i servizi segreti.
Terza domanda. È stato accertato che il giorno prima della strage di via D’Amelio il dottor Borsellino si incontrò con un magistrato che si chiamava David Monti. Le chiedo se le risulta che Borsellino raccontò a Monti i motivi dei contrasti alla procura di Palermo, se parlò di una scissione. Ancora, se le risulta che il generale Mori e il capitano De Donno, a proposito dell’incontro alla caserma di Carini del 25 giugno 1992, riferirono a Borsellino dei loro rapporti con Ciancimino e quando hanno riferito per la prima volta alla magistratura di questo incontro del 25 giugno 1992
Le chiedo ancora se le risulta che è stato accertato nella sentenza Borsellino quater che la decisione di anticipare la strage di via D’Amelio fu assunta verso la metà di giugno, nella terza settimana e quali eventi particolari si verificarono in quel periodo, se vi erano stati o meno già gli incontri con Ciancimino.
PRESIDENTE. Poiché ci sono molte domande, la invito a rispondere.
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. Grazie, presidente. Procedo a rispondere.
Sull’esistenza di soggetti che hanno concorso con cosa nostra, non essendo affiliati a cosa nostra, ma essendo espressioni di gruppi di potere variamente individuabili che con cosa nostra fossero in relazione, si devono fare due puntualizzazioni.
La prima è che alcuni elementi noi li conosciamo e addirittura fanno riferimento perfino alla fase esecutiva della strage, del delitto. Per altro verso ci sono delle risultanze processuali direi abbastanza corpose circa il fatto che l’organizzazione cosa nostra, che sicuramente è stata centrale nella progettazione e nella realizzazione della strage di via D’Amelio, ma non solo della strage di via D’Amelio, prima ancora della strage di Capaci e prima ancora nell’omicidio dell’onorevole Salvo Lima e successivamente con altri attentati e altre stragi, ebbe delle interlocuzioni con esponenti esterni a cosa nostra.
Faccio riferimento alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia. Mi riferisco per primo a uno di quelli sui quali, in tutti i processi, nessuno escluso, tutti i giudici che si sono trovati a valutarlo hanno fatto certificazione di attendibilità assoluta. Mi riferisco ad Antonino Giuffrè.
Antonino Giuffrè era il principale braccio destro di Bernardo Provenzano, forse il capomafia più fidato di Bernardo Provenzano nella fase immediatamente successiva alla commissione delle stragi del 1992. Era naturalmente uomo d’onore da antico tempo, dagli anni Ottanta, nel territorio di Caccamo, che aveva un ruolo particolarmente importante. Basti ricordare una famosa affermazione del dottor Giovanni Falcone secondo cui Caccamo era la Svizzera di cosa nostra. Penso che quando si pronunciò in quel modo non facesse solo riferimento eventuale alle ricchezze, ma in realtà alla sua terzietà, alla sua collocazione fuori dai conflitti fra le varie fazioni di cosa nostra, tanto che proprio in quel territorio nel 1986, lo ricordo, fu arrestato l’allora latitante Michele Greco, che era ufficialmente il capo della commissione provinciale di cosa nostra.
Antonino Giuffrè, la cui fonte principale è Bernardo Provenzano, oltre a essere stato un componente della commissione di cosa nostra in quanto capo mandamento, riferì che cosa nostra, Totò Riina in particolare e anche Bernardo Provenzano, prima di procedere all’attività stragista del 1992, operò quelli che egli definì dei sondaggi, cioè delle interlocuzioni e dei confronti con ambienti che egli definì in varie tipologie: ambienti imprenditoriali, ambienti politici e ambienti – ci tenne espressamente a esprimersi in questi termini – massonici, con i quali cosa nostra si confrontò sulla utilità e sulle conseguenze che dalla realizzazione delle stragi sarebbero derivate.
Nell’esprimersi in questo modo, Giuffrè spiegò che quella strategia di cosa nostra di adesione a progetti stragisti rientrava in una necessità di ricomporre equilibri con gli ambienti del potere che con il crollo della Prima Repubblica erano sostanzialmente da riformulare.
Oltre ad Antonino Giuffrè, circostanze molto simili sono state riferite da altri collaboratori di giustizia, anche in questo caso altri capi mandamento di cosa nostra e quindi ne parlarono per conoscenza personale. Faccio riferimento a Salvatore Cancemi, che era il reggente di uno dei più importanti mandamenti di cosa nostra a Palermo, cioè il mandamento di Porta Nuova. Salvatore Cancemi era legatissimo a Raffaele Ganci, che era sostanzialmente nel 1992 il principale basista di Totò Riina a Palermo. Anche Salvatore Cancemi fece riferimento a contatti di Totò Riina con esponenti esterni a cosa nostra. Arrivò anche a fare dei nomi, come è noto, e alla indicazione di un progetto politico, una necessità di Totò Riina, attraverso la violenza stragista, di trovare degli altri interlocutori con i quali poter convivere felicemente per cosa nostra, come già fatto durante la cosiddetta «Prima Repubblica».
Altro esponente di rilievo di cosa nostra, che ha parlato dello stesso tema in termini analoghi è Giovanni Brusca, che era il reggente del mandamento di San Giuseppe Jato, oltre che il regista, quanto agli uomini di cosa nostra, della esecuzione della strage di Capaci. Giovanni Brusca viene in rilievo per due motivi, perché è persona che ebbe interlocuzione diretta con Salvatore Riina, da cui apprese che Riina agli interlocutori esterni aveva rivolto le richieste per patteggiare un nuovo contratto di convivenza fra cosa nostra e le sfere del potere, il cosiddetto «papello» di richieste formulate da Riina.
Brusca è stato anche il personaggio che per primo parlò del contatto, dell’interlocuzione fra cosa nostra a livello di vertice ed esponenti dell’Arma dei carabinieri. Fu proprio dalle parole di Brusca che si sollevò il velo, molti anni dopo rispetto ai fatti, sui contatti che, almeno a partire da giugno del 1992, quindi prima della strage di via D’Amelio, alti esponenti del ROS dei Carabinieri avevano intrattenuto con Vito Ciancimino, individuato come emissario di Totò Riina e Bernardo Provenzano. Questo è ciò che è stato raccolto in sede giudiziaria quanto al profilo dei possibili mandanti esterni, soggetti che avevano avuto contatti con cosa nostra. Trascuro, ciò che però nella sentenza del processo Borsellino quater e nella sentenza del processo Tagliavia a Firenze non viene trascurato e non lo possiamo trascurare neanche in questa sede per dovere di realtà, quanto ha riferito forse il pentito più attendibile sulle stragi nella storia processuale italiane, Gaspare Spatuzza, a proposito dei contatti avuti da Giuseppe Graviano fino a pochi giorni prima del suo arresto nell’ottica di una intesa che lo stesso Giuseppe Graviano aveva fatto con i soggetti che tutti voi conoscete, perché risulta da sentenze passate in giudicato. Anche nella sentenza della corte di assise di Firenze sono fatti quei nomi e sono i nomi di Silvio Berlusconi e di Marcello Dell’Utri come i soggetti con i quali Giuseppe Graviano aveva stipulato un accordo che gli consentiva, il 20 gennaio 1994, di prevedere che si erano messi il Paese in mano, cosa che poi, in realtà, rispetto ai desiderata di Giuseppe Graviano naufragò il 27 gennaio con l’arresto dei fratelli Graviano a Milano.
La cosa forse più significativa è che della presenza di soggetti estranei a cosa nostra, concorrenti di cosa nostra per le stragi del 1992 e per la strage di via D’Amelio in particolare, ci sono risultanze che riguardano proprio la fase esecutiva.
Gaspare Spatuzza ha riferito all’autorità giudiziaria, in modo particolarmente dovizioso di dettagli, del personaggio sicuramente estraneo a cosa nostra che era presente al momento in cui, sabato 18 luglio 1992, la Fiat 126 utilizzata per la strage il pomeriggio successivo veniva imbottita di esplosivo.
A quella fase delicatissima della esecuzione, dei preparativi per la strage, era presente un soggetto estraneo a cosa nostra. L’autorità giudiziaria ha cercato di procedere a una individuazione mediante riconoscimenti che Gaspare Spatuzza provò a fare. Lo fece in forma solo dubitativa. Indicò solo con grado di possibilità e neanche di probabilità un soggetto che era funzionario del SISDE, l’allora vice capo del SISDE di Palermo. Peraltro, in quell’occasione, nel momento in cui Spatuzza rese quelle dichiarazioni si verificò un problema serio sulla tutela della posizione del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, che vide sostanzialmente un conflitto fra il potere esecutivo e la Direzione nazionale antimafia, perché, proprio dopo quelle dichiarazioni, a Gaspare Spatuzza, con delibera della Commissione centrale ex articolo 10, legge n. 82/1991 non furono assegnate inizialmente le misure di protezione che poi, per fortuna, furono assegnate. Se non ricordo male, anche dopo un annullamento in sede di giustizia amministrativa del provvedimento, perché era palesemente illegittimo, furono poi, per fortuna, assegnate.
Oltre a questo, vanno riferite anche delle altre circostanze che riguardano perfino le ultime cognizioni che Paolo Borsellino ebbe circa i pericoli che egli correva. A partire dal 2009, come sapete, la vedova Agnese Borsellino riferì all’autorità giudiziaria tutto quello che aveva appreso nelle ultime settimane di vita e in particolar modo dopo la strage di Capaci e segnalò un dato che, a mio modo di vedere, è rilevantissimo: Paolo Borsellino, la sera, quando era Palermo e si trovava a casa sua, intimava, mi viene da dire, sollecitava fortemente la moglie ad abbassare le serrande della camera da letto per impedire – queste furono le parole di Paolo Borsellino – «di poter essere controllato dal Castello Utveggio».
Come a tutti voi è noto, il Castello Utveggio è una struttura originariamente residenziale, che si trova sulle alture del Monte Pellegrino, che sovrastano peraltro anche la zona di via D’Amelio. In quel momento, il 19 luglio del 1992 era occupato da un centro di formazione per manager dipendente dalla Regione Siciliana, il cui nome era CERISDI, che aveva una peculiare caratteristica, anzi direi due. La prima, che il dirigente di quel centro era l’ex capo dell’Alto Commissariato antimafia. Fra le competenze che io conosco ordinamentali che aveva l’Alto Commissariato antimafia non credo che ci fossero specializzazioni in materia di formazione manageriale.
La seconda caratteristica, rilevantissima, che io conosco bene, perché riguarda uno degli imputati dell’omicidio del poliziotto Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, è che con le utenze telefoniche del CERISDI al Castello Utveggio risultò in contatto telefonico il mafioso, uomo d’onore della famiglia dell’Arenella, mandamento di Resuttana, Gaetano Scotto, oggi imputato per il duplice omicidio Agostino-Castelluccio.
C’è un altro dato, che è forse il più preoccupante, ed è registrato anche questo nella sentenza del processo Borsellino quater, dove invano abbiamo sentito – nel senso che le parti hanno esaminato – due persone, che si chiamano Mario Santo Di Matteo, noto collaboratore di giustizia, e la ex moglie Francesca Castellese, ovverosia i genitori del piccolo Giuseppe Di Matteo, sequestrato all’età di dodici anni a novembre 1993 e purtroppo finito con una delle morti peggiori che si conoscano.
A novembre 1993 Santino Di Matteo collaborava da un mese con la giustizia, aveva fatto le sue rivelazioni sulla strage di Capaci, essendo esecutore materiale della strage di Capaci, e aveva consentito l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare sulla strage di Capaci. Dieci giorni dopo l’esecuzione di quella misura ci fu il sequestro del bambino. Di Matteo si trovava sotto protezione, chiese un incontro con la mamma del bambino, come è comprensibile, e quell’incontro fu registrato, perché fu celebrato in una caserma ed era stata disposta l’intercettazione ambientale per quell’incontro. In quella occasione la cosa a mio modo di vedere sconvolgente è che la mamma del bambino che era stato sequestrato da cosa nostra in quanto figlio del collaboratore di giustizia, anziché rivolgere le proprie preoccupazioni alle dichiarazioni che Santino Di Matteo aveva già reso sulla strage di Capaci e che avevano portato alle misure cautelari nei confronti di numerosi uomini d’onore, si premurò di supplicare il marito di tacere su una evenienza, che non riguarda la strage di Capaci. Testualmente le parole di Francesca Castellese al marito furono: «Non parlare dei poliziotti infiltrati nella strage Borsellino». Capite che il grado di genuinità di una mamma che cerca di fare di tutto per salvare il figlio è facilmente valutabile da ognuno di voi e secondo i canoni che vengono utilizzati nella valutazione delle prove in un giudizio penale naturalmente è facile comprendere il rilievo di quelle parole.
Su quelle parole l’autorità giudiziaria ha cercato di scavare, senonché si è imbattuta in un muro di assoluto silenzio, di omertà terrorizzata – mi viene da dire – da parte sia di Santino Di Matteo sia di Francesca Castellese. Nessuno dei due ha mai voluto fare alcuna chiarezza. Hanno perfino negato che quelle parole fossero state pronunciate davanti a delle registrazioni, che sono la prova materiale di quelle parole.
Questi sono gli approdi probatori in sede giudiziaria, i più rilevanti, a mio modo di vedere, circa la presenza di concorrenti che insieme a cosa nostra abbiano partecipato, in fase ideativa, in fase deliberativa o addirittura in fase esecutiva, alla strage di via D’Amelio.
La circostanza, peraltro, proprio per quello che ho detto, si lega al tema della seconda domanda, che riguarda le nuove rivelazioni, rese a partire dal 31 gennaio 2020, da Maurizio Avola. Sul punto devo segnalare due cose. La prima è che c’è un’indagine in corso presso la procura di Caltanissetta, a seguito di un’ordinanza del GIP che rigettò una richiesta di archiviazione, indagine fondata sulle dichiarazioni di Maurizio Avola, nel tentativo di comprendere il grado di astratta, molto astratta, anche solo semplice verosimiglianza del racconto di Avola. In contemporanea, la procura di Caltanissetta sta procedendo nei confronti di Avola e del suo difensore per il delitto di calunnia proprio per le stesse dichiarazioni relative alla strage di via D’Amelio. Il fatto che ci siano due procedimenti in corso, che è un dato non segreto, perché è noto per il deposito degli atti che c’è stato, mi ha consentito di fare riferimento al fatto dell’esistenza dei procedimenti.
Per rispondere nel dettaglio, è necessario che io chieda di procedere con la forma della segretezza.
PRESIDENTE. Lo teniamo alla fine.
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. Va bene.
L’incontro del tardo pomeriggio del 18 luglio 1992 all’Hotel Astoria Palace di Paolo Borsellino con il suo collega più giovane David Monti. David Monti è un magistrato che è stato sentito come testimone nel processo Borsellino bis e riferì di questo incontro che ebbe, proprio meno di ventiquattro ore prima della strage di via D’Amelio, con Paolo Borsellino. Effettivamente David Monti è un magistrato che con Paolo Borsellino era entrato in un rapporto di una certa confidenzialità, anche per comune militanza correntizia. Erano nella stessa corrente di Magistratura Indipendente. Infatti, venti giorni prima, a fine giugno 1992, Paolo Borsellino era stato in Puglia, a Giovinazzo, proprio per partecipare a un congresso di Magistratura Indipendente, e anche lì si era trovato con David Monti.
David Monti, il 18 luglio, andò a Palermo e i due si incontrarono intorno alle 20. David Monti ha riferito il contenuto della conversazione avuta nel processo Borsellino bis ed effettivamente ha fatto riferimento a tre circostanze principali, meritevoli di attenzione nelle parole rivoltegli da Paolo Borsellino.
La prima era che effettivamente alla procura di Palermo in quel momento Paolo Borsellino segnalava, denunciava alle orecchie del collega l’esistenza di una spaccatura, una spaccatura della quale riteneva responsabile il procuratore Giammanco. Addebitava a Giammanco non solo una generale mala gestio dell’ufficio, ma anche, fin da anni precedenti, un trattamento persecutorio che Giammanco aveva riservato all’allora procuratore aggiunto Giovanni Falcone, negli ultimi due anni di presenza di Falcone alla procura di Palermo, prima di accettare l’incarico alla Direzione degli affari penali presso il Ministero di grazia e giustizia.
Nell’occasione, Borsellino spiegò a David Monti che Giammanco, anche dopo aver marginalizzato Giovanni Falcone e averlo sostanzialmente costretto ad andare via dalla procura di Palermo, aveva continuato a condurre l’ufficio requirente palermitano in modalità non apprezzate da Paolo Borsellino.
Paolo Borsellino segnalò di avere un carattere diverso da Giovanni Falcone e, quindi, di preferire, anziché arrivare allo scontro, cercare di raggiungere risultati utili. Spiegò che la cosa che gli premeva di più in quel momento era cercare elementi di ricostruzione sulla strage di Capaci. Segnalò al collega che, seppure Giammanco gli creasse problemi, lui, anche operando sulla provincia o dalla provincia, tanto avrebbe fatto che sarebbe riuscito comunque a ottenere elementi sulla strage di Capaci. Segnalò, poi, che proprio in quel momento – siamo al 18 luglio 1992 – la procura di Palermo era segnata – queste sono le parole usate da David Monti – da una «spaccatura verticale», di cui era responsabile il procuratore Giammanco. Con questa espressione mi viene facile richiamare alla memoria quelle che erano state le ultime settimane di lavoro di Paolo Borsellino alla procura di Palermo, gli scontri con Giammanco, il quasi controllo che, attraverso un procuratore aggiunto, Giammanco cercava di fare sull’attività di Paolo Borsellino nel momento in cui aveva iniziato a collaborare Gaspare Mutolo, le resistenze a che Paolo Borsellino si occupasse delle vicende di Palermo e, infine, la spaccatura che si formalizzò immediatamente dopo la strage di via D’Amelio, che è a tutti nota. Quanto a Mori e De Donno e al loro incontro del 25 giugno 1992 con Paolo Borsellino alla caserma «G. Carini», io ho già riferito sull’oggetto di quell’incontro e nella ricostruzione più verosimile propendo per accreditare le parole dell’unico testimone disinteressato che era presente, ossia l’allora maresciallo Canale, che riferì che l’incontro era stato voluto da Paolo Borsellino perché cercava di capire se fosse stato il capitano De Donno il redattore di quell’inquietante documento anonimo, passato convenzionalmente alla storia come il documento del «Corvo bis».
È certa una cosa: il generale Mori e il capitano De Donno per anni mantennero il silenzio su quell’incontro. La cosa ha un rilievo madornale, ai miei occhi, per un fatto. Sicuramente il 25 giugno 1992 i vertici del ROS avevano già avviato l’interlocuzione con Vito Ciancimino. Dietro incarico dell’allora colonnello Mori, il capitano Giuseppe De Donno aveva agganciato il figlio di Vito Ciancimino durante un viaggio e avviata quella interlocuzione, che poi gli stessi Mori e De Donno, soprattutto il secondo, davanti ai giudici di Firenze chiamarono «trattativa». Utilizzarono proprio questo termine.
Il punto è che di quell’incontro per anni i due tacquero davanti all’autorità giudiziaria. Tacquero davanti all’autorità giudiziaria, ma soprattutto a Paolo Borsellino tacquero della trattativa avviata con Vito Ciancimino, emissario di Totò Riina e Bernardo Provenzano.
Perché la questione è molto rilevante? Per due motivi. Il primo è che noi sappiamo per certo che analogo riserbo Mori e De Donno non mantennero con esponenti politici, anzi direi con esponenti del Governo. Noi sappiamo, infatti, in quanto lo ha testimoniato davanti ai giudici l’allora direttrice generale degli affari penali, dottoressa Ferraro, cioè il magistrato che succedette a Giovanni Falcone in quel ruolo dopo la strage di Capaci, che il 28 giugno ella informò il dottor Borsellino, incontrandolo all’aeroporto di Fiumicino, che aveva appreso dal capitano De Donno, mandatole dal colonnello Mori, che i due avevano avviato una trattativa con Vito Ciancimino. Vi lascio immaginare quale possa essere stata la reazione intima di Paolo Borsellino. Sappiamo di quella ufficiale. La dottoressa Ferraro ha riferito che Paolo Borsellino le disse molto sbrigativamente: «non ti preoccupare, me la vedo io». Il punto è che, però, Paolo Borsellino aveva incontrato quei due ufficiali dell’Arma tre giorni prima e tre giorni prima quei due ufficiali dell’Arma una cosa di dimensioni colossali, quali l’avvio di un confronto con l’emissario del capo di cosa nostra, l’avevano taciuta.
Lo stesso difetto di riserbo, perché il riserbo l’hanno mantenuto solo con Paolo Borsellino, la stessa apertura confidenziale il generale Mori e il capitano De Donno la tennero anche con altri esponenti, con la segretaria generale della Presidenza del Consiglio di allora, l’avvocata Fernanda Contri, con l’allora presidente della Commissione parlamentare antimafia, onorevole Luciano Violante. C’è traccia perfino, dall’agenda di Mario Mori, che anche con un altro esponente politico, l’allora credo deputato onorevole Pietro Folena, ebbe degli incontri, nei quali Mori faceva degli aggiornamenti sulle attività che svolgeva.
Questo lo dico per dire che l’unico soggetto che fu destinatario del silenzio, che definirei omertoso, perché non so come definirlo in altro modo, fu proprio Paolo Borsellino. È come se nell’atteggiamento di Mori e De Donno ci fosse una ragione – e vorrei che la spiegassero – per cui a Borsellino doveva essere tenuta nascosta l’interlocuzione avviata con l’emissario di cosa nostra.
Per via deduttiva a me è facile comprendere quale sia il motivo del silenzio davanti a Paolo Borsellino, perché io non oso immaginare quale sarebbe stata la reazione di un magistrato in generale e di Paolo Borsellino in particolare davanti a degli ufficiali dei carabinieri che gli dicono: per risolvere il problema perché bisogna fare questo muro contro muro – sono le parole utilizzate da Mario Mori in una deposizione a Firenze – con cosa nostra (le parole rivolte a Vito Ciancimino)? Vediamo di trovare un accordo.
Non do neanche io la risposta, invito voi a rispondere. Quale sarebbe stata la risposta di Paolo Borsellino all’evocazione di un accordo con Totò Riina e Bernardo Provenzano? Perché di quello si trattava. Lo hanno detto quegli ufficiali dei carabinieri.
Questo spiega il motivo per cui per molti anni Mori e De Donno tacquero davanti all’autorità giudiziaria, perché era difficilmente giustificabile sia il loro comportamento, sia il loro silenzio tenuto nei confronti di Paolo Borsellino. Tanto che, quando resuscitò il discorso dell’incontro con Paolo Borsellino del 25 giugno 1992 e la teorizzazione, che io continuo a definire della «pista palestinese», del rapporto mafia e appalti quale ipotetica causale della strage di via D’Amelio, a ottobre 1997 De Donno fu convocato dalla procura di Palermo e gli fu chiesto di spiegare ciò che aveva fatto il ROS intorno a quel rapporto, intorno a quell’indagine e intorno ai rapporti non perfettamente piani con un altro emissario di cosa nostra, a nome Angelo Siino, che aveva appena cominciato a collaborare con la giustizia e che aveva rivelato alla procura di Palermo la possibilità che, anche attraverso esponenti dell’Arma dei carabinieri vicini a Mori e De Donno e al ROS, cosa nostra aveva avuto informazioni sul dossier mafia e appalti.
Infine, c’è la domanda sull’accelerazione. Questo è un dato documentato e accertato nella sentenza del processo «Borsellino quater» da plurime fonti di prova. È certo che l’accelerazione che portò all’esecuzione nei tempi più immediati possibili è avvenuta fra gli ultimi giorni di giugno e i primi giorni di luglio 1992, quindi sicuramente dopo che era stata avviata l’interlocuzione fra i vertici del ROS e cosa nostra attraverso Vito Ciancimino. Questo, peraltro, è confermato anche, da altra parte, da un dato che riguarda proprio la fase esecutiva del delitto. Basta registrare le dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza a proposito del momento in cui Giuseppe Graviano gli chiese di procurare l’auto, la famosa Fiat 126 rubata, che fu utilizzata per la strage. Quella richiesta venne fatta a Gaspare Spatuzza nella prima decade di luglio 1992, esattamente in conseguenza di quanto vi avevo detto.
Vi aggiungo che è noto e processualmente accertato che in quel periodo uno degli obiettivi di cosa nostra, del programma di rappresaglia vagamente deliberato dai vertici di cosa nostra, era un attentato che era stato progettato ai danni dell’onorevole Calogero Mannino. La responsabilità dell’attuazione di quell’attentato era stata affidata a Giovanni Brusca. Non più di una settimana prima della strage di via D’Amelio, Totò Riina revocò quell’incarico a Giovanni Brusca.
Sono tutti elementi di fatto, comprovati, che impongono di dedurre che l’accelerazione che portò al compimento della strage di via D’Amelio è sicuramente successiva al 25 giugno 1992.
PRESIDENTE. Grazie, avvocato. Solo un richiamo al rispetto dei tempi, per quanto possibile. Non voglio interrompere nessuno, ma se ogni domanda e ogni risposta alla domanda dura 35 minuti, ci vedo in difficoltà. Peraltro, alcune cose erano sicuramente già emerse nella sua audizione.
Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.
RAOUL RUSSO. Signor presidente, vorrei rivolgere delle domande al dottor Borsellino, se è collegato.
SALVATORE BORSELLINO(intervento da remoto). Sono collegato.
RAOUL RUSSO. Grazie, dottor Borsellino. Volevo rivolgere alcune domande relativamente alla situazione del dottor Borsellino dal punto di vista lavorativo, nel contesto della procura di Palermo. In particolare, se avesse ricevuto confidenze sulle difficoltà che incontrava in quella procura tanto – e le chiedo anche il motivo – da arrivare a dire che era un «covo di vipere». Inoltre, se lei mi sa indicare, a questo punto, quali erano i magistrati di cui lui in qualche modo si fidava e quelli di cui non si fidava, se le faceva queste confidenze, naturalmente. E se, dopo la strage di Capaci, abbia avuto modo e tempo di fare delle confidenze sui pericoli che temeva per la sua persona, per la sua incolumità, dopo quell’evento così tragico.
SALVATORE BORSELLINO(intervento da remoto). Guardi, mio fratello usava parlare molto poco del suo lavoro. Era molto riservato sul suo lavoro. Gli unici accenni che mi fece furono relativi al suo contrasto proprio con il procuratore Pietro Giammanco. Non mi parlò mai, non ebbi mai occasione di parlare con lui di altri magistrati, a parte Giovanni Falcone, ovviamente, che gli erano particolarmente vicini. Non mi fece mai queste confidenze.
Dopo la strage di Capaci, sicuramente mio fratello sapeva che sarebbe toccato a lui. Era una cosa di cui era assolutamente certo. Addirittura, aveva degli atteggiamenti con i figli: cercava di allontanarsi effettivamente da loro per abituarli a quella che sarebbe stata la sua assenza. Sicuramente, quindi, mio fratello era consapevole di quello che rischiava.
Quello che posso dire è che gli telefonai il venerdì prima che lo uccidessero per chiedergli di andare via da Palermo. Sapevo che cosa rischiava restando a Palermo e gli chiesi di andare via da Palermo. Mio fratello si alterò rispondendomi. Mi rispose: «Io non accetterò mai di fuggire. Io presterò fino all’ultimo fede al giuramento che ho fatto allo Stato».
Queste sono le cose che posso riferire relativamente ai colloqui con mio fratello.
Ripeto, mio fratello, per quanto riguarda il suo lavoro, era molto riservato. Assolutamente riservato.
GIANLUCA CANTALAMESSA. Signor presidente, tre domande veloci per il dottor Borsellino, che saluto e ringrazio.
Prima domanda. Per quali motivi lei e i suoi nipoti, i fratelli Gatani, dopo esservi costituiti parte civile nel processo contro Matteo Messina Denaro, avete ritenuto di non presentare le conclusioni nel processo, revocando la costituzione della parte civile?
Seconda domanda. Per quali motivi avete ritenuto di non impugnare la sentenza di assoluzione, quindi di non dover procedere nei confronti dei poliziotti Bo, Mattei e Ribaudo, imputati del depistaggio delle indagini su via D’Amelio?
Terza domanda, più generica. Quando è venuto a conoscenza dell’agenda rossa di suo fratello e della sua sparizione e ha mai visto suo fratello annotare qualcosa su di essa? Grazie.
SALVATORE BORSELLINO(intervento da remoto). Per quanto riguarda le prime due domande, a me non risulta di aver revocato la mia costituzione di parte civile. All’interno di questi processi mi sono completamente affidato all’avvocato Repici, di cui ho piena fiducia. Eventualmente, lascio a lui di sostituirmi in questa risposta.
Per quanto riguarda l’agenda rossa, sicuramente l’ho visto più volte, anche se non direttamente. Io vidi l’ultima volta mio fratello a capodanno del 1992. Poi non avemmo più occasione di incontrarci, quindi non ebbi più occasione di vedere lui scrivere qualcosa nell’agenda rossa. Però ho notato quell’agenda rossa in molte sue interviste, ho visto che l’aveva in mano.
Da confidenze con persone come Gaspare Mutolo, che ebbe gli ultimi incontri con Paolo Borsellino, mi è stato testimoniato che su quell’agenda rossa Paolo annotava regolarmente tutto quello che succedeva.
Mi è stato anche riferito della sua particolare cura nel non far vedere ai suoi familiari quell’agenda, che custodiva gelosamente, e di quella che era stata la sua agitazione quando, mentre si trovava in Puglia, uscendo dall’albergo, si era accorto di non avere l’agenda in mano. Aveva fatto di tutto per ritornare precipitosamente e cercare quell’agenda. Aveva una grandissima cura per quell’agenda e sicuramente la utilizzava per scrivere tutto quello che non poteva essere verbalizzato nei colloqui che aveva con collaboratori di giustizia e con altri elementi per quanto riguardava la sua indagine.
PRESIDENTE. Prego, avvocato, se vuole completare.
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. La questione relativa al mancato appello della sentenza di proscioglimento per prescrizione nei confronti degli imputati Bo e Ribaudo e all’assoluzione per non aver commesso il fatto nei confronti dell’imputato Mattei, in realtà, pecca di mancata conoscenza delle questioni giuridiche con le quali è regolato il processo.
Dopo il deposito della sentenza di primo grado, Salvatore Borsellino e i figli di Adele Borsellino, il cui cognome è Gatani, erano costituiti parte civile e sono costituiti parte civile a mezzo della mia assistenza, abbiamo ricevuto la notifica dell’atto di appello ritualmente proposto dalla procura della Repubblica. L’appello proposto dal pubblico ministero vale anche sugli effetti civili nel caso di sentenza di assoluzione in primo grado, tanto che oggi è in corso il giudizio d’appello e il sottoscritto il mese scorso ha partecipato all’udienza di quel processo.
Sia Salvatore Borsellino sia i figli di Adele Borsellino mi hanno dato un mandato difensivo semplicemente finalizzato a una cosa: la ricerca della verità e l’ottenimento della verità e della giustizia, non quello di mettere il marchio o fare iniziative che non hanno alcun rilievo concreto, non hanno alcun effetto concreto, ma possano valere come formalismo puro, mettiamola in questi termini, volendo essere diplomatici. Avendo noi ricevuto la notifica dell’appello della procura della Repubblica, sapevamo che ci sarebbe stato il secondo grado di giudizio, al quale avremmo partecipato, come effettivamente stiamo partecipando.
Quanto alla costituzione di parte civile nel processo contro Matteo Messina Denaro, anche lì, come già ha detto Salvatore Borsellino, non c’è stata nessuna revoca della costituzione di parte civile. Sono accadute varie cose delle quali bisogna tenere conto nella valutazione delle cose pratiche, sia della vita sia dei processi.
GIANLUCA CANTALAMESSA. Chiedo scusa, per essere chiaro. Non vorrei che prima le parole abbiano tradito il pensiero. Non il discorso della revoca della costituzione, la revoca della costituzione sarebbe una conseguenza del non aver presentato le conclusioni nel processo. Questa era la domanda.
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. Anche questa domanda pecca, in questo caso, non di scarsa conoscenza di questioni giuridiche, ma di scarsa conoscenza proprio dei fatti processuali. Posso segnalarle che ho ricevuto la notifica della fissazione del giudizio di appello e ho ricevuto anche la notifica della fissazione del giudizio innanzi alla Corte di cassazione.
Stavo dicendo un’altra cosa, più pratica. Quel processo si aprì in contemporanea al processo Borsellino quater. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter celebrare il processo Borsellino quater davanti alla corte più attrezzata che potessimo trovare. Proprio grazie alla possibilità di celebrare quel processo, si sono ottenuti i risultati che sono certificati nella sentenza della corte d’assise di Caltanissetta, presidente Balsamo, che è passata in giudicato quasi integralmente in sede di giudizi di impugnazione.
Contemporaneamente, partì il processo a carico di Matteo Messina Denaro. Quel processo aveva due caratteristiche che indusse me a consigliare ai miei assistiti di indirizzare tutti i nostri sforzi nel processo Borsellino quater. I motivi erano duplici. Il primo. Le segnalo una circostanza, cioè la norma, l’articolo 419-bis, che era in vigore al momento dell’apertura del processo a carico di Matteo Messina Denaro. Noi viviamo in una dimensione pubblica, nel commento delle vicende giudiziarie, nella quale, giustamente, spesso si sollecita a fare applicazione garantista delle norme in tutti i processi. Naturalmente, il garantismo vale non secondo il nome dell’imputato. La legge è uguale per tutti. È scritto dietro le spalle dei giudici. Matteo Messina Denaro, all’inizio di quel processo, come tutti sappiamo, era latitante. È stato arrestato non molti mesi prima di morire, quando già la sentenza di primo grado era stata emessa e stava per concludersi il processo di secondo grado. La cosa che mi lasciò turbato è che non ci si accorse che era impossibile dimostrare, come la legge imponeva, che l’imputato Matteo Messina Denaro avesse avuto conoscenza dell’avvio del processo.
Questa cosa la riferisco non per amore di formalismo, che non ho per nulla, ma per una circostanza che è comprovata da ciò che, poi, dirò sul depistaggio che ha il nome di Maurizio Avola. Il depistaggio che ha il nome di Maurizio Avola ha trovato l’avvio ad aprile del 2019 proprio nel processo a carico di Matteo Messina Denaro, innanzi a quella corte d’assise che esaminò, in un’aula bunker di Firenze, Maurizio Avola.
Io, sarà che sono malpensante, sarà che, magari, ho un minimo di sensibilità in più rispetto ad altri operatori processuali, mi accorsi di quella anomalia dovuta al fatto che giudici, pubblici ministeri e addirittura difensori dell’imputato non si accorgevano di un evidente difetto di procedibilità. In contemporanea alla celebrazione del processo a carico di Matteo Messina Denaro per le stragi a Caltanissetta, fu avviato un processo innanzi all’autorità giudiziaria di Palermo, perché l’articolo 112 della Costituzione prevede che l’esercizio dell’azione penale è obbligatorio. Quindi, anche in presenza del 419-bis, naturalmente la richiesta di rinvio a giudizio va fatta. Solo che il 419-bis impone al giudice di verificare se l’imputato ha avuto contezza dell’avvio del procedimento. Se questa prova non c’è e non ci sono prove di notifiche effettuate, il processo deve essere sospeso.
Infatti, in contemporanea, mentre Matteo Messina Denaro veniva processato a Caltanissetta, il GUP di Palermo in un processo per associazione mafiosa – naturalmente i processi per le stragi non si celebrano a Palermo per ragioni di competenza funzionale ex articolo 11 – sospese il giudizio. Quel giudizio sospeso fu riavviato dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, perché al momento della cattura di Matteo Messina Denaro gli furono notificate tutte le ordinanze di custodia cautelare e tutte le ordinanze di esecuzione pena – penso una carrettata – che aveva accumulato nel corso di trent’anni di latitanza.
Quella anomalia messa insieme a ciò che è accaduto come fatto materiale, vale a dire che quel processo è stato utilizzato da qualcuno come il palco sul quale costruire ulteriori depistaggi, mi ha indotto a suggerire al fratello di Paolo Borsellino di osservare dall’esterno, senza partecipare a quel processo, che rischiava di diventare una palestra di depistaggi. Purtroppo, mi viene da dire spiacevolmente, quella previsione poi ebbe conferma.
In questo senso io, che avevo molti dubbi, come è naturale – qualunque scelta si fa e qualunque suggerimento si dà a un cliente si vive sempre nel dubbio, l’avvocato per forza di cose vive nel dubbio – quando ho visto accadere ciò che è accaduto, ho detto: «ho fatto bene».
GIANLUCA CANTALAMESSA. Giusto per chiarire. Non sono un avvocato, sono un dottore commercialista, ma ho l’onore di far parte di questa Commissione da sette anni, quindi prima di fare le domande normalmente mi informo. Ebbene, leggo che la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguarda l’azione civile 538, 541 e 600 ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.
Questo semplicemente per dire che mi sembra più una scelta processuale legittimissima, ma non solo, che obbligata. Grazie.
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. Mi perdoni, presidente. C’è un corredo. Naturalmente se la procura della Repubblica non appella una sentenza in assoluzione, la parte civile che vuole insistere nella richiesta risarcitoria deve proporre appello ai fini civili. Ma se l’impugnazione viene proposta dalla procura della Repubblica, il processo va tutto in secondo grado, sia le questioni penali, sia le questioni civili, che sono il corredo di quelle penali, perché io non potrò mai ottenere la condanna a un risarcimento se non viene accertata la responsabilità penale. Se la procura recede dall’azione non impugnando, a quel punto io dovrò proseguire nell’azione civile nell’unico modo, che è quello di impugnare ai fini civili la sentenza.
L’appello della procura della Repubblica di Caltanissetta valeva anche per noi e questo avrebbe indotto la proposizione di un appello solo ai fini civili a semplicemente una duplicazione dello stesso atto.
PRESIDENTE. Io non credo che volesse essere un attacco all’avvocato. Era per capire, in quanto agli atti della Commissione…
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. Volevo spiegare.
PRESIDENTE. Agli atti della Commissione risulta che le altre parti l’hanno fatto, quindi credo che la domanda sia legittima, senza adesso voler entrare in un dibattito.
GIORGIO SALVITTI. Dalle sentenze di assoluzione in riferimento a Mario Mori e Mauro Obinu emerge, in quanto riferito da più testimoni, che Agnese Borsellino chiese al pubblico ministero Cardella di lavorare con il ROS per le indagini sulla strage di via D’Amelio. Perciò, il ROS svolse alcune indagini sui mandanti esterni, come emerso dal processo «trattativa Stato-mafia». Emerge che addirittura chiese la presenza dello stesso ROS alla perquisizione dello studio del dottor Borsellino, che venne eseguito dal personale della squadra mobile. Come si conciliano queste circostanze secondo lei – le chiedo un suo parere – con l’opinione che avrebbe dovuto avere a quell’epoca la signora Borsellino su Subranni, avendo ricevuto le confidenze del marito? Grazie
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. Senatore, le rispondo con franca cordialità. Il dottor Cardella era un pubblico ministero, quindi naturalmente non riceveva deleghe dalla signora Borsellino, ma operava esattamente per come riteneva doveroso operare. Segnalo che il dottor Cardella arrivò a Caltanissetta in applicazione extradistrettuale credo nel mese di ottobre 1992, quando le perquisizioni presso l’ufficio del dottor Borsellino si erano già verificate.
Presidente, a tal proposito voglio ringraziare la Commissione antimafia e lei personalmente, perché solo nelle ultime settimane, dopo aver fatto richieste varie a colleghi, sono riuscito finalmente ad avere copia dei decreti di perquisizione e di acquisizione eseguiti sia presso la casa, sia presso l’ufficio del dottor Paolo Borsellino. Questa è una cosa molto importante. Quindi, poiché li avete acquisiti voi, lei sa bene che quegli atti furono eseguiti nella tarda sera del 19 luglio 1992, immagino che poi si proseguì in data 20, perché penso che si superò la mezzanotte, e naturalmente risulta che li ha fatti, e naturalmente non c’era il ROS.
Io qui richiamo non le parole di Agnese Borsellino, fermo restando quello che proprio sento come dovere civico, io ho deferenza assoluta per le parole di quella donna, ma induco o chiedo alla Commissione di prestare la doverosa attenzione alle parole rese da Lucia Borsellino e Manfredi Borsellino, figli di Paolo Borsellino, deponendo come testimoni innanzi alla corte d’assise di Caltanissetta al processo Borsellino quater.
Qui devo menare un vanto. Mi perdoni la caduta di gusto. In tanti si lamentano di mancate testimonianze nei processi per la strage di via D’Amelio. Quando io ricevetti incarico da Salvatore Borsellino nel processo Borsellino quater, che fu il primo processo per la strage di via D’Amelio al quale ho partecipato, insieme al mio cliente, che mi onoro di rappresentare, Salvatore Borsellino, ci siamo presi cura di indicare nella lista testimoniale e di convocare davanti alla corte d’assise tutti i testimoni vivi che potessero riferire. Questo per dire che, se il dottor Giovanni Tinebra è stato sentito come testimone innanzi alla corte di assise di Caltanissetta, lo si deve grazie alla parte civile Salvatore Borsellino. Se il procuratore Pietro Giammanco è stato citato come testimone innanzi alla corte d’assise di Caltanissetta, lo si deve alla parte civile Salvatore Borsellino. Poi, in corso di dibattimento le condizioni di salute di Giammanco si deteriorarono, per cui non poté testimoniare. Ma naturalmente la parte civile Salvatore Borsellino anche alla salute dei testimoni non poteva in nessun modo prestare alcun beneficio.
Lucia e Manfredi Borsellino io ho avuto l’onore di convocarli come testimoni al processo Borsellino quater. Non avevano mai testimoniato nel processo sulla strage di via D’Amelio, mai! Neanche i loro avvocati li avevano mai indicati come testimoni, neanche nel processo «Borsellino quater». Perché li convocai? Perché era successo un fatto, che ho già riferito, che a me lasciò parecchio sgomento: la reazione del generale Subranni, il 10 marzo 2012, a commento delle parole di Agnese Borsellino riportate nella misura cautelare del procedimento Borsellino quater. Le parole le conosciamo, «Subranni punciutu», la reazione di Subranni la conosciamo.
Convocai come testimoni Lucia e Manfredi Borsellino e Lucia e Manfredi Borsellino riferirono due dati rilevantissimi. Il primo è che la mamma, subito dopo la strage e per lunghi anni, la principale premura che aveva avuto era tutelare la sicurezza dei suoi figli, come chiunque di noi avrebbe fatto. Come si può pensarla diversamente? Solo nel 2009, quando la signora Agnese Borsellino aveva pensato che ormai tutti i doveri di mamma li aveva abbondantissimamente messi in pratica, ritenne doveroso – penso che l’Italia non la ringrazierà mai abbastanza – riferire ai magistrati, dei quali si fidava, tutto ciò che le aveva confidato nelle ultime settimane di vita suo marito. Il Castello Utveggio lo abbiamo appreso da Agnese Borsellino. Il «Subranni punciutu» l’abbiamo appreso da Agnese Borsellino. La trattativa in corso fra parti infedeli dello Stato e cosa nostra l’abbiamo appresa da Agnese Borsellino. L’aria di morte respirata da Paolo Borsellino non a vicolo Pipitone, ma al Palazzo del Viminale l’abbiamo appreso da Agnese Borsellino.
La seconda cosa che dissero all’unisono Lucia e Manfredi Borsellino è che la mamma non solo aveva detto, come è ovvio a tutti, la verità, ma era la persona più lucida dei familiari di Paolo Borsellino nel raccontare quelle cose.
La terza cosa fu la reazione morale, ben comprensibile, di Lucia e Manfredi Borsellino alle parole infami pronunciate dal signor Antonio Subranni nell’occasione.
Questo mi porta a dire che non si può in alcun modo dubitare delle parole di Agnese Borsellino.
Vi segnalo una circostanza, e chiedo scusa al senatore Scarpinato, perché c’era una cosa che avrei dovuto aggiungere nella risposta su David Monti in occasione del suo incontro con Paolo Borsellino. Noi sappiamo che la settimana precedente, l’11 luglio 1992, Paolo Borsellino aveva incontrato un suo carissimo collega, il cui figlio battezzò come padrino, il dottor Diego Cavaliero. Io penso, e l’hanno detto anche i figli di Paolo Borsellino, che Diego Cavaliero fosse il magistrato al quale era più legato Paolo Borsellino al momento della sua morte. Proprio il dottor Diego Cavaliero riferì di aver appreso da Agnese Borsellino della confidenza sul generale Subranni che le era stata fatta da Paolo Borsellino e precisò: badate bene, il senso delle parole di Agnese Borsellino fu che Paolo Borsellino aveva certezza della veridicità di quelle parole.
Poi, chiunque vuole può mettere in dubbio la lucidità e la capacità di comprensione delle cose di Paolo Borsellino o la genuinità delle parole di Agnese Borsellino. Naturalmente io mi sottraggo a questo tipo di indirizzo.
WALTER VERINI. Signor presidente, anch’io mi associo ai ringraziamenti nei suoi confronti, ma voglio in particolare ringraziare l’avvocato Repici, voglio ringraziare Salvatore Borsellino, voglio ringraziare Gioacchino Natoli e aggiungo, anche per il contributo, sia pure in una posizione oggi diversa da quella del passato, il senatore Scarpinato, perché dopo le importantissime esposizioni dell’avvocato Trizzino e di Lucia Borsellino, le corpose esposizioni, le vostre argomentazioni, anch’esse corpose e documentate, hanno contribuito molto e in maniera molto efficace, a mio giudizio, ad allargare il quadro e a non concentrarci soltanto sul tema, importantissimo, mafia e appalti. Hanno contribuito e stanno contribuendo a fornire alla Commissione un quadro molto rilevante di connessioni, di legami.
Credo che questo possa – dal punto di vista mio, naturalmente, non pretendo che sia l’opinione di tutti – riportare il nostro confronto e la nostra ricerca su binari di maggiore completezza del quadro. Se posso usare un’espressione semplificata e banale, rischiavamo di vedere l’albero e di non tenere conto della foresta.
Rivolgo un ringraziamento a tutti coloro che fin dalla prima nostra seduta, mi riferisco anche alla figlia di Borsellino e al suo avvocato, ma soprattutto a queste vostre esposizioni, hanno contribuito ad arricchire, e di molto, il quadro. Mi scuserà sia la presidente che lei, avvocato, se io colgo l’occasione della sua presenza e di quella di Salvatore Borsellino per dire queste cose, soprattutto nella concomitanza involontaria del fatto che, se non sbaglio, domani ci sarà un pronunciamento della Corte di cassazione per una sorta di cosiddetto «quarto giudizio» in relazione a un ricorso degli avvocati di Cattafi. Sbaglio? È confermato? Lo dico perché sia Salvatore Borsellino che l’avvocato Repici sono stati chiamati, Borsellino come familiare della vittima e l’avvocato per assistere.
Cattafi è stato condannato in terzo grado in Cassazione per gravissimi reati. Per capire le sue frequentazioni, le sue amicizie, e non soltanto quelle legate al procedimento in corso, si chiamavano Totò Riina, Bernardo Provenzano, Stefano Delle Chiaie, Licio Gelli, la crème de la crème delle connessioni tra mafia stragista, neofascismo, massonerie. Questo è il quadro.
Cattafi ha avuto una condanna definitiva per gravissimi reati. Adesso i suoi avvocati hanno fatto un ricorso straordinario in Cassazione, senza che peraltro, così risulta, ci siano fatti nuovi, gravi elementi, venuti tali da richiedere una revisione. Tuttavia, questo ricorso è stato ammesso e domani la Cassazione si pronuncerà.
I familiari, Salvatore Borsellino, Nunzia e Flora Agostino, sorelle del poliziotto Antonino, Paola Caccia, figlia del magistrato Bruno Caccia ucciso a Torino, Pasquale Campagna, fratello della diciassettenne Graziella, Roberta Gatani, nipote del magistrato Borsellino, Angela Gentile Manca, madre del medico Attilio Manca, Brizio Montinaro, fratello di Antonio, Stefano Mormile, fratello dell’educatore penitenziario Umberto, hanno rivolto un appello pubblico, un auspicio – naturalmente nessuno vuole condizionare nessuno – per fare in modo che questa già discutibile accettazione di questo ricorso non sia una «sentenza di quarto grado», come si dice, che non è previsto nel nostro ordinamento. Sarebbe uno schiaffo non solo ai familiari, ma a tutti noi. Colgo l’occasione della presenza del dottor Borsellino e della sua per chiederle che cosa vi aspettate alla vigilia di questa sentenza. Grazie.
FABIO REPICI, legale di Salvatore Borsellino. Grazie a lei, senatore, sia per l’attenzione al fatto oggetto della domanda sia per quanto aveva detto prima. Poiché lei ha citato la vicenda mafia e appalti, c’è un’ultima cosa che io mi permetto di aggiungere, sempre ringraziando la Commissione per avermi consentito per la prima volta di leggere i documenti che si trovavano nello studio di casa e nell’ufficio di Paolo Borsellino.
Paolo Borsellino aveva ricevuto, come processualmente accertato, copia del rapporto mafia e appalti del 16 febbraio 1991, una prima volta informalmente dall’allora capitano De Donno e una seconda volta l’aveva ricevuta formalmente dalla procura della Repubblica di Palermo, mentre egli era procuratore di Marsala. Poi era arrivato a Palermo. Segnalo, peraltro, che risulta che quel rapporto non era propriamente segreto, nel senso che la procura della Repubblica di Palermo si trovò nella necessità di trasmetterlo per competenza territoriale, per fatti non riguardanti la competenza dell’autorità giudiziaria di Palermo ad altre autorità giudiziaria. In alcuni casi, come ad esempio nel caso della procura della Repubblica di Reggio Calabria, la procura di Palermo ricevette richiesta dalla procura di Reggio Calabria di trasmissione di quel rapporto mafia e appalti di cui avevano, non ricordo come, credo da pubblicazioni giornalistiche, avuto contezza. Questo per dire che non era propriamente segreto il rapporto mafia e appalti. Ce l’avevano un bel po’ di procure della Repubblica. Dopodiché, purtroppo, il 19 luglio del 1992 c’è la strage in via D’Amelio. Quando ho letto gli atti delle acquisizioni fatte presso la casa e presso l’ufficio del dottor Paolo Borsellino, visto che si sostiene, secondo me in modo del tutto infondato, che Paolo Borsellino avesse particolarmente accesa attenzione a quel rapporto negli ultimi tempi della sua vita, davo per scontato che o a casa o nel suo ufficio una copia del rapporto mafia e appalti si sarebbe trovato. Però non c’era. Poiché sicuramente non c’era neanche nella borsa e quindi non fu sottratto insieme all’agenda rossa che invece fu sottratta, poiché sono in questo molto aristotelico e adesivo al principio di realtà, do per assodato che Paolo Borsellino, nelle ultime settimane di vita, il rapporto mafia e appalti non lo trattò. Punto. Lo dico per realtà documentale.
Dopodiché, c’è il cosiddetto «quarto grado di giudizio». Nel processo a carico di Rosario Pio Cattafi, esponente della famiglia mafiosa barcellonese, del quale peraltro avevo parlato, quindi non mi ripeto, in precedente occasione, mi sono costituito parte civile per conto di una associazione che si è costituita parte civile fin dalla udienza preliminare. Il giudizio poi fu definito con le forme del rito abbreviato. A un certo punto ho ricevuto la notifica della fissazione della udienza innanzi alla quinta Sezione penale della Corte di cassazione su un ricorso straordinario ex articolo 625-bis del codice di procedura penale. Naturalmente, con la notifica dell’avviso non mi era arrivato il ricorso straordinario e quindi non potevo sapere. Avevo letto la sentenza della Cassazione, ero parte di quel processo e non avevo mai rilevato errori di fatto.
Per intenderci, l’errore di fatto, che sarebbe rilevabile pure d’ufficio dalla stessa Corte in una sentenza della Corte di cassazione attiene a dati oggettivi di contrasto fra la decisione assunta e dati di realtà: l’errore nel calcolo del termine di prescrizione. Il calendario è un dato oggettivo. Se si scrive che un fatto è avvenuto il 16 febbraio, mentre in realtà è provato, perfino dal capo di imputazione, che quel fatto è accaduto il 16 gennaio, è ovvio che si può procedere alla correzione dell’errore di fatto. Oppure, se il calcolo di sette anni e mezzo per il decorso della prescrizione è fatto con errore aritmetico e i giudici ne contano otto e mezzo anziché sette e mezzo, è un errore di fatto e allora va bene.
Quando ho letto il ricorso straordinario del difensore di Cattafi, ho pensato che l’avviso che mi era stato notificato di fissazione dell’udienza fosse un refuso, un errore di fatto , perché il ricorso – che ho letto, naturalmente, e domani lo discuterò – tratta della attendibilità dei collaboratori di giustizia utilizzati come fonti di prova a carico di Rosario Cattafi. Il ricorso è fatto per capitoli e ogni capitolo ha il nome del collaboratore di giustizia che ha reso accuse nei confronti di Cattafi. È una cosa che io non avevo mai visto. Non solo non l’avevo mai vista, confido che mai più non solo io, ma nessun operatore processuale rivedrà. Eppure, nonostante questo, nonostante la norma del codice preveda che se il ricorso straordinario, cioè extra ordinem, la sentenza irrevocabile è un macigno, non si può pensare che lo Stato abbia tanta poca credibilità nel pronunciare un accertamento giudiziale definitivo da rendere facilmente possibile una non revisione per prove sopravvenute o per contrasto di giudicati o per qualunque altra ragione prevista dal codice di procedura penale, ma per errore di fatto. Se fosse così semplice l’abbattimento di una sentenza, la Corte di cassazione sarebbe più impegnata in processi per errore di fatto che in giudizi di cognizione.
Io non l’avevo mai vista una cosa del genere. Non so come si possa ritenere che le valutazioni di una Corte sull’attendibilità, anzi le valutazioni di legittimità della Corte sull’apparato motivazionale di una sentenza di merito che aveva ritenuto attendibili le fonti di prova nei confronti di Rosario Cattafi, possano essere oggetto di valutazione sotto il profilo dell’errore di fatto. È una cosa clamorosa. Siccome riguarda un personaggio, come lei riferiva… Io ho consegnato, fra i documenti che ho messo a disposizione della Commissione, una informativa del GICO di Firenze del 3 aprile 1996 che documenta in modo documentale i contatti che nel corso della sua carriera criminale Rosario Cattafi ha avuto. Si tratta di Ministri, Sottosegretari, parlamentari, magistrati, funzionari dei servizi segreti, funzionari di polizia, ufficiali dell’Arma dei carabinieri, burocrati di altissimo livello, dirigenti di imprese produttrici di armi, diplomatici. Allo stesso tempo, quel soggetto è il soggetto che, nel corso di una udienza del processo trattativa, Totò Riina, lasciando l’udienza nella quale si era parlato di Rosario Cattafi, in un commento che fu registrato in un’annotazione di servizio del personale di polizia penitenziaria, definì Cattafi «zio Saro».
«Zio Saro», chiunque conosce i processi di mafia sa che è un appellativo deferente da parte di un mafioso nei confronti di un mafioso superiore. Quello che aveva pronunciato quelle parole era Totò Riina. Naturalmente è facile comprendere qual è il mio auspicio rispetto a ciò che accadrà domani innanzi alla Corte di cassazione. Diversamente, penso che ci sarebbe da riflettere ulteriormente su come sia possibile che accadano certe cose.
Immagino che i dubbi sulla linearità della giurisdizione probabilmente saremmo indotti a corroborarli.
PRESIDENTE. Oggi ho letto, per rimanere in tema di Corte di cassazione, una sentenza che riteneva illegittimo il licenziamento da parte di un’azienda di una persona condannata in via definitiva per mafia. Me l’hanno mandata i consulenti, giusto per concludere la riflessione dell’avvocato. Prima di passare in seduta segreta vorrei rivolgere una domanda a Salvatore Borsellino che penso possa essere utile per il prosieguo dei lavori. Rispetto ai riferimenti che faceva l’avvocato alle testimonianze di Agnese e Manfredi Borsellino, se io non ricordo male, anche Salvatore Borsellino ha testimoniato, e nello specifico, l’ha fatto nel primo processo per la strage di via D’Amelio. In quella situazione, mi pare che abbia ricordato di una confidenza di suo fratello rispetto al suo futuro in magistratura. Ricordo male, Salvatore? Ce lo può raccontare?
SALVATORE BORSELLINO (intervento da remoto). Guardi, prima del Borsellino quater non ho mai testimoniato in nessun altro processo direttamente. Sono stato sentito, e soltanto una volta, a Caltanissetta, prima dei processi, non ricordo esattamente da quale pubblico ministero. Posso sbagliare, quindi non dico il nome. Però poi non ho mai testimoniato direttamente in un processo.
Per quanto riguarda l’impegno di mio fratello in magistratura, non ricordo a quale episodio, a quali parole si riferisce, perché quando mio fratello fece il concorso in magistratura io ero appena laureato e stavo facendo il servizio militare, quindi un periodo nel quale non potei neanche raccogliere le confidenze di mio fratello.
Sicuramente, però, il motivo per cui lui scelse di fare il magistrato lo scrive nell’ultima lettera che Paolo scrisse proprio la mattina del 19 luglio 1992. Paolo, rispondendo alla domanda di una ragazza presso la scuola della quale avrebbe dovuto avere un incontro, che poi era saltato per i suoi impegni di quei giorni, scrisse: «Io ho intrapreso la mia carriera in magistratura perché nutrivo una grandissima passione per gli studi di diritto », e di diritto giuridico civile, neanche di diritto penale. Poi il primo incarico che riguardò processi di mafia fu quello per l’assassinio del maresciallo – non ricordo il grado – Lombardo, capitano, credo, che era il suo collaboratore a Monreale e – dice: – «da quel momento capii che quelli erano i veri problemi del nostro Paese e su quelli dovevo particolarmente impegnarmi». Dice che avrebbe potuto scegliere anche di fare l’avvocato, ma ci sarebbe voluta un’altra famiglia alle spalle che gli avesse potuto assicurare all’inizio di poter portare avanti il suo studio, ma la nostra famiglia non era in condizioni economiche tali da permettersi questo. Avrebbe potuto fare, per coltivare la sua passione per il diritto civile, il professore universitario, ma ci volevano santi in paradiso e santi in paradiso Paolo non ne aveva e neppure li voleva.
PRESIDENTE. Grazie mille. Saluto il dottor Borsellino e lo ringrazio per la sua presenza. Sicuramente la Commissione continuerà a lavorare sotto tutti gli aspetti e per tutto quello che fin qui è emerso.
Propongo di passare in seduta segreta.
(Così rimane stabilito. I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).
COMMISSIONE ANTIMAFIA – Audizione Salvatore Borsellino e Fabio Repici
