«Voi, care Signore, siete nate e cresciute in contesti inquinati dalla criminalità mafiosa, e avete deciso di uscirne. Benedico questa vostra scelta, e vi incoraggio ad andare avanti. Immagino che ci siano momenti di paura, di smarrimento, è normale. In questi momenti pensate al Signore Gesù che cammina al vostro fianco.
Non siete sole, continuate a lottare.
L’intervento
Con Lui hanno fatto il cammino della liberazione.
E lo hanno fatto proprio camminando con Lui e con gli altri discepoli. È così: si diventa liberi non per magia, ma camminando con il Signore – questo ci dà libertà! –, condividendo i suoi passi, la sua strada, che passa necessariamente attraverso la croce e porta alla risurrezione.
Immagino che ci siano momenti di paura, di smarrimento, è normale. In questi momenti pensate al Signore Gesù che cammina al vostro fianco.
Non siete sole, continuate a lottare. Vi consiglio di tenere sempre con voi un piccolo Vangelo.
Ogni giorno leggetene un brano, con calma, e immaginate di essere con Lui, col Signore, in mezzo ai discepoli. E in realtà è proprio così: Lui cammina con noi ogni giorno nella strada della vita. La sua croce dà senso alle nostre croci e la sua risurrezione è fonte di speranza.
Poi vedremo come possiamo fare per farvi arrivare il Vangelo: lo invierò tramite don Ciotti, datemi il numero di quante siete e vi farà arrivare un Vangelo per ognuna di voi. Ma portatelo in tasca, nella borsa, sempre, e leggete ogni giorno un brano. Questa sarà una cosa bella, molto importante.
Quando la mafia attaccò la Chiesa, memoria di 30 anni fa
2.10.2923 La Commissione scomunica ai mafiosi invocata dal Papa in Calabria «bloccata da un Prefetto gesuita
22.9.2023 “La scomunica della cupola”: perché la mafia è anti-Chiesa
5 Maggio 1993 – La LETTERA di AGNESE BORSELLINO a GIOVANNI PAOLO II

Gli appelli al papa affinché la Chiesa, in particolare quella siciliana, assuma una posizione chiara contro la mafia e tronchi l’ intreccio di alcuni suoi rappresentanti con esponenti mafiosi, si moltiplicano provocando reazioni e polemiche proprio alla vigilia della visita di Giovanni Paolo II in Sicilia.
Dopo la lettera di Agnese Borsellino, vedova del giudice assassinato nella strage di via D’ Amelio – pubblicata l’ altro ieri dall’ Osservatore Romano, altre vedove, sacerdoti e intellettuali cattolici e laici impegnati, chiedono al pontefice di sollecitare i vescovi siciliani a fare chiarezza, anche al loro interno.
Ma il cardinale di Palermo, Salvatore Pappalardo ed altri vescovi siciliani hanno subito replicato sottolineando che la Chiesa dell’ isola non è stata a guardare, ricordando che nel ‘ 46, nel ‘ 54 e nel 1982, subito dopo l’ assassinio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, fu ribadita la scomunica contro i boss mafiosi. Tuttavia, l’ appello di Agnese Borsellino suscita consensi ed è condiviso dalla sorella del giudice Falcone, Maria e dalla vedova del procuratore Gaetano Costa, Rita Bartoli. “Nella Chiesa – afferma Maria Falcone – ci vorrebbero più fra’ Cristoforo e meno don Abbondio, non c’ è dubbio che la Chiesa debba combattere con più forza la mafia; naturalmente in tutte le organizzazioni e nelle strutture esistono i pavidi e i coraggiosi”. Maria Falcone ricorda poi che il vescovo di Monreale era il responsabile del “tanto discusso ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro, cui appartenevano il costruttore Arturo Cassina ed il questore Bruno Contrada“. Più duro il commento di Rita Bartoli Costa. “Agnese Borsellino ha ragione – dice la vedova Costa – la Chiesa siciliana nel suo complesso non si è mai schierata apertamente contro la mafia. Certo, singoli preti o vescovi lo hanno fatto, ma la maggioranza è stata assente, se non, in alcuni casi, addirittura connivente”.
La signora Costa ricorda che in alcuni paesi siciliani i preti o i vescovi “erano parenti di noti mafiosi”. “Mi pare che don Calogero Vizzini, uno dei boss di Cosa Nostra di tanti anni fa, avesse un parente monsignore. Poi ci sono anche il cardinale Pappalardo, l’ arcivescovo di Catania ed il vescovo di Agrigento, tutti prelati che nelle loro omelie condannano Cosa Nostra, ma il resto, cosa fa?”. La vedova Costa ricorda ancora che il predecessore di Pappalardo, il cardinale Ernesto Ruffini “sosteneva che la mafia non esisteva, anzi pensava che ‘ mafia’ fosse il nome di una marca di detersivo”.
La dichiarazione della signora Costa si conclude con la “delusione” provata nella visita che il papa fece in Sicilia nell’ 83. In quell’ occasione, dice, furono ignorati completamente tutti i famigliari delle vittime della mafia ed il papa non parlò mai di questo problema, spero che stavolta sarà diverso. Anche l’ appello che i sacerdoti, gli intellettuali cattolici ed i laici impegnati hanno inviato a Giovanni Paolo II è rivolto a sollecitare la Chiesa siciliana a troncare antiche collusioni ed intrecci tra rappresentati della Chiesa cattolica ed esponenti del potere mafioso, un intreccio, è detto nella lettera aperta, che sarebbe stato stabilito attraverso “l’ inquietante mediazione di politici, imprenditori, professionisti, banchieri, sindacalisti, giornalisti ed altri membri del ceto dirigente siciliano”. La lettera prosegue sottolineando che questo intreccio è “non solo vergognoso umanamente e deleterio per la credibilità della Chiesa cattolica, ma costituisce una barriera scandalosa per la stessa evangelizzazione del popolo siciliano”.
Al santo padre, quindi, si chiedono consegne e gesti precisi, una “spinta autorevole e decisiva verso una ridefinizione dell’ identità e della pratica ecclesiale in Sicilia attraverso criteri di rappresentanza nella vita interna ed esterna”.
Ma cosa risponde la Chiesa siciliana alle accuse di scarso impegno contro la mafia? Il cardinale Pappalardo replica con un certo distacco limitandosi a dire: “Mi aspetto dal santo padre una parola di incoraggiamento contro i mali endemici dell’ isola, fra i quali c’ è la mafia”, aggiungendo che tutti i vescovi della Sicilia, nell’ ultima conferenza episcopale, nel mese scorso, hanno ribadito “l’inappellabile condanna della mafia”.
Per il vescovo di Caltanissetta, monsignor Alfredo Garsia “non è giusto dire che la Chiesa non si è schierata a fondo in questa lotta. E addirittura si parla dell’ esistenza di vescovi mafiosi, ma scherziamo? – s’ infuria il presule – Temo che queste cose siano anche il frutto di montature giornalistiche”. Da Trapani giunge la risposta del vescovo Domenico Amoroso: “Non credo che ci siano né preti né vescovi mafiosi, almeno che io sappia, nella mia diocesi non c’ è proprio nessuno”. Infine, don Vincenzo Noto, portavoce della curia palermitana e direttore della rivista diocesana Notiziario di vita cattolica. “Ma come si fa a dire che la Chiesa non si è mai schierata contro la mafia? Si vede – dice padre Noto – che non hanno mai letto tutti i documenti della conferenza episcopale siciliana con documenti di condanna durissima verso la mafia”. LA REPUBBLICA 7.5.1993
Giovanni Paolo II rende pubblica la lettera Agnese Borsellino al Papa «Più coraggio anti-mafia»
Agnese Borsellino, la vedova del giudice assassinato a Palermo con cinque agenti della scorta il 19 luglio scorso, ha scritto al Papa. L’ha invitato a far schierare ancor più decisamente la Chiesa siciliana contro la mafia. Il messaggio è stato inviato a Giovanni Paolo n alla vigilia di una visita che il Papa farà nell’isola tra sabato e lunedì, partendo da Trapani a Mazara (la visita proseguirà ad Agrigento e si concluderà a Caltanissetta). Da procuratore della Repubblica di Marsala, Borsellino agì con grande determinazione contro le cosche, colpendole con inchieste e incriminazioni anche di personaggi in apparenza insospettabili come il parlamentare de Vincenzo Culicchia o l’ex sindaco de di Castelvetrano Tonino Vaccarino, ora guardato a vista a Pianosa. La lettera della signora Borsellino, cattolica come il marito, non è stata tenuta riservata in Vaticano. Il Pontefice – e questo è un segnale – ha ritenuto opportuno che fosse divulgata e martedì l’ha pubblicata l’Osservatore Romano, provocando stupore nella Curia siciliana, guidata dal cardinale Salvatore Pappalardo!
L’arcivescovo di Palermo, prossimo alla pensione, non è mai stato molto tenero né con i boss né con i politici corrotti. Ma talune sue prese di posizione, a volte, sono state variamente interpretate. Secondo alcuni osservatori, fra la celebre omelia in cui paragonò Palermo a Sagunto espugnata fra il disinteresse, la cecità e la sordità del potere centrale a Roma, pronunciata ai funerali di Dalla Chiesa, e quella nel marzo 1992 in cui diede atto all’eurodeputato Salvo Lima di essersi prodigato per Palermo, corre una profonda, sostanziale diversità. Ma cosa dice – e di fatto rimprovera alla Chiesa dell’isola – la vedova Borsellino? «La sua visita oggi è per noi, Santità, un motivo in più di speranza». E aggiunge: «Attendiamo l’indicazione di nuovi impegni perché questa nostra Chiesa sia più e meglio segno di speranza, specchio di giustizia, amore per chi soffre. Preghiamo il Signore perché la Chiesa siciliana proponga sempre coerentemente il messaggio cristiano nei suoi ideali di fondo e nelle persone che di tali ideali debbono essere pastori, guide e testimoni scomodi, disponibili anche a rischiare per non compromettere, con qualunque tipo di collusione, la genuinità dell’insegnamento di Cristo».
Nell’affermare che il sangue del marito in via D’Amelio fu versato «per la liberazione del popolo italiano» Agnese Borsellino, figlia dell’ex presidente del tribunale di Palermo Angelo Piraino Leto ha sottolineato che nei luoghi in cui il marito agì da magistrato diede anche testimonianza di cristiano. «Percorrerò con lei ha scritto ancora al Papa – da Trapani a Mazara, da Agrigento a Caltanissetta, le stesse vie, gli stessi problemi, le stesse ansie che mio marito ha vissuto in profondità e con cosciente rischio, ma oggi certo con qualche speranza in più anche per il sangue versato da Paolo». E alludendo ancora al prossimo viaggio del Pontefice Agnese Borsellino ha parlato di «profonda gioia ed emozione» per questo itinerario che ha definito «ideale di fede e di speranza». Nessun commento ieri né della signora né al palazzo arcivescovile. Il vescovo ausiliare, Salvatore Gristina, si è limitato a spiegare di non avere letto l’Osservatore Romano «cosa che farò al più presto». Anche monsignor Giuseppe Carcione, il più anziano dei vicari della Curia e collaboratore di Pappalardo, si è riservato di esprimere una valutazione appena presa visione della lettera. LA STAMPA 6.5.1993
“Il sapere che il sangue del mio Paolo oggi è seme di speranza e di liberazione per tutto questo nostro popolo mi riempie di gioia e di orgoglio, la sua visita è per noi oggi un motivo in più di speranza…. Preghiamo il Signore perché la Chiesa che è in Sicilia proponga sempre coerentemente il messaggio cristiano nei suoi ideali di fondo e nelle persone che di tali ideali debbono essere pastori, guide e testimoni scomodi” AGNESE PIRAINO BORSELLINO
9 maggio 1993 L’anatema contro i mafiosi di GIOVANNI PAOLO II ad Agrigento – video
CON WOJTYLA LA SVOLTA ANTIMAFIA DELLA CHIESA
Mai un papa – prima di Karol Wojtyla -, ricorda l’arcivescovo di Monreale, si era mai rivolto con tanta forza profetica contro la mafia. E tantomeno qualsiasi altro esponente delle gerarchie ecclesiali, ad eccezione di figure come il cardinale di Palermo Salvatore Pappalardo (che ebbe parole di fuoco il giorno dell’assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa) o sacerdoti del popolo come don Pino Puglisi, il parroco palermitano ucciso a 56 anni dalla mafia per il suo impegno a favore dei giovani il 15 settembre 1993, il giorno del suo compleanno. Con Wojtyla tutto cambia.
La svolta, la domenica del 9 maggio ’78 nella Valle dei Templi di Agrigento, durante la Messa celebrata dal pontefice nel suo secondo pellegrinaggio in Sicilia. Ma Wojtyla quel giorno sa che la Sicilia si aspetta da lui qualche “cosa” di più forte. Sa che la folla che lo ascolta ad ogni tappa nel fitto programma della visita, come pure le migliaia di persone che lo accolgono sulla spianata dei Templi, da anni stanno vivendo una interminabile Via Crucis fatta di vittime innocenti di attentati mafiosi, violenze, oppressioni, culminate pochi mesi prima con le stragi di Capaci e di Via D’Amelio del 23 maggio e del 19 luglio 1992 dove furono trucidati i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e le loro scorte. Giovanni Paolo II sente che, di fronte a tanto dolore e a tanti uomini e donne ammazzati mentre stavano compiendo il loro dovere deve parlare liberamente, senza fermarsi al testo preconfezionato dai suoi collaboratori.

TESTO integrale omelia
Al termine della Santa Messa, dopo la Benedizione finale, Giovanni Paolo II pronunciò queste parole a braccio (la trascrizione che segue è letterale, quindi con qualche imperfezione grammaticale):
Carissimi vi auguro, come ha detto il diacono, di andare in pace: di andare in pace di trovare la pace nella vostra terra. Carissimi, non si dimentica facilmente una tale celebrazione, in questa Valle, sullo sfondo dei templi: templi provenienti dal periodo greco che esprimono questa grande cultura e questa grande arte ed anche questa religiosità, i templi che sono testimoni oggi della nostra celebrazione eucaristica. E uno ha avuto nome di “Concordia”: ecco, sia questo nome emblematico, sia profetico. Che sia concordia in questa vostra terra! Concordia senza morti, senza assassinati, senza paure, senza minacce, senza vittime! Che sia concordia! Questa concordia, questa pace a cui aspira ogni popolo e ogni persona umana e ogni famiglia! Dopo tanti tempi di sofferenze avete finalmente un diritto a vivere nella pace. E questi che sono colpevoli di disturbare questa pace, questi che portano sulle loro coscienze tante vittime umane, devono capire, devono capire che non si permette uccidere innocenti! Dio ha detto una volta: “Non uccidere”: non può uomo, qualsiasi, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio!
Questo popolo, popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita! Nel nome di questo Cristo, crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via verità e vita, lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili: convertitevi! Una volta verrà il giudizio di Dio!

La doppia condanna di Benedetto XVI: “Mafia strada di morte”
Il 3 ottobre 2010 venne in visita pastorale a Palermo, il suo unico viaggio da pontefice in Sicilia. Parlò contro la mafia e incitò i giovani a non avere paura. Se il suo predecessore, Giovanni Paolo II, si era rivolto ai mafiosi intimando loro il “Convertitevi!” il 9 maggio del 1993, appena un anno dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, Benedetto XVI preferì parlare ai giovani indicando loro gli esempi da seguire: il “servo di Dio” Rosario Livatino e “l’eroico” Pino Puglisi, tra questi: “Conosco – disse ancora ai siciliani – le vostre difficolta’ nell’attuale contesto sociale, che sono le difficolta’ dei giovani e delle famiglie di oggi, in particolare nel sud d’Italia. E conosco anche l’impegno con cui voi cercate di reagire e di affrontare questi problemi, affiancati dai vostri sacerdoti, che sono per voi autentici padri e fratelli nella fede, come e’ stato Don Pino Puglisi. Ringrazio Dio di avervi incontrato, perché dove ci sono giovani e famiglie che scelgono la via del Vangelo, c’è speranza. E voi siete segno di speranza non solo per la Sicilia, ma per tutta l’Italia”.
Il successore di Wojtyla Benedetto XVI disse nell’incontro con i giovani siciliani: “Non abbiate paura di contrastare il male! Insieme, sarete come una foresta che cresce, forse silenziosa, ma capace di dare frutto, di portare vita e di rinnovare in modo profondo la vostra terra! Non cedete alle suggestioni della mafia, che è una strada di morte, incompatibile con il Vangelo”, furono le parole di Papa Ratzinger, che anche nel 2007 a Napoli aveva condannato la camorra, parola pronunciata più volte senza mezzi termini nel corso della sua visita. ”Non si tratta solo del deprecabile numero di delitti della camorra – disse Papa Ratzinger ai napoletani – ma anche del fatto che la violenza tende purtroppo a farsi mentalità diffusa, insinuandosi nelle pieghe del vivere sociale, nei quartieri storici del centro e delle periferie nuove e anonime, con il rischio di attrarre specialmente la gioventù”.
Papa Francesco : “I mafiosi sono scomunicati: hanno le mani sporche di soldi insanguinati”
Mafia, il PAPA ai giovani: abbiate il coraggio di contrastare l’illegalità e i soprusi
La mafia é un cancro invasivo … distrugge speranze e calpesta diritti !
Le prime vittime della criminalità organizzata sono gli ultimi, moderni schiavi su cui le economie mafiose si costruiscono. Le mafie vincono quando la paura si impadronisce della vita, ragion per cui si impadroniscono della mente e del cuore, spogliando dall’interno le persone della loro dignità e della loro libertà. Voi che siete qui, vi adoperate affinché la paura non possa vincere: siete quindi un sostegno al cambiamento, uno spiraglio di luce in mezzo alle tenebre, una testimonianza di libertà. Vi incoraggio a proseguire in tale cammino: siate forti e portate speranza, soprattutto tra i più deboli.
Se mancano sicurezza e legalità, le prime vittime sono i più fragili, gli ultimi: Tutti costoro sono i moderni schiavi su cui le economie mafiose si costruiscono; sono gli scarti di cui hanno bisogno per inquinare la vita sociale e lo stesso ambiente. Vi esorto quindi a farvi prossimo a tutte queste persone, vittime della prepotenza, cercando di prevenire e di contrastare il crimine.
“Opporre resistenza al colonialismo culturale mafioso, mediante la ricerca, lo studio e le attività formative”.
Anche, il pensiero mafioso entra come facendo una colonizzazione culturale, al punto che diventare mafioso è parte della cultura già, è come la strada che si deve fare. No! Questo non va. Questa è una strada di schiavitù. Il vostro lavoro è tanto grande per evitare questo: grazie!
“Progresso civile, sociale e ambientale scaturiscono non dalla corruzione e dal privilegio, ma dalla giustizia, dalla libertà, dall’onestà e dalla solidarietà”. PAPA FRANCESCO
- PAPA FRANCESCO: mafiosi e usurai pentitevi – video
- PAPA FRANCESCO: a Palermo omelia in occasione dell’anniversario dell’omicidio di Don Puglisi
PAPA FRANCESCO: «Chi crede in Dio non può essere mafioso»
La Messa al Foro Italico a 25 anni dalla morte di padre Puglisi: essere mafiosi è bestemmiare Dio con la vita. Il pranzo da Biagio Conte. La tappa nel rione Brancaccio, prima di incontrare i giovani – Nel 1993 Giovanni Paolo II lanciava da Agrigento il suo grido “scaturito dal cuore” ai mafiosi: «Convertitevi». Venticinque anni dopo, sempre dalla Sicilia, ma stavolta da Palermo papa Francesco riprende quelle parole. E scandisce: «Ai mafiosi dico: cambiate!». Francesco è il Papa della misericordia e quindi li chiama «fratelli e sorelle», vocaboli aggiunti a braccio. E fra gli applausi incalza gli affiliati: «Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo. Altrimenti la vostra vita andrà persa». Il suo monito risuona al Foro Italico, il lungomare di Palermo che accoglie più di 100mila pellegrini per la Messa che Francesco celebra nella seconda metà della mattina in occasione del 25° anniversario della morte di padre Pino Puglisi, il primo martire della mafia dichiarato beato dalla Chiesa. Perché proprio il 15 settembre 1993 il “sacerdote di strada” veniva ucciso nel suo quartiere d’origine, Brancaccio, il “fortino” di Cosa Nostra dove Puglisi aveva tradotto il Vangelo in promozione umana e riscatto sociale.
TESTO dell’OMELIA
La lezione di don Puglisi fa da spunto a papa Francesco per riaffermare con espressioni durissime la netta incompatibilità fra Vangelo e cosche, come aveva fatto anche Benedetto XVI nella sua visita a Palermo nell’ottobre 2010. «Non si può credere in Dio ed essere mafiosi», sottolinea Bergoglio ancora una volta applaudito dai pellegrini. E precisa: «Chi è mafioso non vive da cristiano perché bestemmia con la vita il nome di Dio». Da qui l’energico richiamo: «Oggi abbiamo bisogno di uomini di amore, non di uomini di onore; di servizio, non di sopraffazione». Un messaggio che è come un prolungamento di quella «scomunica» ai mafiosi lanciata da Francesco in Calabria, a Sibari, nel giugno 2014. A Palermo Bergoglio parla anche in siciliano. E si affida al vocabolo dialettale “piccioli” per condannare la ricerca forsennata di «soldi», «potere» e «piacere» attraverso cui «il diavolo ha le porte aperte», dice. Riferimento indiretto allo stile della malavita, insieme con l’invito a difendere «sempre la vita» e alla frase: «Non si può credere in Dio e odiare i fratelli». Con lo sguardo il Papa si ferma più volte sull’azzurro del mar Tirreno accanto a cui si trova l’altare. In un angolo la reliquia di padre Puglisi che definisce «povero fra i poveri della sua terra». Lui, sottolinea il Pontefice, non «viveva di appelli anti-mafia, ma seminava bene, tanto bene». Come a rimarcare: non bastano i discorsi per sconfiggere la mentalità criminale fondata sulla «logica del portafoglio», del «dio-denaro», sottolinea. Nella sua riflessione il Papa ricorda il «sorriso» di Puglisi che toccò il cuore anche di uno dei suoi sicari. «Abbiamo bisogno di tanti preti del sorriso, di cristiani del sorriso» perché, aggiunge il Pontefice, «credono nell’amore e vivono per servire». E a Palermo Bergoglio indica qual è l’«unico populismo cristiano»: «sentire e servire il popolo senza gridare, senza accusare e suscitare contese». Parole che possono essere lettere anche come una risposta implicita al caso Viganò che ha scosso la Chiesa. E rivolgendosi a ciascun cristiano esorta: «Non aspettare che la Chiesa faccia qualcosa per te, comincia tu. Non aspettare la società, inizia tu». Appello a vincere la rassegnazione che talvolta imprigiona il Mezzogiorno. Poco prima delle 11 il Pontefice atterra in elicottero a due passi dalle banchine del porto di Palermo dove negli anni sono arrivate decine di navi dei migranti salvati dalla Marina o dalle ong. E in papamobile Francesco attraversa tutto il Foro Italico. In 100mila riempiono l’area che qualcuno ribattezza scherzando il “Forno italico” per il sole a picco che c’è sopra il capoluogo siciliano. Si superano i trentacinque gradi dopo che ieri due violenti nubifragi potevano rischiare di rovinare la giornata palermitana del Papa. Pellegrini in piedi già quando l’elicottero “pontificio” sorvola la zona. Le transenne sono in gran parte decorate con le bandiere bianche e gialle del Vaticano. C’è chi ha passato la notte sul lungomare. E da tutta la regione i pellegrini sono arrivati per salutare Bergoglio. Ma c’è anche chi ha attraversato lo Stretto. Come un gruppo di Catanzaro-Squillace che issa uno striscione in cui il nome dell’arcidiocesi si affianca a quello di padre Pino Puglisi.
LENZUOLA BIANCHE SVENTOLANO AL QUARTIERE BRANCACCIO Nel primo pomeriggio la tappa nel quartiere di Brancaccio, alla periferia di Palermo. È il rione di padre Puglisi dove è nato, ha vissuto, è stato parroco ed è stato ucciso dalla mafia. Prima Francesco si ferma nella chiesa di San Gaetano, la parrocchia guidata da don Pino per tre anni, fino a quando non è stato assassinato. Poi l’arrivo nella piazzetta Anita Garibaldi che da due giorni si chiama anche “Piazza Beato Puglisi”. Dalle terrazze delle case scendono molte lenzuola bianche. Alle finestre dei condomini alveari che sono il simbolo di Brancaccio sono tutti affacciati. Una ragazza disabile dona il mazzo di rose che Francesco depone sul medaglione che ricorda il punto esatto in cui padre Puglisi è stato ucciso e il suo corpo trovato fra le auto parcheggiate. In silenzio si ferma in preghiera. E con l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, entra nel condominio dove abitava la famiglia Puglisi, al primo piano della palazzina al civico 5. Un appartamento povero, di quattro stanze, che oggi ospita la casa-museo “Beato Pino Puglisi” e che il Papa visita in forma privata. All’uscita Bergoglio saluta i fratelli di don Pino, Gaetano e Francesco, i nipoti del beato, il presidente del Centro Padre Nostro, Maurizio Artale, il presidio sociale fondato da padre Puglisi a Brancaccio per il riscatto della borgata. E poi i saluti ai volontari del Centro e ai residenti delle case limitrofe.
IL DIALOGO CON I GIOVANI: NON ABBIATE PAURA DI DENUNCIARE «Un cristiano che non è solidale non è cristiano». Nel dialogo con i giovani in piazza Politeama a Palermo papa Francesco risponde a una domanda sull’accoglienza. E spiega che la «vocazione» di un credente è quella «di favorire l’incontro mentre il mondo di oggi è un mondo di scontro». Denuncia una «carenza di amore». E ricorda che l’accoglienza è «amore e gioia» e ha bisogno di chi «si sporca le mani». Bergoglio parla in gran parte a braccio dopo i tre quesiti che i ragazzi gli pongono. In mano ha una penna e qualche foglio su cui prende appunti. Davanti ci sono 5mila giovani giunti da tutta la Sicilia. «Abbiamo necessità di uomini e donne vere che denunciano il malaffare e lo sfruttamento», sprona. E con forza rimarca: «Non abbiate paura di denunciare». Parole che si uniscono a quelle dell’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che nel saluto iniziale incoraggia i ragazzi ad «alzarsi in piedi» e a «strappare» l’isola «dalle mani dei poteri occulti, delle lobby mafiose, delle clientele invadenti, dei politici e degli ecclesiastici infedeli».
Scherza molto il Papa. «Avete il numero di telefono per parlare con il Signore?», chiede. E ammonisce: «Il Signore non si ascolta se si sta seduti in poltrona». Serve essere «in cammino», «in ricerca». «Cercalo nella preghiera, nella relazione, nella comunità», incita. E dice “no” a giovani «pancioni comodi». «Meglio essere don Chisciotte che Sancho Panza», osserva. Da qui l’invito ad «avere grandi sogni in cui trovi tante parole del Signore». Francesco non vuole neppure ragazzi paralizzati dalla «rassegnazione». «Siate costruttori di futuro», esorta. Ma senza essere «gassosi», fra le nuvole, e senza essere «sradicati», ossia privi di radici «nei valori della tua famiglia e del tuo popolo». E, afferma il Papa, le radici «si incontrano nell’ascolto dei vecchi» che aiutano a creare l’«appartenenza» e l’«identità». «Prendi da loro la forza», sottolinea. E alla fine confida: «Scusatemi se sono stato sempre seduto. Ma le caviglie mi fanno tanto male». Più che comprensibile dopo una giornata siciliana davvero intensa.
Sulla strada verso l’aeroporto c’è stato un ultimo fuori programma: papa Francesco ha reso omaggio al giudice Giovanni Falcone alla moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti di scorta uccisi nella strage di Capaci, fermandosi alcuni istanti in raccoglimento davanti alla stele che lungo l’autostrada Palermo-Trapani ricorda l’eccidio del 23 maggio 1992. Il Papa è poi risalito in auto proseguendo il viaggio verso l’aeroporto Falcone e Borsellino da cui successivamente è decollato alla volta di Roma. AVVENIRE Giacomo Gambassi, a Palermo sabato 15 settembre 2018
I Papi contro le mafie, nel segno del Vangelo
25 anni fa il grido contro la mafia di san Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi ad Agrigento. Da Papa Wojtyla a Francesco, passando per Benedetto XVI la continuità del magistero degli ultimi Pontefici nelle dure prese di posizione contro i mafiosi La più antica e grande forma di antimafia è forse il Vangelo, le parole di Cristo che condannano senza mezzi termini quanti attentano la dignità e la vita umana. Una condanna che la Chiesa ha ribadito soprattutto negli ultimi anni, e in particolare con gli ultimi Papi. Da Giovanni Paolo II ad Agrigento il 9 maggio del 1993 – a circa un anno dagli attentati a Falcone e Borsellino – fino a Francesco in Calabria nel 2014. Ma anche Benedetto XVI, nel suo viaggio a Palermo il 3 ottobre 2010, si scagliò contro “le suggestioni della mafia, che è una strada di morte, incompatibile con il Vangelo”.
L’anniversario Proprio oggi, 9 maggio, si ricordano i 25 anni esatti della visita di Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi quando, al termine dell’omelia, lanciò un duro anatema contro la criminalità organizzata e i mafiosi. Da giorni ad Agrigento si tengono celebrazioni per ricordare la visita pastorale del Pontefice e oggi alle 18, davanti al Tempio della Concordia, ci sarà una solenne celebrazione presieduta da tutti i vescovi della Sicilia, che lanceranno per l’occasione un messaggio, ricordando l’invito alla conversione rivolto da Giovanni Paolo II
Benedetto XVI a Palermo Più volte, nel corso degli anni, i Papi si sono espressi contro la mafia e hanno condannato gli atteggiamenti criminali. In particolare a Palermo, in piazza Politeama, il 3 ottobre 2010, Benedetto XVI durante il suo incontro con i giovani siciliani si espresse così: “Non abbiate paura di contrastare il male! Insieme, sarete come una foresta che cresce, forse silenziosa, ma capace di dare frutto, di portare vita e di rinnovare in modo profondo la vostra terra! Non cedete alle suggestioni della mafia, che è una strada di morte, incompatibile con il Vangelo”.
La scomunica di Francesco La criminalità organizzata, negli anni, è arrivata addirittura ad impossessarsi di simboli o figure religiose, con rituali e forme di devozione che hanno storpiato e strumentalizzato la religiose stessa. Per i loro atteggiamenti, infatti, i loro crimini e la vita votata al male, i mafiosi “non sono in comunione con Dio”, come ha affermato Papa Francesco nella sua omelia nella Piana di Sibari, a Cosenza, in occasione della sua visita pastorale in Calabria del 21 giugno 2014. In quell’occasione il Pontefice arrivò a scomunicare – fu il primo Papa a farlo – i mafiosi che “nella loro vita seguono questa strada di male”. VATICAN NEWS 9.5.2018
Una lunga serie di firme, tra le quali spiccano quelle di sacerdoti, di molti fedeli e di Fiammetta Borsellino, figlia del giudice ucciso dalla mafia.
Dietro monsignor Cassisa ci sono molte ombre, sospetti di «collusioni»; presunti illeciti nei restauri del Duomo. Un mese fa, poi, il segretario particolare del monsignore, il giovane don Mario Campisi, è stato raggiunto da un avviso di garanzia per aver favorito mafiosi, in particolare il superlatitante Leoluca Bagarella, che avrebbe utilizzato per qualche tempo il telefonino cellulare del sacerdote. Dall’arcivescovo, 62 anni, non molto gradito dai prelati della vicina e certo più importante curia di Palermo, descritto come «grande amico» di Giulio Andreotti che al tempo del suo «splendore» dispensò favori e contributi al cugino di Cassisa, il fisico Antonino Zichichi, fondatore del centro «Majorana» di Erice, ieri non è venuta alcuna reazione. Già un mese e mezzo fa l’arcivescovo è finito sui giornali per l’aspra contestazione dell’ex presidente del tribunale ecclesiastico siciliano monsignor Giuseppe Governanti, che al Papa e a vari alti gradi della nomenklatura vaticana s’era rivolto sin da un paio di anni fa, chiedendo «trasparen¬ za e chiarezza» sulla già allora chiacchierata permanenza di monsignor Cassisa alla guida dell’arcidiocesi monrealese. Una curia che per storia e censo è tra le più ambite del Mezzogiorno. In special modo, oltre alle ombre sugli appalti per la sistemazione del Duomo, Cassisa è stato ripetutamente criticato perché è uno dei massimi responsabili dell’Ordine dei cavalieri del Santo Sepolcro, un retaggio delle crociate che in realtà sarebbe qualcosa di molto simile a una lobby. I sacerdoti e i circa cinquanta fedeli che hanno scritto al Pontefice non hanno chiesto in via definitiva la testa di Cassisa, ma la sua sospensione «fino a quando non verranno chiarite le vicende che lo coinvolgono e che sono oggetto di inchieste giudiziarie». «Senza volerci erigere a giudici sommari – prosegue – riteniamo auspicabile che l’arcivescovo pubblicamente e secondo la coerenza evangelica renda conto della sua totale estraneità ai contenuti delle accuse e sospenda, almeno temporaneamente, l’esercizio del suo ministero». Nella lettera non è stato tralasciato un accenno all’inchiesta per il dubbio di infiltrazioni mafiose nelle stanze dei bottoni del palazzo arcivescovile. Nella splendida chiesa barocca di San Saverio, nel popolare e cadente rione dell’Albergheria, la lettera è stata sottoscritta da preti e fedeli dopo una messa celebrata dal parroco Cosimo Scordato, che da anni svolge un’intensa azione di apostolato fra i deboli e gli emarginati dei tuguri. Tra i volontari di don Scordato è Fiammetta Borsellino, 21 anni, iscritta a Giurisprudenza, la figlia minore del giudice ucciso dalla mafia nella strage di via D’Amelio con cinque dei sei poliziotti della scorta. Augusto Cavadi, coordinatore della scuola di formazione etico-politica «Giovanni Falcone», ha sottoscritto la lettera con Fiammetta e gli altri. Dice che Cassisa deve andarsene «per una questione di trasparenza umana ed evangelica» e ancora sostiene: «Dobbiamo metterci in testa che l’essere cristiani non solo non ci esonera dalle regole della convivenza civile, ma ci impegna a rispettarle semmai con maggiore puntualità». 11.1.1994 LA STAMPA
Chi é
La Mafia e la Chiesa, il Kalashnikov e il vangelo. Contiguità, omertà ed altro ancora. L’ambigua vicinanza che in numerose e provate circostanze ha segnato la storia dei rapporti tra la CHIESA e la MAFIA e tra i mafiosi e la religione, ha sicuramente segnato una svolta principalmente dopo i due storici interventi di papa Giovanni Paolo II e papa Francesco:
- in Sicilia a Agrigento, discorso pronunciato a braccio da papa Wojtyla ad Agrigento il 9 maggio 1993, dopo la Benedizione finale al termine della S. Messa celebrata nella Valle dei Templi.
- In Calabria a Cassano all’Jonio, il 21 giugno 2014: «I mafiosi sono scomunicati», aveva scandito papa Bergoglio nella spianata di Sibari.
e quello di Benedetto XVI : é il 3 ottobre 2010 quando Papa Benedetto XVI, nel corso della sua visita a Palermo, esorta i giovani siciliani: «Non abbiate paura di contrastare il male! Insieme, sarete come una foresta che cresce, forse silenziosa, ma capace di dare frutto, di portare vita e di rinnovare in modo profondo la vostra terra! Non cedete alle suggestioni della mafia, che è una strada di morte, incompatibile con il Vangelo».
Un primo cambio di rotta a Palermo lo impresse il cardinale Salvatore Pappalardo nel 1982, quando in occasione dei funerali del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa pronunciò il suo memorabile atto d’accusa nei confronti dello stato italiano, citando Tito Livio: “Dum Romae consulitur Saguntum expugnatur”. E Sagunto sta per Palermo, distante dal centro del potere romano, dove si parla é non si agisce.
Dopo aver fatto irruzione nel covo del boss Pietro Aglieri – importante esponente di Cosa Nostra, nonché uno dei mandanti per le stragi di Capaci e di via D’Amelio – le forze dell’ordine trovarono una piccola cappella privata: sei panche, un altarino con un grande crocifisso ligneo e due statue in gesso di Cristo e della Madonna.
Chiesa e Mafia: riflessioni di un rapporto antico, complesso e contraddittorio. La fine di una ambiguità?
Le Mafie e la Chiesa: analisi criminologica di un rapporto controverso
La LA CHIESA DI FRONTE ALLA MAFIA 1945-2000
17.3.2023 Il controverso rapporto tra mafia e Chiesa in un documentario su History Channel
L’opera scritta e diretta dalla regista francese Anne Veron, racconta come nel Sud Italia, dove la criminalità organizzata prospera da oltre 150 anni, solamente negli anni ’90 la Diocesi ha finalmente riconosciuto l’esistenza di Cosa nostra, condannandone le azioni
History Now, la programmazione che History Channel dedica alla storia contemporanea, celebra la giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie con un documentario che racconta un rapporto controverso, quello tra la Chiesa cattolica e le associazioni mafiose; “Mafia e Chiesa. Un passato insidioso”, in onda il 21 marzo alle 21 su History Channel (411 di Sky), scritto e diretto dalla regista francese Anne Veron, racconta come nel Sud Italia, dove le mafie prosperano da oltre 150 anni, solamente negli anni ’90 la Chiesa ha finalmente riconosciuto l’esistenza della criminalità organizzata e condannato le organizzazioni malavitose. ‘Un lungo silenzio che inevitabilmente ha contribuito a ritardare il momento in cui la società civile ha preso le distanze dal fenomeno mafioso”, sottolinea la regista Anne Veron, mentre, come testimonia il colaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, i mafiosi sono cattolici praticanti, e non considerano i loro crimini in contrasto con la fede; per questo finanziano le parrocchie e le feste religiose, e vanno a messa ogni domenica. I giornalisti Saverio Lodato e Felice Cavallaro, il magistrato Roberto Scarpinato, la sociologa Alessandra Dino, la fotografa e attivista Letizia Battaglia, morta l’anno scorso, padre Cosimo Scordato, monsignor Pennisi e molti altri ricostruiscono questa storia di vicinanza tra mafia e Chiesa, anni di sangue che in particolare a Palermo vedono cadere decine di servitori dello Stato senza che la Chiesa faccia quasi sentire la sua voce. Tanti i fatti ricordati nel racconto: la prima strage mafiosa, quella di Ciaculli nel giugno 1963, dopo la quale il cardinale di Palermo Ernesto Ruffini nega l’esistenza della mafia, invenzione dei giornali e dei partiti di sinistra; l’indifferenza della Chiesa che lascia passare senza un commento la morte di Gaetano Costa, Cesare Terranova e Piersanti Mattarella; il cardinale Pappalardo che, celebrando i funerali del prefetto Dalla Chiesa chiede che lo Stato si manifesti nella “povera Palermo”, abbandonata nelle mani mafiose. Ma è solo nel ‘93, a un anno dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che Papa Wojtyla condanna i mafiosi durante un discorso tenuto nella Valle dei Templi. La risposta della mafia è rapida: dopo solo due mesi, colpisce Milano, Firenze e Roma e nella Capitale sono proprio due chiese l’obiettivo delle bombe stragiste. Alessandra Dino sottolinea che ”oggi le più alte sfere della Chiesa hanno preso posizione in modo netto contro la mafia, ma sono ancora i parroci a dover dare una risposta chiara e univoca sul territorio”; a Palermo infatti, negli stessi anni hanno predicato padre Puglisi, morto ammazzato nel ’93 per aver dato speranza ai ragazzini senza futuro del quartiere Brancaccio, e padre Mario Frittitta, che alla Kalsa dispensava privatamente la messa al boss Pietro Aglieri, latitante ”che pregava sette ore al giorno”. PALERMO TODAY
Mafia: in uscita il film “Mafia e Religione” con gli interventi di mons. Raspanti, del Procuratore Gratteri, del card. Montenegro
È in uscita in questi giorni, su scala nazionale, “Mafia e Religione”, il film scritto e ideato da Francesco Millonzi e dal già Gip del Tribunale di Catania, Nunzio Sarpietro, che racconta “l’uso blasfemo che le mafie fanno delle religioni, come il rito di iniziazione, l’inginocchiamento del santo davanti casa dei boss, il bacio in bocca e analizza in modo dettagliato, con testimonianze dirette, il perché la criminalità organizzata usa fare questi riti. Tutto questo attraverso testimonianze e video esclusivi”. Il film è suddiviso in due puntate, ciascuna di 1 h e 10 minuti, e contiene, tra gli altri, gli interventi significativi di mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della CESi, la Conferenza episcopale dei vescovi di Sicilia, del card. Francesco Montenegro, del Procuratore Capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, del Presidente del Tribunale di Palermo Antonio Balsamo, del Gip del Tribunale di Caltanissetta, Graziella Luparello, del Vice Questore di Licata, Cesare Castelli, del giornalista Leone Zingales. Nel film pure le testimonianze dei familiari vittime di mafia: Michele Costa, figlio del giudice Gaetano Costa, Giovanni Impastato, fratello di Peppino, i fratelli del beato Pino Puglisi, Gaetano e Francesco, Carmine Mancuso, figlio del Maresciallo Lenin Mancuso, Lucia Ievolella, figlio del Maresciallo Vito Ievolella, il presidente di Giustizia e Pace, Ugo Tomaselli ed altri. “Ognuno di noi ha il dovere di non lasciare soli quelle persone che ancora oggi hanno il coraggio di schiacciare con forza e determinazione il crimine organizzato, che si insinua ovunque calpestando persino la sacralità della religione, facendo del male alla società”. Il film analizza anche, afferma il regista, “l’uso blasfemo che le mafie, non solo quelle italiane, ma anche quelle internazionali (nigeriana ad esempio) fanno delle religioni, lanciando sin da subito un messaggio immediato: la religione non può essere mafia e la mafia non può farne uso per strumentalizzare la Chiesa, perché la Chiesa non è mafia. La Chiesa è amore, aiuto ai poveri come ci insegna Papa Francesco. La Chiesa è quella di don Pino Puglisi che ha lottato sacrificando la propria vita per aiutare il prossimo ad essere libera, per aiutare i poveri, i diseredati. La mafia non crea nulla, ma distrugge. È impensabile che i mafiosi possano invocare un santo in un rito prima di uccidere, non si può pregare prima di uccidere. Questo è un modo contorto e assolutamente da condannare”. (D.R.) 27 Settembre 2022 AGENSIR
ROSARIO LIVATINO, da magistrato a Beato – Storia del “giudice ragazzino” ucciso dalla mafia
IL MESSAGGIO
Mafia, la Diocesi Palermo: sostegno agli imprenditori coraggiosi che si ribellano al pizzo La Diocesi di Palermo vicina agli imprenditori coraggiosi che si ribellano al racket del pizzo. “Incoraggiati” dalle parole dell’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, pronunciate nel discorso alla città di Palermo, dove implora l’aiuto di Santa Rosalia a svegliarci “prima che sia troppo tardi, di fronte alla crisi della pandemia che ha creato i presupposti per un nuovo fiorire dell’economia mafiosa e dell’imprenditoria criminale, che sguazza nel degrado e nel bisogno”, gli uffici della diocesi esprimono “piena vicinanza e profondo sostegno” al “coraggioso imprenditore Giuseppe Piraino e a tutti gli imprenditori palermitani che si sono ribellati al racket del pizzo, denunciando gli estorsori”. Di fronte a questa “realtà di male organizzato e strutturato bisogna uscire dai nostri recinti di sicurezza effimera ed impegnarci, insieme, in un rinnovato processo di liberazione, alla maniera di padre Pino Puglisi” A firmare il documento gli uffici dell’Arcidiocesi di Palermo: Pastorale Sociale e del Lavoro, Caritas Diocesana, Pastorale Giovanile, ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, ufficio Beni Culturali, ufficio per gli Insegnanti di Religione Cattolica, Pastorale della Scuola, Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport, Pastorale della Famiglia, Centro Diocesano Vocazioni e ufficio Missionario.
- CHIESA NOSTRA – Docfilm
- CHIESA E MAFIA – Docfilm
- LA CONDANNA DEL CARDINALE PAPPALARDO
- DON LUIGI CIOTTI, con Papa Francesco più vigore antimafia dentro la Chiesa
- DON LUIGI MEROLA,UN PRETE CONTRO LA CAMORRA
- PENNISI , “LA CHIESA NON SI LASCI STRUMENTALIZZARE DAI MAFIOSI”
- CARDINALE BAGNASCO: “Chiesa con i preti antimafia”
- VESCOVI SICILIANI:“MAFIOSI SIETE SCOMUNICATI”
- VESCOVI SICILIANI: “convertitevi”
- VESCOVI CALABRESI:«FORMARE I PRETI SUL RISCHIO MAFIA-MASSONERIA»
- CHIESA E MAFIA, I VESCOVI CALABRESI: MAI SILENZI
- GIOVANNI FERRO – MONS. MOROSINI (REGGIO CALABRIA), “LOTTA ALLA MAFIA FU RILEVANTE NELLA SUA AZIONE PASTORALE”
- VESCOVI CALABRIA: «LA ‘NDRANGHETA È STRUTTURA DI PECCATO»
- VESCOVI CALABRESICONTRO LA ‘NDRANGHETA: “E’ L’ANTI-VANGELO”
- SPARI CONTRO L’AUTO DI DON ANTONIO COLUCCIA, IL PRETE DEGLI ULTIMI NEMICO DELLA MAFIA
- ERNESTO RUFFINI,UN CARDINALE DEI SUOI TEMPI
- GIUSEPPE PIGNATONE: Il sacrificio di Don Puglisi ha cambiato la Sicilia
- GIUSEPPE PIGNATONE: “I PADRINI VOGLIONO USARE LA RELIGIONE COME STRUMENTO DI POTERE”
- GIUSEPPE PIGNATONE: “RELIGIOSITA’ TRA FEDE E SUPERSTIZIONE”
- STUDI SU MAFIA E CHIESA
- IL VANGELO E LA LUPARA
- CIANCIMINO IN VATICANO
- IL DIO DEI MAFIOSI
- LA PUNCIUTA CON IL SANTINO
- DON PUGLISI E LA MAFIA
- DECIFRIAMO LA BIBBIA DI PROVENZANO
- PROCESSIONE CON INCHINO
- CAMORRISTA CON CRISTO SUL TETTO
- LA CHIESA SIA UNA SPINA NEL FIANCO DELLA MAFIA
- LA CHIESA DI FRONTE ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
- DIRITTO CANONICO E RELIGIOSITÀ POPOLARE: STRUMENTI DI CONTRASTO ALLE MAFIEGIU’ LE MANI DAL VANGELO
- SE IL RETTORE DEL SANTUARIO DELLA ‘NDRANGHETA È INDAGATO PER MAFIA
- PLATÌ, SACERDOTE CELEBRA FUNERALE DEL MAFIOSO NONOSTANTE DIVITEO QUESTURA
- LE RAGIONI DEL PATTO TRA MAFIA E CHIESA
- DIECI PROPOSTE PER UNA CHIESA VIVA NEL CONTRASTO ALLE MAFIE
- NOI CONTRO LE MAFIE
- ARCIVESCOVO DI MONREALE EMETTE DECRETO CHE VIETA PADRINI MAFIOSI PER BATTESIMI E CRESIME
- IN PUGLIA UNA MESSA IN SUFFRAGIO PER BOSS UCCISO IN CANADA
- BOMBE, TRATTATIVE E L’UCCISIONE DI DON PINO PUGLISI
- DON AGOSTINO COPPOLA, L’AMICO DEI CORLEONESI
- FRA GIACINTO, TUTTO PISTOLA E FRUSTINO
- FRA GIACINTO, POTERE E GLORIA
- SOTTO LE DUE CUPOLE. CHIESA, RELIGIONE, MAFIA – VIDEO DIBATTITO
- MAFIA E RELIGIONE – VIDEO LEZIONI DI MAFIA
- LA CHIESA DI FRONTE ALLA MAFIA: 1945-2000
- ‘NDRANGHETA E CHIESA
- NDRANGHETA, PAPA FRANCESCO NELL’INFERNO DEI BOSS DOVE FU UCCISO IL PICCOLO COCÒ
- PROCESSO JONNY, DON SCORDIO CONDANNATO A 14 ANNI DI CARCERE
- LA MADONNA FA L’INCHINO ALLA CASA DEL BOSS
- DOPPIO INCHINO AL BOSS: STOP ALLA PROCESSIONE – VIDEO
- LA PROCESSIONE S’INCHINA AL BOSS – VIDEO
- INCHINO DAVANTI AL FRATELLO DEL BOSS – VIDEO
- L’ARCIPRETE CI RICASCA, ALTRO INCHINO DAVANTI ALLA CASA DEL BOSS
- PROCESSIONI CON INCHINO: PRATICHE MAFIOSE CHE LEDONO L’IMMAGINE DELL’ITALIA
- A CORLEONE L’ INCHINO DELLA PROCESSIONE ALLA MOGLIE DI RIINA
- BASTA INCHINI DAVANTI LE CASE DEI BOSS
- PAPA FRANCESCO CHIUDE L’ERA DEI BOSS IN PROCESSIONE
- Uscire dalle mafie. Una sfida possibile dove tutti devono convertirsi, anche la Chiesa.
- QUELLA SANTA CHIESA DI NOME COSA NOSTRA Intervista ad Augusto Cavadi, autore de «Il Vangelo e la lupara». Il complesso intreccio fra l’associazione criminale e l’istituzione ecclesiastica in un volume edito in Sicilia
- La Chiesa tra silenzio e scomunica, difficile rapporto coi mafiosi
- La mafia è un peccato strutturale, siamo tutti responsabili
- Stato e Chiesa uniti per liberare la fede dalle mafie
Festa di Polsi, ZUPPI: «purificare la Chiesa dalle contaminazioni con la mafia»
Arcivescovo Palermo: la Chiesa sia libera da condizionamenti mafiosi

“La mafia è una forma di potere e si sforza sempre di avere altri alleati. La questione del rapporto tra mafia e Chiesa rimanda all’identità che le Chiese vogliono avere”: così l’arcivescovo di Palermo, don Corrado Lorefice intervenendo alla conferenza l’antimafia della Chiesa, promossa dal Centro Pio La Torre. Da come le Chiese “si relazionano con le mafie si vede che tipo di fede hanno in Gesù Cristo che predica l’abbassamento e non il potere. Più la Chiesa si rispecchia nella figura di Gesù, più può fare rifulgere lo stile di Gesù che non è quello del potere”. Bisogna, ha continuato mons. Lorefice, “essere liberi dal condizionamento di ogni potere – a maggior ragione da quelli subdoli che vogliono limitare la libertà e ogni forma di espressione”. 25 marzo 2019
Festino della speranza, i 200 mila al corteo e l’invettiva antimafia dell’arcivescovo
CORRADO LOREFICE ARCIVESCOVO PALERMO:il mafioso non è ne può essere uomo di fede
L’ARCIVESCOVO DI PALERMO LOREFICE: “UNA CHIESA NEUTRA È ANCHE PEGGIO DI UNA CHIESA MAFIOSA”
Il pastore della diocesi siciliana ha scritto “Siate figli liberi. Alla maniera di Pino Puglisi”, sull’eredità del sacerdote ucciso 25 anni fa da Cosa nostra. “Don Pino Puglisi e la sua testimonianza non sono alle nostre spalle, ma davanti a noi. Capita che una volta arrivati agli onori degli altari, si sia posti in una nicchia e sia tutto finito lì. Ma non è il caso di un uomo come don Pino, perché il sangue dei martiri è germe di una testimonianza evangelica capace di affrontare l’oggi. E don Puglisi ci rimanda a una chiesa che pende dalle labbra del Signore. Una chiesa discepola, che ripercorre vie, strade, profumi, ma anche gli olezzi della storia dell’uomo e non cerca esenzioni dai poteri costituiti. La chiesa di Papa Francesco”. Le parole sono di chi lo ha conosciuto bene il beato don Pino e ci ha lavorato assieme: monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, che a 25 anni dalla morte per mano di mafia del sacerdote siciliano, ha voluto dedicare un libro (Siate figli liberi! Alla maniera di Pino Puglisi, appena uscito per le Edizioni San Paolo) alla preziosa eredità che questo martire ha lasciato alla chiesa.
Una testimonianza limpida che non parla solo alla terra siciliana. E’ così? “Sì, don Pino è un sacerdote che ha da dire molto alla chiesa in Italia, e non solo. Siamo negli anni ’90, quando il sacerdote è parroco nel quartiere palermitano di Brancaccio proprio dove risiede il clan dei fratelli Graviano, lì dove sta la base di Cosa Nostra. E pensa in termini evangelici una presenza della comunità cristiana che annunci non il… padrino nostro, bensì il Padre Nostro, chiamando proprio così anche il centro aperto in città. E dice: “Siate figli liberi, non di Cosa Nostra, assumendosene paternità e maternità”.
Ma che significa fare memoria del martire a 25 anni dalla sua uccisione? “Partirei dalla scelta fatta dal Papa Francesco che ha scelto di venire in Sicilia il 15 settembre 2018, una data non qualunque: 25 anni dopo la morte del sacerdote, avvenuta proprio quel giorno. Il Papa nei suoi viaggi in Italia non si muove mai a caso, ma sembra tracciare una specie di filo rosso della testimonianza della chiesa italiana che parte da Nord e scende a Sud. E’ partito infatti da Bozzolo, paese lombardo di don Primo Mazzolari, per scendere come pellegrino a Barbiana, dove operò don Lorenzo Milani; per poi passare in Puglia, patria di don tonino Bello. Infine è stata la volta della Sicilia e di Palermo, per incontrare don Pino”.
Tutti preti scomodi… “Sì, preti di avamposto. Che hanno dato testimonianza di profezia, insita nel Vangelo, e che quindi ha bisogno di essere capita e accolta. Come sempre la profezia destabilizza un certo ordine, ma lo fa per riconsegnare la storia a Dio e al suo Regno, che trasforma e libera. Questo è il significato della testimonianza di don Puglisi, che diventa via maestra di una chiesa libera, asservita solo al vangelo, capace di testimonianza fino al martirio, secondo le orme di Gesù”.
Una chiesa povera, come ha sottolineato nel libro più volte, quella propugnata da papa Francesco. Vuol dire che non si dà libertà senza povertà? Sì, e come insegna Francesco, non si tratta di povertà solo in termini teoretici, ma in termini di consapevolezza ecclesiale: la chiesa povera è ricca solo del Vangelo e solo questa forza può dare l’audacia del martirio, fino all’effusione del sangue, creando passaggio dalle tenebre alla luce, dal potere strozzino che schiavizza, tipico della mafia, alla libertà dei figli di Dio”.
Ci sono state resistenze al pieno riconoscimento del martirio di don Puglisi? “Forse qualche opposizione sì, com’è inevitabile che sia. Ma ha prevalso il sensus fidei del popolo di Dio, un po’ come accadde con il martirio di Monsignor Romero. Perché il popolo di Dio ha naso nel riconoscere i veri testimoni del Vangelo”.
Pino Puglisi non amava essere definito prete anti-mafia. Come lo definirebbe? “Don Pino è un prete senza aggettivi, che non rientra nei canoni del prete anti-mafia. Non si faceva spazio solo con le parole, ma lavorava lontano dai riflettori, nella ferialità. E’ stato un grande educatore, proprio per aver fatto leggere ad altri, ad iniziare dai più piccoli, l’esperienza umana seminata della Pasqua di Cristo. E se oggi a Palermo c’è gente capace di esprime una fede adulta e impegnata, è perché ha avuto accanto lui”.
Pare sia riuscito a toccare addirittura il cuore di chi lo ha ucciso. Giusto? “Lui fu uomo del sorriso, fino alla fine. L’ultima immagine che è rimasta impressa nei suoi occhi è quella dei suoi killer che ha portato con sé al cospetto del Signore. Ecco il “convertitevi” e il senso della mitezza evangelica: don Pino ha dato la vita per tutti, anche per chi lo ha ucciso, sulle orme di Cristo”.
Lei dedica un capitolo del libro alla pietà popolare, ricordandone l’importanza. Quella religiosità che non dev’essere strumentalizzata dalla mafia, come ammoniva Papa Francesco al clero raccolto in cattedrale a Palermo. Un rischio ancora attuale? “Papa Francesco ha voluto riprendere il tema della pietà popolare, a lui carissima per la sua formazione teologica. Sapendo che in Sicilia è ancora forte il sentimento di pietà popolare, ma sapendo anche che permangono in essa anche delle forme equivoche, ha esaltato quella vera che è il “sistema immunitario della Chiesa”, patrimonio da custodire gelosamente; di converso la volontà di piegare Dio alla finalità di potere, insito nella cultura mafiosa, deve trovare nella testimonianza della Chiesa una decisa parola critica. E’ una sfida educativa oggi per certi versi ancor più ardua, perché affronta una mentalità invasiva”.
Perché, secondo lei, oggi il contrasto alle mafie è ancor più arduo rispetto a 25 anni fa? “La mafia s’è trasformata: non ci sono più i delitti efferati degli anni Ottanta e Novanta; ma la sua azione è più subdola, perché s’è aziendalizzata e questo fenomeno oggi non riguarda più solamente il Sud, ma prolifera ovunque. A renderla ancora più pericolosa, poi, è il fatto che vive e prospera all’interno di una cultura performante. Una cultura invasiva idolatrica, che venera il dio Mammona. Il Vangelo non può essere che forza di debolezza, per dirla alla San Paolo, che, senza uso di violenza, si oppone alla mafia”.
Perché ha scritto che il “dopo-Pino” deve ripartire dai bambini? “E’ lo stesso stile pastorale di don Pino a dircelo: utile e giusto manifestare in piazza contro la mafia, ma da buon pedagogo sapeva che era ben più importante l’educazione delle nuove generazioni: è da lì che si deve ripartire. Cosa Nostra vuole figli dipendenti. Invece il Vangelo crea figli liberi, adulti”.
Lei ha scritto che “una chiesa neutra è anche peggio di una chiesa collusa”. Parole forti, non crede? Parole che leggiamo anche nell’Apocalisse: “sei freddo, non ti riconosco”, dice l’Angelo. Invece il Vangelo fa prendere sempre posizione, non per spirito di contraddizione, ma perché rende autenticamente liberi. Una chiesa neutra è già segnata, perché si adegua al contesto, senza più diventare ciò che deve essere, cioè lievito e sale del mondo”.
La chiesa di papa Bergoglio non è certo neutra, ma ci sono opposizioni a questa linea… “E’ facile rispondere: vuol dire che Papa Francesco, che pensa a una chiesa umile e discepola del Vangelo, che dimentica tutti i linguaggi e i segni del potere, sta facendo sul serio col Vangelo. Chi fa resistenza sono coloro che sono preoccupati di perdere potere, che hanno nostalgia del passato di potere, un’idea sbagliata della sacralità”.
Lei ha conosciuto Pino Puglisi. In che occasione e che impressione le fece? Lo conobbi perché negli anni ’80 era il direttore del Centro Regionale Vocazioni e io, sacerdote fresco di nomina, nel 1988 fui nominato direttore del Centro vocazioni della diocesi di Noto, quindi ero membro anche del Centro regionale, per cui fino al 1990 ci si vedeva spesso a incontri e convegni. Riconosco nell’esito finale della sua vita lo spessore di un’umanità bella, capace di incrociare l’umanità degli altri, soprattutto dei giovani, e di un uomo coerente innamorato del Vangelo e della Chiesa. Era, inoltre, un grande lettore che frequentava le Scritture e le scienze antropologiche. Un vero formatore”. FAMIGLIA CRISTIANA 10.5.2019
Perché la mafia teme la Chiesa
I mafiosi si fanno una religione per conto loro. Spesso la scomunica non tocca tanto loro quanto i loro parenti. Per esempio sappiamo che il boss Matteo Messina Denaro è indifferente alle problematiche religiose e non è interessato alla scomunica, mentre ne sono toccati i suoi parenti,soprattutto per quello che riguarda il rifiuto dei funerali in chiesa in quanto pubblici peccatori e il divieto di fare da padrino a battesimi e cresime o di entrare in confraternite religiose.
Don Pino Puglisi scrisse: “E’ importante parlare di mafia, soprattutto nelle scuole, per combattere contro la mentalità mafiosa, che poi qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell’uomo per soldi. Non ci si fermi però ai cortei, alle denunce, alle proteste. Tutte queste iniziative hanno valore ma, se ci ferma a questo livello, sono soltanto parole. E le parole devono essere confermate dai fatti”. Sulla figura di don Puglisi è utile leggere il romanzo “Ciò che inferno non è” di Alessandro D’Avenia. Il suo martirio è stato in quanto prete, questo è stato determinante per riprendere la causa di beatificazione che rischiava di arenarsi.
Mi pare interessante quello che scrisse Gianni Baget Bozzo: “Don Puglisi non è stato ucciso per ammonimento o per rappresentanza, è stato ucciso perché era lui, e per quel che faceva. E’ stato ucciso perché prete cattolico, perché sacerdote di Cristo. E in questa morte noi leggiamo la morte di un prete per il suo ministero”. Quindi mi pare che la testimonianza di don Puglisi, il suo coraggio, sia una testimonianza profetica, perché indica alla Chiesa, e quando parlo di Chiesa non mi riferisco soltanto ai sacerdoti ma ad ogni cristiano, una via, la via evangelica di testimoniare Cristo, di seguire Cristo, che comporta anche il rifiuto del male e quindi il rifiuto della mafia, come una forma pratica di ateismo.
Don Pino Puglisi diceva “noi abbiamo un Padre Nostro”, per questo ha intestato il suo centro al Padre Nostro, “non abbiamo bisogno di padrini”. Dire questo in quell’ambiente significava in qualche modo delegittimare i fratelli Graviano, delegittimare la mafia. E’ interessante come nel verbale degli interrogatori dei suoi uccisori risulti come, colpendo don Pino, si volesse colpire la Chiesa. Si voleva colpire un prete scomodo, che invece di limitarsi soltanto a fare le processioni, magari facendole gestire al comitato di certi mafioso, invece educava alla fede, educava al Vangelo.
Ad un certo punto un mafioso dice “questo prete predicava tutta ‘a iurnata’”, cioè tutto il giorno. Questo dava fastidio. E poi mi sembra interessante in questo libro, il fatto che si insista sul perdono. Perché don Pino voleva parlare con i mafiosi, voleva che si confrontassero con lui. Don Pino, un momento prima che venisse ucciso, ha detto “me l’aspettavo” ed è morto con il sorriso sulle labbra, un sorriso che significa perdono ma significa anche speranza, significa che il cristiano, il prete che crede che l’amore di Dio è più forte della morte, sa che alla fine l’amore di Dio è vincitore.
Possiamo ripetere per don Pino: “Se il granello di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto”. La sua beatificazione, ci indica veramente don Pino Puglisi come un profeta. Quindi noi lo possiamo annoverare tra i profeti. Questa sua morte così tragica, così dolorosa, è un seme insuperabile di vitalità. Possiamo dire che don Pino Puglisi con il suo esempio, con tutta la sua vita sacerdotale, è stato un maestro di umanità. mons. Michele Pennisi 15 dicembre 2021 INTERRIS
PADRE GARAU:”La mafia avanza, altri preti salteranno”

Don Patriciello: “La camorra? Un virus mortale da debellare subito”
“Con il lockdown gli operai e i commercianti, rimasti senza lavoro, muoiono di fame. E la camorra – proprio come un virus malefico – si intrufola in questo momento di bisogno acquistando nuova forza, nuovo potere”. E’ la denuncia, forte, di don Maurizio Patriciello, parroco di San Paolo Apostolo a Caivano, un comune nel napoletano situato proprio nella tristemente nota Terra dei Fuochi.
Terra dei Fuochi
Lo scorso 22 aprile, per il 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), In Terris aveva intervistato il sacerdote che lotta a fianco delle mamme “orfane” – quelle madri che hanno perso un figlio per un tumore in quella terra avvelenata – su come il lockdown abbia avuto un duplice effetto. Il primo, dal punto di vista ambientale, è senz’altro positivo: “Con il lockdown delle attività – spiegava don Maurizio – stiamo meglio: i roghi tossici sono diminuiti perché le fabbriche che lavoravano in nero sono bloccate come tutte le altre. I roghi sono infatti il risultato dell’incenerimento degli scarti della lavorazione in nero di prodotti vari: tessuti, plastica, sostanze chimiche. Fabbriche chiuse: roghi spenti”. Il secondo effetto della chiusura delle attività economiche è invece sociale e tutt’altro che positivo: perché “con il lockdown – evidenziava il sacerdote – gli operai e i commercianti, rimasti senza lavoro, muoiono di fame”.
La piovra
Al bisogno della povera gente risponde – non senza conseguenze – la criminalità organizzata. Questa, se da un lato sta perdendo i proventiderivati dallo spaccio di droga e dal traffico illecito di rifiuti, dall’altra riesce a guadagnare grazie al prestito di denaro a quei lavoratori (operai, professionisti, lavoratori autonomi o del sommerso) che hanno urgente bisogno di liquidità per sopravvivere al lockdown. Insomma, dove lo Stato langue (o è addirittura assente) la camorra si infiltra allungando (come una piovra) i suoi tentacoli.
La mutazione
Come si sta trasformando la malavita per sopravvivere e per lucrare in tempo di pandemia? E quali saranno le conseguenze per i cittadini finiti nelle maglie della “piovra” finita l’emergenza coronavirus? A queste ed altre domande, ha risposto per In Terris don Patricello nel suo linguaggio tipicamente diretto e senza sconti per nessuno. Nemmeno per lo Stato.
Don Patriciello, le fabbriche sono chiuse e i roghi spenti grazie alla quarantena e ai relativi controlli. Nella fase post covid basterà dunque fare più controlli per tenere spenti i roghi che avvelenano la terra?
“Non basteranno i controlli del territorio, che sono comunque necessari e fondamentali. Ho più volte espresso ai vari Presidenti del Consiglio e ai due Presidenti della Repubblica incontrati in questi anni di denuncia che per interrompere i roghi tossici bisogna mettere la gente che produce gli scarti di lavorare onestamente”.
Bisognerebbe dunque facilitare la regolarizzazione del lavoro sommerso?
“Sì. Non si può mettere una persona nella condizione di dover scegliere se lavorare in nero o morire di fame. E’ lo stesso discorso che vale per l’ex Ilva di Taranto. Queste sono scelte disumane, vigliacche. Bisogna permettere alle fabbriche di mettersi in linea con le leggi e il fisco una volta per sempre”.
Le fabbriche che lavorano nel sommerso sono in genere di ‘proprietà’ della criminalità organizzata?
“In genere no, sono di comuni cittadini che però non riescono per problemi economici a lavorare nella legalità. Ma non bisogna dimenticare che poi la camorra si infiltra nelle fessure lasciate aperte dallo Stato”.
Come opera la camorra oggi?
“In questo periodo di crisi economica grave, la camorra riesce a rispondere ai bisogni della gente e ad arrivare prima dello Stato perché non ha burocrazia, ha una grandissima liquidità a sua disposizione e tantissimo denaro da riciclare. Si fa avanti e presta denaro a usura sapendo già da subito che quel denaro non gli verrà più restituito”.
E dove sarebbe il suo guadagno?
“I camorristi l’economia e le leggi le conoscono benissimo, meglio di noi comuni cittadini. Ragionano sul medio e lungo periodo. Una perdita nel breve periodo, con tutti i soldi che hanno, non cambia loro niente. Ma alla fine della pandemia la camorra chiederà conto di quei soldi prestati e – di fronte all’impossibilità della restituzione – si prenderà (con le buone o con le cattive) l’intera azienda”.
E ai proprietari che cosa resterà?
“Nulla. Si dovranno accontentare di fare da ‘prestanome’ al clan di turno. La Camorra ci guadagna sempre, anche in pandemia, in un modo o nell’altro. In questo momento è come se nelle città campane fossero presenti due Caritas in auto dei bisognosi. Quella parrocchiale e una ‘pseudo caritas camorristica’ che dà cibo, vestiti e soldi in contanti a chi ne ha bisogno. Finita l’emergenza, questa gente resterà ‘prigioniera’ nelle maglie della criminalità per il resto della sua vita”.
Si può dire di “No” ai clan?
“Tutte quelle famiglie che osano dire ‘No’ a questi finti aiuti, vengono guardate male dai clan, entrano in una sorta di ‘lista nera’ perché chi non è con loro è contro di loro. Non ci vuole nulla ad essere malvisti: basta non accettare quella busta della spesa o quei soldi che loro tanto ‘gentilmente’ ti offrono”.
Cosa succede alla gente comune costretta ad accettare questi ‘aiuti’?
“Alle gente comune i clan non chiedono di compiere azioni o atti criminali, ma obbligheranno i proprietari di case a far controllare al clan il territorio. In questo modo, la camorra diventa il proprietario de facto degli spazi comuni dei palazzi: soffitte, scantinati, terrazzi, tetti di cui ha terribile bisogno”.
Perché i tetti sono tanto importanti per la malavita?
“Perché la criminalità sa di non poter usare i telefonini per comunicare in caso di blitz della polizia in quanto sono tutti sotto controllo. Allora mettono delle vedette sui tetti dei palazzi che avvertono rapidissimamente – comunicando tra loro con segnali prestabiliti e il passavoce – dell’arrivo delle forze dell’ordine nelle piazze di spaccio. Questo permette loro di nascondere la droga, le armi e i soldi nelle cantine o nelle soffitte dei palazzi e di scappare”.
Perché i pusher nascondono la droga negli scantinati dei palazzi?
“Perché secondo la legge i luoghi comuni dei palazzi non sono proprietà di nessuno. Quando scatta il blitz nascondono lì la roba così che – anche se venisse scoperta – nessuno potrebbe risalire a loro. Infatti, se viene trovato un Kalashnikov in una soffitta, chi può dire chi sia il proprietario? Non è stato trovato in casa di qualcuno e la soffitta di un palazzo, per legge, non appartiene a nessuno dei condomini”.
Dunque, soffitte e scantinati sono una sorta di ‘zona franca’ dentro le città?
“Sì, inoltre gli scantinati permettono numerose vie di fuga ai pusher o alle vedette una volta inseguiti dalle forze dell’ordine”.
Oltre agli spazi delle case, i clan chiedono alla gente comune anche il silenzio?
“Sì, impongono loro l’omertà. E così queste persone dovranno vivere obtorto collo con dei criminali ‘in casa propria’. Dico sempre che questa gente non è solo onesta, ma anche eroica. Convivere sullo stesso pianerottolo con degli appartenenti ai clan significa subire le loro regole senza poter fiatare: quando uscire, quando entrare in casa propria, quanto chiudere o aprire il cancello, anche quando alzare le tapparelle di casa…Una situazione che manderebbe chiunque al manicomio”.
Quali le conseguenze sul piano sociale?
“Che questi quartieri diventano praticamente dei ghetti in mano alla malavita”.
Secondo lei, chi ha la responsabilità del fatto che interi quartieri siano caduti, non certo da un giorno all’altro, nelle mani della criminalità?
“Questa è una risposta complessa. Per anni in certe zone – tipo Scampia ai margini di Napoli – sono stati spostati i nuclei familiari più poveri: persone indigenti, in difficoltà economica, senza lavoro, ex carcerati…creando dei quartieri ghetto dove non c’era nulla oltre alla povertà. In questo tessuto nato, come dico io, col ‘peccato originale’, perché senza speranze (dove la parrocchia e la scuola sono gli unici spazi dove si parla di legalità e futuro) la criminalità propone modelli di ricchezza. I cosiddetti ‘soldi facili’, ma che facili non sono, corrompendo i giovani che si sentono emarginati e impossibilitati ad accedere ad un futuro migliore, fuori dall’indigenza, se non attraverso la malavita”.
In conclusione, come potremmo definire la Camorra?
“La Camorra, così come la mafia, spesso viene paragonata ad una piovra dai lunghi tentacoli. Io la considero un virus cattivo e mortale che, se preso per tempo, può essere debellato. Ma se lo si lascia prosperare indisturbato – fuor di metafora: se lo Stato è assente o non fa abbastanza anche in termini economici – il virus si prende tutto e manda in cancrena l’intero organismo”. Milena Castigli 1 maggio

Da Vescovo ausiliare di Roma monsignor Marciante si era scagliato contro il funerale show dei Casamonica ma anche in Sicilia non ha usato mezzi termini contro Cosa nostra: “La mafia è come un ladro: ti ruba la libertà, la dignità, l’anima e ti lascia mezzo morto”.
Mons. Giuseppe Marciante il vescovo di Cefalù.
DOSSIER: IL VANGELO E LA ‘NDRANGHETA
L’ennesimo attentato contro don Panizza e la realtà di una Chiesa che in Calabria è un baluardo contro la criminalità organizzata. L’inchiesta di Famiglia Cristiana.
Era già accaduto a febbraio e la gente calabrese si era mobilitata in segno di solidarietà. Adesso la ‘ndragheta ci riprova a mettere paura a don Giacomo Panizza, il sacerdote che, con la sua comunità Progetto Sud (avevamo già raccontato la sua storia in una videointervista del giugno 2011), sta provando a ridare speranza alla Calabria. Ancora due colpi di pistola la scorsa notte contro la saracinesca della sede Pensieri e parole. L’edificio, che sorge a Lamezia Terme, nel quartiere Capizzaglie, noto per la sua alta densità mafiosa, è stato confiscato alle ‘ndrine e ospita disabili e immigrati. A dicembre era stato fatto esplodere un ordigno e a febbraio erano stati esplosi colpi di pistola all’altezza delle finestre della cucina dove pranza il sacerdote.
«Noi proseguiamo nella nostra attività senza tornare indietro perché la gente ha bisogno di questo tipo di servizi. Non lasceremo sola la popolazione», ha subito commentato don Giacomo. Aggiungendo che «bisogna subito intervenire e capire chi commette queste azioni. Si tratta di un vero terrorismo psicologico perché sono episodi che snervano e che ci lasciano sempre più confusi». Sicuramente, ha concluso il sacerdote, «vogliono farci smettere, ma noi non possiamo tornare indietro».
In questo Dossier, potrete scoprire la storia coraggio di don Giacomo Panizza e degli altri sacerdoti coraggiosi che lavorano nelle zone infestate dalla criminalità organizzata.
I giornali calabresi sembrano le pagine dei vecchi mattinali della polizia. A sfogliarli pare che non ci sia angolo di questa terra dove non è in corso un’estorsione, un’indagine, una retata delle forze dell’ordine, una macchina fatta saltare in aria, minacce al sindaco, al magistrato, alla persona scomoda di turno.
Quella della ’ndrangheta è una presenza pervasiva, costante – la relazione della Commissione antimafia la definisce “istituzionalizzata” – che macchia e imbratta la bellezza dolorosa della regione. Nell’ultimo anno i reati legati alle cosche sono aumentati del 21 per cento, nonostante il forte contrasto di Polizia e Carabinieri e il processo “Crimine”, che si è concluso con la condanna del boss Domenico Oppedisano e la condanna di un centinaio di affiliati.
«Non dobbiamo farci intimorire», ha sempre ammonito monsignor Giancarlo Bregantini, per anni vescovo di Locri. «Non dobbiamo dipingere la ’ndrangheta come invincibile, non è così forte come ci vuol far credere», scrive anche dalle pagine del suo libro Non possiamo tacere. Per sconfiggerla servono proposte e idee e la Calabria sembra sulla buona strada.
Lo dimostra, paradossalmente, proprio il susseguirsi, negli ultimi tempi, di gesti intimidatori anche contro tanti sacerdoti. «Una ’ndrangheta che attacca la Chiesa è debole. Significa che sta perdendo il suo consenso sociale, ma anche che la Chiesa ha cambiato modo di agire», spiega Nicola Fiorita, docente di Diritto ecclesiastico all’Università della Calabria e autore del saggio Mafie e Chiesa: «Si può dire che c’è stata una lunga e colpevole tolleranza, ma oggi l’atteggiamento è cambiato. Si fa prevalere la sostanza del messaggio evangelico sull’esteriorità dei comportamenti e sulla condivisione solo formale dell’insegnamento ecclesiale. Condivisione formale e ostentazione che sono il principale modo di agire mafioso».
«Ormai tutti hanno capito che mafia e Vangelo non possono andare insieme», aggiunge don Pino De Masi, parroco a Polistena, referente di Libera per la Calabria e fondatore della cooperativa Valle del Marro. Sulle terre confiscate alle ’ndrine si coltiva e si produce. In un altro stabile si sta mettendo in funzione un centro ricreativo. Intollerabile per i padrini della ’ndrangheta. Che allora taglia le piante, minaccia i preti, prova a interrompere la produzione. «Ma noi continuiamo a lavorare, anche sul fronte dell’educazione. Perché adesso si tratta di intervenire anche sull’altra questione, quella della “mafiosità” insita un po’ in tutti noi. Ai mafiosi dobbiamo predicare che la mafia è un peccato sociale e che chi intende convertirsi non può farlo solo a parole, deve fare come Zaccheo: dò la metà dei miei beni ai poveri e, se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Nei confronti della zona grigia bisogna impegnarsi a dire no a tutte quelle situazioni ambigue in cui ci siamo imbattuti come cristiani ma anche come Chiesa istituzione».
Una posizione così netta indebolisce le cosche. «I mafiosi», spiega il professor Fiorita, «hanno bisogno di un radicamento nella cultura del luogo di origine. Tale radicamento viene, in prevalenza, dalla partecipazione ai riti, alle cerimonie e più in generale dall’appartenenza visibile e riconosciuta alla Chiesa cattolica. Per questo è intollerabile una presa di distanza tanto chiara».
E anche se ci sono «tante Calabrie sia dal punto di vista delle caratteristiche della mafia sia da quello dell’antimafia», aggiunge Sabrina Garofalo, referente di Libera per Cosenza, «il punto in comune è quello delle proposte concrete. La mafia ha paura quando si attacca il suo patrimonio, si crea lavoro, si costruisce qualcosa tutti insieme».
E per la prima volta insieme nel quartiere Capizzaglie, una delle zone a più alta densità mafiosa di Lamezia Terme, si sono ritrovati giovani e meno giovani per una serata di solidarietà a don Giacomo Panizza, l’ennesimo sacerdote vittima di atti intimidatori. Dopo l’attentato alla comunità da lui fondata, Progetto Sud, i calabresi hanno organizzato la manifestazione Il giorno che non c’è… la’ndrangheta.
Sul palco è salito anche il procuratoredi Lamezia Salvatore Vitello per ringraziare la Chiesa e per dire ai mafiosi: «Fermatevi, l’unica prospettiva che avete è il carcere o la morte. Non illudetevi anche se adesso guidate auto potenti e lussuose, ve le confischeremo. Fermatevi adesso, perché il nostro presidio di legalità non arretrerà». La Chiesa calabrese è in prima linea «e può essere la vera forza di questa regione», conclude Fiorita, «perché i politici hanno le scadenze elettorali, gli imprenditori hanno i loro interessi da far fruttare, la Chiesa può permettersi, invece, strategie di lungo periodo. E nel lungo periodo sicuramente non sarà la mafia a vincere».
«A Cetraro non ci facciamo mancare nulla: abbiamo il capitano, il maresciallo, il prete. Possiamo fare un altro don Matteo». Don Ennio Stamile stempera così la tensione che c’è tra la folla l’ultima domenica di gennaio. Convocati senza troppi clamori, con il passaparola, i fedeli si erano stretti attorno al loro parroco, chiesa di San Benedetto, per un gesto storico in questo comune: una Messa per la conversione dei mafiosi. «Perché non ci sono preti antimafia o contro. I sacerdoti sono per l’uomo», dice don Ennio, presidente uscente dell’Osservatorio per la legalità e tra gli organizzatori, nel 2007, del convegno Caritas È cosa nostra.
La Messa è stata la risposta del sacerdote all’ennesimo atto intimidatorio di cui era stato vittima qualche giorno prima: una testa di maiale mozzata fatta trovare sul pianerottolo di casa con un pezzo di stoffa in bocca. Prima ancora danni alla macchina, con una significativa X graffiata sul cofano mentre era parcheggiata nella piazza principale del paese. «Tutti segnali per dirmi di stare zitto», commenta il sacerdote. Che, però, non ha nessuna intenzione di tacere.
E i fatti gli stanno dando ragione. Nel regno incontrastato del boss Franco Muto, le nuove ’ndrine nascenti possono ancora essere fermate. «Per questo è importante parlare quando si vedono i segnali», spiega don Ennio. «Non possiamo fare come negli anni Settanta e Ottanta. Proprio grazie all’omertà la ’ndrina dei Muto si è rafforzata. Furono anni terribili in cui è successo di tutto, compresi 13 omicidi. Ora nuove forze premono per entrare in questo territorio».
Da mesi obiettivo delle nuove bande erano gli anziani, i disabili, le persone sole. Fino al giorno in cui, spacciandosi per il vescovo, sono entrati in casa di uno psicolabile che il tribunale ha affidato alla tutela di don Ennio. Calci, pugni, botte per portargli via un paio di scarpe. Don Ennio ha denunciato dal pulpito: «Qualcuno a Cetraro pensa che può non lavorare e mangiare a scapito dei poveracci, della povera gente. Pensa che spacciare droga, rapinare, fare furti, equivalga a un vero e proprio impiego. Viene applicata la legge della giungla a scapito del più debole. Ma solo gli animali si comportano così».
Don Ennio ha parole anche contro il boss storico che si vanta, sulle pagine di un quotidiano locale, di essere un “padrino” vecchia maniera che dice no alla droga sul suo territorio. «Rifiutate la droga», dice don Stamile, «ma non rifiutate il pizzo, gli omicidi, il riciclaggio di denaro, l’usura». Seguono le minacce, «credo più legate alle nuove forze emergenti che non alle famiglie storiche». La settimana dopo si costituisce una prima persona, poi altre due. Le indagini sono in corso e i frutti cominciano a vedersi.
L’omertà ha portato, in una terra famosa per il suo mare e le sue bellezze, il cancro della ’ndrangheta. Nell’operazione Overloading, con l’arresto in tutta Italia di 70 persone legate al traffico di droga, quasi una quarantina erano di Cetraro. Le forze dell’ordine stanno lavorando molto bene, ma non basta», conclude il sacerdote. «Noi cristiani, in particolare, siamo interpellati dal Vangelo che ci dice “per amore del mio popolo non tacerò”. Io sto solo cercando di fare la mia parte».
In Calabria la lotta alla ’ndrangheta passa anche attraverso il gioco. A ideare e a mettere in commercio Cittadini. La Sfida quotidiana della legalità ci hanno pensato la cooperativa sociale di Cosenza Dignità del lavoro, Libera, il Centro reggino di solidarietà. Un gioco di società dove i concorrenti devono accumulare i punti assegnati dal proprio ruolo.
Attenzione, però: che sia capitato di interpretare un giornalista o un imprenditore, un’impiegata comunale o uno studente, si vince solo se il livello di legalità complessivo della città supera i 9 punti. A ogni casella i giocatori sono messi di fronte a delle scelte: in alcune il beneficio personale coincide con quello pubblico, in altre si dovrà decidere se portare l’amico in motorino anche senza casco, se scaricare la musica da Internet, se andare alla manifestazione antimafia o alla festa in discoteca. Ogni scelta ha le sue conseguenze. Arrivati a meno 30 la città muore e non c’è nessun vincitore perché, come nella realtà, «al di sotto di una certa soglia di legalità non è più possibile alcuna forma di convivenza». FAMIGLIA CRISTIANA 11.4.2012
Vescovi calabresi. «Mafie e Vangelo incompatibili». Il documento dei vescovi calabresi: la criminalità in questa terra esiste e ha volti, nomi e cognomi. Strumenti per le parrocchie e forme di aiuto a favore dei familiari innocenti delle vittime
Subito regole chiare per le processioni. «La composizione dell’elenco dei portatori sia frutto di discernimento. La presentazione previa alla polizia? È raccomandabile» –
«Le mafie esistono in Calabria nonostante ogni dichiarazione contraria o omertosa. Hanno volti, nomi, cognomi, appoggi, collaborazione, silenzi conniventi… e, in tal modo, continuano a tessere una vera rete asfissiante». È la forte denuncia dei vescovi calabresi nel documento, appena pubblicato, ‘No a ogni forma di mafie! Linee guida per un ‘sentire e agire comuni’ del clero, dei consacrati e dei fedeli laici delle Diocesi di Calabria’. I vescovi ribadiscono «chiaramente l’incompatibilità assoluta tra mafie e Vangelo, tra tutte le forme di mafie e l’essere cristiano».
E aggiungono: «Atti solamente esteriori di devozione, come il partecipare a processioni, pellegrinaggi, iniziative varie, o eventuali elargizioni generose e benefiche anche nei riguardi delle opere promosse dalla Chiesa, non assolvono nessuno dal peccato di mafia». Ma, avvertono, «talvolta le mafie trovano terreno fertile perfino in certuni contesti religiosi, laddove non sono rispettate le leggi dello Stato o, addirittura, per ottenere un proprio diritto o risolvere questioni personali, si conti- nuano a chiedere interventi a persone legate alle mafie». Ecco, dunque, il motivo delle Linee guida, per «offrire uno strumento operativo comune, per coltivare senza posa l’azione corale del rinnovato annuncio della forza del Vangelo in vista della conversione dei mafiosi e dei corrotti». Molte le indicazione pratiche contenute nelle Linee guida. Così «ogni Parrocchia attivi, anche mediante una rete di coordinamento interparrocchiale e/o diocesano, opportune forme di aiuto e di sostegno a favore dei familiari innocenti di vittime della mafia, in particolare donne, minori e giovani. Si cerchi, mediante l’azione di laici qualificati, la possibilità di utilizzare i beni confiscati alle mafie per creare, a imitazione di realizzazioni già riuscite, cooperative produttive finalizzate a sostenere i nuclei familiari che, avendo persone in carcere di cui non condividono le scelte, versano nel bisogno».
Si passa poi al tema della scelta delle madrine e dei padrini, che la ’ndrangheta, «fondando la sua forza sui legami familiari, ha trasformato talvolta in un’occasione per allargare i legami perversi di ‘famiglia criminale’ ». Per questo «non possono essere ammesse le persone notoriamente irreligiose o che provocano scandalo, in particolare quelle condannate per mafia (con sentenza passata in giudicato o che non abbiano finito di scontare la pena) e, soprattutto, che non abbiano dato nessun segno di resipiscenza o di vera conversione». Per quanto riguarda le processioni «la composizione dell’elenco dei portatori sia frutto di un preciso e attento discernimento comunitario, che elimini in partenza motivi di criticità in ordine alla condotta dei singoli. La presentazione previa degli elenchi alle autorità di Polizia è raccomandabile per l’esclusione di eventuali soggetti in odore di ’ndrangheta». Vietati i famosi ‘inchini’. C’è poi l’altro delicato tema dei funerali.
La Chiesa non nega «il conforto delle esequie» neanche ai mafiosi «da celebrare, tuttavia, in forma semplice, senza pomposità, tripudio di fiori, canti, musiche e commemorazioni, ammettendo esclusivamente i familiari stretti e, se necessario e richiesto per motivi di ordine pubblico, a porte chiuse». Infine si invitano le Curie a istituire «un’apposita Commissione diocesana per l’attuazione di queste Linee guida» all’interno della quale «operi uno ‘sportello di advocacy’, al quale indirizzare le segnalazioni e le denunce di violazioni dei diritti, illegalità, soprusi, estorsioni, perché poi attivi interventi giuridici e ‘politici’ di tutela ed accompagnamento delle persone più deboli». Ma che organizzi anche «il servizio di sostegno alle vittime della mafia e della criminalità » colmando «la sensazione di vuoto, di isolamento dei loro familiari e degli imprenditori sotto attacco estorsivo e/o minacce dei mafiosi ». Promuovendo «forme di consumo critico e solidale nei confronti degli imprenditori e commercianti che hanno denunciato il racket e si rifiutano di pagare il pizzo». AVVENIRE 17.9.2021
Nella lingua siciliana, la Punciuta (puntura) indica il rito di iniziazione dei membri di Cosa nostra: la persona da iniziare viene condotta in una stanza alla presenza di tutti i componenti della Famiglia; l’iniziato, puntosi sull’indice della mano con una apposita spilla o con una spina d’arancio, giura fedeltà a Cosa nostra imbrattando col sangue una immaginetta sacra, per poi bruciarla – «giuro di essere fedele a cosa nostra. Possa la mia carne bruciare come questo santino se non manterrò fede al giuramento»
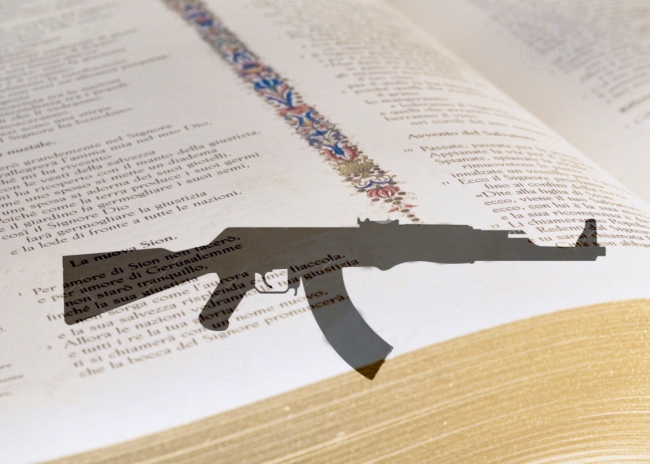
QUELLE MESSE NEL COVO DI AGLIERI
Nel covo di Pietro Aglieri alle porte di Bagheria arrivava almeno un paio di volte la settimana. Entrava da quel cancello di ferro arrugginito, saliva le scale fino alla stanza che sembrava una torretta, poi spariva per un paio d’ ore dentro la tana del latitante. E celebrava messa. Così un frate di Palermo portava la preghiera di Dio – e anche il suo personale “conforto” – a uno dei più pericolosi boss di Cosa Nostra. Il frate ha un nome (che gli investigatori tengono segreto per ragioni d’ indagine), si sa che ha una sessantina d’ anni, si sa anche che il suo convento è nel centro storico della città. Il monaco è già stato ascoltato dai poliziotti e forse anche dai magistrati, in alcune intercettazioni ambientali la sua voce pare che abbia diffuso frasi e commenti definiti – da chi li ha ascoltati – “decisamente poco evangelici”. E’ cominciata con il misterioso frate la seconda puntata della telenovela sulla crisi mistica di uno dei mafiosi più spietati e più ricchi (grazie ai suoi traffici con i Colombiani) della Sicilia. Dopo il ritrovamento di trecento testi sacri nel covo di Fondo Marino, dopo la scoperta della cappella con tanto di altare e panche per la preghiera in una stanza del suo rifugio, ecco che le “cimici” piazzate da qualche parte dagli investigatori della Squadra Mobile rivelano la presenza di un frate nella vita da ricercato di Pietro Aglieri. La divulgazione di questa notizia non ha fatto molto piacere agli investigatori e ai magistrati che, dopo la cattura del signurinu, da alcuni giorni sono sulle tracce degli uomini che per anni hanno protetto la sua latitanza. E’ stata quindi una microspia a svelare il frate amico-compagno-confessore di Pietro Aglieri. Un’ intercettazione captata nella casa di qualche fiancheggiatore, la voce e il nome del monaco, la ricerca, i primi interrogatori. E anche le prime sorprese.
Come la messa che il misterioso frate celebrava nel covo di Aglieri. Più che una cappella – dicono i poliziotti dopo aver portato là dentro un sacerdote per una “consulenza” – quella era una piccola chiesetta dove il boss avrebbe fatto, più volte, anche la comunione. Voci che si accavallano intorno al misticismo del mafioso, intorno alla sua “conversione”, intorno al suo pentimento interiore. Dell’ altro pentimento, per ora non se ne parla. Anzi. Indiscrezioni raccontano che Pietro Aglieri “vuole dimostrare la sua estraneità” alle stragi di Capaci e di via D’ Amelio. La “vicinanza” di questo boss a un frate riporta indietro il tempo, fa scoprire lontane contiguità tra i mafiosi della “famiglia” di Santa Maria del Gesù (di cui Aglieri è il capo) e certi monaci. Anche mezzo secolo fa, anche 20 anni fa, c’ era un rapporto stretto, strettissimo tra i boss di Santa Maria del Gesù e un frate diventato famoso. Si faceva chiamare Fra Giacinto, il suo vero nome era Stefano Castronovo. Era un francescano, aveva i capelli color argento e il fisico di un atleta.
Una volta perquisirono il suo convento che era alle spalle di un cimitero, proprio quello di Santa Maria del Gesù: cercavano Luciano Liggio. Era un uomo diabolico Fra Giacinto: sotto il saio nascondeva una calibro 38. Era amico di don Paolino Bontate, poi diventò amico anche di suo figlio Stefano. Erano i capi mafia di Palermo prima di Pietro Aglieri. Nel suo convento – si sussurrava – ogni notte c’ erano “strani movimenti”. Si parlava di latitanti che si nascondevano nelle celle dei monaci. Si diceva pure che sotto il cimitero vero di Santa Maria del Gesù, ci fosse un cimitero di mafia: se mai avessero trovato qualche ossa o qualche cranio, nessuno si sarebbe potuto meravigliare… Tante “dicerie” su Fra Giacinto furono spazzate via il 6 settembre 1980. Si capì infatti che non erano dicerie…Entrarono in due al convento alle 8 del mattino, e chiesero del frate. Lo fecero secco mentre celebrava messa. Sotto il saio i poliziotti trovarono la sua pistola. Con il colpo in canna. Ai funerali del monaco non venne uno solo dei suoi amici mafiosi. Solo parenti da Favara, il suo paese d’ origine. E toccò al “provinciale” dei francescani l’ omelia in ricordo di Fra Giacinto. Così parlò quel giorno padre Timoteo: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”. 19 giugno 1997 La Repubblica
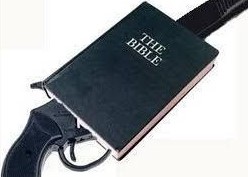
RINVENUTE 5 BIBBIE NEL COVO DI PROVENZANO
Adesso ci proverà l’Fbi a decrittare il ”codice segreto” scritto sulle pagine della Bibbia di Bernardo Provenzano Gli ultimi suoi ”postini” sono stati arrestati all’inizio dello scorso agosto. I ”pizzini” hanno rivelato la loro identità. Liborio Spatafora e Francesco Grizzaffi, presunti favoreggiatori del boss Bernardo Provenzano, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I due, dovrebbero rispondere a vario titolo di associazione mafiosa ed estorsione, ma hanno scelto di non dire niente. Intanto Bernardo Provenzano, nella sua cella nel carcere di Terni, continua ad essere un recluso silenzioso e tranquillo. Secondo il direttore del carcere, Francesco Dell’Aira, Provenzano Bernardo ”è un detenuto che sta bene e che si trova in una situazione di totale tranquillità”. Provenzano, infatti, mangia regolarmente, fa esercizio fisico, benedice tutti e in silenzio legge la sua nuova Bibbia, quella regalatagli dal direttore del carcere pochi giorni dopo essere entrato in cella. Nel libro sacro Provenzano continua a prendere appunti, continua a sottolineare passi e parabole, come faceva in quelle ritrovate nel covo vicino a Corleone. Nel casolare di contrada Montagna dei Cavalli gli agenti trovarono ben 5 copie della Bibbia, con sottolineature e foglietti pieni di appunti. Appunti ritenuti importanti per le indagini che continuano imperterrite col fine di demolire sempre di più la fitta rete che stava dietro e tutt’intorno alla ”primula rossa di Corleone”. Delle cinque Bibbie trovate nel covo gli investigatori si sono concentrati su una in particolare: le pagine di questa erano continuamente sottolineate e segnalate dal padrino, grazie anche ai post-it. E proprio questa è volata in America. Adesso sarà l’Fbi e i suoi specialisti a cercare di capire il significato nascosto, se mai c’è ne sia realmente qualcuno, delle sottolineature, annotazioni e delle decine di segnalazioni ritagliati che il Provenzano ha raccolto e inserito nei testi sacri che leggeva, rileggeva e copiava nel suo ultimo rifugio, e probabilmente anche prima, quando si nascondeva altrove, durante la sua ”infinita” latitanza durata oltre quarant’anni. Dopo una ricerca e uno studio attento degli investigatori italiani, saranno adesso gli uomini della Cryptanalysis and Racketeering Records Unit, la sezione specializzata dell’Fbi, con sede in Virginia, che studia e interpreta i codici segreti criminali utilizzati dalle gang criminali di strada, dalla criminalità organizzata, dal terrorismo interno e internazionale, dai servizi segreti stranieri. Oltre a interpretare i circa duecento ”pizzini” che riguardavano gli ”affari correnti” della mafia siciliana scritti e ricevuti da Provenzano (operazione che ha già portato ad alcuni arresti, e altri ne verranno), i Pm di Palermo e gli investigatori della polizia hanno cercato di capire qualcosa anche di quella Bibbia consumata e vergata dal Boss dei Boss, convinti che potesse nascondere un codice di comunicazione con qualcuno – per esempio coi detenuti, visto che in carcere la Bibbia è consultabile anche da chi è costretto ai rigori dell’articolo ”41 bis” dell’ordinamento penitenziario, ma per adesso senza arrivare a risultati concreti. Di qui l’idea di chiedere un aiuto all’ufficio di polizia più famoso del mondo. Ricordiamo, che appena arrestato, Bernardo Provenzano chiese di poter avere con sé proprio quell’edizione della Bibbia, che adesso sarà letta in tutti i modi possibili dall’Fbi, ma gli venne detto di no. Come detto prima il direttore del carcere gliene regalo una nuova e in questa, da allora, il capomafia ergastolano legge, studia, annota e copia da quel testo. Anche adesso legge e trascrive interi brani, e pure quelli – come la poca corrispondenza con la famiglia – passano al vaglio della censura regolata dal ”41 bis”. Nei fascicoli delle inchieste su Provenzano, insieme ai ”pizzini” inviati e ricevuti, sono finiti anche i fogli su cui il superboss ricopiava interi passi delle sacre scritture e altri testi religiosi. Particolare attenzione il capomafia dedicava al libro dell’Apocalisse. In un foglio, per esempio, ha trascritto tutta la prima parte del capitolo 17, completa di spiegazioni tratte dal dizionario della lingua italiana per parole come ”fornicare” e ”lussuria”. In fondo, un’annotazione tra parentesi: ”Devo confrontare il sopra detto con l’umanità paragonandole alle cose di questo mondo”. Un altro brano di quel testo compare in un diverso appunto: ”La bestia che hai veduto era, ma già non è più; essa sta per salire dall’abisso e per andare alla sua perdizione…”. Con la macchina per scrivere che aveva nel suo ultimo covo, Provenzano ha trascritto altri testi religiosi e di commento alle scritture, o pensieri quasi certamente copiati. Ecco un paio di esempi: ”La luce di Dio ci dà occhi per contemplare il Creato. La propia luce è la legge naturale: nell’intimo della coscienza l’uomo scopre la legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire… L’uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al suo cuore. Obbedire è la dignità stessa dell’uomo. E secondo questa egli sarà giudicato”. E ancora: ”Dio ha voluto l’incarnazione del Figlio, non tanto per avere qualcuno fuori dalla Trinità che lo amasse in modo degno di sé, quanto piuttosto per avere fuori di sé qualcuno da amare in modo degno di sé senza misura… Ecco il perché dell’incarnazione… Noi siamo inclusi in questo amore, essendo diventati membra del corpo di Cristo. Ce lo ricorda lo stesso Prologo di Giovanni: A quanti l’hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio”. Chissà se dall’altra parte dell’Oceano riusciranno a svelare i segreti del ”Vangelo secondo Provenzano”. GUIDA SICILIA 07 SETTEMBRE 2006

L’OMICIDIO DEL BOSS IN CANADA E LE CONDOGLIANZE PUBBLICHE DEL PARROCO DEL PAESE L’omicidio nel sobborgo di Laval, a nord di Montreal Canada: ucciso in pieno giorno Rocco Sollecito, esponente di spicco del clan mafioso Rizzuto Sollecito faceva parte di un “direttorio” composto da sei persone che gestivano la cupola a Montreal.

Muore don Vito. Il killer lo ha aspettato, alle 8.30 del mattino, a una fermata dell’autobus del sobborgo di Laval, a nord di Montreal. Appena la Bmw bianca guidata da Rocco Sollecito è passata, l’assassino ha estratto una pistola e ha sparato alcuni colpi che hanno colpito l’esponente di spicco del crimine organizzato italiano in Canada. L’uomo, membro del clan Rizzuto, è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate alla testa. La sua uccisione ha rappresentato un nuovo colpo per una delle famiglie mafiose più potenti del Canada. Il figlio di Sollecito, Stefano, è ritenuto il capo della mafia di Montreal insieme al figlio di Vito Rizzuto, Leonardo. MAGGIO 2016
- Grumo, pressioni troppo forti: salta la Messa in suffragio del boss Sollecito
- La tirata d’orecchie non basta, il parroco deve essere allontanato da Grumo
- Grumo, Messa in suffragio del boss. Sindaco al vescovo: “Provvedimento esemplare contro il parroco”
- Grumo e la messa per il boss, il vescovo gela il sindaco: “Decido io sul parroco”
Preti di mafia, sono due i sospetti. Dopo Calabria anche a Milano
Preti di mafia o accusati di essere tali. Preti sotto indagine della magistratura per partecipazione a reati di criminalità organizzata. Non i “preti di mafia” di un tempo, quelli che impartivano sacramenti, regalavano processione e inchini e conferivano pubblico rispetto e qualche privata protezione ai “padrini” e comunque agli affiliati. Non i “preti di mafia” che in nome di una misericordia senza limiti perdonavano eccome se perdonavano, assolvevano, benedivano e di fatto coprivano i mafiosi barricandosi dietro una molto improbabile neutralità di dio tra la legge e il crimine. Questi erano i preti di mafia di una volta. Adesso se ne trova di altra specie di preti di mafia. Nell’indagine sul Cara di Isola Capo Rizzuto, quella che coinvolge come primo accusato quel Sacco governatore delle Misericordie, il secondo indagato e accusato che colpisce e stupisce per la sua presenza tra i predatori del denaro destinato ai migranti è un parroco. Edoardo Scordio parroco. Lo accusano di essersi messo in tasca circa 130.000 euro in un anno per aver fornito “assistenza spirituale” ai migranti e rifugiati. Ma soprattutto l’accusa al parroco è di essere parte integrante, membro attivo e consapevole della cosca di ‘ndragheta che aveva le mani su tutto il businness migranti. Un’organizzazione criminale che rastrellava i soldi dello Stato e i fondi europei destinati all’accoglienza, controllava in regime di monopolio appalti, guadagnava fornendo ad esempio meno pasti di quelli che si faceva rimborsare e “pasti con cibo da maiali” per dirla con il Procuratore Gratteri. Insomma un’organizzazione che ingrassava sulla pelle dei neri, rubava i soldi pubblici e controllava il territorio con premi in denaro agli obbedienti e intimidazioni se non peggio a chi fiatava. E dentro l’organizzazione, dice l’accusa, c’era il parroco. Dopo la Calabria anche a Milano un altro sacerdote sospettato, accusato, inquisito per essere prete di mafia. A Milano l’indagine su come la mafia sia riuscita ad acquisire e dominare appalti intorno ai supermercati e perfino a perfino ad infilarsi nella società che gestisce i servizi di sorveglianza al Tribunale. A Milano un’altra organizzazione che gli inquirenti chiamano mafiosa. E a Milano nella stessa indagine Don Giuseppe Moscat, un sacerdote. Sacerdote e amministratore unico e Edizioni Musicali III millennio ruolo nel quale, secondo l’accusa, esercitava l’arte e la pratica della fattura falsa. Fatture false da cui ricavare la provvigione da inviare al Sud, alla casa madre dell’organizzazione che A Milano si era “lavorata” i supermercati e i servizi di vigilanza e chissà quante altre cose. Due sacerdoti coinvolti a pieno titolo in due inchieste di mafia, due sacerdoti che non è che secondo antico e pessimo costume coprano i mafiosi ma che secondo nuova ed emergente circostanza partecipano all’attività mafiosa non attestano certo il proliferare e il diffondersi dei preti di mafia. Però testimoniano di un mutare di ruolo e di soggetti sociali. Oggi i preti di mafia, pochi per fortuna, fanno affari e non processioni. Maneggiano soldi e non rosari, mazzette e non turiboli. Succede perché sono preti ovviamente ma prima di tutto sono uomini contemporanei. Nel mondo in cui vivono l’arraffo del denaro pubblico è industria, impresa, missione. E in questa industria, impresa e missione la criminalità organizzata è l’azienda più efficiente, con maggiore produttività, redditività e remunerazione garantita. Un’azienda che assume e sa assumere per ogni dove: pubblica amministrazione, consigli comunali e regionali, studi professionali, cooperative, sindacati, associazioni di volontariato, imprese, fornitori, artigiani, grossisti…e clero. Quando e dove alla mafia serve un uomo in abito talare, la mafia lo assume, non c’è carenza di offerta neanche in questo segmento del mercato. E’ questa la brutta notizia che portano i due casi in un solo giorno dei due preti accusati di mafia dalla Calabria a Milano. di Riccardo Galli Pubblicato il 16 Maggio 2017 BLITZ
Chiesa e mafia: molti ancora i sacerdoti “collusi”
Che i mafiosi fossero vicini alla chiesa ormai era luogo comune e veniva gridato ma, che nella chiesa ci fossero anche i mafiosi si solo sussurrava. Così, come se ce ne fosse bisogno, nel libro “Acqua Santissima” firmato dal Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri e dallo storico Antonio Nicaso, si ripercorre la storia di “due mondi che dovrebbero interagire come l’acqua e l’olio. E che invece si mescolano di continuo”. Ma, anche se, come assicurano Gratteri e Nicaso, “le cose stanno cambiando”, anche ieri a Cosenza in occasione della presentazione del libro si gridava: “troppi preti amici dei boss”. Papa Francesco, come dice il magistrato sotto scorta dal 1989, sta cambiando le cose all’interno della chiesa “sta facendo innervosire la mafia finanziaria. Se i boss potessero fargli uno sgambetto, non esiterebbero”.
Ma, qual è l’atteggiamento “mafioso” di alcuni sacerdoti? Certo, portare la statua della madonna sotto il balcone del mafioso deviandone l’abituale percorso; “procurare” la benedizione papale alla figlia di Condello sposata nel duomo di Reggio Calabria; prendere il caffè e l’aperitivo insieme ai boss. Certo, è anche questo. Ma è anche sfruttare il bisogno, calpestare i diritti degli ammalati.. vedi Serra Aiello. Atteggiamento mafioso dei sacerdoti è anche, come succede ricorrente nelle nostre parrocchie, chiedere contributi a gente “in odor”, per ristrutturare le chiese appellandosi al detto machiavelliano de “il fine giustifica i mezzi”. Nelle nostre parrocchie numerosi sono gli atteggiamenti di molti sacerdoti che potrebbero confondersi per “mafiosi”, evidenziati anche nei “piccoli” gesti. Ci sono preti che non si guardano in faccia e, con fare, questa volta si, mafioso senza virgolette, se ne dicono di tutti i colori fino a minacciarsi; preti che denunciano il confratello ricorrendo alla giustizia terrena per muovere ogni genere di accusa. Preti che, nonostante tutto questo, dopo qualche minuto celebrano messa e predicano pace dal pulpito. Mafioso, diceva qualcuno, non è solo chi uccide il corpo ma, lo è soprattutto chi uccide quotidianamente “solo derogando”. Infine, se volete, mafioso è anche chi, a conoscenza di queste situazioni, “semplicemente tace”: in gergo mafioso lo chiamano omertoso.
‘Ndrangheta e Chiesa: un oscuro legame per controllare i territori
«In qualità di sacerdote e massimo referente religioso del santuario della Madonna della Montagna in Polsi, grazie all’autorevolezza derivante dai suddetti ruoli, mediava nelle relazioni tra esponenti delle forze dell’ordine, della sicurezza pubblica ed esponenti di rango della ‘ndrangheta. In funzione di garante delle promesse e di agevolatore dello scambio tra le informazioni gradite ai primi e varie forme di agevolazione gradite ai secondi, in maniera che l’azione di contrasto dello Stato si nutrisse di apparenti successi, dietro ai quali nulla mutasse nelle reali dinamiche di potere interne alla ‘ndrangheta ed in quelle correnti tra quest’ultima e le altre strutture di potere, riconosciute e non riconosciute». Un ruolo di raccordo. Di collante tra mondi diversi quello che avrebbe rivestito don Pino Strangio. È questa una parte del capo d’imputazione per il quale il sacerdote, pochi giorni fa, è stato condannato a 9 anni e 4 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito del maxiprocesso “Gotha”, celebrato contro ‘ndrangheta, massoneria e politica.
‘Ndrangheta e religione
La condanna di don Pino Strangio, per anni rettore del Santuario di Polsi, è l’ennesima tappa di un pericoloso percorso che ha visto, negli anni, le strade di ‘ndrangheta e religione incrociarsi pericolosamente. «La condanna penale in primo grado di un sacerdote della diocesi suscita dentro di me sentimenti diversi. Pur non conoscendo ancora le motivazioni della sentenza, da una parte sono profondamente addolorato per la gravità delle accuse che hanno portato alla determinazione del Collegio penale e dall’altra ho molta fiducia nell’operato della Magistratura. Mi propongo d’incontrare il sacerdote appena possibile, per un’approfondita valutazione della sua vicenda giudiziale nel contesto pastorale ed ecclesiale». Così, il vescovo di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, ha commentato la condanna di don Pino Strangio.
Da sempre, la ‘Ndrangheta ruba simboli, ruba credenze, ruba riti. Tutto è funzionale a creare una identità culturale. Qualcosa che possa creare proselitismo e senso di appartenenza. Soprattutto presso i più giovani. Ma tutto è funzionale anche a mantenere quel controllo del territorio, senza il quale le cosche non riuscirebbero a condizionare la vita politica, economica e sociale dei luoghi e delle comunità. Solo per fare un esempio, l’importanza delle feste religiose nei paesi calabresi. Lì, molto spesso, un ruolo fondamentale nell’organizzazione degli eventi, così come nelle processioni, è rivestito dalla ‘ndrangheta. Da Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, alla “Affruntata” di Sant’Onofrio, nel Vibonese. Noti, molto noti, gli esempi degli “inchini” delle immagini della Madonna davanti alle case dei boss ai domiciliari. E altrettanto documentati i sequestri di materiale sacro, dai vangeli alle bibbie, passando per leimmaginette sacre, che spesso vengono rinvenute nei bunker dei grandi latitanti.
In tal senso, riveste un ruolo fondamentale in seno alla ‘ndrangheta il culto per la Madonna della Montagna. Proprio lì, a Polsi, dove don Pino Strangio era rettore del Santuario. Don Pino Strangio, sempre secondo il campo d’imputazione per cui è stato condannato in primo grado, avrebbe rafforzato «la capacità dell’organizzazione criminale di controllare il territorio, l’economia e la politica ed amplificando la percezione sociale della sua capacità d’intimidazione, generatrice di assoggettamento e omertà diffusi».
Da diversi collaboratori di giustizia e nell’ottica della magistratura, don Pino Strangio è considerato l’erede di un altro prete assai controverso. Per qualcuno un mafioso, per altri un martire. Prete ad Africo, roccaforte della ‘ndrangheta dell’area jonica. Da sempre la figura di don Giovanni Stilo divide. Il suo nome è legato anche alla figura di Antonino Salomone, uomo di rango di Cosa Nostra. Il prete avrebbe favorito la sua latitanza.
Colluso o martire? Don Giovanni Stilo
Una circostanza raccontata per primo dal collaboratore di giustizia Giacomo Lauro: «Salomone proveniva dal Brasile e doveva incontrarsi a Parigi con un suo nipote, Alfredo Bono, da me conosciuto nel 1978-79. Il nipote avrebbe dovuto accompagnarlo a Palermo per discutere su di un impegno che Salomone aveva assunto ma che non aveva mantenuto. Salomone pero non passò da Parigi, ma entrò in Italia attraverso la Germania. E quindi comparve ad Africo, dove rimase per oltre un mese, ospite di don Giovanni Stilo, in una casa adiacente all’istituto Serena Juventus. So che qualche tempo prima, precisamente dopo il 1981, anche Salvatore Riina fu presente in Africo, cosi come lo fu a San Luca. Nel periodo in cui si trovava ad Africo indossava abito da prete».
Proprio grazie all’istituto Serena Juventus e ai suoi rapporti con la politica e, in generale, il potere, don Stilo avrebbe accresciuto il proprio potere. Anche di natura clientelare. Il fratello sarà anche sindaco. Ovviamente nelle file della Democrazia Cristiana.
Di don Stilo parla anche il collaboratore di giustizia Filippo Barreca, che definisce «notoria» l’appartenenza del prete di Africo alla massoneria: «Don Stilo si riforniva ogni volta che passava dal distributore di carburante da me gestito a Pellaro e l’avevo conosciuto negli anni Settanta quando dovevo raccomandare una ragazza […] che doveva sostenere esami presso la sua scuola di Africo. Per cui andai da don Stilo assieme a “Peppe Tiradritto” e cioè Giuseppe Morabito. Devo però aggiungere che anche l’ex onorevole Piero Battaglia, allora consigliere comunale, l’aveva raccomandata al medesimo don Stilo. L’intero paese di Africo fu costruito grazie ai rapporti di don Stilo conl’onorevole Fanfani».
Secondo Barreca, don Stilo avrebbe avuto importanti relazioni sia all’interno dell’ospedale di Locri, sia soprattutto all’interno dell’Università di Messina. Lì dove riusciranno a laurearsi decine di rampolli di ‘ndrangheta, diventando di fatto classe dirigente. Legami che, comunque, passerebbero sempre dalla comune appartenenza massonica: «Ci fu un periodo in cui l’Università di Messina era una sorta di dependance di Africo Nuovo, nel senso che vi comandavano don Stilo e i suoi accoliti».
Don Stilo viene anche arrestato e processato con l’accusa di connivenza con la ‘ndrangheta e, in particolare, con le cosche Ruga, Musitano e Aquino. A pesare sul prete erano intercettazioni telefoniche e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Il prete di Africo era accusato di aver presenziato ad alcuni summit mafiosi, cosi come disse il pentito Franco Brunero. Ma, soprattutto, di aver aiutato nella latitanza il boss di San Giuseppe Jato, Antonio Salomone, cugino di Salvatore Greco, detto “Totò l’ingegnere”, uno dei capibastone di Ciaculli. Il Tribunale di Locri, nel luglio del 1986, condannò Don Stilo a cinque anni di carcere. La Corte d’Appello di Reggio Calabria confermò la condanna nei suoi confronti. Ma la Corte di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale (il giudice passato alla storia come “ammazzasentenze”), rimise tutto in discussione. Nuovo processo di secondo grado a Catanzaro. Don Stilo, nel giugno del 1989, fu assolto da ogni accusa.
Oggi collaboratore, ma prima medico, uomo in contatto con le cosche della Piana di Gioia Tauro e anche massone. Il dottor Marcello Fondacaro riversa le proprie conoscenze sul mondo della masso-‘ndrangheta ai pm della Dda di Reggio Calabria. Fondacaro parla dei rapporti tra le logge di Reggio Calabria e quelle di Trapani. Due aree, il Reggino e il Trapanese, tra le più povere d’Italia, ma anche le più gravide di massoni: «Don Stilo lasciò la sua eredità a Don Strangio di San Luca. La sua eredità intesa eredità di rapporti, di rapporti politici, di rapporti massonici».
Il bubbone ‘ndrangheta nella Chiesa
Dal passato a oggi, la funzione dei sacerdoti, quindi, ha rivestito sempre un’importanza vitale negli equilibri. Soprattutto nei piccoli centri. E, purtroppo, talvolta parliamo di equilibri di ‘ndrangheta. Don Pino Strangio, infatti, avrebbe avuto anche un ruolo nei rapporti tra Stato e ‘ndrangheta nel periodo successivo alla strage di Duisburg, avvenuta il 15 agosto del 2007. Le ingerenze delle cosche a Polsi, a Sant’Onofrio o in altri luoghi sparsi su tutto il territorio calabrese sono solo punte più visibili e affilate di un iceberg. Che è molto più grande. Che comprende un controllo capillare, sistematico, da parte delle ‘ndrine sulle celebrazioni sacre. Un controllo messo in atto con la stessa cura e precisione con cui si controllano gli appalti. Con essi si accumulano ricchezze. Con il controllo sociale delle masse, invece, si conquista e si mantiene il potere.
Non è un caso. Non può essere un caso che alcune tra le cariche e le strutture più importanti della ‘ndrangheta abbiano richiami di natura massonica e religiosa. Dal Vangelo alla Santa. Passando per San Michele Arcangelo. Che, curiosamente, è sia patrono della Polizia, sia della ‘ndrangheta. E, ovviamente, il ruolo rivestito dal Santuario della Madonna della Montagna a Polsi, che per anni ha visto insozzata le propria funzione religiosa e spirituale da riunioni e summit di ‘ndrangheta.
È il 21 giugno del 2014 quando Papa Francesco, nella Piana di Sibari a Cassano allo Ionio, lancia la scomunica ad ogni forma di criminalità organizzata. Volutamente il Pontefice ha scelto la Calabria. La regione, forse, dove la Chiesa ha fatto meno contro la ‘ndrangheta. Soprattutto se si pensa ai preti martire, come don Pino Puglisi, in Sicilia. O don Peppe Diana, in Campania.
«I mafiosi non sono in comunione con Dio» disse Papa Francesco. Da quel giorno, nulla o quasi è cambiato. Una parte della Chiesa continua a essere timida sulla lotta alla ‘ndrangheta. E non sono inusuali i collegamenti, talvolta solo relazionali, ma altre volte anche di natura criminale, tra le tonache e il mondo delle ‘ndrine. All’inizio del 2021, due preti del Vibonese sono stati anche rinviati a giudizio per tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose. Claudio Cordova 6
Don Mario Frittitta, il carmelitano scalzo che confessava il padrino latitante
Lo portarono in manette all’Ucciardone una mattina di novembre di vent’anni fa e quelle immagini fecero subito il giro del mondo. Un frate carmelitano a testa bassa fra due poliziotti della squadra mobile con l’accusa infamante di aver favorito la latitanza di un boss mafioso. E mica uno qualsiasi. No, quel padrino inseguito dai poliziotti di tutta Italia era Pietro Aglieri, il più grosso e ricco trafficante di droga della Sicilia occidentale. Un pezzo da novanta di Cosa Nostra che nel suo percorso mistico di avvicinamento a Nostro Signore – tra una partita di coca e un carico di eroina da raffinare – si era fatto costruire un altare nel suo rifugio segreto e, per celebrare messa ed espiare i suoi peccati, di un prete aveva sicuramente bisogno. Fu così che don Mario Frittitta, il parroco della Kalsa, il quartiere arabo di Palermo nel quale erano nati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, si ritrovò alla fine del ’97 in prima pagina su tutti i giornali e le televisioni. La notizia apparve all’alba su Televideo e nel giro di qualche ora diventò di dominio pubblico. Da tempo giravano voci su quel frate, pochi però si aspettavano un epilogo del genere. I poliziotti lo accusarono di avere incontrato più volte Aglieri nel suo rifugio e di aver interpretato con un eccesso di zelo il suo mandato pastorale. Non solo confessioni e messe cantate, insomma, ma anche preziosi consigli al boss del tipo: “Pietrù, non pentirti mai con la giustizia terrena…”. Rimase quattro giorni in isolamento, poi lo spedirono lontano dalla Sicilia. Il suo quartiere, manco a dirlo, si schierò compatto con lui, persino il vescovo dell’epoca manifestò “grande dolore” per l’arresto di quel religioso e si scagliò contro “i giornali ingiusti che sono perverse cattedre di violenze di ogni genere”.
In primo grado don Mario si difese con i denti: “Certo che ho incontrato Pietro Aglieri, ma io volevo solo convertirlo”. I giudici non gli credettero e lo condannarono a due anni e quattro mesi. Poi il colpo di scena: assolto in Appello e in Cassazione. “La conversione del peccatore, anche del mafioso messo al bando dalla stessa Chiesa, è un diritto che ogni sacerdote può esercitare. E dunque non può essere condannato per favoreggiamento un prete che ha incontrato di nascosto un latitante per portargli conforto spirituale”.
Le motivazioni della Suprema corte non lasciarono spazio ai dubbi: “I sacerdoti non sono tenuti a correre da giudici e carabinieri per consegnare persone o informare di reati dei quali vengono a conoscenza a causa del loro ministero”. Insomma, come sostiene il diritto canonico, rientra nei compiti dell’uomo di Chiesa la “conversione del peccatore, sebbene privato dell’ausilio sacramentale dell’eucarestia”. Nessun reato, comportamento lecito da prete, assolto con tante scuse. Un trionfo per don Frittitta che, rientrato alla Kalsa, fu accolto come un eroe.
Lui, ovviamente, ha perdonato tutti fin da quella domenica di maggio del 2001, quando nell’omelia subito dopo la sentenza definitiva di assoluzione, invocò la misericordia di Dio sui suoi accusatori. Con centinaia di fedeli in piedi a fargli la standing ovation e a chiedergli una foto ricordo per l’occasione. Mentre qualche fan un tantino più esagitato sfogava sui cronisti, “sbirri e sciacalli”, la sua rabbia.Storie vecchie, per don Mario è acqua passata. Ha chiesto i danni per quei quattro giorni in cella, un risarcimento – sia chiaro – da devolvere ai bambini poveri della Kalsa. “Mi è stato concesso il privilegio umano e cristiano di capire la sofferenza degli altri” ha recentemente raccontato a un giornale online. “Lo rifarei? Certo che lo rifarei. Io sono un uomo di Dio e un uomo di Dio cerca la pecorella smarrita sulla roccia più impenetrabile. Lo rifarei oggi, domani, dopodomani. Chiaro?”.
Chiarissimo. Ha pure difeso gli inchini alle case dei boss – le “pecorelle smarrite” appunto – durante le processioni religiose. E ci ha persino fatto sapere che mica era solo lui il prete che andava a confessare i latitanti: “A Palermo ce ne sono tantissimi…”. Sembrava scomparso dai radar fino quando i giornalisti raccontarono l’ultimo incidente giudiziario nel quale era incappato: una mansarda abusiva sul terrazzo della sua chiesa. Niente di grave, per carità, probabilmente soltanto l’estremo tentativo di dormire un po’ più vicino al cielo e a quel Padre che ha servito per tutta la vita. I parrocchiani l’hanno immediatamente perdonato. Adesso le minacce al cronista di “Repubblica”. Ma, c’è da giurarci, anche questa volta il suo “popolo” lo difenderà a spada tratta.
Don Agostino, l’amico intimo dei Corleonesi
“Gesù, Gesù, ora pure un parrino in Cosa nostra”, disse Giuseppe Calderone a suo fratello Antonino che, quella notte del 1969, guidava nel buio. Stavano tornando a Catania da Palermo dove si era svolta una riunione della Commissione regionale della mafia, della quale Giuseppe faceva parte.
Quel giorno, a un certo punto, nella stanza del summit era entrato un prete che, con tutti i dubbi del caso sulla fisiognomica, aveva proprio la “faccia del mafioso”: viso rozzo, occhiali bruniti con la montatura d’oro, radi capelli bianchi. Si chiamava Agostino Coppola, un don sia in senso ecclesiale che mafioso.
Don di chiesa, dunque, in quanto parroco di Carini, e don di Cosa Nostra, appena “combinato” a Ramacca.
Ma essere ammesso a quella riunione lo aveva, è il caso di dire, consacrato. Era una presentazione ai massimi livelli e, in ossequio al protocollo canonico, avevano detto: “Lui è come a noialtri”. Aveva 32 anni. Uno promettente, insomma, visti gli organigrammi dell’allora gerontocrazia mafiosa.
D’altra parte don Agostino era uno di “buona famiglia”. Era, per esempio, nipote di Coppola Francesco che a Bruccolino era diventato Frank Coppola e boss. E siccome aveva avuto un incidente con la perdita di due dita di una mano, aveva aggiunto al nome americanizzato anche il temibile nickname “three fingers”, tre dita.
Agostino era diventato prete perché nello stile di vita della Sicilia Antica, farsi prete era una svolta: intanto era un lavoro, poi ci si procacciava un’istruzione nei seminari e, se andava bene, si finiva con l’”amministrare” un territorio, quello della parrocchia o uno, addirittura, diocesano. Va ricordato che la Diocesi di Monreale è una delle più grandì della Sicilia ed è sede arcivescovile. E don Coppola, all’apice della sua carriera ecclesiastica, ne sarebbe presto diventato amministratore dei beni.
Il territorio è quello che è: Palermo, Monreale, Corleone, Partinico, Montelepre. Nella toponomastica mafiosa sono i Luoghi dell’Origine, quelli della mafia del feudo, dei campieri, dei soprastanti. E Agostino viene attratto come la tavoletta calamitata di un ficodindia attaccata al frigorifero di casa. Quasi impossibile salvarsi. Chi sono gli amici di padre Coppola? Uno fra tutti: Luciano Liggio. La “primula di Corleone” diventa il mentore principale del giovane prete rampante che comincia ad operare come “uomo di fiducia” in operazioni dove la fiducia (con la fedeltà) era il primo requisito.
E’ la stagione in cui in Cosa Nostra alcuni giovani puledri cominciano a scalpitare per i vincoli, diciamo così, etici su certe attività. Tutti sanno che la mafia non si occupa di meretricio e, fino alle soglie degli Anni Settanta, c’era una certa opposizione ad occuparsi di traffico di stupefacenti.
Tra le cose “proibite” in Sicilia, c’erano i sequestri di persona. Troppo “scruscio”, troppo clamore che attira sbirri, controlli, provvedimenti, lacera consolidate reti di rapporti amichevoli tra le cosche e certi apparati pubblici. Ma Liggio se ne fotte, è rampante, violento, vanesio al limite di un narcisismo maniacale. Così organizza la sua cosca e la specializza nei sequestri di persona.
Comincia con Luciano Cassina, figlio di uno dei più importanti imprenditori palermitani. Ma entra in conflitto coi vecchi vertici di Cosa nostra. Così, prudentemente, si allontana e se ne va in Calabria da dove gestisce altri due rapimenti tra i quali quello del conte Rossi di Montelera. E in Calabria si porta pure don Coppola che però si “spoglia” e per non dare nell’occhio arriva in compagnia di una donna.
Il ruolo del bis-don era quello di tenere i contatti con le famiglie dei sequestrati e incassare i riscatti. Non è cosa che si possa affidare al primo che passa. E Agostino se la cava benissimo. Ma poiché la storia della mafia è costellata di Misteri che non sono misteri, gli investigatori gli zompano addosso, lo denunciano, trovano in casa sua milioni provenienti dal sequestro Rossi.
Padre Coppola evita la prima condanna (per il sequestro Cassina) perché in suo favore si muove addirittura il potentissimo arcivescovo di Monreale monsignor Corrado Mingo che dichiara sotto giuramento di essere stato lui a chiedere a padre Coppola di contattare i sequestratori e offrirsi come mediatore “a tutela della incolumità del rapito”. Il che, tuttavia, dimostra che il monsignore sapeva benissimo quanto valeva il suo don.
Ma con il sequestro di Rossi di Montelera la cosa non funziona e Coppola viene condannato a 14 anni di galera. Soltanto dopo la scarcerazione viene finalmente sospeso “a divinis” e spogliato dell’abito talare. E, come Napoleone, don Agostino, stette e dei di che furono l’assalse il sovvenir, come quando aveva celebrato le “nozze latitanti” del Capo dei Capi Totò Riina con Ninetta Bagarella.
E non sappiamo quali altri episodi del ministero sacerdotale lo abbiano visto protagonista tra battesimi, estreme unzioni matrimoni e funerali.
La salute non era granché. Problemi polmonari lo costringevano a frequenti ricoveri in ospedale. Ma ora era “spogliato”, libero dal vincolo del celibato. Come in un libro scritto male lui, triste solitario e alla fine, si innamora di una dottoressa e la sposa. Ma, poiché “chi è nato tondo non può morire quadrato”, la sposina si chiama Caruana, esponente della omonima famiglia dell’Agrigentino, protagonista del traffico di stupefacenti tra Canada, Venezuela e la Sicilia.
Padre Coppola muore nel febbraio 1995 e da allora, sicuramente, manifesta il suo veemente disappunto per il fatto di essere finito, immeritatamente, all’Inferno. di Daniele Billitteri La Repubblica 2018
Platì, il parroco contro il divieto di funerali all’esponente dei clan: “In Chiesa comando io, non lo Stato”
“La Chiesa deve dire di no alla ‘ndrangheta. I mafiosi sono scomunicati. La ‘ndrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato. Bisogna dirgli di no”. Le parole di Papa Francesco pronunciate durante la sua visita in Calabria nel giugno 2014 erano chiare. Non lasciavano adito a fraintendimenti. Eppure non sono state ascoltate da tutti. Sicuramente non le ha ascoltate don Giuseppe Svanera, parroco di Platì, che ai mafiosi non solo dice di sì, ma gli celebra i funerali, “li attende in chiesa e va a visitarli”. La polemica si è consumata tutta tra il 22 e il 23 ottobre quando il questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi ha notificato al parroco un’ordinanza con cui ha vietato i funerali pubblici e in forma solenne per Giuseppe Barbaro conosciuto con il soprannome di “U cenni”. Si tratta di un esponente di spicco della ‘ndrangheta di Platì che nei giorni scorsi, a 54 anni, è morto in carcere dove stava scontando una pena perché condannato dal Tribunale di Torino a 5 anni nel processo “Minotauro”. Dal Piemonte alla Calabria, le regole della ‘ndrangheta sono le stesse. Comprese quelle dei funerali, ritenuti un momento importante per le famiglie mafiose che, proprio in queste occasioni, sfoggiano il loro potere e la loro capacità di piegare anche la Chiesa.
IL RICORSO AD ALFANO CONTRO IL QUESTORE – Per Giuseppe Barbaro, all’insaputa del vescovo di Locri, don Giuseppe Svanera prende carta e penna e scrive al ministro Angelino Alfano formulando un ricorso avvers o l’ordinanza del questore sostenendo che ha “infranto il principio di non ingerenza tra Statoe Chiesa”. Nella lettera, il parroco di Platì sfoggia le sue conoscenze giuridiche e, “sicuro di vostro benevole accoglimento del ricorso”, prima ricorda ad Alfano alcuni articoli della Costituzione e una sentenza del Tar della Campania e poi giunge alla conclusione che il “provvedimento di divieto questorile integra un illegittimo impedimento e limitazione allo svolgimento dell’ordinario rito funebre in forma pubblica previsto dal rito cattolico”. ‘Ndrangheta uno, Chiesa zero.
FUNERALI VIETATI PER TUTTI I MAFIOSI – Eppure il divieto dei funerali pubblici non è una novità in territori come quello di Platì. Poche settimane fa c’è stata la stessa ordinanza in occasione della morte del boss Paolo Sergi, un noto trafficante di cocaina coinvolto in numerose inchieste antimafianell’ambito delle quali erano emersi i contatti tra il mondo dei narcos e delle brigate rosse. A queste latitudini, non c’è un mafioso morto che può vantare di aver ricevuto un trattamento diverso da quello imposto dal questore Raffaele Grassi.
Portano la sua firma, infatti, i divieti per altri funerali: da quello di Rocco Musolino, il “Re della Montagna” (ritenuto un boss anche se non è mai stato condannato per mafia), a quello dell’imprenditore di Palmi Vincenzo Oliveri, da quello del boss Antonio Nirta di San Luca a quello di Domenico Polimeni(uomo di fiducia dell’ex pentito Giuseppe Greco ucciso ad aprile).
E questi sono solo i morti eccellenti degli ultimi mesi per i quali è stato vietato il funerale in forma solenne, così come in passato è stato per il boss di Gebbione Santo Labate, per Domenico Vallelunga (padrino di Serra San Bruno), per il boss di Rosarno Giuseppe Pesce, per quello di Sinopoli Mico Alvaro, per il mammasantissima di Siderno Vincenzo Macrì (conosciuto con il nome di “barone”), per l’anziano patriarca Nicola Cataldo e per il reggente della cosca di Seminara Giuseppe Vincenzo Gioffré.
Ma a Don Giuseppe Svanera questo non interessa. D’altronde l’anno scorso aveva concesso una stanza della parrocchia per una protesta (organizzata dall’attuale sindaco di Platì Rosario Sergi) contro la frase del sottosegretario Marco Minniti che, dopo gli attentati terroristici in Belgio, aveva affermato “Molenbeek come Platì”. Una frase che non ha provocato un incidente diplomatico ma che, paradossalmente, ha urtato la suscettibilità degli abitanti di Platì.
DON GIUSEPPE CONTRO LO STATO – Ritornando al funerale di Giuseppe Barbaro, sentito telefonicamente da ilfattoquotidiano.it il parroco rincara la dose: “È arrivata un’ordinanza del questore, l’ha portata la polizia e semplicemente ho detto che non sono d’accordo. Ho fatto tutto quello che c’era scritto lì, ma allo stesso tempo ho pensato che era conveniente e doveroso mandare questa nota al ministro Alfano. Personalmente non sono d’accordo che un questore possa proibire un funerale in chiesa. Un corteo lo può proibire senza nessun problema, ma in chiesa non comanda lo Stato. E dato che questo signore era battezzato e i familiari volevano i funerali in chiesa, io i funerali li faccio in chiesa, piaccia o non piaccia al questore. Non è lui che deve dare ordini”. E dopo la benedizione della salma al cimitero? “Alle 11 abbiamo celebrato la nostra messa in chiesa perché i familiari avevano affisso i manifesti con gli avvisi. Pensavamo di fare il funerale con il corpo ma l’abbiamo fatto senza. Però l’abbiamo fatto”.
Ma la Procura ritiene che Barbaro fosse un mafioso? “Io non so cosa pensa e cosa fa la ‘ndrangheta. Quello che è chiaro è che sono cittadino italiano e in quanto tale esigo che si compiano certi diritti. Io sono prete e, quindi, sono a disposizione della mia comunità cristiana, agli ordini del vescovo. Nessun può interferire su cosa faccio in chiesa. La ‘ndrangheta non è una questione mia. Sono venuto qui a fare il prete e non a cercare i mafiosi. La ‘ndrangheta è una questione dei giudici, dei carabinieri e degli avvocati. Che facciano il loro lavoro. Io faccio il mio. Qui ci sono almeno 600 o 700 persone di cognome Barbaro. Chi sono i criminali lo devono sapere i carabinieri. Io so che ci sono queste persone, li attendo quando vengono in chiesa, vado a visitarli. Io di mafia so solo quello che voi giornalisti scrivete. Per me un mafioso ha gli stessi diritti di una persona che non lo è”.
IL PROCURATORE DE RAHO: “I FUNERALI PUBBLICI VENGONO VIETATI PER EVITARE EPISODI COME QUELLO DEI “CASAMONICA” – “Credo che la Chiesa debba con lo Stato (e quindi con le forze dell’ordine e con la magistratura) condividere un percorso di legalità senza contrapposizioni soprattutto quando il tema è la partecipazione di famiglie di ‘ndrangheta a manifestazioni pubbliche. Anche se queste, poi, si concretizzano in funeraliorganizzati da famiglie mafiose che rappresentano una manifestazione del potere della ‘ndrangheta”. Per il procuratore di Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho non ci sono dubbi su come in certi territori la Chiesa sia sottomessa alle cosche: “Probabilmente – aggiunge a il fattoquotidiano.it – bisognerebbe che tutti ci muovessimo in un’unica direzione per avere un risultato più immediato anche nei confronti della ‘ndrangheta. San Luca e Platì sono comuni in cui la ‘ndrangheta ha un ruolo di signoria”.
Non lo dice espressamente, ma a questo punto il magistrato pone pure la questione dei contributi dati alle chiese: “La forza della ‘ndrangheta è quella che elargisce anche denaro. A volte non si guarda a chi dà il denaro o altre forme di contributo, ma si guarda soltanto a quello che si riceve. Se cominciassimo anche sotto questo profilo a selezionare i contributi, e tutto ciò che fa la mafia per apparire vicina alla religione e alla chiesa, probabilmente si comincerebbe a meditare sui comportamenti che sono stati tenuti. Quando chi rappresenta i valori e i principi della religione si oppone ai comportamenti di censura nei confronti della ‘ndrangheta, si crea una confusione enorme anche nella gente. Quella gente che è assoggettata al potere mafioso e che si accorge che nemmeno la Chiesa si oppone a chi fa del male”. “Il questore – conclude De Raho – doveva vietare i funerali in forma pubblica e questo avviene anche per evitare episodi come quello dei Casamonica. La popolazione è indirettamente e implicitamente costretta a partecipare ai funerali. Chi non partecipa finisce per rappresentare il proprio dissenso e questo nelle comunità piccole è gravissimo e non può avvenire. Così un rito religioso finisce per tradursi in una manifestazione di potere”.
IL VESCOVO OLIVA: “SE NON POSSIAMO NEANCHE PREGARE…” – Sul funerale del boss Giuseppe Barbaro, interviene anche il vescovo di Locri Francesco Oliva che racconta cosa è successo domenica quando si è precipitato a Platì per capire cosa stava facendo don Giuseppe: “Pensavo che il prete non avesse rispettato l’ordinanza del questore – ha spiegato a ilfattoquotidiano.it – Ero preoccupato e invece lui l’ha rispettata. Ho definito Giuseppe Barbaro un ‘padre di famiglia’ perché lo è: è sposato e ha quattro figli. Ma con questo non voglio giustificare i precedenti criminali. Che fuori dal cimitero si siano radunate delle persone, non dipende dal parroco. Chi deve fare rispettare l’ordinanza da questo punto di vista?”. E sulla messa in chiesa dopo la benedizione al cimitero? “Pregare per un defunto, – aggiunge il vescovo – chiunque esso sia, anche un delinquente, si fa sempre. Sono disposizioni dei vescovi calabresi. Si è sempre fatto così. Sono vietate le manifestazioni pubbliche, ma pregare per un defunto si può fare. Se non possiamo neanche pregare… a questo punto chiudiamo le chiese. Il parroco ha fatto quell’istanza al ministro Alfano senza consultarmi”. L’alto prelato prende le distanze dal ricorso di don Giuseppe Svanera. E nello stesso tempo lo difende: “L’unico divieto è che queste celebrazioni non avvengono in maniera solenne. Ma una messa sobria e senza la salma è una cosa ordinaria. La chiesa prega anche per il peccatore”. di Lucio Musolino| 24 Ottobre 2016 FQ
Religione, mafie, Chiese: un rapporto controverso tra devozione e secolarizzazione
«Coloro che nella loro vita seguono questa strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio: sono scomunicati!» Sono decise le parole pronunciate da papa Francesco di fronte a una folla di fedeli radunata per assistere alla celebrazione eucaristica, sulla piana di Sibari. Parole che affrontano nel vivo l’ambiguo rapporto che lega gli uomini di mafia agli uomini di Chiesa, le organizzazioni criminali e le sacre liturgie. Parole taglienti che provocano altrettanto decise e immediate risposte da parte dei clan colpiti da questo nuovo anatema papale. Così, a distanza di pochi giorni, il fercolo che trasporta la Madonna delle Grazie a Oppido Mamertina si ferma a omaggiare l’anziano boss Giuseppe Mazzagatti, condannato agli arresti domiciliari, mentre un gruppo di detenuti per reati di ’Ndrangheta, diserta in massa le celebrazioni eucaristiche nel carcere di Larino. Sono prove di forza. Scontri di potere. Tentativi di rivendicare una supremazia, con messaggi densi di una profonda carica simbolica. Accompagnati da gesti altrettanto eloquenti. È come un déjà vu. La mente ritorna a quel 9 maggio del 1993, quando nella Valle dei Templi di Agrigento, un altro papa pronunciava un’altret- tanto decisa condanna nei confronti degli uomini di Cosa nostra, invitandoli alla conversione e ricordando l’inesorabile giudizio di Dio. Anche in quel caso le reazioni – ancor più dure e violente – non tardarono a manifestarsi. E i devoti mafiosi bombardarono prima le chiese romane di San Giorgio al Velabro e di San Giovanni in Laterano (nella not- te tra il 27 e il 28 luglio del 1993) e assassinarono poi padre Pino Puglisi. Scorrendo le cronache – anche quelle meno recenti – non mancano minacce e violenze nei confronti di uomini di Chiesa. Come non manca- no esempi di collusione tra prelati e “uomini d’onore”. Soprattutto non mancano – dentro la Chiesa – posizioni ambigue e gravi disattenzioni. Come quando all’indomani dell’arresto di padre Mario Frittitta (che aveva celebrato messa nel covo del latitante Pietro Aglieri), mentre mons. De Giorgi e i cinque saggi incaricati di esaminare il caso parlavano di “inde- bita cappellania”, i confratelli di padre Frittitta dichiaravano alla stampa: «Abbiamo meditato tutti insieme, da fratelli, per capire se il metodo anti- mafia assunto dalla magistratura sia cristianamente accettabile. E abbiamo concluso che cristianamente non è accettabile»
”E’ proprio il richiamo del Papa a suonare come sprone per la stessa Chiesa affinché non sia tiepida bensì coraggiosa”, ”nessuno deve dimenticare il comportamento anche eroico di tanta gente di Chiesa. Ma, insieme, occorre riconoscere che ci sono state, e ci sono, anche tante fragilità, zone d’ombra”. «Alcune volte, purtroppo, la Chiesa è rimasta alla finestra rispetto a certi comportamenti lavandosene le mani. Altre volte, invece, è stata addirittura complice. Sono ambiguità non al servizio della verità. E ciò è sempre un male, perché sono comportamenti che tarpano le ali alle energie migliori, a coloro che, invece, vorrebbero mettere le proprie energie al servizio della positività». DON LUIGI CIOTTI 22.6.2014
Mafia e Chiesa, oltre la “zona grigia” il riscatto è nei territori – Intervista al giovane scrittore siciliano Salvo Ognibene, studioso del rapporto tra criminalità organizzata e mondo ecclesiastico I santini imbrattati di sangue al lume di un cero. Gli inchini dei santi patroni ai protettori terreni nel bagliore artificiale dei fuochi delle processioni paesane. Rituali o riti di passaggio obbligato, consumati spesso nel “religioso” silenzio della società civile, a suggellare simbolicamente un legame mai completamente interrotto: quello – da alcuni ritenuto indissolubile – tra mafia e chiesa. Due mondi opposti per definizione, che pure si incontrano e si intrecciano nella storia passata e recente d’Italia. Ma che talvolta si scontrano. Su territori difficili, come avvenne a Brancaccio per padre Pino Puglisi, beatificato due mesi dopo la salita al soglio pontificio di papa Bergoglio, altra figura rivoluzionaria in una Chiesa troppo spesso ambigua nei confronti di un male incompatibile con il messaggio evangelico. Inconciliabilità di fondo che tuttavia, ancora oggi, richiede prese di posizione esplicite per essere affermata: accade così che a Monreale il vescovo Michele Pennisi si trovi a emettere un decreto che dichiari, nero su bianco, come non possano essere ammessi padrini di battesimo o cresima che “appartengono ad associazioni di stampo mafioso o ad associazioni più o meno segrete” e “che hanno avuto sentenza di condanna per delitti non colposi passata in giudicato”. Pronunciazione del marzo scorso, seguita al rientro a Corleone di Giuseppe Salvatore Riina, figlio del capo dei capi che, scontata una condanna di otto anni, era tornato al paese per fare da padrino di battesimo alla nipote, con il permesso del giudice e il beneplacito di don Vincenzo Pizzitola.
MAFIA: Giuseppe Pignatone, Procuratore di Roma, “porre il problema della diffusione al Nord”
“La Chiesa deve porre il problema delle mafie al Nord, di quelle che esistono da Roma in su, perché pongono problemi nuovi”. A sottolineare questa urgenza è stato Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica di Roma, che ha preso parte all’incontro di presentazione della Lettera dei vescovi di Sicilia a 25 anni dall’appello di Giovanni Paolo II, che si è tenuto nella chiesa Santa Maria Odigitria, per iniziativa dei Centri Studi “A. Cammarata” e “Mons. A. M. Travia” e dell’Arciconfraternita Santa Maria Odigitria. “Abbiamo accettato che le mafie non sono solo al Sud”, ha spiegato Pignatone ricordando che “dopo le stragi del 92 e del 93, nessuno può dire di non sapere che la mafia esiste”. “Quelle stragi hanno rappresentato per Italia tutta e per la Sicilia in particolare l’età dell’innocenza rispetto alla mafia”, ha spiegato il procuratore della Repubblica di Roma evidenziando che “fino a quel momento era possibile, credendoci, ritenere che la mafia non ci riguardasse direttamente e fosse solo un problema criminale”. Ma, dopo le stragi del 92 e del 93, “lo Stato ha fatto uno sforzo serio che ha portato alla sconfitta di Cosa Nostra corleonese, quella appunto delle stragi”. “È un segno di speranza il fatto che quella Cosa Nostra sia stata sconfitta dallo Stato”, ha scandito Pignatone per il quale tuttavia occorre ancora lavorare per debellarla, consapevoli del fatto che “non basta scaricare le colpe addosso alla politica, perché lo Stato siamo tutti”. AGENSIR
NELLA MAFIA NON C’È VANGELO.
Giuseppe Pignatone (già Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e Roma ed ora Presidente del Tribunale del Vaticano): «I padrini vogliono usare la religione come strumento di potere» «Credo che non possa più essere messo in discussione il tentativo continuo dei capi delle organizzazioni mafiose di strumentalizzare la religione e l’importanza che ha per le popolazioni italiane in genere e ancor più per quelle meridionali. Su questo ci sono tantissime prove accumulate nei processi». È netto il giudizio del procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, una lunga esperienza di lotta alla mafia, prima a Palermo e poi alla guida della Procura di Reggio Calabria.
Ci racconti qualche esempio. «C’è l’intercettazione di un grosso capo mafia di Palermo, di una decina di anni fa, che raccontava l’incontro con un prete che gli aveva parlato del peccato di mafia. E lui si vantava di avergli risposto: “Ma dove è scritto questo peccato?”. C’è anche il commento che due giorni dopo la morte di Giovanni Paolo II fa un altro importante mafioso siciliano: “Poverino che era. A parte quella che ha fatto quando è venuto qua, un pochettino pesante per i siciliani in generale”. è un termine dialettale siciliano che si potrebbe tradurre come Dunque 12 anni dopo il discorso di Giovanni Paolo II ad Agrigento, con la condanna ferma della mafia, ancora ai livelli massimi di cosa nostra se ne dà questo giudizio negativo».
Quindi per le mafie la religione è uno strumento? «È uno strumento per il dominio che cercano di esercitare. Un esempio sono le feste religiose che, sia in Sicilia che in Calabria, i mafiosi tentano di trasformare in momenti di ossequio per il capo, come riconoscimento del suo potere».
E secondo lei la Chiesa come risponde? «Le prese di posizione ufficiali ai massimi livelli, da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, i documenti dei vescovi, sono di condanna senza appello della mafia, definita come un cancro della società. In mezzo c’è la vita di ogni giorno. Ma soprattutto c’è un atteggiamento diffuso, certamente non trascurabile, anche nella Chiesa così come in tanti settori della società, che dice che tutto sommato la mafia è un problema dello Stato e in particolare del suo apparato repressivo. Ed è molto pericoloso».
C’e una Chiesa troppo silente? «Dobbiamo prendere atto che ci sono preti come don Puglisi e altri che dicono “non mi riguarda”. Che ci sia una difficoltà anche nella Chiesa in queste nostre società meridionali credo non sia contestabile. Serve una presa di coscienza e che, come diceva don Puglisi, ognuno faccia la sua parte».
Già, se ognuno fa qualcosa…«… Il mondo cambierebbe. La Chiesa ha un ruolo importantissimo di educazione. La cultura mafiosa si assorbe fin dall’inizio, quando nasci appartieni automaticamente a un clan in lotta con gli altri. In certe realtà si assume col latte materno. E per il suo superamento la Chiesa può avere un ruolo fondamentale».
Servono preti antimafia? «La Chiesa non deve fare né indagini né processi. Dobbiamo farlo noi, ottenendo condanne e, indirettamente, creando spazi di libertà. Dopo di che ci vuole qualcuno che questi spazi li occupi. E li tenga occupati. In questo sono importanti alcuni esempi di sacerdoti e di associazioni, che sono cresciute negli ultimi anni, gestendo beni confiscati col sostegno del Progetto Policoro della Cei. Combattere la mentalità mafiosa, dare esempi alternativi: tutto questo molti sacerdoti lo fanno e l’augurio è che siano sempre di più».
Alcuni cosiddetti esperti di mafia dicono che il concetto del perdono quasi giustifica i mafiosi… «È assurdo. Qualche raro caso di mafioso seriamente pentito, non solo ai sensi del Codice, ma pentito nell’anima, c’è stato. Ma i mafiosi in quanto tali non si preoccupano del perdono futuro, ma solo del dominio presente. Nel momento in cui si ordinano reati gravissimi, non credo che i santini o l’appello continuo alla volontà di Dio possa camuffare quella che è la realtà». AVVENIRE
Mafia e ‘ndrangheta. L’inchino e la gestualità del corpo. Piegare la statua, farle fare un percorso “obbligato” per costringere il corteo di una processione a passare davanti a questa o a quella abitazione è un gesto di sudditanza tante volte accompagnato dall’ostentazione di una cospicua e pubblica offerta fatta al santo. Ma se è vero questo, è altrettanto vero che l’inchino di una statua, il fermarsi (anche per un attimo) di una processione presieduta dal sacerdote, con tanto di autorità civile e militare, è una vera e propria legittimazione che il boss vuole ricevere. Al mafioso-ndranghetista importa poco la devozione cristiana, perché vive una vita antievangelica fatta di soprusi, atti criminali, perfino di omicidi e vendette. L’inchino è qualcosa di più. È un fatto culturale Piegare la statua, farle fare un percorso “obbligato” per costringere il corteo di una processione a passare davanti a questa o a quella abitazione è un gesto di sudditanza tante volte accompagnato dall’ostentazione di una cospicua e pubblica offerta fatta al santo. Ma se è vero questo, è altrettanto vero che l’inchino di una statua, il fermarsi (anche per un attimo) di una processione presieduta dal sacerdote, con tanto di autorità civile e militare, è una vera e propria legittimazione che il boss vuole ricevere. Al mafioso-ndranghetista importa poco la devozione cristiana, perché vive una vita antievangelica fatta di soprusi, atti criminali, perfino di omicidi e vendette.
L’inchino è qualcosa di più. È un fatto culturale che pervade e penetra nelle midolla della socìetas calabrese più di quanto immaginiamo. Il capo mafia, il capo bastone, vuole l’inchino e gli basta. Non vuole altro, non pretende nulla da un popolo di poveri o di pezzenti. Vuole solo quel riconoscimento, quell’atto di sudditanza che in passato (quando si usavano le coppole) era togliersi il cappello in sua presenza, oppure passando davanti alla sua abitazione. Una vera e propria gestualità (liturgia del corpo), una meta-comunicazione fatta di baciamano, inchini, dallo scoprirsi il capo o abbassare la testa.Lì il capo si sente capo, il boss è soddisfatto nel suo super-Io che trova nei gesti della debolezza e della paura un terreno fertile dove seminare i semi della malapianta. Essa attecchisce proprio in questo terreno già preparato da silenzi, dall’obbligo del rispetto dovuto, dalle paure di essere messo al bando dalla comunità, e poi cresce con continue manifestazioni di ossequio, pretese assurde, fino a disporre della vita e delle cose degli altri. Alla Chiesa il compito di educare e la forza profetica di indignarsi, allo Stato quello di vigilare ed intervenire, al cittadino (che non va lasciato solo) il coraggio di non abbassare il capo davanti ai “signori” durante le diverse processioni liturgiche ma anche della vita. Loro ci provano, ci provano sempre, in ogni occasione, ma noi dobbiamo spezzare in qualche modo questa spirale. Enzo Gabrieli direttore del settimanale diocesano “Parola di Vita”- Cosenza 26.9.2020
Le Mafie e la Chiesa: analisi criminologica di un rapporto controverso Nel 1997 le forze dell’ordine dopo aver fatto irruzione nel covo del boss Pietro Aglieri – pezzo grosso dei vertici di Cosa Nostra, nonché uno dei mandanti per le stragi di Capaci e di via D’Amelio – trovarono una piccola cappella privata: sei panche, altarino con un grande crocifisso ligneo e due statue in gesso di Cristo e della Madonna [1]. Nella lingua siciliana, la Punciuta (puntura) indica il rito di iniziazione dei membri di Cosa nostra: la persona da iniziare viene condotta in una stanza alla presenza di tutti i componenti della Famiglia; l’iniziato, puntosi sull’indice della mano con una apposita spilla o con una spina d’arancio, giura fedeltà a Cosa nostra imbrattando col sangue una immaginetta sacra, per poi bruciarla – «giuro di essere fedele a cosa nostra. Possa la mia carne bruciare come questo santino se non manterrò fede al giuramento» [2]. Nella Camorra l’iniziazione avviene sempre con la puntura, ma, in questo caso, l’immagine usata è quella della Madonna di Pompei: tutti i presenti baciano l’immaginetta, l’omissione di questo passaggio da parte anche di uno solo dei partecipanti preclude all’iniziato l’accesso dell’organizzazione [3]. Nel 2010 il parroco di Sant’Onofrio annullò il tradizionale rito pasquale dell’affruntata a causa della presenza di esponenti della criminalità organizzata calabrese tra i portatori della statua della madonna: a seguito di questa decisione il parroco ricevette sì larga solidarietà, ma anche numerose intimidazioni [4].
Il rapporto tra le Mafie e la Chiesa Cattolica – intendendosi per “chiesa cattolica”, ai fini dell’analisi in questione, il culto cattolico in generale – può sembrare un accostamento azzardato, sicuramente controverso, ma non del tutto impensabile. A primo impatto sembra illogico, quasi contraddittorio, rapportare una fede fondata sull’amore (e sull’espresso dettame di “non uccidere”) a delle organizzazioni sanguinarie, eppure le mafie in generale curano con particolare minuzia i simboli e le pratiche della religione cattolica, dal rito del battesimo fino ai funerali. I gruppi mafiosi si qualificano tendenzialmente per la capacità di radicarsi nel territorio, disponendo delle risorse economiche e delle attività politico-istituzionali, ricercandone però il consenso sociale, essendo specialisti «della violenza e delle relazioni sociali» [5]. Cercano continuamente una legittimazione ed una appartenenza alla cultura del luogo che deriva dalla partecipazione ai riti ed alle cerimonie religiose: proprio per questo non si conoscono esempi di mafiosi atei, salvo il caso di Matteo Messina Denaro [6]. Mediante l’uso di linguaggio evocante l’elemento spirituale, la partecipazione attiva e soprattutto visibile alle feste religione, l’assunzione di ruoli di rilievo nelle medesime feste e nei riti religiosi stessi, il mafioso legittima la propria posizione di dominio all’interno della comunità locale, garantendosi così la signoria territoriale. La Chiesa ha aderito tendenzialmente in ritardo alla battaglia antimafia, il motivo di questo intervento tardivo è da attribuirsi non solo alla sottovalutazione del fenomeno mafioso quanto anche al condizionamento socio-culturali di stampo strettamente conservatore che marchiava la vita dell’epoca, dove la non reazione era frutto di una opposizione a qualsivoglia cambiamento di potere; dove ridottissime erano le quote di interventi episcopali [7]. Un esempio eclatante del rapporto ambiguo tra clero e mafie è rappresentato dal caso di Mario Frittitta: frate carmelitano arrestato negli anni ’90 con l’accusa di favoreggiamento del boss Pietro Aglieri, condannato in primo grado e poi assolto nei giudizi successivi. Frittitta non ha mai negato d’aver frequentato per un certo periodo il covo di Aglieri, derivando da questo comportamento l’accusa di averne favorito la latitanza; il frate si è giustificato adducendo come ci fosse la necessità degli uomini di chiesa di interloquire con le persone e soprattutto con i boss di mafia, proprio per favorirne la purificazione. Più che la vicenda giudiziaria e la motivazione del Frate molti studiosi hanno eccepito come il problema fosse rappresentato dall’aver trasmesso all’opinione pubblica un messaggio errato di vicinanza e comprensione verso il capomafia [8] Negli anni Settanta a Palermo, nel periodo di coesione maggiore tra mafia ed imprenditoria, il Cardinale Ruffini, di fronte alla furia mafiosa che si ripercuoteva quasi a cadenza giornaliera per le strade siciliane, ha sostenuto continuamente come la mafia fosse, in realtà, una “creazione dei comunisti”, evitando ogni riconoscimento ed individuazione del fenomeno. Ma la storia dei rapporti tra le Mafie e la Chiesa non è solo segnata da questi casi, passati, di coesistenza dei sistemi: dietro questo rapporto, inizialmente nato quasi da una esigenza di sopportazione, prudenza e conformazione territoriale, emerge col tempo un filone di protesta, di contrasto del fenomeno, di rifiuto, di tutela: è con il Cardinale Pappalardo che è iniziato il filone di denuncia ferma e aperta della violenza mafiosa, favorendo il riacquisto della dignità mortificata dagli atteggiamenti di complice prudenza. [9] Ai funerali di Boris Giuliano, nella così detta «messa antimafia», si rivolse direttamente ai mafiosi, dicendo: «Il profitto che deriva dall’omicidio è maledetto da Dio e dagli uomini e quand’anche riusciste a sfuggire alla giustizia degli uomini, non riuscireste a sfuggire a quella di Dio». Il 4 settembre 1982 ai funerali di Carlo Alberto Dalla Chiesa, dinnanzi agli uomini di politica presenti: «La mafia è un demone dell’odio, l’incarnazione stessa di Satana. Si sta sviluppando una catena di violenza e di vendette tanto più impressionanti perché, mentre così lente e incerte appaiono le mosse e le decisioni di chi deve provvedere alla sicurezza e al bene di tutti, quanto mai decise, invece, tempestive e scattanti sono le azioni di chi ha mente, volontà e braccio pronti a colpire. Sovviene e si può applicare una nota frase della letteratura latina: Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur; mentre a Roma ci si consulta, la città di Sagunto viene espugnata. Sagunto è Palermo. Povera la nostra Palermo! Come difenderla?». L’”omelia – così poi denominata – di Sagunto” ha segnato una svolta nella storia della lotta alla mafia, a rappresentazione del potere che anche il contrasto religioso, spirituale e sociale può avere nella lotta alla malavita. Dopo qualche giorno dalla omelia di Sagunto, in virtù del terremoto sociale conseguente alla morte di Dalla Chiesa, è stata approvata la legge n. 646/1982, meglio conosciuta come legge Rognoni-La Torre, con la quale viene introdotto il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso nel codice penale italiano; ha inizio, quindi, la lotta alla mafia, per come è conosciuta e riconosciuta oggi. «Occorre spezzare il legame esistente tra il bene posseduto ed i gruppi mafiosi, intaccandone il potere economico e marcando il confine tra l’economia legale e quella illegale», dietro le parole dell’on. Pio La Torre si nasconde la ratio della legge in questione: colpirle nelle ricchezze e nei patrimoni accumulati le mafie: togliere loro le ricchezze economico-finanziare significava dunque indebolirle e diminuirle nel prestigio [10]. All’art. 1 della l. n. 642/1982 si definisce l’associazione a delinquere di stampo mafioso, prevedendo come «l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali», mentre all’art. 1.7 si è disposto il sequestro e la confisca nei confronti del condannato delle cose che sono servite o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Un movimento, quello dell’antimafia, nato tra il fervore sociale, spinto da forze non solo politiche, ma anche ideologiche, fatto di grandi figure provenienti dai più svariati ambienti, anche clericali: oltre il caso Pappalardo citato, necessario è sottolineare i nomi di Pino Puglisi e di don Peppino Diana, simbolo del clero impegnato contro le mafie e disposto a sacrificare le proprie vite pur di non indietreggiare. Ad oggi tanti sono i sacerdoti impegnati nella lotta sociale: da don Pino de Masi (esponente di Libera) a don Giacomo Panizza [11]: figure che hanno il pregio di spostare l’impegno contro la mafia dal piano teorico a quello pratico e concreto, mediante una azione quotidiana di prevenzione e recupero svolto nei luoghi più pericolosi, esposti e fragili del territorio. DI ANTONIO ESPOSITO · ius initinere 05/12/2018
- [1] Di notevole apporto allo svolgimento dell’analisi in questione è l’approfondimento “I mafiosi e la religione” con Alberto Melloni di Roberto Fagiolo, in Rai storia.
- [2] Sul punto P. Grasso e A. La Volpe, Per non morire di mafia, Milano, 2009.
- [3] Sul punto R. Saviano.
- [4] Cfr. N. Fiorita, Mafie e Chiesa, in Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 24 settembre 2012.
- [5] Così R. Sciarrone, Mafie, relazioni e affari nell’area grigia, in R. Sciarrone (a cura di), Alleanze nell’ombra, Roma, 2011.
- [6] Sul punto E. Cicconte, Storia criminale, Soveria Mannelli, 2008.
- [7] Sul punto uno dei primi autori ad occuparsi del rapporto tra chiesa e mafie, M. TEDESCHI in Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico, Milano, 1990.
- [8] Cfr. A. Dino, La mafia devota, Bari, 2008.
- [9] Sul punto P. Grasso, Mafia e devozione. Il lungo silenzio della Chiesa prima dello strappo, 2009.
- [10] Sul punto Legge Rognoni – La Torre, in wikimafia.it
- [11] G. Foffi., G. Panizza., Qui ho conosciuto Purgatorio, inferno e paradiso, Milano, 2011.
Confesso che ho pagato – Preti a cui chiedono il pizzo. Mafiosi ricevuti in sacrestia. Vescovi amici dei collusi. La chiamano “Chiesa nostra” ed è la mafia che cerca di assoldare i sacerdoti. Sempre più soli e spaventati. Non solo nella Sicilia dei boss Quando tre anni fa è arrivato don Miguel Pertini nella chiesa allo Zen i “picciotti” glielo hanno detto subito: “Parrì (prete, ndr), deve mettersi a posto”. Il sacerdote è un italo-argentino e come vanno le cose a Palermo, in special modo nei quartieri degradati come quello in cui è finito, forse l’aveva visto solo in televisione, o letto sui libri. La realtà siciliana, a volte, è così truculenta che riesce a superare anche la fantasia. Sarà stato per questo motivo che don Miguel non ha subito dato peso all’avvertimento ricevuto appena messo piede in parrocchia. Anzi, ha pensato bene di rivedere alcune cose. Ma ai “picciotti” i cambiamenti non sono piaciuti. Con quel messaggio di benvenuto parlavano sul serio: la chiesa di San Filippo Neri, con il suo campo da calcetto, doveva pagare il “pizzo”, come tutti gli altri commercianti, altrimenti “guai” A scatenare l’estorsione sarebbe stata la decisione del neo parroco di togliere la gestione dell’impianto sportivo a un affiliato alla cosca e per questo gli è stato imposto di pagare la tassa del “pizzo” alla mafia. Raccontano due collaboratori di giustizia che il sacerdote avrebbe chiesto in giro e poi, una volta individuati i mafiosi, si sarebbe informato a quanto ammontava il versamento per “mettersi a posto”. Un modo per non far agitare le acque. E per questo motivo, rivela oggi un’inchiesta della procura di Palermo di cui è in possesso “l’Espresso”, don Miguel si sarebbe presentato ai mafiosi per pagare. Ma la tassa imposta è una cifra troppo elevata e don Miguel si rifiuta di versarla. È una storia inedita di cui non si è mai saputo nulla.
A svelare i retroscena ai magistrati sono stati due collaboratori di giustizia: Salvatore Giordano e Sebastiano Arnone, due mafiosi dello Zen. Sono stati loro a raccontare che don Miguel è stato aggredito e minacciato perché si era opposto al pizzo, dopo aver chiesto a quanto ammontasse e, in più, non aveva dato lavoro a un’impresa collegata con le cosche. In questa storia sono importanti i segnali che sono stati raccolti, perché a diciotto anni dall’uccisione di padre Pino Puglisi si torna ancora a registrare l’oppressione della mafia sulla Chiesa. Con il silenzio dei preti, la paura che li attanaglia e l’esempio negativo di chi preferisce subire e non denunciare favorisce di fatto Cosa nostra. Quello che è accaduto a don Miguel oggi lo scopriamo grazie al pentimento di due picciotti. “Mettersi a posto” è una frase importante se pronunciata a Palermo. Perché dire che quando si danno i soldi alla mafia ci si mette a posto, significa nel gergo mafioso che prima a posto non si era, mentre pagando il pizzo si diventa “regolari”. Ma anche per la Chiesa mettersi a posto con la mafia significa riconoscere che lo Stato che controlla il territorio ed esige le tasse è la mafia, ed è sempre con questa che il cittadino deve regolarizzarsi. Sembra un paradosso, ma è così che succede. Ed è così che l’omertà, anche di alcuni religiosi, appare sul territorio come un segnale negativo. Don Miguel non denuncia alcun antefatto. E non fornisce agli investigatori nessuna pista su cui indagare. Sul “pizzo” tace. Il prete preferisce restare in silenzio. Ha paura perfino di confermare di aver subito l’aggressione. Parlando con i giornalisti dice: “A volte è meglio tacere anche una verità”. “Per il bene del quartiere. Non sono il parroco del centro di Milano, basta una parola sbagliata…”. Finita la frase, il prete si passa il dito sotto la gola, da parte a parte. Il segno di una minaccia di morte è forte.
Le estorsioni arrivano fino in sacrestia a Palermo. Questo è il metro per comprendere quanto complesso sia oggi il rapporto tra Chiesa e mafia in Sicilia. Un legame che ancora oggi viene registrato in alcune sacrestie. E proprio per questo motivo c’è chi grida al “vano sacrificio” di don Puglisi, il parroco di Brancaccio assassinato nel 1993 su ordine dei boss stragisti Filippo e Giuseppe Graviano.
“È stato versato invano il sangue di Padre Puglisi”. Ripete più volte don Baldassere Meli, uno degli otto sacerdoti che all’indomani dell’uccisione del parroco inviarono una vibrante lettera al papa in cui chiedevano di ripulire sacrestie e conventi dall’inquinamento mafioso. “Continuano ad esserci sacerdoti e vescovi che non sono testimoni autentici della liberazione che Cristo vuole per questa nostra isola”. Dopo una lunga esperienza al fianco di bisognosi e immigrati a Palermo, don Meli da cinque anni si è trasferito a Castelvetrano, in provincia di Trapani. “La collusione di alcuni preti che abbiamo denunciato dopo l’omicidio di don Pino, purtroppo ancora oggi è diffusa. Per questo motivo sostengo che il suo sacrificio non è servito a cambiare il nostro stile di svolgere la pastorale, soprattutto nella formazione dei giovani. Con queste condizioni non c’è sbocco, e la Chiesa dovrebbe dichiarare bancarotta nella lotta alla mafia”. Don Meli vede ancora incrostazioni nella chiesa palermitana. “Occorre ammettere che non siamo cresciuti con l’idea di ribellarci alla mentalità mafiosa. Alcuni, nel concreto, si sono però resi conto che non potevano restare in silenzio. Ed hanno cominciato a denunciare. Non perché si diventa preti antimafia. Io, ad esempio, non lo sono, ma non voglio essere colluso. Occorre però denunciare per il semplice fatto che il sistema mafioso è anti-evagelico, e per questo non si può far finta di non vedere e non sentire”. Don Meli ricorda come la Chiesa all’indomani dell’omicidio di Brancaccio non seppe valorizzare alcuni segnali importanti da inviare al territorio. “Un mese dopo l’uccisione venne organizzata una manifestazione che si snodava per le strade di Brancaccio. Partecipai a quella iniziativa, e con me solo quattro preti. Al termine della manifestazione era prevista nella cattedrale la messa per don Pino, e trovai lì circa duecento preti. Rimasi sconvolto, perché pensavo che se tutti fossero venuti nel pomeriggio a Brancaccio alla manifestazione avremmo dato un segnale fortissimo al quartiere. Purtroppo non sappiamo cogliere queste occasioni preziose. E oggi mi chiedo ancora una volta: cosa hanno capito dell’uccisione di don Pino?”.
Sono passati 18 anni dall’anatema che venne lanciato nella Valle dei Templi da Giovanni Paolo II: “Mi rivolgo ai responsabili. Convertitevi, un giorno arriverà il giudizio di Dio!”. Undici anni prima, invece, durante un’altra visita del papa in Sicilia in molti rimasero insoddisfatti. Wojtyla, pontefice da poco più di quattro anni, non pronunciò in quella occasione la parola mafia. E andarono deluse le attese di quanti chiedevano una posizione più netta in un’isola che in quel periodo era scossa da omicidi eccellenti: a settembre del 1982 erano stati uccisi il prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, la moglie e un poliziotto.
Quello che caratterizza oggi le parrocchie palermitane è la paura di affrontare a viso aperto la mafia. Il silenzio delle armi voluto da Cosa nostra ha reso la mafia invisibile e tutto ciò provoca la reazione di giovani parroci che sostengono di non parlarne in chiesa perché “è difficile individuare cos’è oggi la mafia”. Un gruppo di bambini palermitani che aderiscono al comitato Addiopizzo Junior hanno incontrato nei mesi scorsi una decina di preti delle parrocchie per sollecitare una loro presa di posizione, anche durante l’omelia. Sono gli stessi ragazzi che hanno chiesto con una lettera al papa, alla vigilia della sua visita a Palermo lo scorso 3 ottobre, di lanciare un forte messaggio contro Cosa nostra, supplica che il pontefice ha ascoltato. Ma quando i giovani hanno incontrato i preti, portando come esempio l’azione evangelica e coraggiosa condotta da padre Puglisi, in alcuni casi si sono sentiti rispondere: “Se tutti fossimo come lui non ci sarebbero più preti a Palermo”. Altri hanno respinto l’idea: “Il prete non deve fare antimafia, ma deve portare avanti le parole del Vangelo”. Eppure il papa e i vescovi siciliani hanno continuato, dopo l’uccisione di don Puglisi, a condannare la mafia, a scomunicare i boss. Ma quella che può essere una linea teorica impartita dall’alto della gerarchia ecclesiastica, sembra non essere messa in pratica da alcuni sacerdoti che vivono il territorio. Un territorio ancora intriso di mafiosi e collusi, in cui accade di dover esplorare il sacrilego scenario dei rapporti tra mafia e chiesa.
La Chiesa, come pure Cosa nostra, vive di messaggi e segnali. Chissà come sarà stato decifrato l’incontro strombazzato nel febbraio 2009 fra l’onorevole Saverio Romano, oggi ministro dell’Agricoltura, già all’epoca indagato per mafia e indicato pubblicamente da un pentito come affiliato ad una cosca, e l’arcivescovo di Palermo Paolo Romeo? Il politico aveva voluto far sapere ai propri elettori che raccoglieva “l’appello che in più di un’occasione in questi anni ha lanciato monsignor Romeo sulla grave situazione in cui versano i cittadini, le famiglie, le imprese”. Romano sosteneva di farsene carico per risolverlo.
Ci sono ancora oggi parrocchie a Palermo in cui il distacco fra organizzazione criminale e Chiesa sembra non essere mai avvenuto. Dove i preti – non in tutti i casi – vivono al di fuori della realtà che li circonda.
Se negli anni Novanta nelle borgate della periferia spuntavano come funghi giovani preti che trasformavano le chiese in prime linee dell’antimafia, oggi tutto ciò sembra essere scomparso.
I vescovi siciliani hanno dato ampi segnali di risveglio ponendosi come argine all’offensiva dei boss. Dall’omelia su “Sagunto” del cardinale Pappalardo, per i funerali del prefetto Dalla Chiesa, all’urlo di papa Wojtyla nella Valle dei Templi, all’uccisione di don Puglisi, la Chiesa ha progressivamente aumentato la sua azione contro la mafia. Lo ha fatto di recente anche papa Benedetto XVI parlando ai giovani siciliani lo scorso ottobre a Palermo: “Non cedete alle suggestioni della mafia, che è una strada di morte, incompatibile con il Vangelo, come tante volte i vostri vescovi hanno detto”. Ma pochi mesi prima dell’arrivo del pontefice l’area cattolica palermitana doveva fare i conti con un altro spiacevole episodio: l’arresto del segretario del Movimento cristiano lavoratori, Giuseppe Liga, architetto, considerato l’erede dei boss Lo Piccolo. Un professionista che ha messo insieme mafia, religione e politica. Un cattolico capace di parlare al mattino con i sacerdoti, a pranzo con gli assassini e il pomeriggio con il presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, così come emerge dall’inchiesta su Liga.
Questo continuo miscuglio non piace a tutti gli uomini di Chiesa. Chi punta il dito su cosa è oggi la mafia, soprattutto agli occhi dei giovani sacerdoti, è padre Francesco Stabile, storico della chiesa, da decenni impegnato nel sociale in un territorio difficile come quello di un quartiere di Bagheria. “La mafia non è così evidente e il clero oggi ha bisogno di una lettura corretta del fenomeno mafioso”. Secondo padre Stabile “in molti nel clero non hanno ancora la convinzione che la mafia tocchi la sfera religiosa”. Per questo motivo il sacerdote parla di una “frattura” che vi sarebbe fra i documenti ufficiali della Chiesa e il territorio, perché “di fatto non vengono vissuti e discussi o fatti propri a livello locale”.
“La mancanza, per fortuna, di fatti eclatanti provocati dalla mafia, ha portato probabilmente a non far comprendere ai giovani del clero palermitano quanto invece è ancora forte e presente la mafia. È pur vero che oggi il primo obiettivo di cui ci dobbiamo occupare nelle parrocchie è la crisi economica che investe centinaia di famiglie, ma proprio per questo motivo dobbiamo sempre tenere alta la guardia contro la criminalità, in modo da evitare che la mafia possa rappresentare l’ancora di salvezza per le persone in difficoltà finanziarie”. L’anziano prete si infervora: “Non sono felice di ciò che accade oggi nel clero palermitano”. E poi aggiunge: “Vorrei una chiesa più forte e coraggiosa, capace di dire parole forti sui temi sociali e sulla mafia. Non siamo gli inquisitori di nessuno, ma occorre sottolineare ciò che il Vangelo ci chiede, e la società deve iniziare a prendere coscienza”.
Chi invece sostiene che anche una minoranza di preti che ogni giorno si batte nel palermitano contro la mafia può sovvertire una maggioranza indifferente è padre Carmelo Torcivia, docente presso la facoltà teologica di Sicilia, il quale insiste sul fatto che adesso la Chiesa ha una sua linea contro Cosa nostra, tracciata nero su bianco in documenti ufficiali. “È sempre una minoranza che porta una coscienza civile e che fa le lotte. La maggioranza sta a casa. E noi preti non siamo dissimili dalla società. Perché non siamo angeli. Siamo uomini in carne e ossa, con le nostre debolezze e i nostri limiti. Pure nella Chiesa c’è un gioco di minoranza e maggioranza”.
Non tutto il clero è lo stesso in Sicilia. A far la differenza e spiegare che ogni realtà è diversa dall’altra è monsignor Mimmo Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo. “Un ruolo importante lo hanno avuto ed hanno i vescovi”. Salvatore Pappalardo ruppe una secolare tradizione di silenzio pronunciando la prima omelia antimafia della storia. Era il 4 settembre 1982. Appena ventiquattro ore prima, in via Isidoro Carini, un commando uccideva il prefetto Dalla Chiesa. Con una similitudine di grande effetto, Pappalardo paragonò Palermo a Sagunto espugnata dai nemici con il cuore livido di rabbia e gonfio di dolore. Le sue parole furono pesantissimi macigni rovesciati sui mafiosi, uomini senza morale e senza onore. Quel pomeriggio Pappalardo divenne un importantissimo punto di riferimento della cultura antimafia che cominciava a montare in quegli anni nel sentimento dei palermitani.
“L’eredità del cardinale Pappalardo è ancora forte a Palermo, ma mentre lui parlava, nel resto della Sicilia non tutte le voci erano coralmente sintonizzate su di lui. Palermo è stata punta avanzata, e forse lo è ancora, ma in altre realtà dell’isola questa stessa sensibilità non ce l’hanno”, denunciano i vescovi pronunciando una condanna decisa della mafia e denunciandone la presenza nel trapanese: “A Mazara la mafia c’è: nel calcestruzzo, nella grossa distribuzione alimentare e nelle piccole forme mafiose presenti nella burocrazia”. Un territorio che è il regno del latitante Matteo Messina Denaro, il personaggio più importante in questo momento in Cosa nostra. “Posso affermare che oggi i familiari di Messina Denaro chiudono la porta in faccia al prete della loro parrocchia. Ciò significa che non lo riconoscono come una persona che è dalla loro parte. Non come persona fisica, ma per quello che rappresenta: la Chiesa. Questo significa che la mafia inizia a percepire la Chiesa come alterità rispetto a prima. Dal punto di vista culturale è cambiato qualcosa”.
Mentre la famiglia del boss latitante trapanese chiude la porta in faccia al suo parroco, a Roma si spalanca la cella del carcere di Rebibbia in cui è rinchiuso l’ex presidente della Regione siciliana, Totò Cuffaro. Cella aperta per poter ricevere la visita di tanti uomini di chiesa. Tra tutti l’ex vescovo di Catania, Giuseppe Bommarito, che ha voluto portare un saluto all’ex governatore che deve scontare sette anni di carcere per aver favorito la mafia. Ma non è il solo prelato a occuparsi del detenuto Cuffaro. Anche l’ex presidente della Conferenza episcopale italiana, Camillo Ruini, ha scritto una lettera che avrebbe fatto commuovere l’ex governatore. Eppure queste visite cristiane al carcere di Rebibbia non hanno lo stesso significato degli incontri del ministro, già all’epoca indagato, Saverio Romano nelle segrete stanze delle Curie siciliane. L’ESPRESSO 21 aprile 2011 DI LIRIO ABBATE
Chiesa e Mafia di Salvo Vitale
Ci sono tre aspetti che oggi hanno cambiato alcune impostazioni, ma che negli anni passati erano la tipica espressione delle articolazioni del potere, come si poteva cogliere, per esempio, nel seguito delle processioni religiose: 1) Il rapporto tra la chiesa e la mafia; 2) il rapporto tra la mafia e la chiesa; 3) il rapporto del mafioso con la religione (con Dio):
L’apparato istituzionale: La chiesa è uno degli elementi base del potere (paesano) rappresentato dal sindaco, dal maresciallo, dal mafioso e dal prete:
– Il sindaco è il detentore del potere politico che egli riceve direttamente dai cittadini: in realtà il voto è la risultante di un reticolo sociale controllato dai ceti dominanti e, in particolare dal loro braccio armato, cioè dal mafioso; al di sopra di lui, sempre nello stesso circuito c’è il circuito politico di potere regionale e nazionale, di cui egli è espressione locale;
– Il maresciallo riceve il potere dallo stato: la tutela dell’ordine pubblico comporta un controllo del territorio che, in realtà, è nelle mani del mafioso: quindi spesso si instaura una sorta di patto tra il mafioso, che “mantiene l’ordine” e il responsabile delle forze dell’ordine che, in cambio, gli lascia mano libera nei suoi affari;
– Il prete riceve il “potere religioso da Dio, tramite i suoi ministri, e quindi deve rendere conto solo a lui: in realtà egli è una pedina dell’insieme, vive grazie ai contributi dei fedeli, organizza le feste e le iniziative grazie ai contributi anche dei mafiosi, è al corrente, tramite la confessione, di quel che succede sul territorio, dove svolge un ruolo di intermediazione con altri rappresentanti istituzionali. E’ il rappresentante di Dio in terra, quello che ha in mano gli strumenti per congiungere l’uomo con la divinità;
– Il mafioso non riceve il potere da nessuno: lo conquista grazie alla sua forza e alla sua capacità di usare la violenza per conservarlo e accrescerlo: tuttalpiù può rendere conto del suo operato al capocosca, al capobastone, alla commissione provinciale, alla cupola, così come il prete rende conto al vescovo, il maresciallo al capitano, il sindaco all’onorevole o al segretario di partito. Anche il mafioso è il rappresentante di Dio in terra: anzi, spesso è proprio Dio in terra, detentore di un potere che trascende ogni legge, che lo autorizza ad ogni delitto, spesso anche nel ruolo di giudice, dove la giustizia umana dei tribunali mostri i suoi limiti.
Ci troviamo così davanti a quattro piramidi tra di esse congiunte da camminamenti sotterranei.
La presenza di preti e religiosi all’interno delle cosche mafiose era stata rilevata sin dal 1838 dal procuratore del re a Trapani Pietro Ulloa.
La chiesa e la mafia: esempi Il cardinale Ruffini: A un giornalista che gli chiedeva cos’è la mafia, il cardinale Ruffini nel 1960 rispose: “Mafia? A quel che ne so io è una marca di un detersivo”. Le parrocchie erano allora il centro pulsante delle campagne elettorali della D.C. e la barriera contro il “pericolo rosso” . Ruffini ribadì la sua posizione a Tina Anselmi, mandata in Sicilia da Aldo Moro, preoccupato di individuare possibili infiltrazioni mafiose nel suo partito: “Non so che cos’è questa mafia, ma con la DC non ha niente a che fare”. E allorché Paolo VI, dopo la strage di Ciaculli, chiese, tramite il card. Dell’Acqua, notizie, Ruffini ancora una volta rispose che la mafia era un’invenzione dei comunisti per fare campagna elettorale contro la D.C. Nulla di diverso rispetto alle attività criminali presenti nel resto d’Italia e d’Europa, ma un fenomeno amplificato dalla stampa e da ingannevoli trasposizioni e informazioni fatte da Tomasi di Lampedusa nel suo romanzo Il Gattopardo e dal sociologo Danilo Dolci, che propagandava nel mondo solo gli aspetti negativi dell’isola.
Caccamo, a due passi da Termini Imerese. Un prete, Teotista Panzeca, scrive al Cardinale Ruffini una arrabbiata lettera in cui si lamenta della persecuzione operata a suo dire dalla polizia nei confronti di suo fratello Giuseppe, boss di Caccamo, artefice delle molte vittorie elettorali della Democrazia Cristiana, inseguito da un mandato di cattura e vittima di una campagna diffamatoria orchestrata dai comunisti. In un rapporto dei carabinieri si legge che “il sindaco di Caccamo Cordone manteneva cordiali rapporti anche con l’arciprete del luogo don Teotista Panzeca”.
Monreale. Contemporaneo di Ruffini e molto più intraprendente l’arcivescovo di Monreale mons. Filippi, capace di “mettere a posto” politici e mafiosi, grazie ai suoi appoggi, a cominciare da quello di Charles Poletti, comandante delle forze aeree americane, che, secondo credenza popolare, non avrebbe bombardato Monreale per un suo intervento. Nell’immediato dopoguerra riuscì a metter fine a una faida mafiosa a Monreale convocando i capifamiglia e imponendo loro di smetterla di sparare e uccidersi a vicenda.
Molte ombre sono rimaste sulla figura dell’ex arcivescovo di Monreale Salvatore Cassisa che, secondo mons. Giuseppe Governanti, ex presidente del tribunale ecclesiastico siciliano, avrebbe preso tangenti sui lavori di restauro del Duomo. Amico di Cassina e di altri personaggi “chiacchierati” di dubbia reputazione e suo successore nella carica di Gran Maestro dei Cavalieri del Santo Sepolcro, dei quali faceva parte anche Bruno Contrada.
Racalbuto: Non meno interessante la vicenda di Padre Giuseppe Russo, parroco di Racalmuto, il paese di Sciascia, che da giovane aveva alternato la tonaca di prete con la carriera di delinquente, ladro e assassino, terrore del il paese. Arrestato e allontanato per molti ani era tornato in paese grazie alle intercessioni dei notabili, che lo avevano rimesso nella sua parrocchia.
Partanna: Non una parola per la morte di Rita Atria venne detta da Don Calogero Russo, parroco di Partanna, anzi, commentando le interviste dei giornalisti fatte agli abitanti del paese e a lui stesso che l’aveva violentemente rifiutato, qualche settimana dopo diffuse un foglio in cui tra l’altro era scritto:”Hanno essi il diritto di pronunciare una sentenza d’infamia a un’intera cittadinanza soltanto al primo incontrato, che non parla perché ‘non sa realmente’ o perché non ha prove su quanto si vocifera”?
Palermo; Emblematica e inquietante la figura di un frate francescano, ospite del convento palermitano di Santa Maria di Gesù, Fra Giacinto, al secolo Stefano Castronovo, ospite dei salotti palermitani frequentati dal boss Paolino Bontade, amico di Luciano Leggio, ucciso nel 1980: nella sua “suite di sette stanze, all’interno del convento, arredata di tutto punto venne trovata una pistola p 38, regolarmente denunciata e la considerevole somma di 5.milioni di lire, a parte una considerevole scorta di liquori, biblioteca, televisore a colori col telecomando e quant’altro utile a rendere comoda la vita, a parte una collezione di frustini. “Il francescano era di casa nei palazzi del potere romano. Grande elettore democristiano, il suo cavallo vincente era Giovanni Gioia, il notabile sul quale confluivano i voti del clan di Tommaso Buscetta. Aveva esordito come capo-elettore sostenendo un altro DC d’eccellenza, Mario Fasino, futuro presidente della Regione siciliana. Poi era diventato fedelissimo di Salvo Lima, altro leader della corrente andreottiana in Sicilia, solo chiacchierato e solo sospettato di collusioni mafiose” (Nota: E.Mignosi: “Il Signore sia coi boss” pag. 79 Arbor Palermo 1993).
Partinico: un posto di riguardo merita Padre Agostino, anzi “Ustino”, Coppola, prima economo al seminario di Monreale, poi docente, poi parroco di Carini. Fratello di Domenico e Giacomo, noti mafiosi di Partinico e nipoti del boss Frank Coppola, anche lui acclamato socio onorario della FUCI di Partinico. Le cronache lo davano in ottimi rapporti con tutti i boss di allora, Luciano Liggio, Peppuccio Garda, Gaetano Badalamenti, Vito Ofria, Filippo Nania: implicato nei sequestri di persona di Cassina, di Rossi da Montelera, (per cui fu condannato a 15 anni), di Emilio Baroni, accusato di estorsione nei confronti di Francesco Randazzo, dal quale comprò la tenuta “Principessa Ganci”, già appartenuta al duca D’Aumale di Orleans, in contrada Zucco-Montelepre. Secondo Antonino Calderone era “punciutu”. Dopo la condanna è al carcere è stato sospeso a divinis e si è sposato con la ginecologa Caruana dalla quale ha avuto due figli. Proprio in quella tenuta è stato celebrato da Coppola, con l’assistenza di due suoi colleghi, il matrimonio di Totò Riina e di Ninetta Bagarella. Si sa che la cella dell’Ucciardone in cui venne rinchiuso, era come una sorta di salotto personale fornito e attrezzato di tutto.
Mazzarino: in un articolo sul Corriere Sciascia scrisse: “A parte i casi eclatanti credo che una tradizione di perversità, di delinquenza, di oscuri ricatti e ricettazioni, percorra la storia di certi conventi siciliani”. I frati di Mazzarino, sono uno dei tanti esempi di gente che, con la protezione della croce, avevano fatto del loro convento il centro di un giro di estorsioni. Frate Agrippino, Frà Carmelo, Frà Vittorio, Frà Felice, Frà Venanzio, padre Sebastiano, l’ortolano Carmelo Lo Bartolo.
Mussomeli: i fratelli Castiglione un prete e tre pastori di Mussomeli, agli inizi del secolo erano i padroni del paese. Singolare la posizione di Padre Carmelo Castiglione, che affermava: “i mafiosi vanno combattuti con le loro stesse armi. Quando si trovano davanti uno con gli attributi fanno marcia indietro. Sono prepotenti con chi non sa reagire. Mafiosi da due lire, ecco cosa sono. Se aspetti che ti aiuti la legge, stai fresco. Devi farti giustizia da solo. Amen”. (1913)
Santo Stefano della Quisquina: i frati del locale convento non esitarono a sparare sul vescovo di Agrigento mons. Peruzzo, che aveva scoperto che non erano angioletti;
Tagliavia: il convento era un ricettacolo di latitanti; con la complicità dei frati. Il superiore, padre Tantillo, venne arrestato, assieme ad altri confrati, per duplice omicidio.
Cinisi: la madre di Peppino Impastato, Felicia Bartolotta, raccontava che il parroco di Cinisi padre Cusumano tenne nascosto nella sua sacrestia il latitante mafioso Nino Badalamenti per sette mesi. In ogni caso, dalle registrazioni della trasmissione “Onda Pazza”, mandata in onda a Radio Aut da Peppino Impastato e dai suoi compagni, risulta che nel 1978 Tano Badalamenti, cugino di Nino, diede due milioni per i festeggiamenti in onore della “santa del Faro”, ovvero Santa Fara, protettrice del paese.
La svolta 1982: Una prima svolta la dà il cardinale Salvatore Pappalardo nel 1982, allorchè, ai funerali di Carlo Alberto dalla Chiesa pronuncia iil suo atto d’accusa nei confronti dello stato italiano, con la frase di Tito Livio: “Dum Romae consulitur Saguntum expugnatur”. E Sagunto è Palermo, lontana dal centro romano del potere, dove si ripetono parole senza prendere alcun provvedimento efficace. Qualche giorno prima del Natale dello stesso anno la mafia diede la sua risposta al Cardinale che si era spinto troppo avanti: alla messa organizzata dallo stesso presule alla cappella del carcere dell’Ucciardone non si presentò nessuno.
Ancora altri dieci anni tra silenzi, voci isolate, timide condanne e attività pastorali di vario tipo, sino al 9 maggio 1993, allorchè, dalla Valle dei templi Papa Giovanni Paolo II grida il suo terribile anatema contro la mafia: “Mafiosi, convertitevi. Un giorno verrà il giudizio di Dio e dovrete rendere conto delle vostre malefatte… Questo popolo talmente attaccato alla vita, un popolo che ama la vita, non può vivere sempre sotto la pressione della morte. Qui ci vuole la civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo crocifisso risorto, di questo Cristo che è vita e verità, lo dico ai responsabili: convertitevi per amore di Dio”. Erano in centomila quel giorno, accorsi per commemorare Falcone e Borsellino, ma dimentichi che, proprio in quel giorno, il 9 maggio, era stato ucciso Peppino Impastato. Non è che i mafiosi si lasciassero spaventare molto dall’anatema, che tuttavia invece venne raccolto da molti religiosi ed è diventato una sorta di direttiva pastorale.
Erano appena passati quattro mesi quando venne ucciso padre Pino Puglisi, un prete mite, ma fermamente deciso nel cercare di cambiare volto all’apparato istituzionale mafioso che controllava la zona di Brancaccio e a dare un’indicazione diversa ai ragazzi che frequentavano la sua chiesa. L’anno dopo (19.3.1994) tocca a un altro prete di Casal di Principe, Giuseppe Diana, fatto oggetto, dopo l’omicidio, di una campagna di vergognosa diffamazione, secondo una tipica strategia mafiosa e camorrista, che tenta di uccidere non solo la persona, ma le suo idee. E da allora questo desiderio di liberazione e di emancipazione è diventato una scelta politica di personale rifiuto dell’oppressione da parte di chi vuole vivere parassitariamente sulle risorse del lavoro altrui e sul malaffare. Assieme a preti impegnati nel sociale e fermamente decisi a prendere le distanze dall’apparato mafioso in cui si trovano a lavorare, sono nate centinaia di associazioni d’ispirazione religiosa, che elaborano e gestiscono progetti educativi, che sono affidatarie di terreni e beni immobili confiscati ai mafiosi, che si sforzano di condurre attività economiche nel segno della legalità e nel rispetto delle regole del mondo del lavoro, in un panorama caratterizzato da dominanti forme di lavoro nero e di sfruttamento. Cito fra tutti don Luigi Ciotti.
Il mafioso cristiano Esiste poi il complicato rapporto del mafioso con la religione. Nel covo di Pietro Aglieri, uno dei più sanguinari boss legato ai Corleonesi, venne trovato un crocifisso, una statua della Madonna, un’intera libreria di pubblicazioni delle edizioni San Paolo, con bibbie, biografie di santi, commenti e interpretazioni filosofiche di questioni religiose, come quelle del libro rinvenuto sul comodino della suora filosofa Edith Stein, “Introduzione al pensiero filosofico” e inoltre registrazioni di “Radio Evangelica” e “Telepace”. Ma destò più stupore la scoperta di una cappella privata, con sei panche, faretti per illuminare il crocifisso, fonte battesimale all’ingresso, ceri, drappi di velluto, dove andava a celebra r messa il frate carmelitano Mario Frittitta, arrestato per favoreggiamento, condannato in primo appello e poi assolto. Aglieri aveva studiato nel seminario di Monreale. La “serenità” di Aglieri, in rappporto alla sua coscienza di mafioso richiama un giudizio del giudice Scarpinato: “Il mafioso ha un rapporto con Dio che non è conflittuale perché il mediatore con Dio che lui stesso sceglie è espressione della sua stessa cultura”.
Nel covo del padrino di Aglieri, Bernardo Provenzano, c’era un quadro dell’Ultima Cena, due quadretti della Madonna, diversi rosari , uno persino in bagno, tre bibbie, un calendario del 2000 con padre Pio, un piccolo presepe, un libricino intitolato “Pregate, pregate, pregate”, 91 santini vari di cui 73 tutti eguali, raffiguranti Cristo in croce con la scritta “Gesù io confido in Te”. A parte i commenti criptati nelle bibbie, quasi tutti i “pizzini” di Provenzano contenevano apprezzamenti religiosi, raccomandazioni di devozione, benedizioni e auguri in nome di Dio, al punto che ci si è chiesto se Provenzano usasse la religione come uno strumento che il patriarca assoluto può permettersi, avendo egli raggiunto rispetto agli altri la maggiore vicinanza con Dio, più o meno come il papa, o come espressione di un’atavica religiosità che costituisce una delle facce del modo di essere della sicilianità. Secondo uno sbrigativo giudizio di Andrea Camilleri “le sue invocazioni a Dio e alla Divina Provvidenza sono più scongiuri, parole magiche, frasi antijettatorie che preghiere autentiche”. La risposta di u zzu Binnu è affidata alle sue parole sgrammaticate: “In qualsiasi posto, o parte del mondo, mi trovo in qualsiasi ora io abbia a comunicare sia parole, opinioni, fatti, scritto, chiedere a Dio il suggerimento, la sua guida, la sua assistenza, affinchè con il suo volere possano giungere ordine per lui eseguirlo affin di Bene”.
La maggiore espressione di “conversione” religiosa è quella di Gaspare Spatuzza, 40 omicidi confessati, tra cui quello di Pino Puglisi: una ferocia pari all’intensità con cui ha intrapreso il cammino religioso: Alessandra Dino cita un episodio riportato da un collaboratore di giustizia: “Spatuzza con una mano mescolava con un bastone di legno i resti sciolti nell’acido di un giovane ladro appena ucciso, e con l’altra mangiava un panino acquistato con i soldi trovati in tasca alla vittima”. Dopo l’arresto egli attraversa un travagliato periodo di presa di coscienza dei suoi delitti e comincia, con la collaborazione di alcuni religiosi la sua “conversione” profonda e, a dire dei giudici “sicuramente attendibile”, che lo porta a iscriversi al corso di teologia e addirittura a immedesimarsi in San Paolo, anche lui convertito al cristianesimo, dopo esserne stato un persecutore. Si è anche firmato Gaspare-Paolo.
Si potrebbe andare avanti all’infinito. Figure come quella di Michele Greco, detto “U Papa”, di cui si ricorda il sinistro invito al maxiprocesso: “Auguro a tutti voi la pace, perchè la pace è la tranquillità dello spirito e della coscienza, perchè per il compito che viaspetta la serenità è la base per giudicare. Non sono parole mie, ma le parole che nostro signore disse a Mosè…” si inquadrano tutte in questo contesto di pseudo-religiosità in cui il piccolo mafioso è tenuto a rendere conto prima di tutto all’organizzazione, nella quale è entrato con la cerimonia “religiosa” del giuramento col santino. I capi-mandamento, a meno di laceranti guerre di mafia, siedono nella Cupola, su cui aleggia la mafia, come Cristo e i suoi dodici apostoli, su cui aleggia lo Spirito Santo. In pochi si sono “emancipati” da questo percorso religioso per riconoscersi in quello spiccatamente criminale, senza alibi o pseudo-giustificazioni. Certamente laico è stato Totò Riina, malgrado il suo matrimonio religioso e un santino che gli venne trovato addosso al momento della cattura.
Ma il mafioso ateo per eccellenza è Matteo Messina Denaro: solo un lucido e spietato senso degli affari, dell’esecuzione dei delitti, con i quali si dice che potrebbe riempire un cimitero, della polivalenza della sua identità e della prudenza nell’evitare errori che potrebbero comprometterlo. Uno di questi parziali errori è stato quello di avere intrapreso una corrispondenza epistolare con l’ex sindaco di Castelvetrano Antonino Vaccarino, (Svetonio), amico del padre, che pare fosse un infiltrato dei servizi segreti. In una di queste lettere egli scrive: “In me in passato non c’è stato niente di soprannaturale e il supremo. Tutto è accaduto al di là della mia volontà. Poi ad un tratto mi accorsi che qualcosa dentro di me si era rotta. Mi resi conto di avere smarrito la mia fede. Mi sono convinto che dopo la vita c’è il nulla, e sto vivendo per come il fato mi ha destinato”. Messina Denaro, la cui cultura è di qualche gradino superiore a quella dei suoi precedenti padrini, ha compiuto l’ultimo inevitabile passaggio, quello di liberarsi del fardello della religione, ormai diventato inutile e inconciliabile con l’identità criminale della sua organizzazione. Si è scrollato della religione, così come la Chiesa si è scrollata, o ha cercato di farlo, dei mafiosi.
Nota: il presente scritto è solo un articolo giornalistico e non ha la pretesa di essere uno studio sociologico o storico di un così complesso fenomeno, già analizzato da illustri studiosi e teologi con analisi e ricerche puntuali, documentate e illuminanti. Cito tra tutte ”Il Vangelo e la lupara” di Augusto Cavadi, (Bologna Dehoniane 1994, “La mafia devota” di Alessandra Dino (Laterza 2008) e, più recentemente “L’eucaristia mafiosa” di Salvo Ognibene (Navarra 2014). Non citato quasi da nessuno, ma fonte romanzata di importanti notizie, poi riprese da altri, il libro di Enzo Mignosi “Il Signore sia coi boss” edizioni Arbor Palermo 1993. ANTIMAFIA DUEMILA 20 Agosto 2019
Chiesa, mondo cattolico e mafia
Mentre la Chiesa cattolica ha compiuto i primi passi per il processo di beatificazione di padre Puglisi, il parroco di Brancaccio ucciso nel settembre del 1993 (sulla lapide nella sua chiesa non c’è la parola mafia ma nessuno ha mai dubitato che sia stato ucciso da mano mafiosa), la Cassazione ha definitivamente assolto padre Frittitta, condannato in primo grado per favoreggiamento aggravato nei confronti del capomafia Pietro Aglieri, assolto in appello e definitivamente scagionato dalla Suprema Corte “per aver commesso il fatto nell’esercizio di un diritto”, cioè per avere esercitato il suo ministero di sacerdote visitando il boss latitante e dicendo messa nel suo nascondiglio, debitamente arredato con un altarino.
Al di là di scelte personali, che possono portare al martirio o all’incriminazione per favoreggiamento, nella lunga vicenda dei rapporti con la mafia la Chiesa cattolica e più in generale il mondo cattolico hanno assunto atteggiamenti diversi, che vanno dal silenzio alla denuncia, dalla complicità all’impegno, dalla condivisione alla condanna.
Nella mia Storia del movimento antimafia ho ricostruito questi rapporti, cercando di essere il più possibile obiettivo e dando spazio a eventi e figure dimenticati.
Chiesa cattolica e movimento contadino Nell’oltre mezzo secolo che vide la contrapposizione tra il movimento contadino, le forze politiche di sinistra e i proprietari terrieri e i mafiosi, dall’ultimo decennio del XIX secolo agli anni ’50 del XX, la Chiesa è stata, quasi unanimemente, dalla parte di chi deteneva il potere, considerando quelle lotte, in nome del socialismo e del comunismo, un grave attentato all’assetto socio-politico in cui era pienamente inserita. Durante i Fasci siciliani, l’unica voce che in un primo momento mostrò di comprendere “le ragioni del malcontento popolare” fu quella del vescovo di Caltanissetta Guttadauro che in una lettera pastorale dell’ottobre 1893 scriveva: “Le ragioni del malcontento esistono e non si possono dissimulare. Il ricco per lo più abusa delle necessità del povero, che viene costretto a vivere di fatica, di stento, di disinganno”. Il vescovo invitava i parroci a reclamare presso i proprietari e i gabelloti, direttamente o indirettamente legati alla mafia, perché si ristabilisse la giustizia e l’equità nei contratti, la giusta proporzione tra il lavoro e il capitale, venisse diviso equamente il raccolto, si desse ai lavoratori la giusta mercede, cessasse l’usura. Ma successivamente, nel febbraio del 1894, quando la parabola dei Fasci siciliani si era chiusa nel sangue (108 morti in un anno), per l’azione congiunta dei campieri mafiosi e dei militari inviati da Crispi, monsignor Guttadauro muta registro e si unisce al coro dei prelati che scagliano fulmini contro i Fasci: le plebi sono state illuse da istigatori malvagi e da ree dottrine, come il socialismo e la massoneria. Il vescovo di Noto propone di rinchiudere “caritatevolmente” i socialisti in manicomio e definisce “stoltizia” l’aspirazione a ordinamenti democratici e a un’equa distribuzione dei beni. Il cardinale arcivescovo di Palermo tuona contro i “mestatori anarchici e socialisti” e riceve nel palazzo arcivescovile il generale massacratore Morra di Lavriano che lo ringrazia per la pubblicazione della sua pastorale. Eppure negli anni successivi nasceranno all’interno del mondo cattolico nuove forme di apostolato sociale, associazioni e istituti “diretti a sollevare la povertà del popolo”, germogli siciliani dell’Opera dei Congressi, che si proponeva di avviare un intervento delle parrocchie nella vita sociale. Si profila così quella che sarà la strategia dei cattolici più avveduti di fronte al movimento contadino: condanna esplicita del socialismo e delle lotte ad esso ispirate, promozione di iniziative volte ad alleviare le condizioni di vita degli strati più disagiati. Così, per fronteggiare l’usura, don Sturzo, fondatore del Partito popolare, si prodiga per lo sviluppo delle casse rurali cattoliche, all’interno di una visione che poggia su un’analisi abbastanza lucida del fenomeno mafioso, salito alla ribalta nazionale con il delitto Notarbartolo del febbraio del 1893, ma sulla chiusura verso la lotta di classe. I cattolici erano favorevoli alle affittanze collettive, che miravano ad eliminare il gabelloto mafioso sostituendolo nell’affitto dei feudi con le cooperative di lavoratori, e puntavano l’attenzione verso i ceti medi: piccoli proprietari coltivatori, mezzadri e fittavoli. In concreto le casse rurali cattoliche nascono in contrapposizione con le casse agrarie socialiste e raccolgono soggetti non proprio raccomandabili. Così a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, si consuma una vicenda esemplare: la contrapposizione tra la Cassa agraria cooperativa, organizzata dal dirigente socialista Lorenzo Panepinto, e la Cassa rurale cattolica, legata ai gabelloti, si inserisce in uno scontro, avviato negli anni dei Fasci e continuato successivamente, che porta nel maggio del 1911 all’omicidio di Panepinto, destinato come tantissimi altri a rimanere impunito. Ma anche in un centro di vitale importanza per le lotte contadine e lo scontro con la mafia, come Corleone, vengono segnalati legami della locale Cassa rurale con mafiosi: affiliati alla cosca dei “fratuzzi” venivano impiegati come campieri nelle affittanze e godevano del credito agrario e commerciale.
Preti uccisi dalla mafia e la “famiglia sacerdotale” di don Calò Vizzini Negli anni precedenti l’avvento del fascismo il movimento contadino vive una nuova stagione di lotte anch’essa conclusa nel sangue. Tra i caduti ci sono il dirigente contadino Nicolò Alongi e il segretario del sindacato dei metalmeccanici di Palermo Giovanni Orcel, che avevano sperimentato le prime forme di collegamento tra lotte contadine e operaie, entrambi assassinati nel 1920. In quegli anni tra le vittime di omicidi ci sono dei preti. Alcuni di essi possono essere caduti per avere svolto attività non gradite agli ambienti mafiosi. Giorgio Gennaro, ucciso nel 1916 nella borgata palermitana di Ciaculli, regno della dinastia mafiosa dei Greco, aveva denunciato il loro ruolo nell’amministrazione delle rendite ecclesiastiche. Così pure Costantino Stella, arciprete di Resuttano, in provincia di Caltanissetta, ucciso nel 1919, e Stefano Caronia, arciprete di Gibellina, in provincia di Trapani, ucciso nel 1920, sono “preti sociali”, la cui attività si lega all’insegnamento di Leone XIII e all’azione di don Sturzo. Ma accanto ad essi troviamo preti legati alla mafia, come l’arciprete di Castel di Lucio (Messina) Gian Battista Stimolo, ucciso sempre nel corso degli anni ’20, e altri come i cinque ecclesiastici della famiglia di Calogero Vizzini, capomafia per molti anni, che non risulta abbiano mai avuto nulla da ridire sulle imprese del loro congiunto. Due di essi, zii di don Calò, sono vescovi, un altro zio è arciprete, e due fratelli sono preti e uno, monsignor Giovanni, per poco non ha indossato anche lui i panni episcopali. Calogero Vizzini, mafioso-imprenditore, gabelloto di feudi e di miniere di zolfo, è il protagonista della sparatoria sulla piazza di Villalba, del 16 settembre 1944, in cui rimase ferito Girolamo Li Causi, da poco arrivato in Sicilia per riorganizzare il Partito comunista. Di casa Vizzini il vescovo di Caltanissetta Giovanni Jacono scriveva che era una famiglia “veramente sacerdotale” e non nascondeva che aveva aiutato il capomafia a scampare al carcere. Il vescovo aveva speso la sua autorità anche per altri mafiosi, congiunti di sacerdoti, arrestati o confinati.
Il cardinale Ruffini: i comunisti fuori legge Nell’ultima fase del movimento contadino, nel secondo dopoguerra, non troviamo traccia di un ruolo dei cattolici, se non dall’altro lato delle barricate. La figura più rappresentativa della Chiesa siciliana è certamente il cardinale di Palermo Ernesto Ruffini, mantovano ma ben presto ambientatosi nel clima isolano. Dopo la strage di Portella della Ginestra del primo maggio 1947, eseguita dalla banda Giuliano ma voluta dagli agrari, dai mafiosi e dai partiti conservatori, battuti alle elezioni regionali del 20 aprile in cui per la prima e ultima volta vinsero le sinistre raccolte nel Blocco del popolo, Ruffini inviò una lettera al Papa, in cui parlava di inevitabile resistenza e ribellione “di fronte alle prepotenze, alle calunnie, ai sistemi sleali e alla teorie antiitaliane e anticristiane dei comunisti”. E dopo la vittoria della Dc alle elezioni del 18 aprile 1948, chiese per iscritto al ministro degli Interni, il siciliano Mario Scelba, e a voce al presidente del consiglio Alcide De Gasperi, di mettere fuori legge il PCI. I nemici sono loro, i comunisti, scomunicati come il nuovo Anticristo, e in nome della lotta anticomunista tutto è lecito o giustificabile. E negli anni ’40 e ’50 ci saranno manovre per indebolire le lotte contadine, con la scissione sindacale, la creazione della Coldiretti, e la Chiesa, che nel maggio ’47 aveva salutato come un fatto positivo la rottura della coalizione antifascista al governo nazionale, avrà un ruolo di primissimo piano nella costruzione di un quadro politico ermeticamente sbarrato a sinistra.
Nel dicembre del 1951 il pontefice Pio XII rivolse un invito ai vescovi radunati nel concilio plenario siculo a “provvedere all’assistenza religiosa e materiale della plebe proletaria” e a favorire “con tutti i mezzi le Associazioni cristiane dei lavoratori e i loro liberi Sindacati”, ma il tentativo del vescovo di Agrigento Giovanni Battista Peruzzo di inserire nei canoni conciliari un capitolo sull’apostolato sociale, riprendendo la dottrina sociale della Chiesa su temi come il pieno impiego, il salario familiare, la bonifica delle terre, la riforma della proprietà terriera, l’assistenza alla piccola proprietà, sempre tenendo ben fermo il distacco dalle organizzazioni comuniste, compresa la CGIL, cadde nel vuoto, per il timore che anche soltanto parlare di “questione sociale” potesse portare acqua al mulino comunista.
Assolutamente isolata rimase la voce di don Primo Mazzolari che in un libretto sulla Sicilia scriveva che “il cristiano non può rimanere indifferente di fronte ai conflitti e alle contese di classe e di casta”. In compenso continuano le convivenze con la mafia anche sotto lo stesso tetto familiare. A Caccamo, in provincia di Palermo, il fratello del capomafia è l’arciprete Teotista Panzeca e in quella zona cadranno Filippo Intile, un contadino che si batteva per l’attuazione del decreto che disponeva la divisione del prodotto a favore dei coltivatori, e il sindacalista Salvatore Carnevale, mentre la Dc raggiungerà percentuali da monopolio.
La mafia? Un’invenzione dei comunisti! Una volta sconfitto il movimento contadino e apertasi la strada all’emigrazione, la lotta alla mafia negli anni ’60 e ’70 è condotta da una sinistra ormai minoritaria. Nei primi anni ’60 si scatena una sanguinosa guerra di mafia e dopo la strage di Ciaculli, del 30 giugno 1963, il pastore della piccola comunità valdese di Palermo Pietro Valdo Panascia fa affiggere un manifesto in cui condanna esplicitamente la violenza mafiosa. A nome del Papa Paolo VI, il sostituto della Segreteria di Stato scrive al cardinale di Palermo, segnalando la presa di posizione di Panascia e invitandolo, con lo studiato linguaggio della diplomazia vaticana, a promuovere un’azione “per dissociare la mentalità della così detta “mafia” da quella religiosa e per confortare questa ad una più coerente osservanza dei principi cristiani”.
La risposta di Ruffini è molto meno diplomatica: non si può neppure lontanamente supporre un rapporto tra mentalità mafiosa e religiosa: questa è una calunnia dei comunisti. Il manifesto dei valdesi è solo “un ridicolo tentativo di speculazione protestante”; si parla tanto di mafia, ma sono solo delinquenti comuni, come ce ne sono dappertutto. E la Chiesa cattolica è impegnata quotidianamente in mille opere di bene.
L’anno successivo Ruffini pubblica una pastorale dal titolo Il vero volto della Sicilia, in cui dice che la mafia è formata da “gruppi di ardimentosi” mobilitati da alcuni capi, che la Sicilia ha dato i natali a tanti uomini illustri ma è purtroppo denigrata da personaggi come Danilo Dolci e da un romanzo come Il Gattopardo. Il documento del cardinale mantovano si può annoverare tra le pagine più emblematiche del sicilianismo, un’ideologia a forte tasso di filomafiosità. Non mancheranno all’alto prelato occasioni per continuare a tempestare contro i comunisti: è opera loro la montatura inscenata contro i monaci di Mazzarino – scriveva Ruffini a Giovanni XXIII – ma i frati saranno condannati come complici di mafiosi responsabili di estorsioni e di omicidi. Invano a loro difesa si erano levate le voci di avvocati come Giovanni Leone e Francesco Carnelutti, che sostenne che i frati erano dei santi, perché cercavano di persuadere gli estorti a pagare il pizzo, per evitare guai peggiori. Un esempio di francescanesimo riscritto in chiave mafiosa.
Dagli anni ’80 ad oggi: emergenze, impegno e compromesso Le vicende degli ultimi decenni dovrebbero essere meglio note ma non mi pare che sia in corso una riflessione adeguata. Con la montagna di morti dell’ultima guerra di mafia (1981-83) e soprattutto con i grandi delitti e le stragi dei primi anni ’90, si è riscoperta ancora una volta la mafia (una storia che si ripete, dal delitto Notarbartolo ai nostri giorni) e c’è stata una reazione che ha portato alla legislazione antimafia, agli arresti e alle condanne e alla mobilitazione della società civile. La Chiesa, attraverso la parola del cardinale di Palermo Pappalardo e del Papa, ha preso posizione, c’è stato un impegno, meno visibile ma prezioso, di preti e credenti che ha portato al martirio di don Puglisi e di don Diana in Campania; si è parlato di mafia in termini nuovi, come “peccato sociale” e “struttura di peccato”, si sono gettate le basi per una “pastorale antimafia”. Ma anche la Chiesa e il mondo cattolico non sono sfuggiti al limite di fondo che hanno avuto istituzioni e società civile, attivate in una logica d’emergenza, cioè di risposta alla sfida mafiosa, con il ripiegamento e il ritorno alla “normalità” una volta che i mafiosi più accorti hanno messo da parte la strategia stragista. Se la mafia viene considerata soprattutto o esclusivamente una fabbrica di omicidi, un’emergenza straordinaria coincidente con la stagione dei delitti eccellenti, è facile passare all’equazione secondo cui una mafia che non uccide più, o uccide meno, comunque non uccide personaggi di primo piano, è una mafia alle corde, di cui non preoccuparsi eccessivamente.
E poi, tenendo conto di quello che rappresentano Chiesa e mondo cattolico nel nostro Paese, e non solo, non si poteva andare oltre un certo punto. Così le omelie del cardinale Pappalardo e del Papa si sono fermate quando era chiaro che bisognava affrontare il nodo del potere democristiano e del ruolo della Chiesa al suo interno. Le reazioni all’omicidio di don Puglisi sono state sottotono, la Curia e la parrocchia non si sono costituite parte civile al processo contro i mafiosi incriminati dell’assassinio, con una giustificazione inquietante: alla Chiesa interessa la conversione dei peccatori e quindi la giustizia terrena non ha molta importanza, una valutazione che rischia di somigliare al non riconoscimento del monopolio statale della forza e della giustizia teorizzato e praticato dai mafiosi.
A cosa alludeva il sostituto della segreteria di Stato nella lettera al cardinale Ruffini del 1963 quando parlava di mentalità mafiosa e mentalità religiosa? Il discorso allora non fu sviluppato ma successivamente non sono mancati contributi significativi. Teologi, moralisti, sociologi hanno sottolineato che c’erano e ci sono concezioni, linguaggi, riti, pratiche, che spiegano come in società ufficialmente cristianizzate si possano affermare e istituzionalizzare comportamenti e organizzazioni criminali. I mafiosi devoti, da Michele Greco ad Aglieri, assidui lettori della Bibbia e di testi edificanti e con altarino da latitanza, come pure i sicari di Medellín che pregano Maria Ausiliatrice prima di recarsi a compiere il loro omicidio quotidiano, condividono una religiosità che è fatta di pratiche esteriori, di elemosine e processioni, di frequentazioni con uomini di Chiesa che li esortano al pentimento, assicurando che Dio non farà mancare il suo perdono. Qualcuno ha visto nel culto dei santi come intermediari tra Dio e gli uomini qualcosa di molto simile al clientelismo, una sorta di proiezione celeste della pratica della raccomandazione; certamente l’autoritarismo della struttura gerarchica non aiuta a promuovere la partecipazione democratica e un’etica che dà maggiore importanza agli “atti impuri” che ai comportamenti sociali non stimola i fedeli a diventare cittadini impegnati per il rinnovamento della società.
Chiesa e mondo cattolico erano e rimangono una realtà composita, in cui convivono don Puglisi e padre Frittitta, la teologia della liberazione e le spregiudicate operazioni finanziarie di monsignor Marcinkus (su cui non si è mai fatta chiarezza). E se gli occhi sono rivolti al cielo, i piedi sono ben piantati sulla terra. La Chiesa fa politica, amministra consenso, assegna preferenze. In passato l’azione politica dei cattolici osservanti aveva come collante l’anticomunismo, e in suo nome si sono fatti compromessi e ingoiati rospi; ora, rottamata l’unità politica, può bastare la condivisione di concezioni e interessi, che vanno dalla condanna dell’aborto al finanziamento delle scuole private. Nessuna sorpresa se su questa base si trovano consonanze con il centro-destra, verso cui vanno le simpatie del Vaticano e della Conferenza episcopale italiana. La “questione morale” può attendere. Dopo mezzo secolo di Andreotti, ben venga Berlusconi, anche se della sua compagnia fa parte un certo Bossi che preferisce la acque del Po all’acqua benedetta.
Come pure non bisogna sorprendersi se già sono cominciate le gare di salto sul carro del vincitore. Alle elezioni regionali siciliane si è candidata con Forza Italia una dirigente delle Acli, una delle più popolari organizzazioni cattoliche, che a suo tempo fu nominata referente regionale di Libera. Scelta che non fu condivisa da noi del Centro Impastato, da alcuni del Centro sociale San Saverio dell’Albergheria e da qualche altro, che pure non aveva fama di estremista, e sulla base di argomentazioni non peregrine. Le Acli in Sicilia avevano avuto un ruolo nel movimento per la pace dei primi anni ’80, avevano fatto parte del Coordinamento antimafia, costituitosi a Palermo nel 1984 su proposta del Centro Impastato, ma il loro impegno doveva fare i conti con la compartecipazione al potere democristiano (per cui in privato si poteva dire tutto il male possibile di Salvo Lima, ma in pubblico bisognava tenere la lingua a posto) e con le compatibilità del sistema clientelare. Osservazioni che caddero nel vuoto.
Allora, in nome di scelte discutibili, si produssero lacerazioni che non hanno certo giovato al movimento antimafia. Ora chi predicava l’educazione alla legalità ha pensato bene di traslocare in condomini più accoglienti, porta a porta con personaggi sotto processo per mafia (ma si può scommettere sulla loro assoluzione, dopo il diritto all’impunità proclamato da un voto che, anche per effetto di un sistema elettorale aberrante, somiglia a un plebiscito). Queste vicende, in un quadro in cui la lotta antimafia rischia di essere archiviata e le istituzioni sono in mani certamente poco affidabili, saranno un’occasione per riflettere o si dirà che sono soltanto un incidente di percorso? Pubblicato, con il titolo La mafia è male, però…, su “Narcomafie”, luglio-agosto 2001
Chiesa e mafia, una ferita sempre aperta
di Alessandra DinoDocente di Sociologia della criminalità e della corruzione, Università di Palermo Interrogarsi oggi sul rapporto tra Chiesa e mafia chiama in causa differenti piani di analisi. Occorre chiedersi il significato delle devozioni e dei riti religiosi, il ruolo svolto dalla “fede” dentro i contesti criminali; ma è indispensabile anche considerare le posizioni espresse dalla Chiesa nei confronti delle mafie sia nei pronunciamenti ufficiali delle gerarchie ecclesiastiche, sia nelle prassi pastorali sui territori, sia nel dibattito ecclesiologico.
Di cruciale importanza è infine l’approfondimento di alcune questioni sollevate dagli studi e sollecitate dalla cronaca; tra queste, il rapporto tra giustizia divina e giustizia terrena, tra pentimento e collaborazione, tra peccato e reato; la possibilità di elaborare una pastorale antimafiosa e il dibattito sulla scomunica per mafiosi e corrotti.
Punti nodali che chiamano in causa i non semplici rapporti tra Chiesa e Stato, con una Chiesa unita nei pronunciamenti ma incapace di esprimere, nella prassi, una linea di condotta unitaria.
Il legame tra ritualità religiosa e mafia è risalente nel tempo.
Col suo ricco corredo di riti e di cerimonie sacre, la religione offre agli “uomini d’onore” e alle loro donne certezze e modelli identificativi. Attribuisce sacralità all’organizzazione, prestigio all’autorità del capo; lenisce inquietudini e momenti di crisi, facendo da sostrato alla coesione del gruppo e agendo come agenzia primaria di produzione di senso.
Chiedersi, quindi, quale sia lo spazio oggi occupato dalla questione mafiosa nella pastorale della Chiesa cattolica e nel dibattito ecclesiologico, significa – come ha scritto Rosario Giuè – confrontarsi con una “ferita aperta”.
Pesano i silenzi dei ministri della Chiesa. Primo fra tutti quello della Conferenza Episcopale italiana sulle stragi di mafia degli anni ’90, certo non mosso dal desiderio di tener lontano dal regno di Dio il regno di Cesare; ben altra loquacità i vescovi italiani hanno, infatti, mostrato nel contrastare il referendum sulla legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita.
Profonde le ferite aperte tra i cattolici dalla netta contrapposizione dell’Episcopato alla legge sul divorzio, nel 1974. Durissima l’opposizione della Chiesa, nel 1978, contro legge sull’interruzione di gravidanza che stava per essere approvata dal Parlamento.
Ciononostante, non sono in pochi a sostenere che il sacerdote debba limitarsi a curare lo “spirito” piuttosto che produrre un impegno concreto contro la mafia, offrendo utili scappatoie a chi riesce a conciliare pentimento religioso e fedeltà agli “amici” mafiosi.
Recentemente, poi, l’emergere di nuovi scenari chiede strumenti di analisi più raffinati.
Di fronte al processo di secolarizzazione che coinvolge anche le organizzazioni criminali si potrebbe ritenere, infatti, che le strade della chiesa e quelle della mafia si avviino a divenire davvero divergenti. La situazione, però, si mostra più complessa e accanto a indicatori di laicizzazione (si pensi a Matteo Messina Denaro che si professa esplicitamente ateo), permangono evidenti richiami a forme di pseudo-sacralità che fanno presagire come non imminenti sia l’abbandono dei simboli religiosi, sia il ricorso alla “fede” da parte dei mafiosi. L’accreditamento che le sacre liturgie offrono è difficilmente sostituibile con altra simbologia di analogo impatto e condivisibilità, ma anche se ciò avvenisse non sarebbe da considerare una vittoria, se la Chiesa non prendesse coscienza dell’ambiguità cui si espone finché rimane saldo il suo legame col potere.
E se nel documento del 2010 i vescovi italiani hanno ribadito l’opzione in favore dei poveri, per indirizzarsi concretamente su questo percorso occorrerebbe tranciare quell’alleanza coi potenti che ha reso possibile che l’Italia, culla del cattolicesimo, fosse anche culla di stragi e corruzione.
Lungo e travagliato l’iter che ha condotto la chiesa a dichiarare inconciliabili mafia e Vangelo. Difficile capire il perché di dubbi ed esitazioni che non si sono manifestati di fronte a problemi di analoga importanza, come aborto, divorzio, eutanasia. Tortuoso anche il percorso per la beatificazione di Padre Puglisi.
Nel frattempo Papa Francesco è tornato con rinnovata chiarezza a decretare la scomunica per “tutti” i mafiosi. È un tema sul quale la Chiesa aveva già dibattuto nel 1944, nel 1952 e nel 1982 esprimendo l’estensione ai mafiosi della scomunica verso “tutte le manifestazioni di violenza criminale”. Affermando nel 1994 “l’insanabile opposizione al Vangelo di Gesù Cristo” di “tutti coloro che, in qualsiasi modo, deliberatamente, fanno parte della mafia o ad essa aderiscono o pongono atti di connivenza con essa”. Ribadendo tale opposizione nel 1996, nel 2010 e nel 2012.
Ma il papa è andato oltre in quest’operazione di chiarezza; celebrando con don Luigi Ciotti la giornata della memoria e dell’impegno nel 2014 e indossando la stola sacerdotale di don Peppino Diana; denunciando corrotti e corruttori che con le mafie fanno i loro affari.
«Scandaloso chi dona alla Chiesa ma ruba allo Stato», ha detto il papa, definendo la vita dei «cristiani e dei preti corrotti» «una putredine verniciata». Istituendo, infine, nel giugno del 2017, un gruppo di lavoro incaricato di “approfondire a livello internazionale e di dottrina giuridica della Chiesa” la questione della scomunica per corruzione e associazione mafiosa.
Di fronte a questo delicato crinale, l’auspicio è che la Chiesa non si spacchi ancora una volta, attratta dalle sirene del denaro e del potere, dilacerata da un confuso sentimento di pietas, aprendo salvifiche crepe all’esibita devozione di corrotti, collusi e mafiosi; che riesca a schierarsi dalla parte dei più deboli, non avendo timore di confrontarsi col cambiamento, impaurita da una “secolarizzazione” che ha già consumato quando ha accettato il mortale abbraccio coi potenti e i mafiosi. La Repubblica 3.4.2018
La resistenza cristiana alla mafia
Il 9 maggio del 1993, Giovanni Paolo II pronunciava ad Agrigento – a conclusione della messa celebrata nella Valle dei Templi – un discorso che ha tracciato definitivamente le peculiari caratteristiche di un ragionamento cristiano sulla mafia. A venticinque anni da quella celebre riflessione, profondi cambiamenti hanno trasformato tanto il quadro globale quanto il contesto locale. La geopolitica internazionale e i partitismi territoriali hanno nuovi volti e si muovono a partire da aggiornate istanze destinate raramente allo sviluppo della comunità umana. Anche la Sicilia si trova, con tutte le sue potenzialità e depressioni, a decifrare i rischi e le opportunità della globalizzazione. Così, da un lato il massiccio fenomeno dell’immigrazione dall’Africa e dall’Asia che coinvolge migliaia di persone, dall’altro l’inarrestabile diffusione di pratiche perverse e malsane nell’amministrazione della cosa pubblica sembrano tagliare fuori la Sicilia da ogni progetto economico e politico di sviluppo. Inoltre da diversi anni l’isola subisce in uscita un flusso migratorio di giovani verso il Centro-Nord Italia e l’estero che priva i territori di competenze spendibili nell’impresa, nella scuola, nella sanità, nell’impegno politico. Nonostante i repentini cambiamenti economici, politici e culturali avvenuti nell’ultimo ventennio, in terra siciliana permane una radicata e influente criminalità organizzata. Infatti, concluso il periodo “stragista”, oggi la mafia – come annotano i vescovi italiani nel documento Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno – si muove al pari di un torrente sotterraneo che investe ogni angolo della società isolana e, perciò, interroga e preoccupa anche le comunità ecclesiali: «le organizzazioni mafiose, che hanno messo radici in tutto il territorio italiano, hanno sviluppato attività economiche, mutuando tecniche e metodi del capitalismo più avanzato, mantenendo al contempo ben collaudate forme arcaiche e violente di controllo sul territorio e sulla società» (Conferenza Episcopale Italiana 2010, n. 9).
A venticinque anni dalle parole di condanna di Giovanni Paolo
II rivolte alla civiltà della morte generata dalla criminalità organizzata e in preparazione alla visita di papa Francesco dello scorso 15 settembre, con la lettera intitolata Convertitevi! – rivolta tanto ai credenti quanto a chi opera per la giustizia e la pace, oltre che agli stessi mafiosi – i vescovi siciliani sono intervenuti per sostenere un discorso propriamente cristiano ed ecclesiale di resistenza alla mafia. Secondo i pastori delle Chiese di Sicilia, è necessario lasciarsi interpellare ancora da quel celebre discorso di Wojtyla poiché si tratta di un vero e proprio: «annuncio evangelico, peraltro, coraggiosamente e sapientemente mirato. Vale a dire non formulato in termini generici o espresso in astratto, bensì rivolto proprio a noi siciliani» (Conferenza Episcopale Siciliana 2018, 11). La riflessione ecclesiale sul fenomeno mafioso ha vissuto diverse stagioni, alcune delle quali hanno indotto certi commentatori a parlare di una sorta di silenzio della Chiesa sulla criminalità organizzata. In realtà, alla luce dell’insegnamento del vescovo siciliano Cataldo Naro, possiamo individuare tre fasi che hanno condotto la comunità credente a una matura riflessione sulla mafia. Secondo Naro, dopo le questioni fra Chiesa e Stato per via dell’unità d’Italia, la comunità ecclesiale si percepiva estranea a problematiche come la mafia, la cui diretta competenza ricadeva nell’autorità statale. Si trattava di «un silenzio nato da un’estraneità ostile» (Naro 2007a, 261). All’indomani della Seconda guerra mondiale, quando i cattolici guidavano politicamente la Regione siciliana e l’intero Paese, il cardinale arcivescovo di Palermo Ernesto Ruffini fu il primo a utilizzare la parola mafia accostandola alla delinquenza comune presente in tutti i grandi agglomerati urbani. In quel periodo, a parere di Naro, la Chiesa assumeva le categorie interpretative diffuse nella società civile. Difatti le parole di Ruffini «non erano diverse da quelle utilizzate dal Presidente della Regione di allora o dal Procuratore della Repubblica di quel tempo, i quali ancora, a quell’epoca, sottovalutavano di fatto il fenomeno […] Anche le parole di Pappalardo, più tardi, erano identiche a quelle del sindaco di Palermo e a quelle dei magistrati del suo tempo» (Naro 2007b). La svolta si compie con il discorso di Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi con il quale per la prima volta la Chiesa utilizzava le categorie biblico-profetiche per interpretare e giudicare le cosche mafiose: «Finalmente il modo di parlare della Chiesa sul fenomeno mafioso fa riferimento alla sua tradizione. La Chiesa giustamente si unisce al coro che chiede giustizia, legalità […] ma aggiungendo finalmente l’apporto peculiare ricavato dalla sua tradizione evangelica» (ivi, 265). Da quel grido di dolore e di speranza di Wojtyla si è avviata una riflessione sistematica sulle mafie a partire da categorie specificatamente cristiane. Il discernimento cristiano del fenomeno mafioso comincia dall’assunzione degli esiti nefasti prodotti dalla presenza delle cosche nell’isola. A parere dei vescovi siciliani, al ricordo delle tante e diverse vittime di mafia bisogna legare una testimonianza educativa, sociale, politica, culturale e imprenditoriale tesa ad arginare l’opera mafiosa. L’analisi della realtà riletta alla luce dell’annuncio evangelico genera nella storia un particolare timbro profetico come quello che Wojtyla ha tracciato alla Valle dei Templi. Pertanto, il cambiamento può avviarsi a partire dalla consapevolezza che la mafia è una struttura di peccato, la quale sparge il proprio seme di morte sia fra gli appartenenti alle cosche sia tramite la corruzione amministrativa e la cultura malavitosa: «Tutti i mafiosi sono peccatori: quelli con la pistola e quelli che si mimetizzano tra i cosiddetti colletti bianchi […] Peccato ancor più grave è la mentalità mafiosa, anche quando si esprime nei gesti quotidiani di prevaricazione» (Conferenza Episcopale Siciliana 2018, 20-21). L’incompatibilità tra mafia e Vangelo è la logica conseguenza dell’opposizione di una cultura della morte, come quella mafiosa, alla cultura della vita annunciata dal messaggio cristiano. In terra di Sicilia, la profezia della parola inaugurata da Giovanni Paolo II si lega alla testimonianza concreta di don Pino Puglisi. La sua opera pastorale e il suo martirio, riconosciuto dalla Chiesa tramite la beatificazione del 2013, indicano alle comunità credenti il terreno per resistere e contrastare la mafia attraverso una visione cristiana della storia. Così, a parere dei pastori delle Chiese siciliane, il discorso cristiano sulla mafia non può livellarsi su ragionamenti sociologici, giuridici, politici o esclusivamente morali tipici dei vari segmenti istituzionali operanti nella società. Piuttosto, con sempre maggiore consapevolezza, la comunità ecclesiale intera è chiamata a elaborare parole e opere profetiche capaci di interpellare e scuotere la coscienza tanto dei mafiosi quanto di chi ha perso ogni speranza di cambiamento. Perciò, nel mutamento d’epoca in atto, per i pastori delle comunità siciliane: «dobbiamo accettare la sfida – precipuamente formativa ed educativa – di risvegliare nelle persone il senso dell’appartenenza ecclesiale» (ivi, 32). Un invito che ha trovato un’ulteriore conferma nell’omelia di papa Francesco a Palermo in occasione del 25º anniversario della morte di padre Pino Puglisi. Le parole pronunciate nella nostra isola venticinque anni fa da Giovanni Paolo II hanno definitivamente avviato il discorso cristiano sulle mafie. La lettera, che i vescovi inviano al popolo siciliano nella ricorrenza di quella storica visita, si propone di continuare a rileggere con la luce del Vangelo i problemi e le sfide che si presentano tanto alle comunità ecclesiali quanto all’intera società. Il titolo dello scritto rimanda all’atteggiamento di umile pentimento e di concreto cambiamento di sé che ogni fedele, non meno dei mafiosi, è invitato ad assumere nella propria esistenza. L’invito alla conversione riguarda integralmente la nostra comunità che deve abbandonare la cultura della morte per abbracciare quella della vita. L’intera Chiesa siciliana guidata dai suoi vescovi può avanzare un contributo al popolo siciliano se, alla luce del proprio specifico cristiano, oltre a un modo di dire nuovo proporrà e testimonierà un modo di vivere nuovo. Continuare ad “armare il cuore degli uomini” al fine di resistere alla mafia, per le Chiese di Sicilia significa contribuire ad avviare un nuovo protagonismo – dei credenti e dell’intera società civile – fatto di coraggio e di speranza attraverso una capillare opera di formazione delle coscienze (cfr Conferenza Episcopale Italiana 1991). La Sicilia e l’intero meridione d’Italia hanno tutte le potenzialità per liberarsi dalla morsa delle cosche e mobilitarsi in vista di un progetto per le future generazioni. AGGIORNAMENTI SOCIALI ROCCO GUMINA
La Chiesa e la mafia
“La lotta alla mafia ha bisogno di un maggiore coinvolgimento della Chiesa”. Lo ha detto il procuratore nazionale Franco Roberti che ha lanciato una stoccata molto forte alle gerarchie ecclesiastiche: “Sono convinto che la Chiesa potrebbe moltissimo contro le mafie e gran parte delle responsabilità le ha proprio la Chiesa perché per secoli non ha fatto niente”. Posto che la mafia è un fenomeno sviluppato negli ultimi 200 anni e riconosciuto come tale, ovvero come organizzazione criminale strutturata con finalità ben precise, dal dopoguerra in poi, il sito UCCR ha fatto un lavoro molto completo di ricostruzione di tutte le azioni della Chiesa per contrastare questa realtà.
L’impegno della Chiesa Non solo i momenti più eclatanti come la denuncia di Giovanni Paolo II del 1993 o l’omicidio del beato Pino Puglisi o ancora il costante sforzo di oggi di don Luigi Ciotti ma anche il costante lavoro promosso dai vescovi di Palermo e dalla conferenza episcopale siciliana (e italiana) dal 1946 in poi. Eppure, una delle frasi che maggiormente citata quando si parla della presunta ambiguità della Chiesa nei confronti della mafia è quella che viene così riportata: “La mafia non esiste è una invenzione del nord/dei giornali/dei comunisti” (la versione cambia a seconda di chi cita la frase incriminata).
La mafia è una invenzione? Questa affermazione è stata attribuita al cardinale Ernesto Ruffini, vescovo del capoluogo siciliano dal 1945 al 1967 (a volte viene citata virgolettata ma senza una attribuzione particolare, come se fosse la posizione ufficiale della Chiesa o della chiesa sicialiana negli anni tra il dopoguerra e gli anni ’80). Cercando nei documenti ufficiali e nei giornali dell’epoca non si trova una fonte che riporti esattamente questa frase così come viene comunemente usata. Sicuramente il cardinale, lombardo di nascita, già conosceva la serietà del problema mafioso in Sicilia durante il suo episcopato. Tanto da affermare, in un’intervista rilasciata sulle pagine de La Stampa, intitolata “Colloquio con l’Arcivescovo di Palermo”, del 22 maggio 1959:
Qui abbiamo problemi enormi da risolvere, pensi a cosa è la mafia, alla sua rete di delitti. Già i mezzi per combatterla sono insufficienti e come se non bastasse arriva una nuova amnistia. Faccia il calcolo di quante amnistie sono state concesse dalla fine della guerra, una ogni due anni »
Il primo vescovo a parlare di mafia È evidente che la risposta di Ruffini tradiva una certa irritazione per aver dovuto smentire qualunque commistione tra la fede cristiana e qualsivoglia mentalità criminale o mafiosa. Non di meno non vi è alcuna smentita circa l’esistenza del fenomeno mafioso. L’accusa rivolta alle forze politiche di sinistra è da inquadrare in un momento storico di forte tensione tra Chiesa e forze marxiste e va spiegata anche con la volontà di Ruffini di tutelare l’immagine di una Sicilia dipinta in modo fortemente stereotipato, come se fosse una regione intrinsecamente mafiosa. L’anno dopo infatti il cardinale Ruffini parlò pubblicamente di mafia con lo scopo palese di non minimizzare il fenomeno ma anche di tutelare la stragrande maggioranza dei siciliani e la loro dignità di popolo onesto e spesso dimenticato. Fu inoltre il primo a parlare di “stato nello stato” riferendosi alla mafia. In occasione della Domenica delle Palme del 1964, pubblicò una lettera pastorale dal titolo Il vero volto della Sicilia che rappresenta il primo documento ufficiale di un vescovo siciliano e della Chiesa cattolica riguardo alla mafia. La lettera evidenzia un chiaro intento di difesa della Sicilia e di distinzione dei siciliani rispetto alla mafia: « Non può destare meraviglia che il vecchio, deplorevole sistema sia sopravvissuto: pur essendo cambiato il campo d’azione. Le radici sono rimaste: alcuni capi, approfittando della miseria e dell’ignoranza, sono riusciti a mobilitare gruppi ardimentosi, pronti a tutto osare per difendere i loro privati interessi e per garantire la loro supremazia nella orticoltura, nel mercato e nei più disparati settori sociali. Questi abusi sono divenuti a poco a poco tristi consuetudini perché tutelati dall’omertà degli onesti, costretti al silenzio per paura, e dalla debolezza dei poteri, ai quali spettavano il diritto e l’obbligo di prevenire e di reprimere la delinquenza in qualsiasi momento, a qualunque costo. Si rileva dai fatti che la Mafia è sempre stata costituita da una sparuta minoranza. La Sicilia è ancora lontana dall’avere quel benessere che le spetta; per troppo tempo è stata quasi dimenticata; sono necessari provvedimento che il popolo non può darsi da sé. Occorrono case, scuole – specialmente elementari e professionali – e fonti di lavoro. […] Urge che siano applicati con la dovuta energia e la maggiore sollecitudine i rimedi deliberati dalle pubbliche autorità – e altri siano presi se risultano necessari – perché scompaiano quanto prima la delinquenza e l’immoralità, sia individuali che associate »Così rispondeva Ruffini: È una supposizione calunniosa messa in giro, specialmente fuori dall’Isola di Sicilia, dai socialcomunisti, i quali accusano la Democrazia Cristiana di essere appoggiata dalla mafia, mentre difendono i propri interessi economici in concorrenza proprio con organizzatori mafiosi o ritenuti tali”. Da dove nasce allora l’attribuzione a Ruffini di quella frase? Tutto comincia subito dopo la strage di Ciaculli del 1963. Il 5 agosto di quell’anno Angelo Dell’Acqua, sostituto della segreteria di Stato, inviò una lettera al cardinale Ernesto Ruffini, in cui invitava l’arcivescovo a valutare se non fosse “il caso, anche da parte ecclesiastica, di promuovere un’azione positiva e sistematica con i mezzi che le sono propri – d’istruzione, di persuasione, di deplorazione, di riforma morale – per dissociare la mentalità della cosiddetta “mafia” da quella religiosa e per confortare questa a una più coerente osservanza dei principi cristiani, col triplice scopo di elevare il sentimento civile della popolazione siciliana, di pacificare gli animi e di prevenire nuovi attentati alla vita umana”. La risposta che inviò Ruffini al Vaticano generò l’incomprensione che ancora oggi viene citata. Nella lettera spedita alla segreteria di stato l’arcivescovo di Palermo volle fortemente sottolineare come chi era mafioso era già molto lontano dalla Chiesa e che a volere accomunare elementi di Cosa Nostra e modi di fare mafiosi al mondo cattolico erano forze che si muovevano per interessi politici.
Giovanni Faclone e il card. Pappalardo Le reazioni a questa lettera furono molte e contrastanti fra loro e tra di esse molte addebitarono senza alcun fondamento a Ruffini di aver negato l’esistenza della mafia, che sarebbe stata un’invenzione dei comunisti. Al riguardo, valga l’analisi acutamente svolta dal Giudice Giovanni Falcone, che – in un articolo comparso su L’Unità il 31 maggio 1992, otto giorni dopo la sua morte – rilevava come negli anni del dopoguerra il fenomeno mafioso fosse stato totalmente sottovalutato sia da parte di tutti i mezzi di informazione, sia da parte di tutte le istituzioni dello Stato, politiche e giudiziarie. Nel 1994 il cardinale Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Palermo, in un’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia il 25 febbraio di quell’anno ha scritto: «Il Cardinale Ruffini, che tanti meriti ebbe a Palermo, per l’attività sociale che promosse, per i tanti e diversificati centri di servizio che aprì, tuttora operanti, per il lavoro che procurò e diede, sollecitando le autorità di allora, svolse certamente un’azione quanto mai efficace nei riguardi della mafia, anche se non ebbe a parlarne quanto dopo se ne è fatto. In fondo le opere valgono più delle parole. Non si può pretendere ora, quando tante cose sono meglio conosciute, che egli avesse allora così circostanziato il quadro di cosa fosse la mafia, e delle azioni che si potessero ad essa riferire». di Raffaele Buscemi, 5 marzo 2015 DOC
LA CHIESA E’ CONTRO LA MAFIA – I messaggi di Mons. Moscone scuotono le coscienze addormentate – Di M. Illiceto
L’estate, specie al sud, è ricca di feste patronali, di novene e di riti religiosi che hanno nella devozione popolare un loro punto di appiglio che sembra resistere a quel processo di secolarizzazione che altrove sta dichiarando la fine della religione. Ma ciò che trapassa di una religione è solo la sua parte sbagliata. Al contrario, quando questa è autentica non c’è tramonto che possa segnarla. Non c’è solo devozione nelle nostre feste patronali, c’è anche altro che ogni tanto emerge e va oltre gli stretti confini della pura realtà ecclesiale. E’ vero però che troppo spesso e per troppo tempo siamo stati abituati a vedere e a vivere le nostre feste patronali come un fatto puramente religioso. Una sorta di bigottismo sterile e infecondo che tradiva il messaggio autentico del cristianesimo evangelico, solo perché fondato su dualismi anacronistici che si nutrivano della separazione tra vita spirituale e le reali condizioni materiali, tra culto da rendere a Dio e servizio da dedicare all’uomo in termini di giustizia e carità. Come se la religione fosse sganciata dalla vita sociale e dai problemi reali della vita quotidiana. Una religione che il filosofo L. Feuerbach vedeva giustamente come una forma di “alienazione” e K. Marx definiva in maniera opportuna come “oppio dei popoli”, cioè uno strumento nelle mani dei ricchi e dei potenti per addomesticare le masse ignoranti, per assopire le coscienze in modo da avere campo libero nella gestione del potere senza che nessuno si potesse ribellare. Era questa una visione della religione che, anche se rifletteva le condizioni storiche di un certo cristianesimo ormai datato, non corrisponde affatto al messaggio evangelico che invece vede un Gesù di Nazareth usare la religione come critica sociale e come risveglio delle coscienze, come una vera propria liberazione interiore dalle radici del peccato che possono essere non solo di matrice individuale ma ancor più sociale, specie se si trattava di ridare dignità alle persone, in particolar modo agli ultimi, ai diseredati e agli sfruttati. Su questa linea, e sulla scia già tracciata dal compianto Mons. Michele Castoro, si va ponendo in questi suoi primi mesi di episcopato il nuovo arcivescovo della diocesi di Manfredonia-Vieste-S. Giovanni Rotondo, Mons. Franco Moscone. Lo ha fatto nel messaggio proclamato alla fine della processione in onore della Madonna di Siponto, quando, invitando la città di Manfredonia a “rialzarsi” ha sottolineato che “Il rispetto e promozione della legalità è un punto focale per il nostro territorio garganico tanto come società civile che ecclesiale”. Per Padre Franco Moscone “Il crescere esponenziale di azioni violente, fino agli omicidi ed alla sparizione di persone … non ci possono lasciare silenti”. Come a dire che la legalità non è un regalo che dobbiamo aspettarci che venga dall’alto dei poteri, ma è patrimonio di tutta una comunità e si costruisce dal basso tramite meccanismi di partecipazione e di cittadinanza attiva e resposnabile. Più che un regalo o una concessione è un impegno che coinvolge tutti a vario livello: culturale, educativo, sociale e vivile, politico ed economico. E anche religioso!
Per questo motivo per Padre Franco Moscone “Denunciare l’illegalità è un dovere”. E ancora di più “lo è il farsi protagonisti di gesti di legalità, partendo da quelli che, scorrettamente, possiamo giudicare meno significativi”. Per il vescovo la legalità comincia dai gesti di vita quotidiana: “Se non rispettiamo la legalità diventa inutile lamentarsi per la carenza di lavoro o per la desolante fuga dei nostri bravi e volitivi giovani in altre regioni italiane ed europee per studio e attività professionali. Al di fuori di un recupero della legalità, infatti, non c’è spazio per lo studio serio ed il lavoro onesto che producono a loro volta ricerca e novità lavorative-occupazionali”. Da qui la necessità di educare e soprattutto di educarci al rispetto delle regole cominciando da quelle più piccole che riteniamo siano le più ovvie. “Educare alla legalità significa innanzitutto prendere coscienza della realtà per quello che è, senza nascondersi dietro false etichette, paure, morosità e sterili lamentele, cercando di innescare processi positivi nelle imprese (che esistono nel nostro territorio e sono capaci di progettare), nelle scuole, nelle associazioni, nei gruppi di riferimento a cui ognuno a titolo diverso aderisce. Manfredonia non perdere la speranza, ri-alzati decisa sul fondamento della legalità”. Nessuno si aspettava che alla fine di un evento religioso quale una processione si potessero ascoltare parole così forti su questioni sociali che interpellano i cittadini prima che i credenti, ma anche la politica e di riflesso l’impegno di tutte le forze sociali e civili della città. Finalmente si capisce che il vangelo ha una sua dimensione sociale che davvero può rovesciare i rapporti di forza falsamene costruiti su privilegi e soprusi. Lo stesso è accaduto ieri a Monte S. Angelo, durante la festa in onore di S. Michele. In questa occasione Padre Franco ha esordito dicendo che non solo la mafia garganica ha una sua specifica connotazione, ma soprattutto che “Chi è nella mafia pensa di essere libero ma in fondo ha un piede nella fossa e uno legato alla catena…pensa di assoggettare ma in fondo è assoggettato“. Padre Franco ha invitato i mafiosi locali a “convertirsi” non solo a Dio ma anche all’uomo, a quella legge morale che secondo il filosofo Kant si trova in ognuno di noi, anche in chi momentaneamente l’ha sospesa e tradita compiendo atti criminali. E così il risveglio delle coscienze è stato avviato. Chi voleva una chiesa rintanata e chiesa in sacrestia è rimasto deluso. Tale processo è cominciato e ha preso avvio dalla chiesa che promuove nelle persone un cammino di liberazione da tutti quegli elementi di cui si fa forte la mafia, e cioè dalla paura e dall’omertà, dall’inerzia e dalla rassegnazione, dall’isolamento e dall’indifferenza verso tutto ciò che è pubblico e sociale. Soprattutto dalla falsa idea di uno Stato percepito come lontano, assente, se non addirittura come nemico da combattere e da eludere. Ora tocca ai partiti, ai movimenti, ala cultura, ala scuola, alle associazioni, alle parrocchie riprendersi il territorio. Ma soprattutto alle singole persone come credenti ma specialmente come. Tutte le coscienze vanno accompagnate in un cammino di maggiore consapevolezza sociale e civile per estirpare le ragioni socio-storiche e culturali che hanno permesso il radicarsi di questo male che in fondo non è così potente come appare, ma che al contrario mostra già segni di debolezza e che pertanto può essere combattuto insieme e con speranza. Se la forza della mafia è la nostra divisione, allora la nostra coesione sarà l’arma con cui combatterla per vincere in termini di legalità, civiltà e cittadinanza. 30.9.2019 Il Giornale di Monte
Fucile e Bibbia, boss devoti. Bagarella si sentiva simile a Dio
Negli ultimi tempi, con sempre maggiore frequenza, le cronache ci danno notizia del cosiddetto “inchino”, cioè la sosta di un santo, portato in processione, dinanzi l’abitazione del boss mafioso locale e ciò in segno di rispetto e quasi di sottomissione, nei confronti di quest’ultimo. Così abbiamo appreso dell’“inchino” al boss di san Michele di Ganzaria, Francesco La Rocca, in occasione della processione del Cristo morto o di quanto accaduto durante la processione a Paternò in provincia di Catania, in occasione dei festeggiamenti della patrona del paese santa Barbara allorquando due cerei, portati a spalla da alcuni portantini, si sono fermati davanti alla casa della famiglia di un pregiudicato degli “Assinnata”, vicini alla cosca Santapaola. La processione si è fermata ed è stata intonata la musica del Padrino. Altro episodio analogo è quello verificatosi nella frazione Livardi di San Paolo Belsito, allorquando un gruppo di fedeli decideva di fare sostare la statua della Vergine in un determinato punto del percorso rivolgendola verso l’abitazione di Agostino Sangermano, agli arresti domiciliari, esponente di spicco della camorra. L’episodio più recente è quello che, a Corleone, ha visto la processione fermarsi davanti la casa di Riina, in via Scorsone 24. In questo caso, sembra che, Ninetta Bagarella, moglie di Totò Riina, al balcone, guardasse soddisfatta la vara di San Giovanni Evangelista. Quest’ultima peraltro ha sostenuto che quel giorno non si trovava a Corleone essendo andata a trovare il marito detenuto fuori dalla Sicilia. Resta comunque il fatto che la processione si è fermata dinanzi la casa del noto boss mafioso, attualmente detenuto in regime di 41 bis. Questi episodi inducono alcune riflessioni sulla religiosità e devozione che molti esponenti, anche di spicco dell’organizzazione mafiosa, hanno, talvolta anche in modo plateale, professato. Gli esempi non mancano.*
I mafiosi hanno sempre preteso di avere una loro religiosità. Nei libri che parlano di mafia, ad esempio, si può quasi sempre vedere una foto degli anni Cinquanta, che ritrae il potente capo mafia di Mussomeli, Genco Russo, al centro di una processione in onore della Madonna dei Miracoli. Russo aveva una panca riservata nella Chiesa madre di Mussomeli. Calogero Vizzini aveva due fratelli preti, un cugino parroco e due zii Vescovi, Luciano Liggio non mancava mai alla messa domenicale, Nitto Santapaola, capomafia catanese, aveva realizzato nel suo covo di latitante un altare alla Madonna e teneva sul comodino la Bibbia e la corona del rosario. Per non dire dei famosi frati cappuccini di Mazzarino che negli anni 50 avevano trasformato il convento in un centro di attività illecite e di mafia. Ma connubi tra mafia e religione si riscontrarono anche all’interno delle Curie vescovili. Una fonte altamente attendibile è certamente Mario Scelba, ministro di polizia dei governi De Gasperi e statista cattolico e per ciò non sospettabile di anticlericalismo. Scrisse Scelba nel suo libro di memorie : “Giuliano si era legato in amicizia con un monsignore (l’Arcivescovo di Monreale?) al quale aveva consegnato per le opere di carità delle somme di denaro, naturalmente rubato. In cambio il monsignore spesse volte aveva fatto ricoverare Giuliano in posti sicuri. (….) era stato nascosto in un convento di suore di clausura, dove era stato presentato dal monsignore, il quale garantiva che si trattava di un buon giovanotto” (Scelba, 1990, p.160) La storia della mafia e le indagini condotte dagli inquirenti, ci danno uno spaccato di boss che pregano, che durante la latitanza ricevono preti per confessare i propri peccati, chiedono la celebrazione di messe, realizzano altari all’esterno delle loro sontuose ville o nelle cappelle interne. Senza dire che negli archivi di molti comuni della Sicilia è possibile rinvenire delle foto di gruppo in cui si notano, in prima fila e l’uno accanto all’altro, il parroco, il sindaco e il capo mafia, in processione dietro la statua della Madonna. Quando Michele Greco, dopo un lungo periodo di latitanza, venne arrestato in un casolare nelle campagne di Caccamo, ricordo che vennero rinvenuti una Bibbia ed altri testi religiosi. Al processo dichiarò: “In questi anni di galera ho trovato conforto solo nella Bibbia che è la base fondamentale…”
Emblematico è il caso di don Mario Frititta. Don Frititta si recava presso il rifugio del boss Pietro Aglieri latitante, secondo il suo assunto, per celebrare messa e amministrare i sacramenti. Venne arrestato con l’accusa di favoreggiamento nei confronti dell’Aglieri in quanto vi era il sospetto che oltre a celebrare messa, gli incontri con quest’ultimo servissero a fare da tramite con l’organizzazione esterna e altresì che gli avesse consigliato di non pentirsi in caso di cattura perché “pentirsi e accusare gli altri non è da cristiani”. Don Frititta poi non era alieno da frequentazioni mafiose tant’è che celebrò le nozze di un altro efferato boss latitante. Giovanni Garofalo. Venne assolto in Appello in quanto avrebbe agito nell’esercizio di un diritto. In altri termini i giudici sostennero che si recava ad incontrare l’Aglieri esclusivamente per finalità inerenti al suo ministero sacerdotale. Quando uscì dal carcere, trovò una folla che lo applaudiva e che implorava la sua benedizione. Il Padre provinciale dei Carmelitani, in disaccordo con l’Arcivescovo di Palermo, non soltanto non lo ammonì ma anzi lo elogiò:
Fra Mario ha svolto la sua opera pastorale con assoluta onestà (….) ha sempre operato per combattere la cultura mafiosa”. Come? E’ un mistero. Uno dei misteri siciliani. Se secondo la logica Dio e mafia costituiscono un binomio impossibile, sembra che ciò venga contraddetto nella realtà. Se infatti dopo le stragi di mafia e l’uccisione di don Pino Puglisi la Chiesa si è mostrata più attenta alla legalità assumendo delle chiare posizioni di condanna della mafia, tuttavia non può non riconoscersi come, specialmente nelle zone ad alta densità mafiosa, si sia assistito ad una sorta di condiscendenza della Chiesa verso Cosa Nostra che, in alcuni casi, sembra porsi come mediatrice del dialogo dei mafiosi con il loro Dio. Come si è visto infatti a proposito di don Frititta, vi sono preti, culturalmente vicini alla mafia, che, come è stato osservato, “ritengono legittimo supportare psicologicamente la latitanza di feroci killer con confessioni e assoluzioni: oppure che teorizzano che il mafioso debba confessare solo ciò che lui ha commesso, senza inguaiare o compromettere terze persone
Certamente non può non rilevarsi l’assoluto contrasto tra le azioni delittuose dei mafiosi e i valori religiosi evangelici. In proposito è interessante riferire quanto alcuni collaboratori di giustizia, ai quali è stata fatta rilevare questa contraddizione, hanno riferito. Ha dichiarato un collaboratore:
Guardi io sono religioso, certo mi vergogno ad andare dal prete e confessarmi, ora no, ora ci potrei andare. Ma quando ero mafioso non è che mi potevo confessare perché dovevo dire al prete che avevo commesso dei reati….ma io penso che sono religiosi (i mafiosi ndr) principalmente perché trovano una giustificazione ai loro misfatti. Certamente verrà difficile per Totò Riina passare per religioso. Anche lui sicuramente se lei avrà l’occasione di andarci a parlare sicuramente lui ci passeranno questi pochi anni di vita che ha, a leggere la Bibbia, i Vangeli, per come fanno tutti gli altri (ride) anche Michele Greco già quando c’era il maxiprocesso nell’87 parlava di Bibbia…..Per certe persone essere religiosi è una cosa essere criminali un’altra.
Altro collaboratore di giustizia dichiarava di essere religioso e che ogni domenica andava a messa con i figli. Alla domanda se non gli veniva difficile il sabato sparare e la Domenica andare a Messa rispondeva di sentirsi in colpa per quello che faceva precisando che in Cosa Nostra:
Non ho mai ammazzato una persona per me…non ho ammazzato le persone diciamo, per un oltraggio che hanno fatto a me….. Eppure io ho ammazzato tante persone che io non conoscevo, che a me non mi avevano fatto niente, e quindi…mi sentivo in colpa, a voglia che mi sentivo in colpa!
Rispondendo all’interrogativo sul contrasto tra la religiosità e l’uccidere, rispondeva di essersi posto l’interrogativo ma che non riusciva a darvi una risposta. “Ma allora se lo poneva? Anche allora me lo ponevo, perché le ripeto io ci andavo a Messa, non è che ci vado adesso a Messa, io ci andavo e ci portavo i miei figli ogni domenica a Messa, poi se lei considera i miei figli vengono tutti da una scuola religiosa, a pagamento, ma religiosa. Siete tutti religiosi in famiglia? Si.” Dichiarava ancora di essere rimasto colpito dalla scomunica del Papa anche se lui non si sentiva scomunicato “perché…è difficile spiegarlo, uno ci dovrebbe essere dentro, in un contesto del genere. Cioè non che io mi voglio assolvere, perché non c’è niente che mi possa assolvere. Però tutti questi che parlano, che sono pieni di morale, di questo e di quest’altro, dovevano crescere a Palermo, per dire, in determinate famiglie…e poi diciamo, si vedeva le strade che facevano. Quindi lei dice nel mondo in cui vivevo la normalità era Cosa Nostra. A casa mia si! Perché da bambino io ho conosciuto carceri……” Girolamo Alberto Di Pisa 11 Febbraio 2019
Mafia e devozione. Il lungo silenzio della Chiesa prima dello strappo
Pietro Grasso 25 Novembre 2014- Come può un mafioso dichiararsi cattolico osservante? Una volta posi questa domanda a un collaboratore di giustizia che aveva confessato quasi un centinaio di omicidi. Mi rispose seraficamente: «Signor giudice, le giuro sulla testa dei miei figli: non ho mai ucciso nessuno per un mio interesse personale, sono stato sempre comandato». Giustificazioni di questo tipo, sono certo, saranno ben analizzate per comprendere come un giuramento di appartenenza possa trasformare un uomo in un automa privo di qualsiasi principio etico, in un soldato in perenne guerra contro una enorme quantità di nemici. Non v’è dubbio che il riconoscimento sociale di volgari assassini come persone di rispetto, di giustizia, d’onore si sia basato, in passato, sulla legittimazione concessa da una Chiesa che, rimasta in silenzio, ha rinunciato a denunciare la violenza della mafia, anche se l’insegnamento di Cristo ripudia la violenza. Perché la Chiesa rinunciò per lunghi decenni alla sua secolare funzione di indirizzo etico, celebrando per i mafiosi e le loro famiglie battesimi, cresime, matrimoni e funerali in pompa magna? Perché non ha usato nei loro confronti l’esecrazione aperta, la scomunica, l’emarginazione dalla comunità dei fedeli, nonostante calpestino quotidianamente il diritto alla vita? A Palermo negli anni Sessanta, nel momento di maggiore coesione tra mafia, imprenditoria, amministrazione pubblica e politica, il cardinale Ruffini, di fronte alla violenza omicida che riempiva le strade cittadine, continuava a ripetere nelle sue pastorali che la mafia era una creazione dei comunisti, che la Sicilia non era solo mafia, e che più pericoloso di questa era il comunismo, recepito nel suo aspetto ideologico come negazione di Dio. È con il cardinale Pappalardo che comincia la denuncia ferma, aperta, della violenza mafiosa; è con lui che la Chiesa siciliana acquista quella dignità che in passato era stata mortificata da un atteggiamento di “complice prudenza”. La sua presa di posizione suonò per la comunità religiosa palermitana come una novità dirompente. Da qualche anno, dagli omicidi di Boris Giuliano, Cesare Terranova, Piersanti Mattarella, Emanuele Basile, Gaetano Costa, Pio La Torre, sino a Carlo Alberto Dalla Chiesa, era emersa l’intensità del momento storico, con una mafia che non esitava a colpire, con attentati cruenti, personalità dello Stato di altissimo livello che osavano contrastarla. Il cardinale aveva levato senza timori la sua voce nel 1979, ai funerali di Giuliano; due anni dopo, mentre infuriava la guerra di mafia e le strade di Palermo erano insanguinate e lastricate di cadaveri, celebrò una funzione nella Cattedrale, poi definita «messa antimafia», in cui si rivolse direttamente ai mafiosi, dicendo: «Il profitto che deriva dall’omicidio è maledetto da Dio e dagli uomini e quand’anche riusciste a sfuggire alla giustizia degli uomini, non riuscireste a sfuggire a quella di Dio». L’eco mediatica che accompagnò l’ultimo tragico evento, l’assassinio di Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro, e la cassa di risonanza del sentimento di orrore dei cittadini, spinsero Pappalardo a sintonizzarsi in maniera ancora più ferma e decisa con i sentimenti della società civile, offrendo pieno sostegno a chi contrastava il fenomeno mafioso. Vale la pena riascoltare anche oggi quelle parole, che cambiarono il ruolo della Chiesa in Sicilia e ne riscattarono il passato. Il 4 settembre 1982, dal pulpito della chiesa di San Domenico, il cardinale fece impallidire i più importanti uomini politici siciliani e d’Italia, che assistevano nelle prime file alla messa funebre del prefetto Dalla Chiesa.
«La mafia», disse il cardinale, pronunciando questa parola con tutto il disprezzo di cui era capace, «è un demone dell’odio, l’incarnazione stessa di Satana. Si sta sviluppando una catena di violenza e di vendette tanto più impressionanti perché, mentre così lente e incerte appaiono le mosse e le decisioni di chi deve provvedere alla sicurezza e al bene di tutti, quanto mai decise, invece, tempestive e scattanti sono le azioni di chi ha mente, volontà e braccio pronti a colpire. Sovviene e si può applicare – continuò Pappalardo citando il passo che rimase famoso – una nota frase della letteratura latina: Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur; mentre a Roma ci si consulta, la città di Sagunto viene espugnata. Sagunto è Palermo. Povera la nostra Palermo! Come difenderla?» A seguito delle sferzanti accuse, dal fondo della chiesa, dove sedeva la gente comune, esplose un fragoroso applauso. Un urlo liberatorio, un grido di condanna diretto allo Stato. Pappalardo fece vergognare la classe politica italiana che, indugiando a concedere al generale Dalla Chiesa i poteri speciali che aveva richiesto, l’aveva lasciato in una situazione di incertezza dalla quale non era uscito vivo. Ma fu come se, grazie a quelle parole, i cittadini palermitani avessero trovato una guida morale, e il coraggio civile accese una luce nel buio delle istituzioni. L’ “omelia di Sagunto” segnò una grande svolta nella storia della lotta alla mafia. Dopo qualche giorno venne approvata la legge Rognoni-La Torre, fu nominato un prefetto di Palermo con poteri speciali e l’azione della Commissione parlamentare antimafia riprese vigore.
Da allora giovani parroci-coraggio iniziarono a porsi domande sul loro ruolo in una terra di violenza, sangue e diritti negati, chiedendosi se dovevano limitarsi a curare le anime o invece impegnarsi in un’azione apostolica in difesa dei diritti dell’uomo. Sorsero, su impulso del cardinale, movimenti, missioni popolari fuori dalle parrocchie, istituti dedicati alla formazione evangelica dei credenti, dei giovani, degli emarginati. Successivamente a squarciare la coltre del silenzio come un tuono furono le parole pronunciate nella valle dei templi ad Agrigento da Giovanni Paolo II nel 1993: si rivolse apertamente al potere mafioso esprimendo la piena condanna nei riguardi di tale fenomeno criminale in nome dell’uomo e della fede. L’intervento del Papa ebbe grande risonanza: le Sue parole provocarono tra i fedeli commozione e gioia, molti videro un annuncio di liberazione e di ritrovata solidarietà umana nel segno dell’antica fede. Il percorso si conclude definitivamente con le parole pronunciate dal cardinale arcivescovo di Palermo Paolo Romeo nell’Omelia per la beatificazione di don Giuseppe Puglisi:
«I mafiosi, che spesso pure si dicono e si mostrano credenti, muovono meccanismi di sopraffazione ed ingiustizia, di rancore, di odio, di violenza, di morte. Il Beato Puglisi servì e amò i fratelli da padre. Fu soprattutto a Brancaccio che trovò bambini e giovani quotidianamente esposti ad una paternità falsa e meschina, quella della mafia del quartiere, che rubava dignità e dava morte in cambio di protezione e sostegno. La sua azione mirò a rendere presente un altro padre, il ‘Padre Nostro’. Secondo lui di ‘nostro’ non può esserci ‘cosa’ che si impone a tutti attraverso un ‘padrino’ onnipresente. Di ‘nostro’ c’è solo Dio che ama tutti dentro e fuori la Chiesa.»
Ma il suggello definitivo si è avuto con le prese di posizione di Papa Francesco: che emozione l’incontro con i parenti delle vittime di mafia insieme a don Ciotti! Ero presente in quel momento toccante, e ho sentito il Papa rivolgersi ai mafiosi e dire: «Il potere, il denaro che voi avete adesso da tanti affari sporchi, da tanti crimini mafiosi è denaro insanguinato, è potere insanguinato e non potrete portarlo all’altra vita.» Ho avvertito un grido di una forza e di una potenza paragonabile al «convertitevi” gridato ai mafiosi da Papa Giovanni Paolo II. Significative infine le chiare parole pronunciate da Papa Francesco all’indomani della beatificazione di don Puglisi:
«I mafiosi volevano sconfiggere Padre Pino Puglisi perché sottraeva loro i giovani, ma in realtà è lui che ha vinto. Preghiamo il Signore perché converta il cuore di queste persone, non possono fare questo, non possono fare i nostri fratelli schiavi, dobbiamo pregare il Signore, preghiamo perché questi mafiosi e queste mafiose si convertano a Dio.» Un rapporto definitivamente spezzato, sia dalle più alte incarnazioni della Chiesa sia nel cuore di tutti i fedeli. Queste righe sono tratte dal messaggio di apertura ai lavori inviato dal Presidente del Senato (e già Procuratore nazionale antimafia) Pietro Grasso agli organizzatori deL’immaginario devoto tra organizzazioni mafiose e lotta alla mafia (Roma – Casa della Memoria e della Storia, 20-21 novembre 2014).
Dio, mafia, potere Roberto Scarpinato – mons. Domenico Mogavero Roberto Scarpinato: Vorrei iniziare questo dialogo con una premessa che riguarda il mio rapporto con la religione. Da molto tempo non mi riconosco più nel Dio ecclesiastico, e, tuttavia, non ho mai smesso di interrogarmi su Dio, di cercare cioè un senso della vita che trascenda le nostre brevi esistenze individuali. Così dalla trascendenza verticale che attribuisce valore al prossimo solo perché crede in Dio, sono approdato a una problematica trascendenza orizzontale che dà valore al prossimo anche a prescindere da Dio. Nella prima parte della mia esistenza sono stato il classico italiano: un cattolico non per libera scelta ma per «destino culturale». Si attraversa un’esistenza scandita dal succedersi di riti – battesimi, matrimoni, comunioni, funerali – dei quali si è quasi smarrito il senso. Riti che in fondo sembrano servire a tenerci compagnia, a non farci sentire soli nella vita. Ho cominciato a riflettere seriamente su Dio e sulla religione quando, nella seconda parte della mia esistenza, sono stato costretto per motivi professionali a una lunga frequentazione degli assassini. Il primo approccio con il mondo della criminalità organizzata è stato con i mafiosi dell’ala militare, i killer, gli esecutori materiali, persone per lo più di estrazione popolare, e sono rimasto molto colpito dal verificare, interrogandone parecchi, che si trattava di cattolici devoti e praticanti. Alcuni mi hanno confessato che dopo ogni omicidio andavano in chiesa a pregare e sono noti alle cronache episodi di tanti capimafia che durante la latitanza si facevano costruire delle cappelle votive nei loro rifugi, da Nitto Santapaola a Pietro Aglieri. Altri, come Michele Greco e Bernardo Provenzano, erano assidui lettori della Bibbia. Fin dall’inizio ho dovuto rendermi conto che non si trattava di una simulazione, ma che questi mafiosi avevano un reale rapporto con il cattolicesimo che andava capito. La mia sorpresa è aumentata quando, con il passare degli anni, ho cominciato a conoscere i collaboratori di giustizia e i mafiosi di estrazione borghese, quelli che appartengono alla cosiddetta borghesia mafiosa, e quindi medici, avvocati, commercialisti, architetti, imprenditori, persone di elevata scolarizzazione, e poi ancora i politici – anche di livello nazionale, taluni dei quali ogni mattina andavano a messa e poi magari partecipavano a summit mafiosi. La questione quindi ha assunto una dimensione ancora più complessa, perché il fenomeno non era limitato alla componente mafiosa popolare che poteva dare un’interpretazione neo-paganeggiante del cattolicesimo, ma attraversava tutti gli strati sociali. E quindi mi sono posto questo problema: come è possibile che vittime e carnefici preghino lo stesso Dio? Sembra una contraddizione insanabile. La risposta che mi sono dato, grazie ai tanti dialoghi che ho avuto con i mafiosi, è che in realtà pregano un Dio diverso perché i mafiosi traggono dalla religione cattolica quello che conviene loro e si costruiscono un Dio «adeguato alle loro esigenze», operazione questa che, come dirò più avanti, è replicata anche da tanti cattolici non mafiosi. Poi però mi sono chiesto: che cosa determina la non contraddizione tra la cultura mafiosa e quella cattolica? E ho provato a dare una risposta anche a questa domanda. Innanzitutto il mafioso – e quando uso questa parola intendo il mafioso di tutti i livelli sociali – assume come principio fondante del proprio comportamento non l’etica della responsabilità ma l’etica dell’intenzione, secondo la quale ciò che conta è il pentimento interiore dinanzi a Dio e non il pentimento dinanzi agli uomini. Faccio alcuni esempi. Ci è capitato di intercettare una conversazione tra la moglie di un capomafia e un mafioso, il quale le comunicava che all’interno del carcere c’era un componente dell’organizzazione che stava attraversando momenti di crisi interiore sicché vi era il pericolo che, sottoposto a stringenti interrogatori, potesse iniziare a collaborare con i magistrati. La donna commentò che quella persona, se proprio doveva pentirsi, doveva farlo solo dinanzi a Dio e non dinanzi agli uomini «rovinando» tanti poveri cristiani. Per la cronaca è già accaduto in passato che mafiosi in crisi siano stati assassinati perché ritenuti psicologicamente poco affidabili e quindi incapaci di autogovernarsi pentendosi solo interiormente. Ricordo anche la vicenda di un capomafia, un medico chirurgo, il dottor Giuseppe Guttadauro, che raccomandava a un altro mafioso, che gli aveva confessato di essere in crisi e di avere bisogno di un prete, di trovarsi un prete «intelligente», e non come era capitato a lui che aveva avuto a che fare con un prete che gli aveva fatto notare una serie di contraddizioni del proprio comportamento. E anche Pietro Aglieri, capo di uno dei più importanti mandamenti mafiosi – che poi una volta catturato ha studiato teologia – ha sempre ribadito che secondo l’etica cattolica non è importante pentirsi dinanzi agli uomini, ma dinanzi a Dio, motivo per cui non ha mai voluto collaborare con la giustizia. E ancora, ricordo l’episodio riferitomi da un collaboratore di un suo parente mafioso che, sul letto di morte, aveva avuto una crisi e voleva chiedere perdono. I parenti subito avevano pensato di chiamare un prete, ma lui aveva detto che non voleva pentirsi dinanzi a un prete, che lo «avrebbe dovuto perdonare per mestiere», ma dinanzi ai familiari delle sue vittime che aveva fatto tanto soffrire. I parenti, preoccupatissimi, gli avevano negato questa possibilità e avevano fatto venire in casa un sacerdote il quale aveva rassicurato il moribondo che quel che contava era il perdono di Dio e non quello degli uomini. Ho anche conosciuto killer mafiosi che, dopo ogni delitto, andavano in chiesa e chiedevano perdono a Dio trovando così il modo di «aggiustarsi» con lui e sentendosi poi a posto con la propria coscienza, pronti per il successivo delitto. Questa etica dell’intenzione – che caratterizza anche molti cattolici non mafiosi – consente, come è stato osservato anche da alcuni teologi – una riconciliazione con se stessi che non passa attraverso la riconciliazione con il prossimo. Si tratta di una sorta di «privatizzazione» della salvezza, ottenuta grazie a un rapporto solipsistico e interiore con Dio. Un altro elemento che consente una piena conciliazione tra la cultura mafiosa e quella cattolica è la centralità che nella predicazione cattolica hanno l’etica familiare e la morale sessuale. Nel decalogo del mafioso trovato nel 2006, quando fu arrestato il capomafia Salvatore Lo Piccolo, tra i più importanti precetti c’era quello di non desiderare la donna d’altri e di rispettare la propria moglie. I mafiosi doc sono campioni di etica familiare ed estremamente rigorosi quanto ad etica sessuale. Ricordo che nel corso di un confronto al maxiprocesso, Riina accusò Buscetta di essere un immorale perché andava con molte donne, mentre lui era sempre rimasto fedele alla moglie. Lo stesso Buscetta mi confidò che in passato aveva declinato l’offerta di entrare a far parte della Commissione, l’organo di vertice della mafia, perché era consapevole che non gli sarebbe stata consentita e perdonata la sua condotta licenziosa in questo campo. Ma i mafiosi non si sentono in contraddizione con l’etica cattolica neanche su quello che dovrebbe essere il punto di rottura: l’omicidio. Ricordo che un mafioso, uno dei più famosi medici di Palermo e persona di grande cultura, a proposito dell’omicidio mi disse: «Dottore, ma anche il diritto canonico prevedeva la pena di morte, e non fu forse il papa a condannare al rogo Giordano Bruno per eresia? Lei e i suoi colleghi vorreste forse processare anche il papa? Quindi anche la somministrazione della morte, quando è giustificata da esigenze superiori, quindi come extrema ratio, non provoca nessuna contraddizione con il comandamento «non uccidere». Mi raccontò anche che suo zio, il quale era stato un famoso capo mafia, andava a pregare sulle tombe di coloro che era stato costretto ad «abbattere». Dio sapeva – diceva lo zio – che erano stati loro stessi a volere la propria morte in quanto si erano rifiutati sino all’ultimo di seguire i buoni consigli degli «amici».
Mons. Domenico Mogavero: Quello che lei ha appena raccontato è impressionante perché rivela un quadro di disvalori, una filosofia e soprattutto una visione della religione e della morale che, partendo da alcuni elementi veri, costruisce un sistema nel quale io, cattolico, vescovo della Chiesa cattolica, non ritrovo nulla del patrimonio genuino di valori etici e di religiosità della mia fede. Mi ha colpito in particolare il fatto che lei attribuisce ai mafiosi una religiosità che si fonda sull’etica dell’intenzione e non sull’etica della responsabilità, che è una distorsione sostanziale della visione cristiana della vita. Nell’ottica cristiana l’etica dell’intenzione, è vero, è centrale, ma nel senso che l’intenzione talvolta qualifica un’azione che in sé non avrebbe una rilevanza morale precisamente definita. Quando io guardo una persona posso essere mosso dal fatto che mi è simpatica, o che mi ricorda un incontro precedente. Ma posso guardarla anche con un desiderio malsano, o con l’intenzione di sopprimerla. In questo caso è l’intenzione che qualifica l’atto del guardare. Ma di fronte al furto, all’omicidio, a delitti conclamati il problema dell’intenzione non si pone neanche perché si tratta di azioni in se stesse immorali! In tutto questo discorso a farne le spese è, purtroppo, il buon Dio. Quando noi parliamo del «Dio dei mafiosi» a me si drizzano i capelli, perché un Dio dei mafiosi non esiste; non può esistere; non deve esistere. Esistono, invece, dei mafiosi, uomini senza Dio, uomini contro Dio che pretenderebbero di portare Dio dalla loro parte; un Dio – si badi bene – costruito a loro immagine e somiglianza. Dal quadro così articolato che lei ha tracciato – che non è astratto, ma è un quadro che viene dell’esperienza diretta – emerge in modo inequivocabile una infausta corruzione della visione di Dio, della morale e della vita. Dal mio punto di vista sarebbe molto interessante capire qual è il momento e quali sono le motivazioni che determinano questa degenerazione del concetto di Dio e, in connessione, l’impoverimento del concetto di pentimento come rapporto privato con Dio che esclude il prossimo; e, in dipendenza da questa dinamica relazionale, come nasce un’etica dell’intenzione che possa prescindere dall’etica della responsabilità. Quello che mi interesserebbe capire è cosa è rimasto in questi soggetti dell’insegnamento appreso nell’infanzia e nell’adolescenza con il catechismo, negli incontri eventuali con singoli sacerdoti, nella lettura della Bibbia; così pure come si è determinata questa graduale e progressiva divaricazione dalla retta dottrina fino a giungere alla «deviazione» da lei segnalata e che configura un’elaborazione – per così dire teologica – personalissima, ma errata, finalizzata a crearsi una moralità di comodo ridondante a proprio esclusivo vantaggio.
La mia voglia di comprendere l’origine e l’evoluzione di questo percorso mentale ed etico è dettata anche dalla necessità di capire se in questa elaborazione teorica, in questo processo di rottura rispetto alla corretta visione cristiana, hanno influito responsabilità, dirette o indirette, di uomini di Chiesa. Personalmente, infatti, salvaguardando eventualmente la buona fede degli interessati, non penso che padre Mario Frittitta, quando andava a celebrare la messa e a portare la comunione a Pietro Aglieri nel suo covo di latitante, agisse in modo coerente con i princìpi della dottrina cattolica. A suo tempo – lei ricorderà – ci furono parecchie tensioni e lacerazioni all’interno del mondo cattolico palermitano tra chi si schierò decisamente contro l’operato di padre Mario e chi tentava invece di rilevarne i risvolti positivi. Quindi, mi chiedo: fino a che punto quella del mafioso è l’elaborazione autonoma di una religiosità deviata e quanto, invece, è influenzata dall’apporto di qualcuno che in qualche maniera avalla una deriva e, perciò, una devianza del concetto di Dio, di pentimento, di giustizia, di rispetto della vita?
Io non ho avuto mai contatti diretti con i mafiosi, li conosco attraverso quello che è riportato nei resoconti dei processi e anche dalla pubblicistica ormai abbondante che ha sollevato il velo su un mondo una volta assolutamente impenetrabile. Un altro tema che mi interessò e mi turbò molto fu quello del «pentimento» e del «pentitismo» quando si verificarono i primi casi di collaborazione. La cosa mi colpì particolarmente perché il senso di queste parole usate a proposito dei collaboratori di giustizia non aveva niente a che fare con il concetto cristiano di pentimento. Il pentimento non è un atteggiamento che produce vantaggi per chi lo mette in atto; non è neanche qualcosa che riguarda gli altri; è, invece, una scelta ardua e impegnativa che cambia decisamente la vita di chi perviene a una tale decisione. Se però guardiamo al pentito di mafia, non possiamo fare a meno di domandarci: perché ha scelto di parlare? La risposta è facile ed è dettata anche dalla legislazione sui pentiti. Il mafioso parla perché gli conviene: ottiene sconti di pena, e vantaggi nel trattamento detentivo. Raramente c’è anche qualcuno che, partendo dal pentimento – per così dire – dettato dalla legge, intraprende un cammino di redenzione, quando il peso delle sue colpe gravissime diventa insostenibile e la sua coscienza gli impone un cambiamento di vita. Questo è il pentimento secondo l’etica cristiana che porta a rinnegare completamente un certo comportamento immorale, con l’impegno serio di allontanarsene nelle intenzioni e nei fatti. Quindi, il pentimento vero non solo è assolutamente gratuito, ma impone anche di pagare qualcosa come riparazione del male commesso. Ne consegue che l’uso di questi termini a proposito dei cosiddetti pentiti – che il più delle volte non rinnegano affatto quello che hanno compiuto, ma parlano per convenienza – non è pertinente e ha contribuito anche a creare una certa confusione.
Tornando al tema della religiosità, occorre essere chiari e senza tentennamenti: i mafiosi, quale che sia la loro origine e la loro posizione sociale, non hanno mai avuto una religiosità vera perché hanno vissuto sempre, e non potrebbe essere diversamente, ai margini dell’esperienza religiosa autentica; nessuno di loro – per quanto è dato di sapere – ha mai avuto una vita cristiana a 18 carati. Io ho la percezione che queste persone abbiano assunto una linea di condotta nella quale è rimasta solo qualche traccia superficiale di cristianesimo, risalente all’infanzia o all’adolescenza; su questa verniciatura di religiosità hanno poi sovrapposto un quadro di valori e una visione della vita che li ha portati a sfruttare quello sfondo di religiosità per piegarlo alla giustificazione della propria condotta assolutamente priva di respiro religioso. Il fatto stesso che molti mafiosi hanno continuato ad appartenere alle confraternite, o hanno continuato a portare con grande ostentazione la statua del santo nelle processioni, esibendo in maniera molto conclamata una pratica religiosa esteriore e priva di coerenza nella vita, quasi a voler controbilanciare e nascondere in tal modo una condotta per nulla irreprensibile, sia sotto il profilo civile sia soprattutto sotto il profilo religioso, mi induce a pensare che il loro percorso li abbia portati molto lontani da una religiosità autentica. In conseguenza di ciò e per le considerazioni che ho tentato di esporre, mi rifiuto categoricamente di pensare che vittime e carnefici pregano lo stesso Dio. No: il Dio dei mafiosi non è il Dio delle vittime; è un altro dio, che in verità non esiste. Io mi rifiuto di pensare che il dio di Riina, di Provenzano, di Aglieri sia il mio Dio.*
Scarpinato: In realtà, se ci pensiamo bene, il problema di cui stiamo discutendo travalica il mondo mafioso e pone interrogativi di ordine generale sul modo in cui viene vissuto il cattolicesimo. Il mondo infatti è pieno di assassini ben più pericolosi di un Riina o di un Provenzano, assassini che sono cattolici ferventi e praticanti e la cosa più impressionante, dal mio punto di vista, è che tanti di essi muoiono nel proprio letto senza sensi di colpa, in pace con se stessi. Mi riferisco per esempio ai dittatori latinoamericani, come Augusto Pinochet o come il generale Videla, che si sono resi responsabili del genocidio di migliaia di persone. Augusto Pinochet si è sempre professato un fervente cattolico, confermato in questa sua convinzione da vescovi che frequentavano la sua mensa, ne condividevano le idee e che sul letto di morte l’hanno benedetto come salvatore della patria. Il generale Videla e i suoi colonnelli, quando sono stati processati in Argentina, hanno professato il loro essere buoni cattolici. Alcuni di essi hanno raccontato che alcuni preti cattolici avevano sostenuto che era anticristiano uccidere i dissidenti politici mettendoli su un aereo e poi buttandoli nell’oceano in pieno stato di coscienza. Per questo motivo, proprio seguendo il consiglio di quei preti, essi avevano cominciato a narcotizzare le vittime prima di scaraventarle nell’oceano dall’aereo, col che erano convinti di aver ottenuto la patente di buona cattolicità.
C’è poi una questione che non smette di interrogarmi: l’Italia è la culla del cattolicesimo e la patria di una Chiesa che per secoli è stata la più importante e capillare agenzia di formazione culturale del paese, eppure non solo è il paese delle mafie, ma è anche il paese dove c’è la più alta corruzione d’Europa, ed è il paese di uno stragismo che ha segnato ininterrottamente la storia nazionale, e mafiosi, corrotti e stragisti, sono spesso cattolici praticanti. Allora il problema secondo me va ben al di là di Riina, di Provenzano, dei mafiosi, e ci interroga sulle cause di quello che, stanti le sue dimensioni, sembra piuttosto assumere i contorni di un fallimento pedagogico del cattolicesimo che ha prodotto e continua a produrre falsa coscienza e ateismo pratico in vaste masse cattoliche e non solo in Italia. Perché personaggi come Pinochet, Videla e tanti altri dittatori cattolici che si sono macchiati di crimini efferati non sono eccezioni. Non ci troviamo dinanzi alla follia morale di singoli individui. La storia insegna che le dittature argentine, brasiliane, cilene e quelle di tanti altri paesi dell’America latina sono state il braccio armato di borghesie latinoamericane in larghissima misura cattoliche che non hanno esitato a fare ricorso al genocidio di massa per difendere sistemi di privilegio che venivano messi in pericolo dalle rivendicazioni popolari di milioni di sfruttati. Allo stesso modo dietro personaggi come Riina e Provenzano, elevati nell’immaginario collettivo a icone assolute ed esclusive del male di mafia, vi sono in realtà imponenti masse di cattolici appartenenti alla cosiddetta borghesia mafiosa e paramafiosa che sin dall’Unità d’Italia aggrega intorno ai propri interessi uno dei più potenti blocchi sociali del paese. La mia frequentazione coatta con i mafiosi è divenuta quindi con il tempo il punto di partenza per una riflessione di carattere più generale il cui tema centrale restava come fosse possibile la coabitazione all’interno della stessa Chiesa del Dio dei carnefici e di quello delle vittime, e cioè la coabitazione non problematica di modi di relazionarsi con Dio e con la religione apparentemente incompatibili. La risposta che mi sono dato è che, poiché nella religione cattolica il rapporto con Dio è gestito da un «mediatore culturale» che è un sacerdote, ogni segmento sociale esprime dal proprio interno un mediatore culturale che consente di avere un rapporto non problematico con Dio, per cui i dittatori latinoamericani avevano un rapporto con Dio mediato da vescovi che condividevano la loro visione della vita e del mondo, così come durante il fascismo e il franchismo vi erano dei vescovi che condividevano le idee di Mussolini o di Franco, mentre dall’altra parte vi erano vescovi e prelati che condividevano le idee dei perseguitati. E mi pare che questo pluralismo della mediazione culturale determini una sorta di occulto politeismo, nel senso che ognuno ha la possibilità di costruirsi un Dio a immagine della propria visione della vita.
Lo stesso ragionamento si può applicare alla mafia, a proposito della quale credo che si debba parlare di una pluralità di Chiese che convivono tra di loro. Abbiamo una Chiesa dei mafiosi, che è fatta di ecclesiastici che non sono mafiosi ma che sono talora imbevuti di una cultura paramafiosa perché magari vengono dallo stesso habitat culturale, dallo stesso segmento sociale. Sono numerosi i mafiosi doc che hanno cugini, parenti, zii vescovi e preti. Poi abbiamo una Chiesa dell’antimafia che esprime un padre Puglisi, un don Fasullo, don Cosimo Scordato e pochi altri, e poi abbiamo la Chiesa di quelli che padre Ernesto Balducci chiamava i «burocrati di Dio», cioè quelli che non stanno né con la mafia né con l’antimafia, né con lo Stato né con l’antistato, né con la destra, né con la sinistra, né con il centro, ma stanno esclusivamente dalla propria parte…
Mons. Mogavero:… o dalla parte vincente…
Scarpinato: … e per i quali va bene una predicazione evangelica di taglio generalista, che è appunto quella improntata sulla morale sessuale, sulla famiglia, sul generico amore per il prossimo e sulla carità ridotta alla cultura dell’elemosina, che non crea alcun problema e che non costa nulla, specie se l’elemosina viene fatta con le briciole dei soldi pubblici rubati con la corruzione, o del denaro accumulato con l’evasione fiscale o con lo sfruttamento degli altri.
La cultura dell’elemosina lascia le cose come stanno e si traduce in un’acquiescenza all’esistente. L’esatto contrario della cultura dei diritti, che costituisce la declinazione di una carità attiva, e che invece è una cultura problematica e scomoda perché costringe a prendere posizione nei confronti dei potenti che sono responsabili dell’ingiustizia sociale e della sofferenza dei nostri confratelli.
E qui si pone secondo me – e lei ne accennava poco fa – un problema di responsabilità dei vertici istituzionali della Chiesa. Insomma, in questo occulto politeismo io so per certo che ci sono chiese frequentate dal popolo di mafia, che ascolta messe celebrate da sacerdoti nei quali quel popolo si riconosce, ci sono chiese frequentate dal popolo dell’antimafia e ci sono chiese frequentate dal popolo degli indifferenti. E questa coesistenza dà vita a più Dei, perché Dio a volte parla per bocca di un prete che ha una cultura paramafiosa, a volte per quella di un prete che ha una cultura antimafiosa. Il rapporto con Dio viene quindi mediato culturalmente e qui si pone un problema non solo di occulto politeismo, ma di vero e proprio relativismo etico della cultura cattolica. Il relativismo etico nella cultura laica è un valore democratico perché la democrazia si basa sulla libertà di coscienza e quindi sul pluralismo dei valori e delle culture. Dal punto di vista laico, pluralismo dei valori non significa quindi nichilismo, ma rispetto dei valori degli altri che si confrontano poi nel libero gioco democratico. Il relativismo etico della cultura laica viene costantemente avversato dai vertici ecclesiastici che rivendicano di essere depositari di una verità assoluta senza se e senza ma e, per questo motivo, pretendono di condizionare talora la legislazione statale. Gli stessi vertici ecclesiastici sono tuttavia ben consapevoli che nella realtà delle Chiese e delle parrocchie di tutto il mondo, convivono una pluralità di mediazioni culturali cattoliche tra gli uomini e Dio, spesso tra loro incompatibili, per cui il vissuto culturale di Dio – il Dio ecclesiastico – e l’etica cattolica si relativizzano quasi balcanizzandosi.
Da questo punto di vista, la storia dei vescovi di Palermo è emblematica della coesistenza all’interno della stessa Chiesa di una pluralità di mediazioni e approcci culturali alla realtà della mafia. Possiamo distinguere tre fasi a far data dal secondo dopoguerra. La prima lunga fase è stata quella del cardinal Ruffini – il quale definì la strage di Portella della Ginestra come una reazione all’estremismo di sinistra e si rifiutò di prendere posizione netta contro la mafia persino dopo la strage di Ciaculli del 1963, nonostante la sollecitazione del segretario di Stato vaticano preoccupato del fatto che invece la Chiesa valdese locale aveva tappezzato la città di manifesti di ripulsa contro quell’eccidio. Poi vi è stata la fase del cardinal Pappalardo, figlio di un carabiniere, il quale ha iniziato a introdurre nelle sue omelie prese di posizione chiare contro la mafia, soprattutto dopo l’omicidio del giudice Terranova e del commissario Boris Giuliano. È passata alla storia la sua omelia al funerale del generale Dalla Chiesa durante la quale egli pronunciò quella famosa citazione di Tito Livio: «Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo». Quando poco tempo dopo Pappalardo si recò al carcere dell’Ucciardone per officiare la messa, non solo non si presentarono i mafiosi, ma non si presentarono neppure i detenuti comuni. Quel che è più grave – e che forse meno noto – è che il cardinale Pappalardo non dovette subire solo l’ostracismo palese e scontato della mafia popolare, che tuttavia continuava ad affollare parrocchie dove officiavano sacerdoti di suo gradimento, ma subì anche il dissenso della potente borghesia mafiosa, di cui facevano parte tanti potenti del tempo, e fu criticato anche all’interno dell’ambiente ecclesiastico. Nel libro La mafia devota, la professoressa Alessandra Dino ha intervistato alcuni prelati i quali hanno rivelato che Pappalardo fu contestato internamente per aver usato quell’espressione ritenuta troppo forte, gli si disse che doveva parlare solo di misericordia e di pietà e, secondo queste testimonianze, Pappalardo ammise di aver sbagliato.
E in effetti da quel momento in poi il cardinale fece commenti sempre più rari e generici sulla mafia e, in una conferenza stampa dopo il maxiprocesso, disse che Palermo non era Sagunto e che non voleva essere scambiato per un vescovo antimafia perché il problema mafia occupava solo il 2 per cento della sua attività pastorale. Poi c’è stata la terza fase quella del cardinale De Giorgi, che pure in occasione della festa di Santa Rosalia nel 1997 ha detto che la mafia è incompatibile con il Vangelo e che il pentimento non può essere solo un fatto interiore. Ma quando dopo il caso Frittitta si è rifiutato di prendere netta posizione a favore di quest’ultimo, ha subìto anche lui vivaci critiche all’interno del mondo curiale ecclesiastico. Per arrivare infine ai tempi di oggi, abbiamo in Sicilia da una parte il vescovo di Piazza Armerina Michele Pennisi che rifiuta i funerali pubblici al boss mafioso Emanuello, dall’altra un altro prelato, l’arcivescovo di Palermo Salvatore di Cristina, che, in occasione della commemorazione di Placido Rizzotto, è stato capace di non pronunciare la parola mafia per tutta la sua omelia, per due volte ha pure storpiato il nome di Placido Rizzotto e non ha consentito a don Ciotti di prendere la parola.
Tutti questi esempi per dire che l’esistenza di più Chiese è un problema reale che chiama in causa non tanto i singoli prelati, ma direttamente il vertice vaticano, il quale è responsabile della formazione culturale dei mediatori tra Dio e gli uomini. Io credo che sia mancata nella prassi una presa di posizione netta da parte dei vertici vaticani per impedire questo occulto politeismo, questo relativismo di fatto che si trasforma in un pericolo di scristianizzazione strisciante. Insomma, se ciascuno può di fatto scegliersi il Dio che più gli conviene e nella stessa Chiesa trovo la vittima della mafia e il mandante dell’omicidio e ciascuno dei due si sente in pace con se stesso perché ciascuno dei due ha un mediatore culturale che gli consente di avere un rapporto non problematico con Dio, allora io credo che esista un problema che, come lei stesso ha accennato, chiama in causa le responsabilità della Chiesa come istituzione.
Mons. Mogavero: La sua è un’analisi che guarda con grandissima attenzione i fenomeni e li guarda dall’esterno. Li guarda nelle loro manifestazioni fenomeniche sulle quali non c’è granché da aggiungere perché i fatti non si possono contestare. Mi ha molto colpito, invece, il suo discorso sul ministro sacro visto come mediatore culturale, perché si ricollega con l’interrogativo che mi ponevo prima: quando nasce e come si determina la discrepanza tra il Dio unico e vero e il dio che il mafioso si costruisce a suo uso e consumo? E chi potrebbe avere delle responsabilità o un’influenza diretta e/o indiretta in questa devianza corruttiva dal concetto di Dio? Ora è chiaro che se la religione è «Dio e basta», senza alcun riferimento agli altri, io privilegio il rapporto con un Dio che non vedo e non sento, un Dio che non mi bacchetta, un Dio tutto interiore; di riflesso, quando io trasgredisco la legge di questo Dio, è sufficiente che, quando ne avverto il bisogno, io mi riconcili con lui ignorando gli altri. Ma invece nella religione cristiana «Dio e gli altri», secondo gli insegnamenti evengelici, si richiamano in modo necessario. Dice Gesù: il primo comandamento è «Ama Dio con tutte le tue forze, con la tua mente, con il tuo cuore, con tutto te stesso»; e il secondo è simile a questo: «Ama il prossimo tuo come te stesso». Se, per una qualche ragione, mettiamo da parte questa seconda faccia dell’unica medaglia, noi abbiamo tradito Dio, il Vangelo, Gesù Cristo, la Chiesa.
Ci siamo costruiti un universo che non esiste, in quanto non ci sono diverse Chiese, non ci sono Dio diversi. Se si nega la dimensione umana del cristianesimo, si arriva alla negazione di Dio. Per me parlare di un «Dio dei mafiosi» è l’uccisione di Dio, perché quel Dio non esiste, non può esistere – lo ripeto. I mafiosi hanno abolito Dio creandosi un feticcio; quindi Dio è assente dal loro mondo. Il mafioso, di conseguenza, è un ateo, quali che siano le sue pratiche esteriori di religiosità. Infatti, non ci può essere una religiosità che vincola a Dio escludendo l’altro, l’altro che è mio fratello, mia sorella, mia madre, l’altro che è anche il mio concorrente, che, se intralcia i miei disegni, deve essere eliminato perché mi impedisce di perseguire i miei obiettivi. Ecco, una religiosità che esclusivizza il rapporto con Dio e che rende la Chiesa, sia come istituzione sia come singoli soggetti, semplicemente mediatrice che mi consente di avere quegli avalli che mi interessano per poter andare avanti, una simile religiosità è ateismo pratico. Il mafioso che si è costruito questo feticcio ha distrutto Dio e quindi non è un cattolico, anche se esternamente continua a compiere gesti e pratiche che sembrerebbero attestarne l’appartenenza alla Chiesa cattolica.
Se poi a tutto questo si aggiunge la funzione di quello che lei, con una formula elegante, chiama il mediatore culturale, allora il discorso diventa assai problematico. Il vescovo che benedice Pinochet o Videla, il prete che avalla il mafioso, o che va addirittura a celebrare messa nel suo covo, o suggerisce di pentirsi davanti a Dio senza prescrivere le condizioni connesse con il vero pentimento – e cioè rinnegare tutto il passato, riparare il male fatto e pagare il debito di giustizia contratto con la società – hanno fatto un danno incalcolabile alla Chiesa cattolica. E se l’hanno fatto in buona fede il buon Dio forse avrà misericordia di loro. Ma se costoro hanno agito in mala fede non so quali conti dovranno pagare alla giustizia divina, perché Dio è misericordioso, ma è anche giusto.
Per entrare poi nel dettaglio delle responsabilità personali, ci sono, come ha ricordato lei, sacerdoti che hanno rapporti di parentela anche stretta con alcuni mafiosi e che, sulla base di una malinteso familismo, si sono sentiti di prendere le parti dei loro congiunti. E Dio domanderà loro conto di tutto questo. Che ci siano state delle carenze nella formazione dei sacerdoti in certi periodi ben identificati, che ci sia stata da parte di taluni uomini di Chiesa un’inadeguata o non corretta lettura di alcuni fenomeni sociali è innegabile. Io sono entrato in seminario quando era arcivescovo di Palermo il cardinale Ruffini e ho avuto modo di conoscerlo abbastanza bene. Lei ricorderà certamente che, nel 1964, il cardinale Ruffini scrisse la lettera pastorale Il vero volto della Sicilia in cui affermava che la mafia non esisteva e che era un’invenzione dei comunisti. Si trattò di un documento che divise e divide ancora gli opinionisti e i commentatori. Il ragionamento che il cardinale faceva – e mi rendo conto che è operazione ardua tentare di giustificarlo – non era tanto di ordine sociologico, o etico. Ruffini era lombardo; aveva molto lavorato a Roma; era stato professore e rettore della Pontificia Università Lateranense. Era stato nominato arcivescovo di Palermo nel ’46, cioè in piena epoca di ricostruzione, quando la Sicilia e Palermo in particolare uscivano martoriate dalla guerra. L’arcivescovo aveva avuto modo di conoscere l’animo del siciliano semplice e proprio in base a questa sua esperienza si era convinto che la mafia non poteva esistere perché il siciliano che conosceva lui non poteva essere mafioso. Questo approccio, indubbiamente apologetico a favore dei siciliani onesti, poteva dipendere o dall’idea di mafia che egli si era fatto, o dall’idea di siciliano che aveva elaborato dentro di sé, o dalla volontà di difendere la Sicilia da questo marchio che indubbiamente si è portata addosso per tanto – troppo – tempo.
Il cardinale Pappalardo fu arcivescovo di Palermo in un periodo molto diverso e assai drammatico; fu testimone delle stragi, essendo rimasto a Palermo dal 1970 al 1996. La lettura che lei ha fatto del percorso del cardinale Pappalardo la condivido in parte, mentre dall’episodio accaduto nel carcere dell’Ucciardone in poi farei qualche distinguo. Innanzitutto bisogna precisare che il cardinale Pappalardo fu solo sia nel momento in cui pronunciò le sue omelie contro la mafia, senza avere alcun timore di eventuali rischi, sia successivamente. Pappalardo era siciliano, figlio di un maresciallo dei carabinieri, ma aveva abitato quasi sempre fuori. Aveva frequentato il Seminario romano; aveva prestato servizio in segreteria di Stato e successivamente nella diplomazia vaticana. Era arrivato a Palermo a 53 anni senza precedenti esperienze pastorali, senza una conoscenza approfondita della realtà palermitana così complessa e contorta. All’inizio ha avuto bisogno di capire e si è dato un tempo di riflessione per rendersi conto della realtà, ma senza mettersi sul filone garantista, ossia «la mafia non esiste». Il giorno del funerale del prefetto Dalla Chiesa ebbi modo di incontrare Pappalardo prima e dopo la celebrazione delle esequie. Il cardinale era apparentemente tranquillo, ma si notava una certa tensione. L’omelia non fu improvvisata; l’aveva scritta e, quindi, era ben ponderata nei suoi contenuti. La famosa citazione di Tito Livio gli venne proprio dal cuore con l’espressione finale: «povera Palermo». Con quelle parole accorate egli si mise dalla parte della città come vescovo e come padre che aveva la missione e il compito di soccorrere una creatura così lacerata e martoriata nel suo tessuto sia sociale sia umano. Dopo quell’episodio, in effetti, qualche voce dissenziente ci fu. Però posso affermare con certezza che il cardinale da quel momento in avanti non tacque perché qualcuno gli impose il silenzio, ma perché non accettò di diventare il cardinale antimafia nel senso mediatico del termine. Il cardinale Pappalardo era una persona passionale per cui a un certo punto si stancò…
Scarpinato: Scusi se la interrompo, ma ricordo che la stampa nell’83 pubblicò la notizia che il cardinale Pappalardo rischiava di essere trasferito da Palermo, notizia che, mi pare, non fu smentita.
Mons. Mogavero: Non fu smentita perché in quel momento si ebbe la percezione che il cardinale fosse in partenza, ma non tanto per queste polemiche quanto perché in quel momento le sue prese di posizione e il suo lavoro pastorale a Palermo gli avevano meritato molta stima all’interno dell’episcopato siciliano e della Chiesa italiana. Si ebbe la sensazione che fosse in procinto di lasciare Palermo per assumere responsabilità maggiori, proprio perché gli si riconosceva un carisma che lo proponeva come testimone di religiosità non indifferente verso i problemi dell’uomo del nostro tempo.
Scarpinato: A proposito del rapporto problematico tra Pappalardo e i vertici vaticani, ho letto un libro dedicato alla storia del movimento Città per l’Uomo, che è stata un’esperienza di cattolicesimo politico molto significativa per la Palermo della prima metà degli anni Ottanta. Alcuni fondatori di questo movimento riferivano che in un primo momento il cardinale Pappalardo aveva favorito e sponsorizzato questo esperimento che tentava di ricristianizzare la politica partendo dal basso e dalle effettive esigenze del territorio, recidendo ogni legame del mondo cattolico con politici compromessi con la mafia e con quelli adusi alle pratiche clientelari. Ma non appena il movimento aveva cominciato a decollare suscitando entusiasmi e aspettative, erano intervenuti sulle alte gerarchie ecclesiastiche alcuni maggiorenti della Dc del tempo, tra i quali anche l’onorevole Salvo Lima, massimo referente politico della mafia in Sicilia, e a quel punto Pappalardo era stato costretto a tirarsi indietro, sicché Città per l’Uomo privata del suo autorevole sostegno e lasciata a se stessa aveva consumato brevemente la sua parabola politica. Vorrei anche ricordare che il cardinale Pappalardo non riuscì, nonostante ci avesse provato in diverse occasioni, a far inserire nei documenti ufficiali della Conferenza episcopale italiana il tema della mafia. E, sempre a proposito di responsabilità istituzionali, mi ha molto colpito che, sia dopo la strage di Capaci sia dopo quella di via d’Amelio, non vi sia stato nei documenti ufficiali della Cei nessun riferimento alle stragi, e addirittura un documento che uscì poco dopo la morte di Falcone era incentrato sul problema del disfacimento del partito cattolico a seguito della caduta della Prima Repubblica, come se quelle stragi, quegli eventi così drammatici da essere vissuti come una ferita dall’intera nazione, fossero invece fuori dall’orizzonte culturale e dalla stessa sensibilità cristiana della Conferenza episcopale italiana.
Mons. Mogavero: E lo erano. Non dobbiamo dimenticare che la Chiesa in quanto istituzione vive in questo mondo. La consapevolezza della pericolosità della mafia da parte dell’opinione pubblica e delle istituzioni civili non nasce nel ’48 dopo Portella della Ginestra, nasce dopo le stragi. La Chiesa risente di questo clima e ne è in qualche modo cassa di risonanza. Insomma, non possiamo pretendere che la Chiesa esprimesse già 30-40 anni fa una sensibilità che è cresciuta e maturata nel tempo, anche nella società civile. Per tornare al cardinale Pappalardo, negli anni in cui è stato a Palermo, la città ha conosciuto momenti di grande impegno religioso e sociale. Puglisi non nasce per caso, Puglisi non è un giglio che nasce isolato in mezzo a un territorio circostante fatto di letame puzzolente che odora di mafia in ogni sua piega. Puglisi è sicuramente l’espressione di una linea di pensiero e di strategia pastorale, che potremmo definire carsico e abbastanza minoritario ma mai assente all’interno della Chiesa palermitana. Puglisi, Fasullo, Pintacuda, Garau, Scordato… sono figure che dimostrano come il cammino fatto a Palermo e in tutta Italia avesse una sua consequenzialità. Ricordiamoci delle parole che Giovanni Paolo II pronunciò l’8 maggio del ’92 ad Agrigento, parole che rimangono nella storia, perché per la prima volta e in maniera assai informale e per questo ancora più significativa – si dice che sia stato determinante l’incontro avuto con il papà e la mamma del giudice Rosario Livatino prima della messa – un papa prese una posizione che non lasciava ombra di dubbio su come si devono considerare la mafia e i mafiosi di fronte al giudizio di Dio. E io non mi sento di escludere un qualche nesso fra quelle parole e l’attentato di Firenze, quello di San Giovanni in Laterano e l’uccisione di don Pino Puglisi. Forse la mafia finalmente in quel momento si rende conto di essere incompatibile con il tessuto ecclesiale.
A questo punto occorre comprendere che non si potrà trovare la mafia come punto prioritario dell’agenda della Conferenza episcopale italiana perché noi siamo il Sud e la Cei le vicende del Sud non sempre le ha vissute come un problema del paese, anche se oggi le cose sono comunque molto cambiate. Infatti, già in un documento di dodici anni fa sul Mezzogiorno – redatto dai vescovi del Mezzogiorno – si parlava della mafia come cancro, come peccato; parole inaudite tra gli anni Cinquanta e Ottanta. Insomma a fatica e con mille incertezze, però un buon cammino l’abbiamo fatto anche noi come comunità ecclesiale, soprattutto per merito di coloro che hanno tenuta desta una sensibilità e un’attenzione vigile e vera nei confronti della mafia e che ci hanno lasciato la pelle, come don Peppino Diana in Campania e don Pino Puglisi da noi in Sicilia.
Dico questo non per fare un discorso apologetico, che non avrebbe nessun senso, ma per dire che un’evoluzione c’è stata. E, ripeto, il problema mafia non è un problema che investe la Chiesa italiana nella sua totalità. Il papa ne ha parlato e ne parla nelle circostanze in cui questo può avere un senso. Nei discorsi degli ultimi due papi ai vescovi siciliani questa attenzione sulla mafia come urgenza pastorale è costantemente presente. Riconosco che il cammino è stato lungo e variegato; che siamo partiti da una posizione quasi di fiancheggiamento di fatto per le ragioni che ci siamo detti precedentemente, ma che oggi la situazione è completamente diversa e che la posizione di rifiuto e di esecrazione della mafia è un punto di non ritorno e di estrema chiarezza in termini di condanna morale e sociale.
Scarpinato: Prendo atto dei passi avanti da lei sottolineati, però continuo a pensare che, fino a quando continueranno a convivere l’uno accanto all’altro alti prelati che fanno una chiara scelta di pastorale antimafia, alti prelati che invece non pronunciano ancora la parola mafia e magari condividono certi aspetti della cultura paramafiosa, come l’etica dell’intenzione intesa in senso distorto, e alti prelati che possiamo definire burocrati di Dio, noi ci ritroveremo ancora dinanzi a una forma di relativismo etico, perché di volta in volta possiamo prendere un esempio positivo e uno negativo, ma resta il fatto che noi oggi, nell’Italia, nella Sicilia del 2012, continuiamo ad avere masse di cattolici che si scelgono a piacimento il proprio mediatore con Dio, e questo mi pare un problema grave che riguarda non solo la mafia, ma anche la corruzione. La corruzione è un gravissimo peccato contro la solidarietà sociale, che sta distruggendo le possibilità di riscatto di questo paese e abbiamo una massa di politici cattolici corrotti che non si sentono assolutamente in colpa con se stessi e anzi vengono talora additati come buoni cattolici e buoni cristiani perché elargiscono alla Chiesa le briciole dei soldi che hanno rubato. Voglio raccontare un episodio che sembra inventato e invece è riportato in una sentenza a carico di un ministro della Prima Repubblica, il quale, dovendo subire un’operazione al cuore molto difficile, si recò negli Stati Uniti e prima di entrare nella camera operatoria fece un voto alla Madonna in base al quale, se si fosse salvato, avrebbe regalato 100 milioni delle vecchie lire alla parrocchia della sua città. L’operazione andò bene e allora il ministro chiamò un imprenditore e gli disse: tu mi dovevi dare 100 milioni di tangente, invece di darli a me li dai al parroco perché io ho fatto un voto, e così si sentiva assolutamente in pace con se stesso.
Lei ha citato don Diana e padre Puglisi. Io ho conosciuto la storia di don Diana quando le monache paoline mi hanno invitato a presentare un libro a lui dedicato scritto da un sacerdote e teologo palermitano che si chiama Rosario Giuè, e sono rimasto molto colpito dal ringraziamento che in quell’occasione l’autore fece alla casa editrice delle monache paoline per il «coraggio» che avevano avuto nel pubblicare quel libro. Giuè infatti racconta che don Giuseppe Diana era stato cancellato dalla memoria collettiva e storica della Chiesa cattolica e spiega perché i vertici del Vaticano non l’hanno mai valorizzato come martire. Don Giuseppe Diana aveva tradotto nella sua azione pastorale i princìpi della teologia della liberazione del cardinale Oscar Romero e questo in una Chiesa cattolica che aveva condannato la teologia della liberazione non veniva gradito. Per quanto riguarda padre Puglisi, ricordo che il regista Roberto Faenza, che ha realizzato un film su di lui, ha scritto in un articolo che l’eredità di padre Puglisi si è in gran parte dispersa perché il suo successore è, a suo parere, una persona molto diversa da padre Puglisi tanto che ha persino avuto incarichi dall’onorevole Cuffaro all’interno della Regione Siciliana. Faenza sostiene – ma dialogando con diverse persone mi sono reso conto che si tratta di un’opinione condivisa da altri – che anche i seguaci di padre Puglisi, tra cui suor Carolina e un altro sacerdote, sono stati dispersi, per cui quello che aveva rappresentato un salto qualitativo della presenza cristiana sul territorio si è trasformato in una piccola holding della solidarietà che ha ricevuto in passato finanziamenti pubblici anche da parte di personaggi politici talora poco trasparenti.
Io non so quanto tutto questo corrisponda o meno alla realtà, però mi sembra di poter dire che permangono aspetti problematici che ci riconducono a quello che lei ha detto a proposito del fatto che la Chiesa vive nella realtà. Verissimo, e infatti vivendo nella realtà, il primo problema che la Chiesa ha sempre avuto è il rapporto con il potere. Ecco perché io faccio una distinzione di fondo tra Chiesa istituzione e Chiesa comunità. La Chiesa comunità a mio parere non può non riflettere tutte le contraddizioni della società civile, una società che si porta dentro anche la cultura della corruzione, della paramafiosità e della illegalità di massa. Ma il punto secondo me è la responsabilità della Chiesa come istituzione. Siccome la Chiesa cattolica è l’unica monarchia assoluta che è rimasta nella modernità ed è un ordinamento giuridico fondato sul vincolo di obbedienza e di subordinazione gerarchica, ci sarebbero tutti i presupposti per una rapida riconversione culturale guidata da quei vertici ecclesiastici che sono responsabili della formazione culturale e dell’educazione etica dei mediatori con Dio e delle masse cattoliche. Una riconversione che potremmo definire come la ricristianizzazione del cattolicesimo.
A me pare che il vizio di fondo della Chiesa istituzione sia invece una sorta di machiavellismo il cui prezzo è la scristianizzazione strisciante del cattolicesimo. Si ritiene in genere che il machiavellismo sia un’invenzione della cultura laica, e invece io ritengo che sia un’invenzione della cultura cattolica, per la quale nessun fine è superiore a quello della salvezza della Chiesa stessa e, in vista di questo fine superiore, nel corso della storia i vertici vaticani hanno rinsaldato di volta in volta il patto con il potere, il patto con Cesare. Quando il papa sceglie il fascismo, nonostante il fascismo avesse ucciso anche dei preti antifascisti, è una scelta che la Chiesa compie sull’altare degli interessi della Chiesta-Stato e un ragionamento simile si può applicare anche al rapporto con la mafia. Il cardinal Ruffini era un ammiratore del generale Franco, fascista, ed era uno che riteneva che il maggior pericolo per la Chiesa di allora fosse il comunismo, tutto il resto era secondario.
Mons. Mogavero: E non era il solo.
Scarpinato: E non era il solo, anzi c’era proprio un filone culturale che non considerava la mafia un pericolo, anzi, riteneva che almeno una parte della mafia fosse una mafia devota, una mafia che non solo non contestava la Chiesa, ma che addirittura aveva una sua propria religiosità e soprattutto costituiva un importantissimo baluardo contro la diffusione del comunismo. Ma il problema del rapporto col potere si pone anche al di fuori della mafia, perché quando si è trattato di scegliere tra Pinochet, uomo simbolo delle dittature sanguinarie sudamericane, e il cardinale Oscar Romero, uomo simbolo della teologia della liberazione, il vertice vaticano ha fatto la sua scelta: è noto che papa Wojtyła si mostrò sul balcone insieme a Pinochet, legittimandolo, e quando anni dopo il giudice spagnolo Garzón chiese l’estradizione di Pinochet, i vertici del Vaticano fecero di tutto per impedirla, tanto che le madri dei desaparecidos inviarono una lettera al papa in cui manifestavano tutta la loro indignazione per il fatto che non solo non aveva fermato il genocidio allora, ma si intrometteva ora anche per evitare l’estradizione del capo degli assassini.
Come dicevo all’inizio di questa nostra conversazione, io quando ero ragazzo ero sostanzialmente indifferente nei confronti della Chiesa cattolica, però ho avuto la fortuna di vivere in un tempo in cui avevamo tutti l’illusione di poter cambiare il mondo ed era anche il tempo del cattolicesimo riformista, un momento in cui c’era un ampio dialogo tra laici e cattolici, eravamo ancora pienamente dentro la primavera del Concilio Vaticano II, una stagione di rinnovamento interno per la Chiesa, di democratizzazione, di apertura alla società civile, una stagione iniziata con il pontificato di papa Giovanni XXIII e drammaticamente conclusasi proprio con l’omicidio di Oscar Romero, che ha segnato un ritorno alla Chiesa pre-conciliare. Oscar Romero tentò disperatamente di avere l’appoggio del papa, e invece venne lasciato solo e fu proprio questo suo stato di isolamento che lo condannò a morte, mettendolo nelle mani della dittatura di San Salvador che sapeva bene che quell’omicidio sarebbe passato sotto silenzio e avrebbe chiuso una stagione di neocristianesimo che dava voce e speranza a milioni di campesinos sfruttati a sangue da poche famiglie di grandi latifondisti che, grazie alla violenza, si erano impadroniti di tutte le ricchezze del paese. Ma quel che è più grave dal mio punto di vista è che quando tempo dopo Wojtyła si recò a San Salvador, non inserì nel suo itinerario ufficiale la visita alla tomba del cardinal Romero, come riconoscimento postumo del valore del suo martirio. Ci andò solo privatamente, proprio per non attribuire valore simbolico a quella visita. Poi tutte le cattedre della teologia della liberazione vennero chiuse e al posto di Romero è stato nominato un cardinale che era ai suoi antipodi. Anche questa vicenda – una tra le tante che si potrebbero ricordare – mostra come l’interesse supremo del Vaticano sia sempre stato la salvezza della Chiesa intesa come compromesso con i poteri che ne garantiscono la sopravvivenza come istituzione, e in quest’ottica si riteneva che Oscar Romero, con la sua Chiesa dalla parte dei popoli, potesse favorire il comunismo, visto come la più grave minaccia per la Chiesa.
Ecco, a me pare che questo machiavellismo cattolico sia il peggiore tradimento dell’importante lezione antipotere di Gesù Cristo. Come sostiene il teologo Alberto Maggi, Gesù opera una rivoluzione culturale perché, mentre prima di lui il rapporto tra Dio e l’uomo era un rapporto di sottomissione dell’uomo a Dio, a cui si doveva obbedienza, un Dio che era soprattutto potenza, con Gesù Dio è amore ed è quindi al servizio dell’uomo e, se non c’è più un rapporto di dominio di Dio sull’uomo, a maggior ragione non può esserci rapporto di dominio di un uomo su un altro uomo. Una rivoluzione del rapporto tra l’uomo e Dio che investe anche il rapporto tra uomo e uomo e il rapporto tra uomo e potere, rivoluzione che è il fondamento della democrazia. Non è un caso che Gesù chiami sempre in causa i potenti come responsabili del dolore degli uomini. E non è un caso che Gesù venga condannato a morte dai potenti del suo tempo – Cesare e Caifa – che lo ritenevano un pericolo sovversivo dell’ordine costituito. Ecco, questo insegnamento antipotere, che aveva trovato nella teologia della liberazione e nella stagione conciliare una possibilità di nuova rivisitazione, è stato completamente abbandonato dalla Chiesa post-conciliare. Una Chiesa tornata alla cultura pre-conciliare, con una riaffermazione del vincolo di subordinazione gerarchica, del vincolo di obbedienza, con una sostituzione della sostanza spirituale con la gestione mediatica delle masse. Mi pare che la Chiesa stia subendo una deriva che assomiglia in qualche modo a quella del potere laico: un potere che diventa sempre più oligarchico e verticistico e che usa i mass media come principale veicolo di comunicazione. In tv vediamo continuamente sceneggiati sui santi e una presenza costante dei vescovi, ma non vediamo mai il popolo di base. Eppure frequentando le parrocchie si scopre che c’è una forte domanda di senso, di nuovo cristianesimo. Cosa di cui non ti accorgi se ascolti parlare i vescovi in tv che non usano il linguaggio del «sì, sì, no, no, e il resto è farina del diavolo» ma parlano in maniera criptica e molto politicante. Quando mi è capitato di fare dei discorsi critici sul Vaticano in contesti cattolici – dalle suore paoline o al Centro Balducci, per esempio – temevo di essere travolto dai fischi e invece ho sempre ricevuto applausi scroscianti, come se volessero dirmi: siamo d’accordo con te, ma di’ tu queste cose che noi non le possiamo dire. Insomma, come accade anche nella società civile, c’è un popolo di base che è molto più avanti delle sue gerarchie, ed è un’occasione che non andrebbe sprecata.
Mons. Mogavero: Se io fossi stato tra i suoi ascoltatori in quelle occasioni pubbliche che ha citato stia certo che mi sarei unito molto volentieri agli applausi. Le cose che lei dice, infatti, sono in parte anche le mie sofferenze. Io ho vissuto la stagione del Vaticano II; ho vissuto il prima, il durante e il tempo della sua ricezione attraverso nuovi modelli di vita ecclesiale e nuove dinamiche di partecipazione. E sto vivendo un presente che mi fa soffrire maledettamente perché – lei non ha usato questa parola che io invece voglio usare – siamo in clima di restaurazione. Ritengo, perciò di avere motivi per rimpiangere quella stagione così promettente – una meravigliosa primavera dello Spirito – apportatrice di aria pulita, di finestre aperte, di dialogo col mondo, di capacità di guardare alle altre religioni non come a concorrenti da combattere, ma come compagni di un’avventura da condividere. Dalla mia diocesi, Mazara del Vallo, io guarda l’Africa e sono convinto che non dobbiamo temere l’islamizzazione dell’Europa e che il dialogo con l’islam, pur se difficilissimo, è l’unica risorsa che abbiamo se non vogliamo fare perennemente la guerra. Avendo molto a che fare con le Chiese del Maghreb, posso dire che ne rimango molto ammirato perché sono Chiese che non hanno niente a che spartire con il potere perché non hanno niente da dare al potere. In un paese di 10,5 milioni di abitanti come la Tunisia, una Chiesa di ventiduemila fedeli, come quella cattolica, pur essendo poco rilevante sotto il profilo numerico, non è irrilevante dal punto di vista della presenza e della capacità di testimoniare il Vangelo. La stessa cosa vale anche per gli altri paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo. Facendo tesoro di queste esperienze, ritengo che anche nel nostro paese noi dobbiamo gestire una presenza e assumere un ruolo nella società che non siano modellati su categorie dell’organizzazione umana, e meno che mai sulla gestione del potere. Ci dobbiamo collocare su prospettive altre rispetto a chi rimpiange la Democrazia cristiana o pensa a un nuovo partito dei cattolici; per non dire dell’inverosimile partito dei preti!
Però per fortuna la Chiesa oggi, anche in Italia, che pure è un paese abbastanza retrivo, non si identifica nella gerarchia e sente, nonostante tutto, un grande bisogno di Vaticano II da riprendere, non solo nelle sue idealità ma anche in talune sue linee operative e progettuali. Purtroppo, il magistero conciliare è tenuto ben custodito in un congelatore, in attesa che qualcuno la riprenda nella sua inalterata freschezza. Io, comunque, sono molto fiducioso perché oggi non abbiamo più talune preoccupazioni che nel recente passato, per varie ragioni, ci hanno fatto perdere di vista qual è il nostro essenziale, e cioè che noi siamo portatori di una speranza che non è un concetto ma è una persona, Gesù Cristo, che è il Dio degli ultimi, colui il quale non ha niente a che spartire con il potere e che proprio per questa sua guerra al potere costituito, religioso e civile, ha pagato con la vita. In ragione di ciò sono persuaso che il martirio oggi nella Chiesa è una risorsa, non una sciagura. Quando ammazzano un prete o un laico, quando fanno fuori qualcuno che con la sua vita e con la sua parola è diventato un messaggio scomodo, siamo davanti a una grazia, perché il martirio è la conferma, l’avallo autorevole attraverso il sangue di un messaggio che altrimenti non sarebbe credibile.
Lei ha citato più volte il santo Oscar Romero, che santo non è ancora, ma lo diventerà, perché, a mio modesto avviso, la beatificazione di don Pino Puglisi è il precedente per la beatificazione del vescovo Romero. Il tempo è galantuomo e fa giustizia. E se davanti a Dio mille anni sono come un giorno solo, come recita un salmo, i nostri anni sono veramente poca cosa nell’ottica di una lettura religiosa della storia. Ed è quello di cui abbiamo bisogno perché una lettura religiosa nel senso alto del termine, non devozionistica, né bigotta, ci fa comprendere il disegno che Dio va manifestando attraverso le vie contorte e le teste matte di noi uomini, ecclesiastici e non, devoti e non, guardandosi dagli atei devoti, soggetti un po’ sospetti…
Io penso che viviamo oggi un tempo assai tribolato di crisi molteplici, che, come tutti i tempi di crisi, è la premessa di un qualcosa di nuovo e di buono che si sta preparando, anche attraverso fatiche, indecisioni, oscillazioni tra il sì e il no, la mafia e l’antimafia, l’ateo devoto e il devoto assolutamente ateo, il credente e il non credente, il praticante e il non praticante. Abbiamo bisogno di una grande purificazione del pensiero, di intelligenze grandi, di nuovi umanesimi. La vera crisi che ci sta logorando non è una crisi di fede, è una crisi di cultura. Se noi oggi riuscissimo a recuperare la dimensione culturale della fede, della liturgia, della devozione, della pietà popolare, dei rapporti vicendevoli, daremmo a questo nostro mondo quello che si aspetta da noi e che noi forse non percepiamo chiaramente. C’è – e le sue parole lo confermano – una grande domanda – spesso inespressa – di Chiesa, che è una domanda di valore, di senso, di orizzonti e di prospettive che consenta a ciascuno di prendere le proprie decisioni ispirandosi unicamente alla verità, alla giustizia, alla corretta e costruttiva relazione interpersonale.
Scarpinato: Io credo che bisognerebbe impegnarsi per favorire un nuovo incontro tra cultura laica e cultura cattolica su nuove basi che mettano da parte vecchi paradigmi del passato. Quando sento parlare della creazione di nuovi partiti cattolici fondati solo sulla comune appartenenza allo stesso credo religioso, mi sembra di assistere alla riproposizione fuori tempo massimo di vecchie e improponibili operazioni di Palazzo che pretendono di mettere insieme il diavolo e l’acqua santa: cattolici onesti e cattolici corrotti e mafiosi. Bisogna abbandonare la falsa distinzione tra credenti e non credenti: alcuni miei colleghi magistrati non erano credenti eppure si sono fatti uccidere perché credevano nei valori di eguaglianza, di giustizia, di fratellanza e io credo che loro fossero molto più cristiani di tanti atei pratici che si definiscono buoni cattolici solo perché vanno ogni domenica a messa e poi sono corrotti o traccheggiano con i mafiosi. Il punto è che ci sono modi diversi di credere negli stessi valori, ma del resto la Rivoluzione francese, che determina la nascita della modernità, dell’Illuminismo, a quali valori si ispirava? Libertà, eguaglianza e fraternità. E l’eguaglianza e la fraternità non sono forse valori cristiani? Il punto è che questa domanda di senso è trasversale al mondo laico e al mondo cattolico e non trova più risposta né all’interno della Chiesa istituzione né all’interno delle istituzioni statali.
Mons. Mogavero: Sono molto d’accordo sulla sua conclusione. Io ho la fortuna di incontrare molta gente e molte persone, con cui dialogo piacevolmente, mi fanno sorridere quando, rivolgendosi a me quasi scusandosi, precisano: guardi che io non sono cattolico! Come se questa fosse una discriminante e non, al contrario, un motivo in più per un dialogo sincero e costruttivo. MicroMega 7/2012
Rinascere criminali. Padrini, battesimi e simboli nell’iniziazione mafiosa Il corredo di simboli e rituali che caratterizzano i cosiddetti “battesimi” mafiosi presenta dotazioni, logiche e sintassi pressoché analoghe. Che si tratti dell’iniziazione a cosa nostra, alla camorra, alla ‘ndrangheta, alla sacra corona unita, oppure alla yakuza giapponese, le triadi cinesi o l’ms-3 salvadoregno – la “forma strutturale” che soggiace ai riti di affiliazione resta identica ovunque. Così come identici sono i valori che li sottendono e che, come si vedrà più avanti, sembrano rinviare a veri e propri archetipi del pensiero umano.
- Sono essenzialmente tre gli elementi costitutivi il cerimoniale dell’iniziazione mafiosa: la recita di formule verbali pronunciate dal maestro di iniziazione e dal postulante, spesso ricorrendo a un linguaggio criptico volto a conferire un alone di mistero al contesto e a produrre un’intensificazione emotiva tra i presenti;
- L’esposizione e la manipolazione di sacra cui è demandato il compito di conferire efficacia simbolica e valore di costituzionalità al rito;
- Il giuramento solenne di adesione ai valori e alle norme di comportamento della società mafiosa.
I riti, di norma, hanno inizio con una formula di sacralizzazione dello spazio. Riferisce al riguardo il collaboratore di giustizia Gianni Cretarola, intervistato da la Repubblica:
Per il rito ci vogliono cinque persone, non di più non di meno ma nella calzoleria ce n’erano solo due, oltre a me. Gli altri erano rappresentati da fazzoletti annodati. Il primo passo è la “formazione del locale”, una sorta di consacrazione che, alla fine del rito, verrà rifatta al contrario: “Se prima questo era un luogo di transito e passaggio da questo momento in poi è un luogo sacro, santo e inviolabile.
La sacralizzazione dello spazio, oltre alla formula verbale pronunciata dal maestro di iniziazione è garantita dall’evocazione di testes mitologici o religiosi che variano – dall’arcangelo Michele alla Madonna del soccorso, da Osso, Mastrosso e Calcagnosso, a Gaspare, Melchiorre e Baldasarre, compresi Mazzini, Garibaldi e la Marmora – a seconda dei contesti o dei gradi di iniziazione previste dall’organizzazione mafiosa. Significativo poi è il fatto che vengano utilizzati riferimenti proprio al rito del battesimo. Sono ancora le parole di Cretarola a darne testimonianza:
A nome dei nostri tre vecchi antenati, io battezzo il locale e formo società come battezzavano e formavano i nostri tre vecchi antenati, se loro battezzavano con ferri, catene e camicie di forza io battezzo e formo con ferri, catene e camicie di forza, se loro formavano e battezzavano con fiori di rosa e gelsomini in mano io battezzo e formo.
Il riferimento al battesimo trova riflesso anche nella presenza di padrini che svolgono un ruolo fondamentale sia nel reclutamento del novizio, sia nel rito di affiliazione che lo introduce nella onorata società e sia in tutta la sua successiva condotta di vita di cui lo stesso padrino è ritenuto il responsabile e il fideiussore. Un altro aspetto costitutivo dei riti è la rivelazione di un segreto iniziatico riguardante il codice di comportamento al quale il postulante dovrà conformarsi per sempre, giacché dal giuramento non è possibile recedere da vivi. Come il giudice Giovanni Falcone spiegava a Marcelle Padovani in Cose di cosa nostra, questo codice di comportamento implica: l’obbligo di conservare il segreto a costo della vita; il dovere di non mettersi in contrasto con altri uomini d’onore e di dimostrare sempre un comportamento leale verso i fratelli di sangue; l’obbligo di non presentarsi mai soli al cospetto di altri uomini d’onore, bensì accompagnati da un altro uomo d’onore che garantisca la medesima appartenenza a Cosa Nostra affermando: “quest’uomo è la stessa cosa”. A queste clausole essenziali e non eludibili se ne possono aggiungere altre accessorie che trovano attuazione con intensità di vincolo non sempre (o non più) riconosciuta: il non desiderare la donna di altri uomini d’onore; il non sfruttare la prostituzione; il non uccidere altri uomini salvo in caso di assoluta necessità; l’evitare la delazione alla polizia.Ulteriore topos ricorrente nei riti di affiliazione è il sangue. Viene fatto fuoriuscire tramite un taglio dell’avambraccio o tramite la punciuta di un dito e viene lasciato cadere su un’immaginetta votiva successivamente bruciata nel palmo della mano del neofita cui viene chiesto di pronunciare una breve formula promissoria:
Poi hanno preso una candela accesa, hanno disinfettato un ago facendolo bruciare al fuoco e ci hanno punto il dito. Pigghiaru a santa, ci dettiru focu e nna’ misiru nna’ manu, poi ci fecero giurare: io giuro di essere fedele alla famiglia, se io dovessi tradire le mie carni saranno bruciate come brucia questa santona.
Con queste parole Candido Cannavò, in Pretacci. Storie di uomini che portano il vangelo sul marciapiede, mostra come l’atto del pungere o dell’incidere la pelle al fine di provocare la fuoriuscita di sangue, costituisca un espediente rituale dall’impatto emotivo molto potente e drammatico Sul perché il sangue giochi un ruolo così determinante nei rituali di iniziazione si vogliono richiamare le considerazioni che Luigi Lombardi Satriani espone nella sua introduzione a Fratelli di Sangue, il libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso sulla ndrangheta. Secondo l’antropologo calabrese, capire il ruolo del sangue nelle cerimonia di iniziazione mafiosa significa innanzitutto riconoscere il significato profondo che lo stesso sangue riveste nella cultura folklorica meridionalistica, quindi significa tener conto di cosa, in prospettiva interculturale e diacronica, il sangue rappresenti alla luce di un pensiero simbolico universale. Scrive testualmente Lombardi Satriani:
Il sangue è un elemento investito di intense cariche di valorizzazione simbolica e può declinarsi tanto come principium vitae che come principium mortis. Il sangue cioè si pone come elemento atto a far vita, a fondarla, a renderla imperitura. Inoltre si qualificandosi come supremo regolatore della quotidianità, non è sottoposto alle norme del quotidiano, e quindi può infrangere le barriere del tempo, introdurre al potere, richiamare al potere, essere potere. Il sangue, poi, in quanto nesso dialettico vita-morte, introduce a una dimensione sacra in cui la ritualità rappresenta la trascrizione sul piano simbolico dell’esperienza di vita e di morte.
Tra i vari scopi assegnati alla profusione rituale del sangue (dal garantire l’efficacia del rituale al produrre l’idea della fratellanza) c’è anche quello di attestare i requisiti di coraggio del postulante nell’atto di diventare uomo d’onore. Ebbene letto in questa in questa prospettiva dietro il simbolismo del sangue noi possiamo cogliere un assunto assai importante che il rito iniziatico esalta e che il sistema mafioso ratifica come proprio: quello della virilità. Una virilità che, nella cultura mafiosa descritta dallo stesso Lombardi Satriani in Il silenzio, la memoria, lo sguardo, si vede assegnare un valore di primissimo piano e che viene recepita sulla base di due accezioni:
- quella – più ristretta – che ruota attorno al concetto di “mascolinità” e che porta a escludere gli omosessuali (o coloro che hanno moglie e sorelle che non siano di specchiata rispettabilità) dal consesso degli uomini d’onore;
- un’altra – più estensiva – che ruota attorno al concetto di “omineità” e che fa riferimento alla capacità di testimoniare con le proprie azioni la validità delle norme e l’efficacia indiscutibile dei valore. È da uomo non tradire, è da uomo tacere, è da uomo darsi alla latitanza, è da uomo persino dire bugie al fine di instaurare con lo stato un rapporto di antagonismo. In pratica è da uomo l’esercizio dell’omertà che il mafioso considera alla stregua di una virtù.
Volendo dunque sintetizzare. L’utilizzo di scenari e di simbolismi iniziatici nelle cerimonie di affiliazione mafiosa, se da una parte mirano a suggellare il passaggio da uomo comune a uomo d’onore, o da contrasto onorato a picciotto liscio, dall’altra rispondono al bisogno di trasformare gli affiliati in un consesso di similes e di pares vincolati da un giuramento per nessuna ragione derogabile. Tuttavia il ricorso a scenari e simbolismi iniziatici svolge anche un’altra importante funzione nell’ottica dell’ideologia mafiosa: ossia quella di creare una identità forte dove la distinzione tra sé e il gruppo è impossibile da concepirsi; dove l’interesse collettivo (della famiglia) deve prevalere su quello del sé; dove il senso del noi deve assumere il sopravvento su quello dell’io.
Conclusioni Secondo il fenomenologo delle religioni rumeno Mircea Eliade, l’iniziazione rappresenta una esperienza vitale che appartiene in proprio alla condizione umana e che si accompagna ad ogni percorso di rinascita o di rinnovamento esistenziale; una esperienza totale e totalizzante che, basandosi sull’acquisizione di saperi specialistici, sul cimento di prove interiori più o meno traumatiche e traumatizzanti e sulla volontà di trascendere il passato è volta a perseguire la trasformazione radicale dello status esistenziale della persona:
Sia che si tratti di un giovane Masai, di uno sciamano iacuto, di un bramino induista, di un congregato gesuita, [sia che si tratti di uno ndranghetista calabrese o di un camorrista casalese] colui che decide di sottoporsi a tali percorsi di decostruzione/ricostruzione dell’identità viene a godere di un’esistenza diversa dalla precedente; realizza la propria palingenesi. Come dire: muore e rinasce.
(E. Di Renzo, Si fa il cammino con l’andare, Roma, Bulzoni, 2002)
E l’ideologia dei riti d’iniziazione implica sempre, in maniera più o meno trasparente, una morte simbolica seguita da una nuova nascita.
Premessa indispensabile all’inizio di una esistenza diversa e rinnovata, la morte iniziatica può esprimersi attraverso una gamma diversificata di immagini allegoriche: le tenebre, l’ascesi, la reclusione, simboli di tipo embriologico (regressus ad uterum) o simboli di matrice tellurica (descensus ad inferos), il sangue.
(E. Di Renzo, Si fa il cammino con l’andare, Roma, Bulzoni, 2002)
Tutte immagini atte a significare la regressione ad una condizione di tabula rasa che conduce mentalmente l’individuo lontano da ciò che egli era o da ciò che gli è usuale. Ebbene perché questo riferirsi ai simbolismi di rinascita dovrebbe essere ritenuto conforme a spiegare l’esistenza di ritualità iniziatiche nelle pratiche di affiliazione mafiosa. La risposta la fornisce lo stesso Mircea Eliade allorché afferma:
L’ideologia e l’esperienza delle iniziazioni lontano dal riferirsi ad “altrovi” culturali distanti nel tempo e nello spazio, esprimono permanentemente e con efficacia tutte quelle aspettative di rigenerazione e di rinnovamento esistenziale che contrassegnano la vita dell’individuo.
(M. Eliade, La nascita mistica, Brescia, Morcelliana, 1974) Come altrimenti dire: se si decide di trasformare la propria vita rendendola altra da ciò che essa fino ad ora è stata – al di là delle possibili ragioni per cui si vuole che ciò accada o quali tipo di esistenza ci si propone di costruire – non si può non far riferimento a questo archetipo nel rendere pensabile e perseguibile il cambiamento. E che le iniziazioni costituiscano un archetipo in base al quale è pensabile e perseguibile il cambiamento ontologico della propria identità ne costituisce riscontro evidente il fatto che ancora oggi l’homo laicus occidentale, benché abbia da tempo rinunciato a questo modello mitico-rituale socialmente istituzionalizzato per sancire il passaggio da una condizione esistenziale a un’altra, ha comunque continuato a rimanere del tutto sensibile a simbolismi di tipo iniziatico. Simbolismi che residuano nella dimensione ritualistica del battesimo e della cresima, o che trapelano nei percorsi di noviziato e di presa dei voti; simbolismi che operano nella psiche profonda e che spesso affiorano nell’immaginazione letteraria e cinematografica; simbolismi che, nel caleidoscopico universo delle associazioni segrete di stampo mafioso, sono ritenuti del tutto efficaci per ambire a diventare uomini d’onore. Ernesto Di Renzo 20 Novembre 2014 RESET
Corleone, l’inchino della processione a lady Riina
Ninetta Bagarella si è affacciata al balcone. I rappresentanti di polizia e carabinieri hanno lasciato il corteo. Aperta un’indagine. Il parroco: “Non una sosta voluta ma serviva più prudenza”. L’ira del vescovo di SALVO PALAZZOLO l confrate suona la campanella e la processione si ferma, proprio davanti a casa Riina, in via Scorsone 24, nel cuore di Corleone. Ninetta Bagarella, la moglie del capo del capi rinchiuso al 41 bis, è al balcone. Guarda soddisfatta la vara di San Giovanni Evangelista e sorride alle sue sorelle, Matilde e Manuela, che sono accanto a lei. Mentre la folla acclama il Santo. L’ultima processione che ha attraversato Corleone è già diventata un caso. Domenica pomeriggio, quell’inchino alla moglie di Salvatore Riina non è passato inosservato. Il commissario di polizia e il maresciallo dei carabinieri, che erano poco distanti, hanno subito lasciato la processione. E hanno inviato una relazione alla procura distrettuale antimafia. Perché i Riina sono ancora un simbolo in Cosa nostra: nelle ultime intercettazioni dei carabinieri, i boss del paese invocavano addirittura la mediazione di donna Ninetta per risolvere vecchie controversie. E, intanto, si davano un gran da fare per inviare un po’ di soldi a Salvuccio Riina, il figlio del capo di Cosa nostra che dopo otto anni di carcere ha deciso di trasferirsi a Padova e scrivere (a modo suo) un libro sulla famiglia. Adesso, c’è un’indagine su quella processione. E i primi accertamenti hanno già portato a un risultato: è emerso che uno dei membri della confraternita di San Giovanni è cugino di secondo grado della Bagarella, si chiama Leoluca Grizzaffi. Il parroco di Santa Maria, padre Domenico Mancuso, è amareggiato: “Ho ribadito alle forze dell’ordine che non è mia usanza sostare davanti ai potenti o pseudo potenti – dice – quella non era una sosta prestabilita, è accaduto. Mi rendo conto che ci voleva più prudenza”. Il sacerdote ha già convocato i confrati. “Tutti insieme abbiamo stabilito che la processione di San Giovanni non passerà mai più da via Scorsone”. Parole ancora più dure arrivano dal vescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi: “Su episodi come questi non transigo. Ho già nominato una commissione d’inchiesta, sono in attesa di una relazione. Intanto, ho proposto al questore di Palermo di stilare un protocollo d’intesa, per prevenire altri episodi: propongo che d’ora in poi anche le soste delle processioni siano concordate con le forze dell’ordine, per evitare spiacevoli sorprese”. Nei mesi scorsi, monsignor Pennisi aveva anche imposto alla confraternite di inserire nello statuto una clausola: “Nessun pregiudicato per mafia può far parte delle nostre associazioni”. Ma Leoluca Grizzaffi è un perfetto incensurato. Si difende. Eppure, attorno a quel cognome c’è grande attenzione da parte della procura e delle forze dell’ordine. Un altro Grizzaffi, Giovanni, ancora per qualche mese in carcere, viene citato come fosse il messia nelle ultime intercettazioni: l’uomo forte che Cosa nostra aspetta per ritornare ai fasti di un tempo. I boss cercano di riorganizzarsi. Nei mesi scorsi, è emerso che erano in contatto addirittura con il fratello del sindaco, Lea Savona. Il prefetto di Palermo, Antonella De Miro, ha inviato gli ispettori al Comune. Intanto, il genero di Riina lancia insulti su Facebook. E il sindaco di Corleone difende i confrati: Lea Savona smentisce le relazioni di polizia e carabinieri, che hanno annotato la presenza delle sorelle Ninetta, Manuela e Matilde nel balcone di via Scorsone. “Ninetta Bagarella, il giorno della processione incriminata, non era a Corleone – dice il primo cittadino – E’ andata a Parma, dove il marito è detenuto, e non è ancora tornata in paese. Quindi è impossibile che fosse al balcone a guardare un inchino che non c’è mai stato”. Per il sindaco di Corleone, “è l’ennesima falsità strumentale che contribuisce a dare un’immagine falsa del paese”. La Savona annuncia un esposto all’Ordine dei giornalisti e alla procura “contro chi racconta cose non vere”. LA REPUBBLICA 4.6.2016
La svolta anti ‘ndrangheta della chiesa calabrese: “Basta inchini davanti alle case dei boss”
La svolta antimafia della chiesa cattolica calabrese. La Conferenza episcopale regionale marca con decisione il sentiero della nuova pastorale rivolta al futuro clero che opererà in questa nostra terra, una terra impastata col sangue delle troppe vittime di mafia e il dolore dei tanti imprenditori oppressi, costretti a pagare periodicamente la “mazzetta” ai signori del racket. Quella dei vescovi rappresenta una scelta destinata a provocare uno stravolgimento nella storia della pastorale nei confronti del potere mafioso. Domani, alle 14.45, nel salone del President Jolì di Castrovillari, verrà presentato il corso istituzionale accademico che la Cec ha preteso per la formazione dei suoi religiosi sul tema “La Chiesa di fronte alla ‘ndrangheta”. La didattica sarà poi attivata nell’istituto teologico calabrese “San Pio X” di Catanzaro, aggregato alla Pontificia facoltà dell’Italia meridionale di Napoli. La Chiesa ha deciso di chiudere definitivamente le porte ai boss e ai loro reggipanza: non ci saranno più inchini di statue davanti alle abitazioni di malavitosi, non ci saranno per loro sacramenti. Nei confronti dei mafiosi sarà applicato il protocollo della scomunica annunciato da Papa Francesco, nel giugno del 2014, dalla spianata di Sibari. Quel giorno il pontefice, scese in Calabria nella terra di Cocò, e davanti a 250mila fedeli, attaccò quella ‘ndrangheta senza onore, quella ‘ndrangheta di vigliacchi che all’epoca si facevano (ma continuano a farsela anche adesso) la guerra per il controllo della droga. E per la droga quella ‘ndrangheta non risparmiò la vita di un bambino di quattro anni. Quella fu la seconda volta che un pontefice reagì con forza alla violenza del potere mafioso. Prima di Bergoglio era stato Giovanni Paolo II a scagliarsi contro i boss con il profetico discorso della Valle dei Tempi di Agrigento. Il Papa-Santo si rivolse agli assassini di cosa nostra invitandoli a cambiare vita, a pentirsi convertendosi al Vangelo. L’anatema lanciato ai mafiosi si concludeva con un avvertimento: «Un giorno verrà il Giudizio di Dio…». Da quella spianata archeologica la speranza sembrò improvvisamente rinascere e correre verso l’infinito di una Chiesa più coraggiosa e laica. Una Chiesa che non si piegò più davanti all’arroganza delle coppole e dei loro reggipanza. Un atteggiamento che provocò l’ira dei mafiosi che scatenarono la strategia della tensione con le bombe a San Giovanni in Laterano e a San Giorgio al Velabro. E, soprattutto, con l’omicidio di don Pino Puglisi, parroco a Brancaccio, uno dei quartieri popolari di Palermo. Il prete del popolo pagò con la sua vita il suo desiderio di salvare tanti ragazzi di strada. Giovani che accoglieva nella sua parrocchia, sottraendoli alla criminalità organizzata. Questa scelta della Chiesa calabrese, guidata da monsignor Vincenzo Bertolone, è chiara: contrastare con decisione la cultura mafiosa per restituire a questa nostra terra la speranza. Giovanni Pastore 30.9.2019 GAZZETTA DEL SUD
CHIESA e MAFIE di Isaia Sales
Se si chiedesse a un campione di cittadini italiani se essere mafioso o camorrista o ‘ndranghetista sia compatibile con l’essere cristiano, se cioè la mafia la camorra la ‘ndrangheta siano conciliabili con la Chiesa, ciascuno degli intervistati risponderebbe con un no risoluto, meravigliandosi anche della domanda. Ma allo stesso modo, se si formulasse la medesima domanda a dei mafiosi camorristi e ‘ndranghetisti, anch’essi resterebbero meravigliati: per loro è ovvio rispondere di sì, che cioè non c’è nessuna contraddizione tra credere in Dio, nella Chiesa e al tempo stesso aderire ad una di queste organizzazioni criminali. Tanto è vero che non si conoscono mafiosi atei (escluso Matteo Messina Denaro) o anticlericali, non ci sono appartenenti alle mafie che non ostentino apertamente la loro fede. Nei loro covi si sono rinvenute numerose bibbie, immagini sacre, statue di santi, e in alcuni casi sono stati scoperti dei veri e propri altari su cui preti e frati andavano a dire messa e a porgere la comunione a dei ricercati per efferati delitti. Essi si sentono naturalmente religiosi, credenti, devoti, anzi pensano di avere un rapporto del tutto particolare e speciale con Dio. Non li sfiora neanche lontanamente la percezione di assoluta incompatibilità tra l’essere dei feroci assassini e dei ferventi cattolici. Oggi ci sembra assurdo che degli appartenenti ad associazioni criminali che hanno segnato la storia di quattro regioni meridionali e dell’Italia intera per più di un secolo e mezzo possano intrattenere un rapporto normale e sereno con la religione cattolica. Ma questo intenso rapporto è stato accettato tranquillamente dagli stessi esponenti della Chiesa locale e nazionale fino a pochissimi anni fa, e in molti luoghi di mafia continua ad esserlo. La Chiesa italiana non ha mai prodotto un documento ufficiale, una presa di posizione contro le mafie fino agli anni ’70 del Novecento, cioè più di un secolo e mezzo dopo l’affermazione e il consolidamento di alcune delle organizzazioni delinquenziali più violente al mondo. La Chiesa non le ha mai combattute, non c’è stato mai un aperto contrasto fino ai tempi recenti. Un lunghissimo silenzio dei cattolici, del clero, delle gerarchie locali e nazionali, ha dominato incontrastato accompagnando l’evolversi di quei fenomeni criminali anche quando avevano assunto fama internazionale e la parola mafia era diventata il termine per antonomasia in tutto il globo per indicare la criminalità organizzata. Anzi, la storia della Chiesa in quei territori si svolgeva parallela a quell’espansione e più di una volta con essa si intrecciava, soprattutto in Sicilia. Le cose sono cambiate nella seconda metà degli anni settanta del Novecento, ma lentamente e senza coinvolgere totalmente gli esponenti delle chiese locali, come vedremo in seguito. Il silenzio fu squarciato dalle omelie del cardinale Pappalardo nel 1982 in occasione di alcuni delitti eccellenti. Prima in Campania lo aveva fatto don Riboldi vescovo di Acerra, poi Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento nel 1993. In seguito, gli omicidi di Padre Pino Puglisi a Palermo e di Padre Giuseppe Diana a Casal di Principe, gli attentati alla basiliche di S. Giovanni in Laterano e del Velabro a Roma, hanno spinto la Chiesa a più coraggiose prese di distanza dalle mafie, fino al documento della Conferenza Episcopale Italiana nel 2010. E questo atteggiamento nuovo (anche se minoritario) si è manifestato solo dopo la caduta del muro di Berlino e dopo la fine della Dc, cioè dell’unità politica dei cattolici. Come va interpretato questo plurisecolare silenzio della Chiesa? Ed è un silenzio superato completamente dalle posizioni di oggi? E le posizioni di oggi riguardano tutta la Chiesa o solo una minoranza? Di che natura è stato il silenzio: impaurito, complice, impotente o di comune appartenenza a valori e culture condivise, o tutte queste cose insieme? Ancora, la pastorale e la teologia morale della Chiesa si sono adeguate alla svolta degli ultimi anni? Per quale motivo, nonostante la svolta recente, Cosa nostra e le altre organizzazioni similari non sono state formalmente scomunicate, e si continuano a celebrare ancora oggi matrimoni, cresime e funerali di mafiosi, camorristi e ‘ndranghetisti? E perché alcuni preti vanno a dire messa nei covi di latitanza di pericolosi capimafia? Infine, è possibile il pentimento davanti a Dio senza che ciò abbia conseguenze sociali e civili verso le vittime? La concezione del perdono e del pentimento dominante nella Chiesa è compatibile con una lotta senza quartiere a questi fenomeni criminali? Insomma, le domande sono tante e le potremmo racchiudere in una complessiva: oltre a un lunghissimo ed evidentissimo silenzio, non c’è stata anche una certa assonanza tra la cultura mafiosa e la cultura che la Chiesa ha diffuso soprattutto nell’Italia meridionale? Bisogna prendere atto che una società profondamente plasmata dalla cultura cristiana ha partorito Cosa nostra, la Camorra, la ‘Ndrangheta e la Sacra corona unita. E le ha partorite non in contrapposizione alla Chiesa e alle sue istituzioni, ma in una formale e pubblica adesione ai suoi riti, alle sue credenze, al rispetto delle sue gerarchie e del suo ruolo nella società. Le mafie hanno trovato terreno fertile proprio laddove la presenza della Chiesa e dei cattolici è molto rilevante. In quattro ‘cattolicissime’ regioni meridionali si sono sviluppate alcune delle organizzazioni criminali più spietate e potenti al mondo, senza che – fino a pochi anni fa – ci fosse contrasto tra esse e le gerarchie cattoliche. Questa la verità storica incontestabile. È un fatto storico che le mafie hanno sempre rispettato la Chiesa e (purtroppo) la Chiesa ha sempre rispettato o non ostacolato i mafiosi. Ma se degli assassini si sentono credenti in Cristo e nella sua Chiesa, «o c’è un problema nella loro testa bacata o c’è un problema nella Chiesa cattolica, o in tutti e due»: sono parole di Augusto Cavadi da condividere pienamente. Le mafie durano da quasi 200 anni. Se non sono state ancora sconfitte o ridimensionate vuol dire che i motivi del loro ‘successo’ non sono stati completamente individuati. Numerosissimi studi hanno interrogato la politica, le istituzioni, lo Stato, la cultura e la società meridionali. Chi ha cercato nel familismo amorale la causa di tutti i nostri mali (comprese le mafie), chi nell’assenza storica di senso civico. Ma se la spiegazione è di ordine culturalista, cioè attiene alla cosiddetta mentalità, perché mai non si interroga fino in fondo la cultura cattolica che ha svolto un ruolo fondamentale come principale agenzia formativa del senso comune dei meridionali? Se degli assassini credono in Dio, se si sentono dei buoni cristiani, se non li sfiora minimamente la inconciliabilità tra il macchiarsi le mani di sangue e sentirsi parte della grande famiglia cattolica, ciò dovrebbe rappresentare la principale preoccupazione dei vescovi italiani. Limitarsi a dire che si tratta di una «forma brutale e devastante di rifiuto di Dio e di fraintendimento della vera religione», come hanno fatto nel loro documento in materia del 2010, non è assolutamente sufficiente. Si continua a bollare la religiosità dei mafiosi come una forma evidente di superstizione. Ma se queste testimonianze di fede dei mafiosi vanno etichettate come superstizione, allora si dovrebbe dichiarare superstiziosa gran parte della popolazione cattolica. Essi non fanno altro che manifestare la loro religiosità nelle forme in cui normalmente si manifesta e si è manifestata nei secoli la fede cattolica nel Sud d’Italia. Il messaggio della Chiesa si è dimostrato capace di coesistere senza conflitti con l’appartenenza mafiosa. È del tutto ovvio che le mafie non avrebbero potuto radicarsi così profondamente nella storia meridionale senza un’acquiescenza degli esponenti della Chiesa cattolica, che spesso hanno piegato la dottrina cristiana alle esigenze di dare buona coscienza a degli assassini. Insomma, il successo delle mafie italiane rappresenta anche un insuccesso della Chiesa cattolica. Perché si sono permessi i sacramenti a dei pii assassini, si sono svolti per loro solenni funerali, sono stati accettati come padrini di battesimo e cresima, sono stati scelti per presiedere i festeggiamenti dei santi patroni e portare le loro statue sulle spalle? È normale tutto ciò? Certo, va indagata in profondità la psiche di questi assassini e la loro particolare idea di Dio, ma al tempo stesso andrebbe interrogata la storia della Chiesa meridionale (e la storia della società meridionale influenzata dall’insegnamento cattolico), perché c’è qualcosa che non va se si sono sviluppate, senza contrasto con la Chiesa, alcune delle associazioni criminali più feroci al mondo proprio laddove più forte è il legame delle popolazioni con la fede cattolica. La domanda che molti studiosi della criminalità si pongono è questa: le mafie avrebbero potuto ricoprire un ruolo plurisecolare nella storia meridionale e dell’intera nazione se, oltre alla connivenza di settori dello Stato e di parte consistente delle classi dirigenti locali, non avessero beneficiato del silenzio, dell’indifferenza, della sottovalutazione della Chiesa cattolica e della sua dottrina? La risposta è no. Senza di ciò le mafie non sarebbero arrivate a tenere in pugno il futuro di intere popolazioni. Si è trattato solo di paura, di vigliaccheria dei rappresentanti della Chiesa o di qualcosa di più profondo? Le mafie, ripeto, vanno considerate anche come un insuccesso della Chiesa, un problema da cui questa non può sottrarre le proprie responsabilità. Cosa sarebbe il Sud d’Italia se la Chiesa fin dall’inizio avesse combattuto in tutti i suoi uomini, e con tutto il peso della sua dottrina e della sua predicazione, questi fenomeni antievangelici e anticristiani? Sarebbero stati già sconfitti, o ridimensionati? Sicuramente sì. Senza la cultura cattolica e senza la sua influenza sulle vicende storiche e sociali dell’Italia, e in particolare del Sud, sarebbe stato più difficile il radicamento e il condizionamento di massa da parte delle mafie. Ci sono sicuramente spiegazioni funzionali sulla religiosità dei mafiosi. Per un criminale il problema principale è il controllo dei sensi di colpa. Ammazzare non è una cosa così semplice, non è una ‘normale’ attività umana. Il senso di colpa per le azioni delittuose può mettere in crisi anche il più spietato degli assassini. Se si riesce a dominarlo, si è poi in grado di poter continuare a delinquere e a ottenere consenso, ricchezza e potere. I killer seriali sono tali proprio perché non sentono nessun senso di colpa. Stessa cosa per i mafiosi. Convincersi che Dio è dalla propria parte, che comprende la ratio delle azioni mafiose e criminali e che è pronto al perdono per tutto quel che di delittuoso si compie, è una incredibile comodità. La Chiesa cattolica ha dato buona coscienza a degli assassini: questo è il principale ‘regalo’ fatto dalla religione cattolica ai mafiosi. Anche chi non crede riconosce alle religioni (a tutte le religioni) un presidio morale contro il male. Tutte le religioni tentano, ciascuna a proprio modo, di contenere il male che si sprigiona dall’uomo. Ancora di più ciò viene riconosciuto alla religione di Cristo. Ma se degli assassini non provano neanche rimorso per quello che commettono, e di norma si fanno il segno della croce prima di ammazzare, vuol dire che la credenza religiosa si è trasformata in auto-assolvimento. In secondo luogo, i mafiosi non vogliono essere avvertiti come delinquenti dalla società che li circonda, dalla comunità in cui operano. Come si fa a percepirli come delinquenti se la loro presenza è accettata in Chiesa, se ad essi sono riservate le cerimonie più fastose, se li si sceglie come organizzatori delle feste religiose, se si consente loro di portare sulle spalle i santi in processione, se sono tra i principali benefattori delle attività caritative? L’ossessione della Chiesa per i peccati legati alla sfera sessuale l’ha privata nel Sud del ruolo di guida nella lotta alle più agguerrite organizzazioni criminali che il nostro Paese ha prodotto nella storia. La scomunica è stata usata solo per i suoi avversari ideologici (massoni, socialisti, comunisti) e per coloro che non rispettano le sue prescrizioni in materia sessuale e matrimoniale. Un divorziato non può accedere ai sacramenti, ma un Provenzano, un Riina, un Cutolo o un Piromalli sì. Anzi, ad alcuni capimafia i sacramenti sono stati portati nel loro rifugi di ricercati. Non è venuto il momento di risolvere radicalmente questa storica contraddizione?
La religiosità dei mafiosi. L’aiuto ricevuto da uomini di Chiesa Scrive lo storico Marino: «Le due autorità, le due istituzioni sociali, la chiesa e la mafia, si annusavano e si incensavano vicendevolmente. Non a caso in una medesima famiglia potevano convivere, senza conflitto, ecclesiastici e notabili mafiosi. La mafia, con la benedizione di preti, monsignori e cardinali, era dedita a salvaguardare tutte le tradizioni locali dai pericoli crescenti della modernizzazione». Numerosi sono innanzitutto i casi di presenze di preti, frati, suore in molte famiglie di tradizione mafiosa. La cosa riguarda molto di più la Sicilia, meno la Calabria, e raramente la Campania e la Puglia. In Sicilia avere un prete in famiglia voleva dire prestigio e possibilità sociali per i mafiosi. Preti e mafiosi vivevano nella stessa casa senza imbarazzi e senza casi di coscienza, come un fatto naturale. Il caso più clamoroso è quello di Calogero Vizzini, capo della mafia siciliana fino agli anni ’50 del Novecento, definito il «re Sole della mafia». Lo zio, Giuseppe Scarlata, divenne vescovo nel 1910, precedendo di qualche mese analoga nomina di un altro zio, Giuseppe Vizzini. I due fratelli, preti di don Calò, erano padre don Totò (Salvatore) e padre don Giuanninu (Giovanni), vivevano in casa con lui, non potevano non sapere delle sue attività e non ebbero mai niente da obiettare. In quella famiglia le preghiere si alternavano ai comandi criminali. Quando il fratello Calogero veniva arrestato, procuravano le prove per scagionarlo, tra queste numerose attestazioni di alti prelati sulle sue spiccate «virtù cristiane». Anche Albert Anastasia, il capo in America della cosiddetta Anonima Assassini, era legatissimo al fratello sacerdote. Joe Profaci aveva un fratello prete e due sorelle suore. Frank Coppola aveva un nipote prete, il famigerato don Agostino Coppola (che sposò in latitanza Totò Riina e Ninetta Bagarella) che era addirittura membro effettivo di Cosa nostra. Gli episodi che raccontano poi della profonda religiosità dei mafiosi e dell’acquiescenza di uomini di Chiesa nei loro confronti sono sterminati. Di omelie a favore di mafiosi è ricca la storia della Chiesa meridionale. A S. Paolo Belsito, in Campania, un prete ha recentemente ricordato nella predica domenicale «i giovani che non hanno potuto riavere la libertà», tra cui il camorrista del posto Michele Russo. Lo stesso prete aveva stabilito che a portare sulle spalle un giglio (delle enormi macchine sceniche di cartapesta a forma di fallo), nella famosa festa che si celebra a Nola in onore di S. Paolino, sarebbe stato un altro camorrista, Vincenzo Giagnuolo («se uscirà dal carcere» aveva precisato in una intercettazione telefonica). Sta di fatto che la gran parte delle feste dei gigli che si svolgono in provincia e nella città di Napoli sono tutte dominate o fortemente influenzate da camorristi. Avviene a Barra, a Crispano, a Ponticelli. La cosa è così evidente da essere diventata oggetto di numerose inchieste della magistratura che spesso hanno evidenziato la compiacenza dei preti di quei quartieri e di quei comuni. La procura di Napoli, ad esempio, ritiene che da anni «dietro i comitati organizzatori della festa dei gigli a Barra ci sono boss di primo livello». Qualche anno fa durante la stessa festa comparvero questi manifestini: «Omaggio per la tradizionale festa dei gigli ai piccoli padrini Luigi e Gennaro Aprea», cioè i figli minorenni di Giovanni Aprea, il boss che anche dal carcere controllava il quartiere della periferia orientale della città partenopea. A settembre del 2011 il settimanale l’Espresso ha pubblicato un video sulla stessa festa di Barra in cui si vedono baciarsi in bocca il rappresentante del clan Cuccaro e del clan Adinolfi sotto la «paranza» e Antonio Cuccaro, padrino del giglio (colui che lo ha finanziato e realizzato) ha sfilato su un’auto di lusso, una Rolls Royce bianca, tra gli applausi del pubblico. Il parroco ha benedetto il giglio ed è stato chiesto un minuto di raccoglimento «per i morti nostri» (cioè per quelli ammazzati negli scontri tra i clan di camorra). L’anno prima dalla stessa «paranza» si era reso omaggio ad un altro boss, Arcangelo Abate, appartenente al clan degli «scissionisti» protagonista della lunga faida di Secondigliano. Nel settembre 2010 a Polsi, una frazione del comune di S. Luca in Aspromonte, durante la tradizionale festa in onore della Madonna, il boss Domenico Oppesidano è stato nominato «capo della Provincia», cioè capo della ‘ndrangheta. La cerimonia svoltasi all’aperto sotto un’effige della Madonna è stata ripresa dalle forze dell’ordine. Per i calabresi devoti la festa della Madonna di Polsi nella prima domenica di settembre è la ricorrenza religiosa più importante dell’anno. Gli ‘ndranghetisti non sono mai mancati all’appuntamento e da più di un secolo eleggono durante la festa il loro capo annuale. La prima notizia storica di un summit ‘ndranghetista a Polsi risale addirittura al 1895.Nel dicembre 2011, appena dopo l’arresto di Michele Zagaria, uno dei capi storici del clan dei Casalesi, il parroco di Casapesenna, don Luigi Menditto, ha definito il boss «un parrocchiano come gli altri al quale portare il Vangelo», facendo immaginare che fosse andato a trovarlo, e forse a confessarlo e comunicarlo, nel suo covo da latitante a 6 metri sotto terra nel suo paese natale. Un feroce assassino «parrocchiano come gli altri»? È in frasi come queste che si avverte la distanza abissale tra il sentire comune di un cittadino preoccupato dal pericolo mafioso e quello di un uomo di Chiesa. Benedetto Santopaola è stato per decenni il capo della famiglia mafiosa di Catania, ha studiato nell’istituto salesiano di San Gregorio, ha frequentato l’oratorio di Santa Maria delle Salette, sognava di fare il sacerdote e poi è diventato un assassino. Quando viene arrestato ha con sé una Bibbia, e prima di essere portato in carcere chiede di baciarla. Nel covo di latitante nelle campagne di Caltagirone aveva fatto costruire un piccolo altare dove si celebrava messa. A Castellammare di Stabia c’è stato l’episodio della processione in onore di S. Catello guidata dal vescovo e fermatasi davanti alla casa di un boss (come da tradizione) suscitando le giuste e sacrosante proteste del sindaco. In molti comuni della Calabria durante le festività di Pasqua si svolge la cosiddetta «affruntata». Vengono portate a spalla le statue di Cristo e della Madonna. Al momento dell’incontro, viene slacciato il nodo del manto nero della Madonna. Ma non tutti possono avere questo privilegio. Occorrono somme considerevoli e in molti posti questo privilegio è riservato solo agli ‘ndranghetisti. Negli anni scorsi a S. Giovanni a Teduccio la statua del santo è stata portata in spalle dagli uomini del clan Esposito-Gitano. Il santo aveva già subito l’onta di girare con la fascia nera al braccio perché due membri del clan erano stati uccisi nei giorni precedenti la processione. Ma il caso più clamoroso riguarda la festa di S. Agata a Catania. Secondo le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, entrambi affiliati al clan Santapaola, nel corso degli anni ’90 la criminalità organizzata catanese avrebbe controllato la gestione di diverse «candelore»1 e perfino soste e percorsi della statua della Santa in processione. Ecco quanto si legge nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuffrida: «Il cereo dei pizzicagnoli era gestito dalle famiglia dei Ceusi e Cappello, alle quali il mio gruppo riuscì a sottrarla con la forza nel 1994-1995. Anche gli altri cerei venivano gestiti da clan mafiosi. Quello dei pescivendoli era gestito dal clan Savasta. Il cereo dei macellai, invece, era gestito dai Cappello che gestivano anche il cereo dei fruttivendoli». Secondo l’altro collaboratore, Di Raimondo, il cereo del circolo Sant’Agata avrebbe fatto tappa nel quartiere di Monte Po per 7 anni per rendergli omaggio. «Decisi di fare arrivare la candelora nel quartiere sia per acquisire maggiore prestigio quale “mafioso” sia per senso di devozione verso la Santa. Il quartiere era perfettamente a conoscenza che la candelora era a Monte Po per una mia iniziativa. La “venuta” della candelora nel quartiere, comportò una spesa di circa 30-40 milioni di lire. Con tale somma vennero pagati i portatori, l’illuminazione del quartiere e i fuochi di artificio». La cifra venne stornata dai proventi di una bisca clandestina di zecchinetta. Continua Di Raimondo: «A celebrazione della venuta della candelora nel quartiere, feci realizzare uno stendardo con l’indicazione del nome della mia famiglia, con la dicitura “Di Raimondo 1992-1993”, che all’epoca costò tre milioni di lire. Lo stendardo venne appeso alla candelora del circolo di sant’Agata e vi rimase mentre io ero detenuto. Poi, nel 1998, non venne più appeso perché io ero diventato collaboratore di giustizia». Ben diversa la versione di Giuffrida: i motivi che portano alla gestione della festa sarebbero prettamente economici: «L’interesse a gestire un cereo è di natura esclusivamente economica. Ogni settimana venivano raccolte piccole offerte, da duemila a cinquemila lire, da ciascun esercente, raccogliendo a fine anno anche 200 milioni di lire. Una parte veniva utilizzata per pagare i portatori, ai quali veniva anche fornita gratis della cocaina detraendo il costo dalla somma complessiva. Altra parte della somma veniva destinata al pagamento del fuochista. Circa 150 milioni venivano versati in un fondo cassa del gruppo utilizzato per il pagamento degli stipendi o per acquistare cocaina o armi». Il ricovero dei latitanti nei conventi è poi una vecchia tradizione. Riferendosi al recente passato un magistrato ha ricordato che Carmine Alfieri, il boss di Piazzolla di Nola a capo della Nuova Famiglia contrapposta alla Nuova camorra organizzata di Cutolo, fu ospitato nella sua latitanza nel convento dei cappuccini di Nola. Stessa cosa avvenne con Salvatore Giuliano. L’arcivescovo di Monreale divenne uno dei riferimenti obbligati delle trame intessutesi tra mafia e banditismo (nella sua diocesi operava Salvatore Giuliano). Secondo Mario Ovazza, deputato per quattro volte all’assemblea regionale siciliana, egli sarebbe diventato, probabilmente con l’intermediazione del capomafia monrealese Miceli, il depositario dei personali risparmi del Giuliano (20 milioni, una grossa somma di denaro a quei tempi) che dopo la sua morte sarebbero andati a finire nelle tasche di qualche altro prelato a conoscenza della vicenda. Il giudice Cantone, nel suo libro Solo per giustizia, ha raccontato di una visita di un prete suo conoscente per raccomandargli benevolenza verso un imputato in un processo importante, quello contro i Casalesi. La motivazione era che si trattava del marito di una donna molto fervente, abituale frequentatrice della chiesa e della parrocchia. Il prete conosceva personalmente l’uomo e lo riteneva una brava persona, ma il brav’uomo era nientemeno che il cognato di uno dei capi dei Casalesi. Altri giudici hanno raccontato episodi analoghi. Nel 2003 nella chiesa di S. Maria delle Cinque Piaghe nei quartieri spagnoli venne rubata la statua di Gesù bambino, detto «Ninno d’oro». Del furto si occupò anche la malavita organizzata. Una suora ammise: «Ci hanno aiutato. Ricordo che ci è stato molto vicino un uomo che poi è stato ucciso. Ci disse che avrebbe fatto di tutto per trovare il piccolo Gesù. Noi abbiamo pregato per lui tutti i giorni». Nel gergo si chiama «cavallo di ritorno», contrario alla legge e al senso civico, ma per le suore era un atto di fede. Quando è stato catturato Provenzano, il suo rifugio era pieno di immagini e statuette sacre, e portava al collo alcune crocette, di cui una di legno. C’erano 91 santini (di cui 73 di Cristo), una Bibbia e un libro di preghiere con l’effige della Madonna e la scritta «pregate, pregate, pregate», una Sacra famiglia dentro una campana e un rosario nel bagno. C’erano inoltre, alle pareti, solo quadri religiosi (Ultima cena, la Madonna delle lacrime di Siracusa, una Maria regina dei cuori e delle famiglie, e un calendario con l’effige di Padre Pio). Dominava una maniacale attenzione per i simboli della religione cattolica. I pizzini ritrovati contengono frasi appartenenti ad una subcultura profondamente intessuta di religione, con frasi tratte dalla Bibbia e dai Vangeli. Tutti hanno una Bibbia e tutti pregano. In tasca hanno sempre un santino, in genere con l’immagine di Cristo o della Madonna. Sono religiosissimi e ostentano la loro devozione. E nelle carceri le loro celle sono piene di immagini sacre. Maranzano, il boss originario di Castellammare del Golfo, capo della mafia americana prima dell’avvento di Lucky Luciano, era anch’egli religiosissimo e consigliava a tutti di andare a messa la domenica. In un vertice di Cosa Nostra il locale era addobbato di tantissimi quadri di argomento religioso. Lucky Luciano diceva di lui che era «il più grande patito di croci al mondo». E i fratelli Cuntrera di Siculiana (Gaspare, Paolo e Pasquale), trasferitisi in Venezuela e considerati «i più grandi commercianti di eroina del bacino del Mediterraneo», ottengono di portare in una chiesetta di Montreal la statua del Cristo Nero che si venera nella chiesa di Siculiana. Il 3 maggio di ogni anno a loro spese veniva spedita la statua dal loro paese di origine in Canada. Di Giuseppe Genco Russo, capo della mafia dell’anteguerra, sappiamo che era sempre presente a messa e disponeva di una panca riservata nella chiesa madre di Mussomeli. Era anche «superiore» della confraternita del SS. Sacramento, per cui aveva il diritto di sfilare nelle processioni davanti al baldacchino. Ebbe per il suo passaggio alla Dc il sostegno del vescovo di Caltanissetta. Santo Sorge, una delle menti del traffico internazionale tra Sicilia e Usa, discendente da una famiglia che annoverava oltre a due prefetti anche un monsignore, ricevette una raccomandazione dalla curia di Palermo nei suoi rapporti con l’Irfis, Istituto regionale di finanziamento per l’industria in Sicilia. Si incaricò di ricostruire la chiesa del suo paese natale, Mussomeli. Tra il 1947 e il 1950 in quasi tutti i paesi della Sicilia occidentale sorsero comitati di beneficenza con il preciso compito di raccogliere somme tra gli immigrati per riparare campanili, sacrestie, cappelle di campagna, orfanatrofi tenute da suore. Don Cesare Manzella, ritornato dagli Stati Uniti nel 1947, prese a cuore l’orfanatrofio delle suore del sacro Cuore del Verbo Incarnato di Cinisi, con annessa chiesa. Jimmy Quaresano (pregiudicato, cognato di John Bonventre) venne più volte in Sicilia per portare le offerte per riparare la chiesetta della Madonna del Ponte. E a lui fu dedicata una lapide sulla facciata per ricordarne la generosità. Il boss Frank Coppola, detto tre dita, si dedicò alle orfanelle e alla chiesa di Partinico, e gli fu offerta per questa opera di beneficenza la tessera ad honorem della Fuci (federazione universitaria cattolica italiana). Salvatore Zizzo, boss del traffico degli stupefacenti, partecipava a tutte le processioni di Salemi, con il particolare di portare il fucile in spalla. Angelo Bottaro, boss di Siracusa, si presentava ai processi con il crocefisso in mano. Fu ammazzato mentre recitava il rosario. Devoto era Luciano Liggio, il boss di Corleone. In carcere legge Le confessioni di Sant’Agostino. E devoto era quel Filippo Marchese, uno dei più spietati killer di Cosa Nostra, che prima di strangolare qualcuno si faceva il segno della croce. In genere alcuni mafiosi pregano prima di un omicidio, e ringraziano Dio e i santi dopo averlo commesso. Cercano il consenso divino sulle loro malefatte e considerano un segno divino sfuggire ad un agguato. Gioacchino Pennino, medico e uomo d’onore, ha raccontato che suo zio, capomafia, aveva addirittura l’abitudine di andare a pregare sulle tombe di coloro che «avevano dovuto abbattere», e tutto ciò senza nessun rimorso. Un altro uomo d’onore della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, autore di decine di delitti, confidò al giudice Scarpinato che sin da ragazzo ogni sera, prima di addormentarsi, diceva le preghiere, e anche quando era diventato un killer la sera, rientrando a casa dopo un omicidio, pregava. È noto inoltre che un killer della mafia siciliana andava a confessarsi in una chiesa di Palermo prima di commettere un omicidio. Coloro che sapevano bene chi era, vedendolo al confessionale, il giorno dopo andavano a comprare il giornale per capire chi era stato ammazzato. Aveva inventato la ‘confessione preventiva’. Un ultimo episodio clamoroso riguarda la prima visita di Giovanni Paolo II a Palermo nel 1982. L’autista della macchina papale era Angelo Siino, il cosiddetto ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra. Com’è stato possibile affiancare al Papa un mafioso del calibro di Siino?
Cerimonie mafiose allusive alle pratiche religiose In tutte e quattro le organizzazioni criminali di tipo mafioso le cerimonie di iniziazione fanno riferimento alla religione. Per entrare nella mafia siciliana si riceve il «battesimo»: il candidato deve bruciare nelle palme aperte delle mani un’immagine sacra della Madonna (in genere la Madonna dell’Annunziata). Le parole pronunciate sono le seguenti: «Come carta ti brucio, come santa ti adoro, come brucia questa carta deve bruciare la mia carne se un giorno tradirò Cosa nostra». Lo stesso rito con parole diverse viene seguito nel giuramento degli ‘ndranghetisti. Nella strage del 15 agosto 2007 a Duisburg, in Germania, nella quale sono state assassinate sei persone appartenenti alla ‘ndrina dei Nirta e degli Strangio, una delle vittime, il diciottenne Tommaso Venturi, aveva nelle tasche una immaginetta bruciacchiata dell’arcangelo Michele. La sera della mattanza era stato affiliato alla ‘ndrangheta con il rito tradizionale, che prevede, come in Cosa nostra, di tenere nelle mani un’immagine sacra a cui viene dato fuoco. Cutolo, invece, dà vita ad un’altra ritualità, copiandola dai riti ottocenteschi della camorra: prima della cerimonia di iniziazione «battezza» il locale dove si svolge la riunione. Il camorrista, poi, giura «innanzi a Dio e ai compagni di essere fedele a tutte le leggi della società dell’umirtà e di sottostare a tutti gli ordini che mi vengono dai miei superiori». Nello statuto della «Guarduna», la confraternita esistente a Toledo in Spagna fin dal Quattrocento che molti studiosi ritengono essere il modello della camorra ottocentesca, si fa riferimento a numerose attività religiose da sostenere con i proventi dei crimini: dire messe, fare offerte alle anime del purgatorio. Qualcuno ha avvicinato le regole della camorra codificate nel 1842 nel cosiddetto «frieno» alle Constitutiones di S. Ignazio di Loyola. Si racconta che la prima riunione della «setta detta camorra» si sia svolta in una chiesa di Napoli nella prima metà dell’Ottocento. All’articolo 10 dello statuto è scritto: «I componenti delle paranze e delle chiorme, oltre Dio, i Santi e i loro capi, non conoscono altre autorità». Non a caso lo scrittore Luigi Compagnone ha definito ‘catechistico’ lo statuto della camorra. L’ingresso in una di queste organizzazioni comportava e comporta l’iniziazione, la sottomissione ad una gerarchia e l’osservanza di certe regole ritualistiche. Lo stesso giuramento mafioso e le regole a cui debbono sottostare gli adepti di Cosa nostra somigliano ai dieci comandamenti2. Anche nel nome delle organizzazioni ci sono riferimenti alla religione: Sacra corona unita è quello della criminalità pugliese, la ‘Ndrangheta è anche chiamata «la Santa» e «santisti» gli ‘ndranghetisti. Il termine di santista viene usato anche da Cutolo riprendendolo dalla camorra ottocentesca. E «mammasantissima» è il nome con cui si fa riferimento ai boss mafiosi e camorristi. «Cupola» è detto il vertice della mafia siciliana. «Il Papa» è in genere il capo della cupola, e «Padrino» si è nella mafia e in alcune cerimonie della Chiesa cattolica (battesimo e cresima). Nella storia meridionale ritornano spesso leggende in cui violenza e religione sono strettamente legate, anche se a fin di bene. Nell’immaginario della mafia, il ricorso a presunte origini religiose dell’organizzazione è abituale. Per Cosa nostra si fa riferimento alla leggenda dei Beati Paoli, una setta segreta di incappucciati operante tra il XVII e il XVIII secolo in Sicilia per riparare ai torti subiti dal popolo. La leggenda fu ripresa dallo scrittore Luigi Natoli in un romanzo d’appendice, uscito su Il Giornale di Sicilia tra il 1909 e il 1910, che ebbe uno straordinario successo. Gli antenati religiosi della camorra sono i membri della citata Guarduna. La compagnia della Guarduna viene descritta da Manuel de Cuendias, nel commento a un libro sui misteri dell’Inquisizione e sulle società segrete spagnole, come una specie di ordine militare monastico di grande potere nella vita politica spagnola, introdotta negli ambienti di corte e della Chiesa, con regole ferree legate all’obbedienza. Anche i membri di questa setta riparavano con la violenza a presunti torti subiti dalle classi popolari. Altri antenati religiosi dei camorristi sono «gli abati di mezza sottana» o «tabanelli», delinquenti che sotto una specie di abito da prete nascondevano numerose armi e imponevano «paci con violenza e matrimoni a forza». Le loro azioni consistevano, scrive Pietro Giannone, nel «percorrere di giorno, e più spesso di notte quanti vicoli c’erano, dal quartiere di San Lorenzo fino alla Vicaria, ora ricattando bottegai e artigiani, ora scassinando e depredando i fondaci de mercadanti di drappi e panni e ricorrendo all’incendio quando qualche porta opponesse resistenza troppo lunga, senza che la povera gente, spaurita, osasse protestare. Basti dire che si erano ridotti i mercadanti nelle loro strade a far da sentinella la notte per le finestre». Anche in altre criminalità di tipo mafioso nel mondo si fa ricorso abitualmente ad una nobilitazione religiosa delle origini o si copiano i riti di iniziazione dalla propria religione. Nella mitologia delle Triadi cinesi, per ribadire che non si tratta di una organizzazione criminale, si parla di una mitica nascita nel XVII secolo tra i monaci buddisti del monastero di Fuzhou in lotta contro la dinastia ‘straniera’ di origine Manciù dei Qing, che aveva spodestato la secolare dinastia dei Ming. Si racconta che per sconfiggere la resistenza di questi monaci, inventori del kung-fu, l’imperatore Ding mandò un esercito che distrusse completamente i nemici. I cinque sopravvissuti diedero origine alla Lega Hong, o banda rossa o triade, dal nome del triangolo scelto a simboleggiare i tre fondatori dell’universo, cioè terra, cielo, uomo. Anche nella cerimonia di iniziazione c’è un riferimento religioso. Il nuovo adepto deve prostrarsi di fronte agli Dei del cielo e della terra e deve pronunciare ben 36 giuramenti solenni. Anche nella Yakuza giapponese c’è un rituale di iniziazione che si rifà a pratiche religiose: l’adepto deve bere il sakè sacro. In Messico, infine, si è sviluppato enormemente il culto di Jesus Malverde, un bandito di strada venerato come un santo nello stato di Sinaloa. Viene anche definito «il bandito generoso», «l’angelo dei poveri» e ultimamente «il Santo dei Narcos», perché la sua specializzazione starebbe nella protezione delle persone che si dedicano alla produzione e al traffico della droga. Proprio per questa ‘qualità’ il suo culto si è esteso anche alla città colombiana di Calì, altro centro mondiale del traffico di stupefacenti. La sua santità e il suo culto non sono tuttavia riconosciuti dalla Chiesa cattolica.
Preti e frati mafiosi Del rapporto tra delinquenti e chiesa è ricca la storia meridionale e non solo. Pietro Ulloa, procuratore del re a Trapani, già nel 1838 parla di molti arcipreti aderenti a una «fratellanza» di tipo mafioso. Leopoldo Franchetti, nella sua inchiesta sulle Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, pubblicata nel 1876, parlava apertamente di preti mafiosi. Secondo lo storico Marino tra il 1870 e il 1882 almeno 30 preti erano a capo di cosche mafiose. Nel 1900 nel rapporto del Questore di Palermo, Ermanno Sangiorgi, si fa riferimento alla provenienza sociale di 206 mafiosi: 8 di questi erano preti. Nel 1912 don Ciro Vittozzi, un prete vicedirettore del cimitero di Napoli, viene condannato dal tribunale di Viterbo come aderente alla camorra. Così di lui scrive il giornale socialista dell’epoca La Propaganda: «l’arresto di questo malvivente chiercuto non ci ha destato alcuna meraviglia. Doppia qualità di prete e camorrista. Prendeva la tangente sulle compravendite». Il prete di Africo in Calabria, Don Giovanni Stilo, era amico di ‘ndranghetisti e mafiosi siciliani e fu al centro del celebre libro-denuncia di Corrado Stajano, uscito nel 1979 e intitolato appunto Africo. Celebre la sua scuola privata dove si distribuivano facilmente diplomi a persone provenienti da tutt’Italia. Anche il prete mafioso don Agostino Coppola vi si diplomò, e Luciano Liggio vi alloggiò durante la latitanza. In un altro libro, La terribile istoria dei frati di Mazzarino di Giorgio Frasca Polara, si parla di seguaci di S. Francesco condannati per rapporti con la mafia in un celebre processo che aveva scosso e diviso l’opinione pubblica italiana all’inizio degli anni ’60 del Novecento. Questo gruppo di frati cappuccini del convento di Mazzarino in Sicilia fu al centro di estorsioni, ricatti, minacce, ferimenti, omicidi. Non era certo la prima volta che succedevano fatti di sangue all’interno di un convento, ma era la prima volta che all’interno di un luogo religioso si organizzava una banda di estorsori in combutta con dei mafiosi. Della terribile vicenda di Monsignor Peruzzo ci parla Andrea Camilleri nel libro Le pecore e il pastore. Giovan Battista Peruzzo era vescovo di Agrigento quando nel 1945 fu ferito in un attentato di mafia da parte dei monaci del convento di Santo Stefano di Quisquina, un eremo a 2000 metri di altezza dov’era andato a pregare. Un proiettile lo centrò al torace, altri tre gli spaccarono l’avambraccio. Il vescovo rimase tra la vita e la morte per diversi giorni. L’attentatore era un frate dello stesso eremo, già precedentemente condannato a sei anni di confino dalla Questura di Agrigento. Vent’anni prima era stato assassinato il padre superiore del convento con sessanta coltellate. In Campania, prima di don Peppino Diana, è stato ammazzato nel 1985 un prete a Somma Vesuviana, insegnante nel liceo di Ottaviano. Si tratta di don Peppino Romano, legato a Raffaele Cutolo e alla sua devotissima sorella Rosetta. Il prete era stato arrestato nel 1983 perché con la sua auto portava in giro per l’Italia Rosetta Cutolo allora latitante.
Ma il titolo di prete mafioso per eccellenza spetta a don Agostino Coppola, parroco di Cinisi. colui che il 16 aprile 1974 nei giardini di Cinisi sposa Totò Riina (latitante) con Ninetta Bagarella. Insieme a lui c’erano altri due preti, don Mario e don Rosario. Don Coppola venne ‘combinato’ mafioso (entrò in Cosa nostra) a Ramacca nel 1969. È celebre l’esclamazione di Pippo Calderone rivolta al fratello Antonino: «Gesù Gesù, anche un parrino in Cosa Nostra». Don Agostino era legato a Luciano Liggio e nipote di un capo di Cosa nostra Frank Coppola. Amministrava i beni della diocesi di Monreale (la più chiacchierata di Sicilia) e faceva da mediatore nei sequestri di persona fatti dai Corleonesi (quello di Cassina, di Luigi Rossi di Montelera e dell’industriale Emilio Baroni). Fu arrestato nel 1974, e nella sua abitazione vennero trovati 5 milioni provenienti dal riscatto di un sequestro di persona. Il colonnello Russo, ucciso poi dalla mafia, era convinto che don Agostino avesse nascosto Luciano Liggio latitante a Piano Zucco, zona in gran parte controllata dal prete e dai suoi fratelli Giacomo e Domenico. Tra il 1971 e il 1973, periodo di permanenza di Liggio latitante nel palermitano, padre Agostino Coppola acquistò beni per 49 miliardi di lire.
Sulla dissociazione o sulla privatizzazione della salvezza All’interno del nesso tra mafie e Chiesa, il rapporto tra il concetto di pentimento (così come si è consolidato nel senso comune meridionale influenzato dalla cultura cattolica) e la figura del collaboratore di giustizia registra uno dei punti più critici e complessi. Non è scopo di questo saggio affrontare il tema e il ruolo dei pentiti nello smantellare organizzazioni criminali che si fondano sul vincolo della segretezza. Il giudizio degli esperti, a partire dai magistrati impegnati in prima linea nel contrasto, è unanime al riguardo: senza l’apporto dei pentiti e senza le norme che ne hanno favorito la collaborazione con lo Stato, la lotta alle mafie sarebbe ancora in alto mare. Su questo aspetto la Chiesa italiana non è stata di grande aiuto. In fondo, qual è il comportamento ideale di un mafioso? Convertirsi e pentirsi davanti a Dio senza che ciò abbia conseguenze per altri, senza dover accusare nessun altro. Ciò si chiama in gergo giudiziario «dissociazione», mentre in termini religiosi «conversione» o «ravvedimento». In questo caso si resta uomini d’onore e ci si mette in pace con Dio. È la posizione di Cutolo, di Aglieri, di Guttadauro, di Riina, di Provenzano. Dice Cutolo in proposito: «Se avessi fatto come Giuda accusando e calunniando le persone, già sarei nella vita libera. Si deve essere pentiti, ma nel proprio animo e pagando le proprie colpe con umiltà». E ancora: «Un vero uomo deve affrontare le colpe del suo passato con dignità e coraggio. La conversione deve essere dentro al proprio animo e si deve soffrire anche per le tante colpe commesse da altri sulla mia pelle e sul mio animo. Il pentimento deve essere soltanto con Dio: giudice di tutti i giudici. Se non avessi creduto sempre e immensamente in Dio già sarei morto. Gesù in croce è la vera cattedra di vita». Questa posizione di Cutolo è simile a quella di molti capimafia. E qual è la posizione di molti preti? Essa è molto simile a quella di Cutolo e dei capimafia: il pentimento davanti a Dio è più importante del pentimento davanti alla legge; e spesso i pentiti di legge sono considerati degli «infami» perché rovinano altre famiglie. Se un collaboratore di giustizia ha reso tantissimi contributi alla lotta alla mafia, permettendo di scoprire numerosi delitti impuniti, consentendo di arrestare e neutralizzare decine di assassini, evitando altri lutti e sofferenze, ma non si è contemporaneamente riconciliato con Dio, non si è pentito davanti a lui e alla sua Chiesa, allora la sua collaborazione con la giustizia non vale niente, anzi il suo può essere considerato addirittura un comportamento anticristiano. Se, invece, colui che ha commesso un crimine si è pentito e riconciliato con Dio, ma non ha rivelato nessun segreto, non ha permesso alla giustizia di fermare altri assassinii e di evitare altri lutti e dolori, non ha ricompensato le vittime dei suoi delitti, non ha restituito i capitali illecitamente accumulati, allora egli è la pecorella smarrita che torna all’ovile o il figliol prodigo che torna alla casa paterna e per il quale si ammazza l’agnello più grasso. In questo modo di pensare e agire della Chiesa c’è il più stridente contrasto tra buon cristiano e pessimo cittadino. E purtroppo su questa posizione convergono non solo preti discutibili come don Frittitta, di cui parleremo in seguito, ma anche figure della Chiesa che sicuramente un impegno antimafia l’hanno dimostrato, come Monsignor Nogaro. Quest’ultimo, all’epoca vescovo di Caserta, scrive una prefazione a un libro su Cutolo in cui annuncia la conversione a Dio del boss di Ottaviano e chiede per lui comprensione da parte della giustizia italiana. Il punto non è se Cutolo si sia o no veramente pentito dei suoi delitti davanti a Dio, ma che non lo ha fatto davanti alla legge, e soprattutto che non ha fatto niente perché altri delitti fossero scoperti, altri lutti evitati, altri feroci assassini consegnati alla giustizia. Così come non è accettabile considerare quelli che non si pentono davanti alla giustizia e non collaborano con essa come degli esseri moralmente criticabili, non può essere al contrario considerato dalla Chiesa moralmente superiore solo chi si pente davanti a Dio e decide di non collaborare con la giustizia. C’è qualcosa di strano nel fatto che molti preti hanno grande considerazione per i dissociati e mostrano un aperto disprezzo per i collaboratori di giustizia. Va ricordato che durante il periodo del terrorismo in Italia la Chiesa non assunse la stessa posizione sui dissociati, nel senso che non disse con nessuno dei suoi uomini che accusare altri terroristi per avere i benefici di legge fosse una posizione anticristiana. Invitò anzi al pentimento anche davanti alla legge. Forte fu l’impegno della Chiesa al fianco dei terroristi in carcere nel loro percorso di redenzione e di collaborazione con la giustizia. Invece diversa è stata la posizione nei confronti dei mafiosi collaboratori di giustizia. Mafiosi e terroristi sono, certo con motivazioni diverse, tutti assassini. Anche i terroristi pentiti hanno accusato altri e permesso allo Stato di scardinare le loro organizzazioni; non vuol dire forse che anch’essi si sono comportati da cristiani?
Pentimento senza riparazione Nella dottrina cattolica, la violazione di alcuni comandamenti che hanno a che fare con la violenza sugli uomini e sulle cose (non rubare, non ammazzare) non rende necessario riparare con atti concreti l’ingiustizia commessa e il dolore procurato, così da annullare o attenuare (laddove possibile) gli effetti negativi dei propri misfatti. L’ingiustizia compiuta e il danno arrecato non implicano obblighi nei confronti delle vittime. È solo l’autorità religiosa che ha il potere di liberarci dal peso degli errori commessi. Lo strumento di questa traslazione di colpa è il sacramento della confessione e il sacerdote ne è il tramite. La colpa, dunque, non è mai verso gli altri, verso la società, la collettività, lo Stato e le sue leggi, ma è innanzitutto colpa verso Dio, peccato contro il Signore. La confessione serve a ripristinare il rapporto di fiducia con Dio che il peccato aveva compromesso. Dev’essere riparato il peccato verso il Signore, non verso le persone oggetto del torto. Colui che ha subito le conseguenze del peccato resta un estraneo, un non partecipe al rito della confessione e dell’espiazione. Così concepita la confessione si trasforma in una deresponsabilizzazione etica che salta in blocco la dimensione pubblica e sociale del peccatore. Alla Chiesa è sufficiente il pentimento interiore, non quello rivolto all’oggetto del proprio atto peccaminoso o verso la collettività offesa. Insomma tutto si regge sul principio che bisogna riparare nei confronti della Chiesa (rappresentante in terra di Dio) ma non nei confronti della vittima. Questa si chiama «etica dell’intenzione», e si basa su questo assunto: se tu, peccatore, modifichi la tua interiorità che ti ha portato al peccato mediante il pentimento, ciò è sufficiente a farti rientrare tra coloro che possono riavere l’amore di Dio. Il tragitto che si interpone nel mondo cattolico tra pentimento e perdono, tra colpa ed espiazione, è il più breve rispetto a qualsiasi altra religione. Sembra che la dottrina cattolica consideri più appagante il recupero di ogni singolo peccatore piuttosto che mettere in moto la reciprocità tra offeso e offensore. In questa ottica si considera secondario il giudizio terreno sulle colpe commesse e il sottoporsi all’autorità dello Stato. Non si fa nessuna distinzione tra peccati con conseguenze sociali e peccati senza conseguenze per gli altri. La Chiesa ha lasciato intendere con il suo messaggio che c’è un Dio con il quale si può negoziare in via privata la salvezza della propria anima senza dover passare per il recupero del danno arrecato socialmente e collettivamente sopportato. Un teologo l’ha definita «privatizzazione della salvezza». È a questa concezione che si rifanno i mafiosi, a questa idea del rapporto con Dio che si rapportano. Perciò, la dissociazione nella concezione dei mafiosi è quanto di più vicino ci sia alla teologia del perdono.
La vicenda di Padre Frittitta C’è stata una vicenda emblematica dell’ambiguità del rapporto tra concezione del pentimento cattolico e collaborazione con la giustizia. Nel 1997 viene arrestato padre Frittitta, dopo la cattura del boss di Cosa nostra Aglieri. Non solo padre Frittitta è colui che ha celebrato la messa nel covo del capomafia, non solo lo ha confessato e comunicato mentre era latitante, ma ha anche dissuaso Aglieri dalla collaborazione con i magistrati. La sua posizione è «pentirsi e accusare altri non è da cristiani». «Pietro pensaci, riflettici prima di fare questo passo» è il consiglio che il frate dà al boss in una telefonata intercettata. L’incarico al frate di dissuadere il boss dal collaborare con la giustizia gli era stato affidato dai luogotenenti di Aglieri preoccupati di una sua possibile crisi mistica. Il frate viene poi scarcerato, e nel provvedimento di scarcerazione il suo comportamento viene pesantemente criticato: «L’insegnamento di Cristo è inconciliabile coi fatti di mafia», scrivono i magistrati. Dopo la scarcerazione il frate è acclamato da tutto il quartiere, si affaccia al balcone della chiesa e saluta la folla numerosissima, e poi dall’altare dice: «Gesù è morto fra due ladroni, tutti noi siamo fratelli e ci dobbiamo amare. Nessuno deve essere escluso da questo amore». Significativa a tal proposito l’intervista al padre provinciale dei carmelitani, padre Agostino Cappelletti, dopo l’arresto del suo confratello Frittitta: «Loro debbono arrestarli, noi dobbiamo convertirli. È stato il Papa ad invocare ad Agrigento “mafiosi convertitevi”. E tutti, anche i magistrati, ci chiedono “convertiteli”. Così noi ci incamminiamo per arrivare alla conversione, ma è un processo faticoso e lungo che può approdare alla confessione soltanto dopo incontri, consigli, contatti spirituali. Al procuratore Caselli [all’epoca capo della procura di Palermo] vorrei dire una cosa soprattutto: con la nostra antimafia avrete pentiti veri non falsi. Questo non significa criticare la sua antimafia, ma alla Chiesa bisogna lasciare la possibilità di praticare un metodo diverso. Loro li debbono arrestare, noi li dobbiamo convertire. Abbiamo meditato tutti insieme, da fratelli, per capire se il metodo antimafia assunto dalla magistratura sia cristianamente accettabile. E abbiamo concluso che cristianamente non è accettabile perché la chiesa non deve perseguire i reati per i reati, non deve estorcere confessioni per raccogliere favori, diminuzione di pena o altro. Deve annunciare Gesù Cristo e sentirsi libera di farlo anche esponendosi a persecuzioni, ma senza lasciarsi condizionare. Tutto ciò per tendere alla conversione dei peccatori. Quindi, primi fra tutti i mafiosi. La condanna della mafia rimane. Come la condanna del mafioso, ma non il rifiuto del mafioso. La chiesa non può, finché c’è richiesta di luce. Si sa, all’interno della Chiesa c’è una frangia molto legata alla politica, che mette in secondo ordine il valore evangelico della conversione. E la conversione ha esigenze diverse dal pentitismo. Per dichiararmi pentito, basta che io mi presenti, accusi qualcun altro e ottenga vantaggi, come gli sconti di pena, magari qualche villetta, mi dicono, protezione, soldi. Ecco la conversione è tutt’altra cosa. È una scelta piena ed interiore. A questa pensiamo noi, che siamo sacerdoti, non magistrati». Meglio di così non si poteva riassumere un certo tipo di atteggiamento verso la mafia e i mafiosi. Traspare l’ostilità verso la magistratura, verso i pentiti di legge, e soprattutto i preti che vogliono recuperare a Dio i mafiosi si sentono, loro sì, dei martiri perseguitati dalla legge. Quando dei religiosi arrivano a sostenere che è un’infamia accusare altri, anche se questi altri hanno commesso spietati delitti che hanno privato numerosissime famiglie della vita di loro cari, allora ci si deve interrogare su dove sia il confine tra cultura mafiosa e cultura religiosa, perché queste che sembrano posizioni assurde sono assolutamente conciliabili con la dottrina cattolica. Ma c’è un’altra chiesa che non la pensa allo stesso modo. Padre Fasullo intervistato da Luigi Offeddu così si esprime: «No, le conversioni dei boss spettano a Dio e nessuno può insultare i magistrati. A Palermo due chiese dai comportamenti diversi. Quello di padre Puglisi che considerava insanabile la frattura tra mafia e il Vangelo, e coloro che vanno a colloquiare con i mafiosi, sospinti dal desiderio di ritrovare ad ogni costo la pecorella smarrita». In un’inchiesta pubblicata nel 2008, in appendice al libro di Alessandra Dino La mafia devota si può facilmente notare che sull’argomento il clero siciliano è diviso. Un questionario distribuito tra i sacerdoti di Palermo svela che sono ancora troppi i parroci indulgenti verso i boss mafiosi, in molti non avvertono Cosa Nostra come un pericolo vicino. Il 15% del campione ha piena consapevolezza della gravità del problema mafioso. Il 20% ne ha una conoscenza stereotipata, talvolta esprimendo critiche dirette soprattutto nei confronti della magistratura (in particolare sui pentiti), il 65% mostra ancora un’ambiguità nell’affrontare il tema mafia e la presenza mafiosa non viene vissuta come una questione di diretta competenza della Chiesa. Durissimo è il giudizio espresso sui collaboratori di giustizia da gran parte degli intervistati. Ed è significativo il parere di un sacerdote in materia: «Da un punto di vista umano i pentiti sono gente senza rispetto, sono esseri a Dio spiacenti, fanno ribrezzo. Il pentito vero è quello che si pente e rimane in carcere a scontare la pena. La legge, invece, premia il delatore, il collaboratore». Sembra di sentir parlare Raffaele Cutolo. La risposta alla domanda sul perché degli assassini possano aver goduto continuativamente di una rapporto privilegiato con gli uomini di Chiesa, con le funzioni, i sacramenti e la dottrina, non va cercata solo nella vigliaccheria o nell’apatia dei preti siciliani e meridionali (dei don Abbondio moderni), né nella cautela della Chiesa di fronte a tematiche che riguardano la precipua responsabilità delle classi dirigenti, né tanto meno solo nella scelta dell’anticomunismo che nella storia recente ha caratterizzato il suo atteggiamento al punto di coprire qualsiasi altra ignominia pur di non favorire l’odiato pericolo comunista (il cardinale di Palermo Ruffini – 1947/1967 – ne è stato un campione fino a negare la presenza stessa della mafia). La mafia era inserita a pieno titolo nel fronte anticomunista, di cui la Chiesa era un avamposto, e dunque non era un nemico. La risposta va invece cercata nella lunga sedimentazione degli insegnamenti della Chiesa sul costume, sulla mentalità, sul senso civico, sui valori privati e pubblici della società meridionale. La Chiesa non ha fatto da ostacolo alla mafia e ai mafiosi sia perché essa è stata parte fondamentale delle classi dirigenti meridionali, e ne ha condiviso tutti i limiti e le compromissioni in quanto coinvolta pienamente nella proprietà e nel controllo della terra (questione al centro, come è noto, dell’evoluzione della mafia siciliana), sia perché la sua teologia morale (severissimi con il peccato, indulgenti con il peccatore; combattere l’errore, cercare l’errante) ha permesso a degli assassini di sentirsi quasi dei privilegiati, essendo le pecorelle da recuperare e non avendo l’obbligo di legare la propria confessione dei delitti ad una espiazione sociale, pubblica, riparatrice dei danni provocati al singolo e alla società. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, va indagato come la lunga avversione alla formazione dello Stato nazionale si sia tradotta nell’Italia meridionale in una concezione privatistica della Chiesa e dei suoi precetti senza interrelazione con lo Stato e con la società, al punto da ritenere che una volta risolti i propri problemi di coscienza con Dio, con il sacerdote e con la Chiesa, non ci fosse nessun altro obbligo da soddisfare per potersi ritenere, anche se assassino, a pieno titolo membro della comunità religiosa. Per tutto il periodo post-unitario la Chiesa ha avuto un atteggiamento di pratico disinteresse per il buon funzionamento dello Stato italiano, per la moralità della politica, l’osservanza delle leggi, la formazione di un diffuso senso civico. In questo quadro di avversione e di contrapposizione allo Stato unitario la Chiesa ha ritenuto il problema della mafia non come un suo problema. Inoltre, una serie di circostanze (la permanenza dei preti siciliani e meridionali nel paese di origine; l’abitare non nella canonica ma a casa dei propri familiari, non estranei dunque all’ascesa sociale della propria famiglia che veniva prima degli interessi della Chiesa; la garanzia di una vita agiata legata al possesso delle terre di proprietà della Chiesa; un maggior peso dato all’esteriorità rituale in virtù di una particolare presa della ‘religiosità barocca’) hanno fatto sì che il prete siciliano e meridionale fosse parte organica di quella borghesia che ha avuto un ruolo non secondario nel successo delle mafie. Nella religiosità cattolica del Meridione, l’estraneità ai doveri e agli obblighi verso lo Stato e la società ha fatto della confessione e del recupero del peccatore qualcosa di assolutamente originale, al punto, in alcuni casi, di identificare nel mafioso il cattolico perfetto. A tal proposito è illuminante questo giudizio espresso da Padre Ribaudo: «Mi augurerei che tanti dei miei parrocchiani avessero quella passione per Dio e per le cose di Dio e per il Vangelo che hanno tanti mafiosi». La mafia, dunque, è un caso di insuccesso della Chiesa, almeno quanto lo è dello Stato e delle classi dirigenti siciliane e meridionali. La Chiesa non ha usato nessuna delle armi a sua disposizione (scomunica, interdizione dai sacramenti, predicazione, etc.) per emarginare i mafiosi, per prenderne le distanze, per separarli dalla comunità dei credenti. La teologia morale cattolica si è dimostrata impotente o addirittura convergente con gli interessi di assassini mafiosi quando al suo centro c’è il recupero del peccatore senza che ci sia nessun obbligo verso la società di espiare i propri peccati. Dice il pentito Leonardo Messina: «quando ero un assassino andavo in chiesa con animo tranquillo, oggi che sono un pentito no, non prego serenamente». Queste parole esprimono uno dei più grandi paradossi della società meridionale e siciliana, poiché i mafiosi sono dei criminali che si sono sentiti sempre in pace con Dio Com’è stato possibile, com’è potuto accadere che tanti uomini di Chiesa non abbiano avvertito la stridente contraddizione dell’essere mafiosi con le esigenze morali del Vangelo? Com’è stato possibile convivere pacificamente, intendersi e addirittura collaborare con questi uomini? La contrapposizione tra degli assassini e il Vangelo, tra mafia e cristianesimo, è assoluta, assai più netta che tra cristianesimo e marxismo, tra cristianesimo e più moderni costumi sessuali e sentimentali. Eppure solo queste ultime incompatibilità sono state sempre denunciate arrivando anche alla scomunica.
Una questione meridionale nella Chiesa? Si può parlare di una diversità della chiesa meridionale rispetto alla chiesa centro-settentrionale? Esiste, cioè, una questione meridionale all’interno della chiesa italiana? E se sì, quali ne sono i termini È indubbio che la chiesa meridionale ha risentito dei caratteri che nell’insieme ha preso la società meridionale nel corso di una lunga trasformazione storica. Al punto che anche all’interno di un divenire condiviso della chiesa italiana, gerarchicamente centralistica e dal punto di vista della dottrina fortemente unitaria, si sono manifestate delle specificità frutto dell’intreccio tra i caratteri assunti dalle trasformazioni della società e dell’economia meridionali e il quadro unitario e nazionale entro cui si è mossa la dottrina e la pratica cattolica. Insomma, la forte gerarchizzazione e la impostazione necessariamente unitaria di una Chiesa addirittura universale (e, dunque, neanche solo nazionale) non ha impedito la sua meridionalizzazione, un’aderenza cioè ad alcuni tratti della specifica evoluzione del contesto in cui operava. E al tempo stesso, oltre che essere marcata indissolubilmente dal contesto storico-economico-sociale in cui operava, la Chiesa meridionale ha a sua volta influenzato decisamente i caratteri della trasformazione dell’ambiente, della società, dei valori, delle abitudini dei meridionali. Una dottrina e una prassi ‘universale’ che si sono plasmate sul contesto circostante e che a sua volta lo hanno condizionato e modificato. Quindi parlare di Chiesa meridionale, non solo in un’accezione geografica, non è una forzatura, e va ricercata una «questione meridionale» all’interno della Chiesa cattolica italiana. Non ci sono stati papi meridionali negli ultimi secoli (dal ‘500 in poi solo Paolo IV, Innocenzo XII, e Benedetto XIII), mentre la Chiesa settentrionale, in particolare quella del lombardo-veneto, sembra aver avuto un primato dottrinale che si è manifestato nel contributo massiccio di eletti al soglio di Pietro, e un numero foltissimo di vescovi catapultati nel Sud d’Italia in particolare dopo l’unificazione. Segno anche questo di una diversità profonda? E di che tipo? Nel Nord la contrapposizione frontale all’Italia unita e alla perdita del potere temporale si accompagnava ad una fortissima presenza dei cattolici e delle strutture della Chiesa nel formarsi economico-sociale della nazione. Ad una estraneità politica si contrapponeva un’attiva partecipazione al forgiarsi dei caratteri della nazione sia nelle sue attività industriali (Torino e Don Bosco) sia nel tessuto di solidarietà sociale che accompagnava la lenta trasformazione da società rurale ad agricola-industriale. Nasce l’oratorio, che affianca alla ‘passività’ delle funzioni e della preghiera un attivismo sociale sorprendente, nascono le casse mutue e le prime banche cooperative in competizione con l’analogo attivismo socialista. Non c’è niente di simile nel Sud. Gli oratori si consolidano solo nel secondo dopoguerra e le iniziative cooperative e sociali sono quasi inesistenti, se si esclude ciò che farà in Sicilia Luigi Sturzo. Anche i fermenti del ’68 hanno un impatto diverso tra Nord e Sud, non maturano le figure dei preti-operai né tanto meno l’esperienza delle comunità di base e del dissenso cattolico Nel Sud le Confraternite prevalgono sulle organizzazioni più attive nel campo sociale e la stessa Azione Cattolica stenta a radicarsi. Il culto dei santi prevale sull’insegnamento del catechismo. Anche i fermenti preconciliari e postconciliari hanno un andamento diverso nel Nord e nel Sud d’Italia. Don Zeno e don Milani non hanno analoghe figure per personalità e impegno nella Chiesa meridionale, che si identifica totalmente in Padre Pio, il quale è stato nel bene e nel male il contributo più significativo del Sud alla chiesa nazionale e universale. Si può descrivere questa differenza come un contrasto tra misticismo e attivismo, tra una religiosità passiva e religiosità dinamica, tra una Chiesa che scende nella società e un’altra che si preoccupa solo delle forme e dei riti? Qual è stato l’impatto della riforma tridentina con l’Italia meridionale e in particolare con quel territorio poi dominato dai Borbone? Da sempre, più che altrove, la Chiesa meridionale è stata esposta ad una curvatura superstiziosa. L’impressione è che la controriforma trovi nel Regno di Napoli un suo terreno ideale, diventi un elemento costitutivo di una certa meridionalità che si afferma poi nel tempo. Religiosità barocca e Sud d’Italia via via si identificano. In questo quadro va affrontato il particolare culto dei santi, che, forse più di altre caratteristiche della controriforma, assumerà nel tempo i caratteri di una particolare congenialità con la religiosità meridionale. Il concilio di Trento e il dominio spagnolo diventano due elementi inscindibili per capire la religiosità di quel periodo. Il culto dei santi è precedente la controriforma, ma con essa assume nel Sud un carattere distintivo e identitario che non ha precedenti. Alla fine del Medioevo il Sud non ha un così radicato culto dei santi né un numero così impressionante di persone che vengono beatificate. Pochi erano stati eletti santi nel periodo medievale (Celestino V, S. Tommaso d’Aquino) e pochi lo saranno nell’età moderna (non più di dieci). Invece, tra il 1540 e il 1750 l’Italia meridionale è per numero di santi la prima regione dell’occidente cattolico. Un fatto eccezionale, poiché nel Medioevo la santità aveva investito l’Italia comunale e la Francia del sud, e pochi erano i santi nati in quell’epoca nel Regno di Napoli. I santi sono per lo più aristocratici, possidenti, mercanti, liberi professionisti. Anche la santità non è accessibile agli strati più poveri della popolazione, salvo qualche rara eccezione. E i miracolati dai santi sono per la maggior parte aristocratici o possidenti. Dunque, l’accesso alla santità è possibile solo a determinati strati sociali: la santità diventa classista. L’identificazione totale della Chiesa e della santità con le classi dominanti è fattore non secondario nel tempo nel plasmare i caratteri della religiosità meridionale. Il popolo si riconosce nel santo non perché lo trova simile al suo modo di vivere, ma al contrario proprio perché più lontano. Più è nobile il santo, più può proteggere; nella santità si trasferisce lo stesso modello di protezione che il popolo intravede nei nobili. Così la santità meridionale assume le caratteristiche di intermediazione e di protezione tipiche del rapporto tra ceti popolari e ceti nobiliari. Il santo è l’unica forma interclassista di accesso a una protezione. La Chiesa si modella sui vertici della società e sulle classi dominanti, e i suoi santi ne sono l’espressione. Il popolo non può aspirare a somigliare ai santi, non è in grado di mettere in atto i loro insegnamenti, non li vuole né può copiarli, imitarli, ma solo servirsene, usarli per i propri bisogni (protezione dalle malattie, dalla cattiva sorte, dalla morte e dalla fame). Dunque, la santità meridionale non stimola l’imitazione, l’esempio; il modello di santità (rinuncia ai piaceri della carne, alla vanità, meditazione perpetua, ore e ore di preghiere, fustigazione del corpo) è possibile solo a ceti che già hanno e che possono disporre del tempo dell’ozio e trasformarlo in preghiera. La santità non spinge ad azioni virtuose, impossibili ai ceti popolari, ma si condensa in una ritualità in grado di attivare la protezione. I santi non insegnano a fare del bene ai poveri, ad essere altruisti, generosi, ma ad essere devoti, umili e obbedienti. E la Chiesa incoraggia il culto delle reliquie, che darà vita ad una vera e propria caccia alle carni e alle vesti dei santi. Se nella religione luterana riformata il fedele accede al sacro attraverso le Scritture e il relativo commento, per i cattolici sarà il culto delle reliquie, spesso congiunto a quello dell’immagine sacra, che farà partecipi della materialità del sacro i fedeli che il clero tiene lontano dalle Scritture. È questa la santità barocca meridionale. E l’anoressia, il digiuno, sono tra le forme più caratteristiche del suo manifestarsi; un modello non imitabile da chi invece tentava di fuggire dalla fame. È questa attenzione ai riti e ai culti, più che alla sostanza dell’essere cristiano, che ha permesso a tanti (compresi i mafiosi) di ritenersi dei buoni cattolici limitandosi a parteciparvi. La religiosità dei mafiosi dimostra fino alle estreme conseguenze il carattere formale che ha assunto la fede cattolica in Italia e soprattutto nel mezzogiorno; svela l’uso di essa come fattore di legittimazione sociale più che come espressione di una sofferta interiorità. Una fede che serve a posizionarsi verso la società e gli altri piuttosto che ad obbligare a vivere in accordo con i suoi precetti. La religiosità dei mafiosi conferma il fatto che anche l’uso della violenza come strategia di vita e di ascesa sociale può essere coperto tranquillamente dalla fede cattolica.
Alfonso e la confessione Cosa c’entra S. Alfonso de’ Liguori con questa storia? S. Alfonso è il più grande innovatore della Confessione in epoca moderna e ha influenzato come nessun altro il rapporto confessore-penitente, segnando profondamente la concezione e la pratica di questo Sacramento, e dunque la storia stessa della Chiesa universale e di quella meridionale. Egli diede una particolare interpretazione della pietà e della morale cristiana, recependo in chiave cattolica il «secolo dei lumi» e le sue suggestioni. La sua più documentata biografia si intitola appunto Il santo del secolo dei lumi. Sulla sua grandezza intellettuale e umana non ci sono giudizi differenti tra cattolici e non; egli ha avuto ammiratori anche nel mondo protestante e tra intellettuali atei o anticattolici; alcuni lo hanno considerato assieme a Gianbattista Vico come la figura intellettuale più forte del Settecento italiano; altri, addirittura, lo considerano con Voltaire una delle vette del Settecento europeo. Più complessa la valutazione sul piano prettamente dottrinale, teologico, pastorale: si va dalla esaltazione (un gigante, appunto) alla riprovazione, soprattutto tra i contemporanei suoi avversari. Per Harnack, teologo protestante, egli rappresenta per il cattolicesimo moderno ciò che fu S. Agostino per l’antico. Fu il vero contrappeso a Lutero, la sua concezione della morale rappresenta per alcuni la vera risposta identitaria del cattolico rispetto al protestante, o meglio colui che più di altri «ha fatto rifluire la marea del rigorismo» all’interno del cattolicesimo. Se i gesuiti con il loro lassismo, probabilismo e casistica morale rappresentano il compromesso cattolico con la propria coscienza, S. Alfonso rappresenta invece l’anima latina benigna e tollerante per i limiti e le debolezze umane contrapposta al puritanesimo arcigno e intransigente dell’area centro-europea, cattolica e protestante, da Pascal a Giansenio fino a Lutero e Calvino. Egli ha cercato una via di mezzo tra lassismo e rigorismo morale, e perciò fu considerato un rivoluzionario della morale, cercando un rapporto nuovo tra legge, norma e libertà e una dottrina più confortevole con i penitenti. Fu colui che trasformò peccati ritenuti mortali e non assolvibili in peccati veniali, si trattasse dello spergiuro, o della bestemmia, dell’adulterio o dell’omicidio. In questo senso va l’espressione riferita alla sua opera e alla sua persona: «il più santo dei napoletani, il più napoletano dei santi». Poiché per ‘napoletano’ si intende ‘meridionale’, è importante capire il suo ruolo e la sua funzione nell’ambito del sentire religioso meridionale che interessa la nostra ricerca: in che modo la sua concezione della Confessione ha condizionato il cosiddetto «perdonismo» cattolico? «Severi e duri con il peccato, tolleranti e comprensivi con il peccatore»: sono tipiche espressioni alfonsiane, fatte proprie da ogni uomo di Chiesa. Sembra che tutte le giustificazioni e le motivazioni di un atteggiamento permissivo e lassista del sacramento della Confessione facciano riferimento al suo insegnamento. Ma è proprio così? S. Alfonso sarebbe l’ideologo o il moralista di riferimento di un padre Frittitta e di tutti coloro che ne hanno condiviso il comportamento nei confronti del boss mafioso Pietro Aglieri? È in nome della dottrina ‘benigna’ del santo napoletano che Frittitta si è recato nel covo di un latitante, confessandolo e comunicandolo periodicamente? È applicando la sua morale che un cardinale assolve Michael Corleone da tutti i suoi peccati senza altra contropartita, come Coppola ci fa vedere ne Il padrino Torniamo a S. Alfonso missionario. In genere per missione si suole intendere un’attività religiosa di conquista al Vangelo e di diffusione del credo cattolico tra popolazioni che ‘non conoscono il vero Dio’, cioè un’attività rivolta all’esterno di territori già cristianizzati, ad esempio verso le popolazioni indigene dopo la scoperta dell’America, o quelle asiatiche a seguito dell’apertura delle rotte commerciali, o verso l’Africa in epoca più recente. Ma nel Settecento, a Napoli soprattutto, si pose il problema delle condizioni ‘sotto-cristiane’ di molta parte del popolino della città e delle masse rurali che vivevano al di fuori dell’area urbana e al di là di Eboli. Questa ‘riscoperta’ della popolazione extraurbana (dal punto di vista delle condizioni religiose) andava di pari passo con una maggiore sensibilità che l’intellettualità della capitale cominciava a manifestare, nel secolo riformatore, verso le condizioni economico-sociali dei «regnicoli», cioè di coloro che non abitavano e non venivano a trafficare a Napoli. Il Galanti era andato in giro a descrivere i tratti economici, geografici e civili di un regno che si basava su di «una testa enorme» (Napoli, la capitale) e su un corpo gracilissimo (il resto del territorio). S. Alfonso seguì questa tendenza alla scoperta del non napoletano, del non conosciuto, dell’inedito, del mai-visto, dell’ignorato, cioè dell’uomo delle campagne e delle aree interne. Diventerà presto l’apostolo delle campagne abbandonate proprio perché prima non c’era stata nessuna figura religiosa di valore che evangelizzasse (o ri-evangelizzasse) villaggi e casolari della sterminata campagna a pochi chilometri da Napoli e di quella al di là del Sele e del Cilento. Non faccia meraviglia che un uomo del Settecento napoletano ignorasse completamente le condizioni di vita di chi non viveva in città; anche oggi la classe dirigente di Napoli conosce pochissimo (e le interessa pochissimo) tutto ciò che non rientra nel perimetro urbano. Ma per S. Alfonso «andare alle pecore perdute» non voleva dire preoccuparsi dei peccatori prima di ogni altro essere umano, ma interessarsi innanzitutto dell’attività e della vita religiosa di coloro che erano abbandonati alla povertà per condizioni economiche, per sfruttamento feudale, per incuria: appunto le popolazioni rurali del regno delle Due Sicilie. Fu, a suo modo, una scelta di classe, non nel senso economico-politico che a questo termine viene attribuito, ma religioso-sociale. La stessa scelta che un secolo prima aveva fatto in Francia S. Vincenzo Ferreri. S. Alfonso scopre un altro mondo al di là di Napoli e oltre Eboli. Le mura della città sono un confine sociale prima che geografico. Come due secoli dopo Carlo Levi scoprirà un mondo totalmente diverso dalla città e dalla civiltà urbana nelle montagne lucane, così al de’ Liguori si svelerà su cosa era basata la «grandezza» della capitale: «Le terre migliori sono coperte dalle paludi… anche le città sono spopolate eccetto Napoli, la cui grandezza funesta è il frutto della miseria di un Regno intero». E la stessa cosa, fatte le dovute proporzioni, poteva essere detta di Palermo. «Dio è amore, e i santi vanno anche nell’inferno» esclamava Alfonso. E l’inferno era rappresentato dalle campagne e dalle montagne del regno S. Alfonso, trovandosi nell’impossibilità tipica della sua cultura di appartenenza di offrire alle masse rurali gli strumenti dell’emancipazione e dell’affrancamento economico e sociale, si avvicina con comprensione cristiana alla loro miseria umana e religiosa. E svolge da questo punto di vista un’azione di egualitarismo religioso, nel senso che mette le parole e gli uomini di Dio a disposizione anche di popolazioni che ne erano prima completamente e sprovviste. L’obiettivo della predicazione non è solo quello di confortare e consolare, non è quello di offrire una giustificazione alla propria condizione sociale, quanto piuttosto di ripristinare «pari condizioni» di salvezza anche a coloro che per lontananza da Napoli, per ignoranza e apatia del clero locale, non avrebbero potuto altrimenti incontrare la parola di Cristo e il suo messaggio salvifico. Nella città l’opportunità di incontrare la parola di Dio era più garantita, perciò S. Alfonso si fa missionario extraurbano. È a questa intenzionalità alfonsiana che si deve legare strettamente la sua concezione morale, i suoi insegnamenti teologici, la sua particolare concezione della Confessione. Egli scrive la Theologia moralise la Pratica dei confessoritenendo conto non solo della Bibbia, degli insegnamenti del Muratori e del Genovesi, ma anche delle condizioni materiali dei contadini del suo tempo. Non vuole mutare i rapporti sociali e feudali nelle campagne, vuole solo che le particolari condizioni dei contadini siano tenute nel giusto conto dal confessore. Mettere a confronto Alfonso de’ Liguori con Voltaire è utile per capire il Settecento antireligioso e quello cattolico; metterlo a confronto con Lutero e Calvino è necessario per intendere compiutamente la matura risposta cattolica all’essenza spirituale del protestantesimo; confrontarlo con il gesuitismo o con Pascal e Giansenio è importante per comprendere la differenza tra lassismo, rigorismo morale e concezione benigna e ottimistica dell’uomo peccatore. S. Alfonso, amico ed estimatore di Vico, regge la sfida intellettuale e spirituale con questi grandi della storia del pensiero e della religione. Ma senza questo suo «voler andare verso le campagne», senza questa scelta antiurbana e nei fatti antiaristocratica e antiborghese, noi non capiremmo appieno la sua concezione morale, che è poi diventata nei secoli successivi la morale tout court della Chiesa cattolica universale. Non dimentichiamo che ancora nel Settecento esistevano disposizioni vescovili che invitavano a una maggiore comprensione dei peccati di alcune classi sociali, l’aristocrazia e l’alta borghesia, mentre si raccomandava maggiore severità verso i peccati del popolo; anzi i peccatori per antonomasia erano individuati tra coloro che per ceto e ignoranza non riuscivano a tenersi lontani dal peccato. S. Alfonso, dunque, rompe con la morale precedente contrapponendosi sia (all’esterno) alla concezione luterana e calvinista, sia (all’interno) a quella gesuitica e giansenistica (la prima identificabile nel lassismo e permissivismo, la seconda nel rigorismo), ma lo fa tenendo ben presente l’obiettivo della sua missione: la cura e la guida, l’avvicinamento alla Chiesa (ai suoi precetti e al suo messaggio) di popolazioni rimaste estranee o ai margini della cristianità. La morale alfonsiana è comprensibile solo in questa dimensione, in questo particolare contesto storico in cui un napoletano (il più santo dei napoletani) si accorge della dimensione morale, oltre che sociale, delle campagne interne. Di quella realtà dove neanche l’utilizzo e l’accesso ai sacramenti era paritario. Il contadino non si confessava con serenità e con frequenza; anzi in alcune zone delle montagne non si confessava affatto. In una piccola comunità in cui tutti si conoscevano, il solo avvicinarsi al confessionale era segno di ‘peccato’ e di riconoscibilità del proprio stato di peccatore. E il peccato era bollato dai preti del posto come una condizione infernale già su questa terra. Nella durissima vita dei campi e della montagna la virtù cristiana, per come veniva predicata precedentemente, era un miraggio, un tendere verso qualcosa di impossibile, non alla portata di persone alle prese con la sopravvivenza quotidiana, che imponeva di non rispettare tutte le norme feudali per potersi almeno sfamare. I preti avevano come unico modo di far vivere la presenza divina quella del castigo, terribile per come veniva rappresentato ed evocato. E tra i peccati «ingiustificabili» c’erano quelli contro la proprietà e i privilegi feudali. Le fiamme dell’inferno non erano altro che il prolungamento di una vita terrena d’inferno. Come poteva essere attraente un messaggio cristiano così formulato? Come abbiamo già detto, le popolazioni meridionali delle campagne si aggrappavano solo alla loro concezione della santità come difesa dalla natura, dalle malattie e dalla cattiva sorte. Nella loro concezione religiosa si rispecchiava fedelmente l’isolamento e l’atomismo semifeudale dei grossi borghi, dispersi per i latifondi del Mezzogiorno. Al santo il contadino non risparmiava gli onori e neanche gli insulti e le imprecazioni, quando falliva nel suo compito di protezione. Si facevano amico Dio attraverso il santo, per farsi amica la natura e il destino. È questa condizione che comprese profondamente S. Alfonso, il quale perciò elabora una teologia morale che consenta loro di avvicinarsi ai sacramenti senza paura di essere marchiati e senza timori delle fiamme dell’inferno. Li affranca dalla severità dei peccati, non potendo (e non essendo neanche lontanamente nel suo orizzonte culturale) affrancarli dal dominio feudale. Il compito principale del sacerdote non era più di allontanare i ‘rozzi’ dal confessionale spaventandoli con il pericolo del peccato mortale, ma di esaminare quale cognizione avessero del peccato stesso. «Iddio condanna solo chi pecca formalmente per malizia, o per ignoranza colpevole, ma non già chi opera con buona fede, e certezza morale del suo operare», scriveva S. Alfonso. Il santo napoletano umanizza il confessionale. Sposta la tolleranza del secolo dei lumi dalle classi alte e borghesi alle classi rurali, sposta la tolleranza dalle convinzioni politiche a quelle religiose, dalla libertà personale alla salvezza individuale, dalla società al confessionale. Anche i rozzi contadini possono salvarsi, mentre prima di lui questa ‘opportunità’ del messaggio evangelico sembrava restringersi solo alle classi dominanti o a quelle urbanizzate delle grandi città. Un Voltaire cattolico delle campagne. S. Alfonso invitava ad andare incontro ai contadini, gli abbandonati dell’epoca, non certo ai mafiosi. Ma bisogna prendere atto che l’attitudine al perdono facile, l’assoluzione automatica per qualsivoglia peccato, la comprensione per le ragioni dei peccatori, trovano in lui, al di là delle intenzioni, un punto di riferimento che influenzerà tutta la Chiesa cattolica. Il facile perdono, infatti, unito al bassissimo senso dello Stato e delle sue leggi, ha prodotto nel Sud uno spaventoso cortocircuito, di cui è anche espressione la particolare religiosità dei mafiosi e l’accondiscendenza verso di essi.
La mancata scomunica 1989 alla vigilia della assemblea annuale della Cei, l’organismo di governo dei vescovi italiani, il cardinale di Napoli, Michele Giordano, annuncia in conferenza stampa che i vescovi stavano per decidere la scomunica di tutti coloro che fossero stati definiti mafiosi o camorristi da una sentenza di tribunale. Il messaggio era chiaro: Giordano aveva parlato di «sanzioni canoniche» da adottare nei confronti dei mafiosi, vietando loro sia i sacramenti che la partecipazione in qualità di padrini a cerimonie quali battesimi o cresime. Ma il cardinale Poletti nel discorso di chiusura della stessa assemblea corregge la posizione di Giordano: non ci sarà nessuna scomunica dei mafiosi in quanto questa sanzione è già prevista dal codice di diritto canonico. Che cosa era successo nel corso della discussione tra i vescovi italiani da causare una così clamorosa e pubblica marcia indietro da parte del segretario della Cei? Possibile che il cardinale Giordano si esponesse a una così magra figura prospettando decisioni in materia di mafie che già erano vigenti? Un principe della Chiesa, e per giunta di una delle città più coinvolte dalla criminalità di tipo mafioso, non ne era a conoscenza? È indubbio che nel corso dell’assemblea ci fu un duro scontro tra diversi settori dell’episcopato italiano. Ma come siano andate effettivamente le cose, quale sia stato il motivo precipuo del contendere, resta un mistero, uno dei tanti della storia della Chiesa. Poletti dal palco parla in tono pacato, ma poi torna sulla questione con una certa perentorietà, fastidio e imbarazzo: «La scomunica della mafia non era all’ordine del giorno e non è stata trattata dall’assemblea della Cei. La questione è stata posta solo da alcuni vescovi del gruppo di studio sul Meridione. Ma tutto è finito lì. Non è prevista e non è prevedibile nessuna sanzione di questo tipo». Il cardinale Poletti esclude anche che il documento sul Meridione, che si stava elaborando proprio in quel periodo, potesse contenere qualche accenno alla condanna della mafia (infatti il documento che uscirà nell’autunno del 1989, una delle più significative analisi sui problemi del Sud scritte dalla Chiesa, non conterrà riferimenti alla questione della scomunica). Il segretario della Cei insiste: «La Chiesa nella sua legislazione generale, che è contenuta nel codice di diritto canonico, già prevede sanzioni che valgono per tutti gli stati di violenza. Quindi basta attenersi a queste. La condanna della violenza da parte della Chiesa è sempre chiara e inequivocabile. Ma non è compito della Chiesa varare provvedimenti particolari, anche perché le stesse autorità civili e giudiziarie sono perplesse quando devono individuare i responsabili di atti criminosi». Intanto, come si fa a sostenere che la questione della scomunica non era all’ordine del giorno se uno dei cardinali più importanti e rappresentativi della Chiesa italiana, quello di Napoli, ne aveva parlato in conferenza stampa prima dell’apertura dell’assemblea? E ammesso anche che formalmente la scomunica dei mafiosi non fosse all’ordine del giorno, era sicuramente in quel periodo, dopo infiniti silenzi, una problematica molto avvertita e discussa all’interno e all’esterno della Chiesa cattolica. Erano gli anni successivi all’omicidio di Piersanti Mattarella, di Pio La Torre, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Rocco Chinnici in Sicilia, delle guerre tra Nuova Camorra Organizzata di Cutolo e Nuova Famiglia di Alfieri in Campania, dei numerosissimi delitti di ‘ndrangheta dopo l’eliminazione del potente capoclan Paolo De Stefano, e dell’affacciarsi sulla scena criminale nazionale della Sacra corona unita. Nel 1989 le mafie erano una delle principali questioni della società italiana e una spina nel fianco della stessa comunità cattolica. «L’aspetto interessante di questa vicenda non era tanto nel ritardo con cui si era pensato a una misura così radicale, quanto nel fatto che essa fosse seriamente presa in considerazione». Ma la scomunica non ci fu allora, non c’era stata prima, non ci sarà dopo. Cos’è la scomunica? Il termine scomunica appare per la prima volta in documenti ecclesiastici nel IV secolo. Nell’ambito del diritto canonico essa rappresenta la più grave delle pene che possa essere comminata a un battezzato: con quella decisione lo si esclude dalla comunione dei fedeli e lo si priva di tutti i diritti e i benefici derivanti dall’appartenenza alla Chiesa, in particolare quello di amministrare e ricevere i sacramenti. Oggi le scomuniche si definiscono latae sententiae se scaturiscono da un comportamento delittuoso in quanto tale, e non è necessario che vengano esplicitamente comminate da un ente ecclesiastico: chi compie un certo atto si trova ad essere scomunicato automaticamente. Si definiscono invece ferendae sententiae se non sono automatiche, ma devono essere inflitte da un organismo ecclesiale. Prima della nascita degli stati di diritto, la scomunica aveva gravi effetti sullo scomunicato: nella pratica era una morte civile, lo scomunicato cioè perdeva qualsiasi diritto ed era alla mercé di chiunque avesse interesse a perseguirlo. Era dunque un’arma potentissima nelle mani della Chiesa. Diverse scomuniche hanno segnato il corso della storia, e non solo di quella religiosa. Negli ultimi decenni sono stati scomunicati i divorziati, chi pratica l’aborto o lo favorisce, coloro che usano la pillola RU486 o spingono ad usarla, coloro che interrompono la vita con mezzi artificiali. È difficile, comunque, districarsi tra scomunica latae sententiae (automatica) e quella per la quale deve pronunciarsi direttamente il Vaticano. È del tutto evidente che quando una questione è centrale per la Chiesa, che ne vuole fare avvertire l’importanza per tutti i suoi membri, su di essa (e sulla relativa scomunica) si pronunciano direttamente il Vaticano e i suoi organi. Sui mafiosi non è stato finora così. Nonostante ripetute prese di posizione in documenti vari, nonostante il discorso coraggioso di Giovanni Paolo II ad Agrigento nel 1993, gli affiliati alla mafia e alle sue consorelle non sono stati oggetto di scomunica da parte della Santa Sede e dei suoi organi. Non è un fatto sorprendente? Si potrebbe ritenere che la Chiesa non consideri più la scomunica un’arma adatta a far valere la sua autorità morale e dottrinale, dopo averla usata in tal senso per secoli e secoli. In un mondo contemporaneo profondamente cambiato potrebbe aver ritenuto anacronistico uno strumento appartenente al suo passato e, in ogni caso, non più efficace. Ma non è così, poiché l’arma della scomunica è stata usata fino ai nostri giorni. Dunque, la Chiesa non ha usato finora la scomunica contro le mafie sicuramente non per convinzione di scarsa efficacia dello strumento. D’altra parte la Chiesa sa che la scomunica non è tanto importante per il singolo che la riceve ma per il messaggio rivolto alla società. Se è vero che in altre epoche lo scomunicato veniva posto fuori dal consorzio sociale, in epoca contemporanea la scomunica è stata usata anche come ‘avvertimento’, in un senso cioè politico-sociale, oltre che religioso-dottrinale. È sicuramente questo il caso della scomunica ai comunisti per incidere sul comportamento politico in maniera preventiva e dissuasiva. Nel caso delle mafie il messaggio culturale e sociale della scomunica sarebbe stato ancora più decisivo e isolante, basandosi il potere di queste organizzazioni proprio sulle relazioni con l’insieme della società e con le istituzioni preposte a combatterle. La scomunica avrebbe intaccato quel prestigio sociale, religioso e istituzionale di cui vanno alla ricerca e di cui ampiamente usufruiscono i mafiosi. La Chiesa è troppo consapevole dell’impatto sociale e civile delle sue sentenze e decisioni per non aver preso in considerazione l’arma della scomunica anche contro le mafie, ma alla fine l’ha scartata. Perché Una risposta a questo interrogativo non è semplice. Le mafie, intanto, non sono nemici ideologici della Chiesa, nel senso che non propugnano l’ateismo e dunque non hanno finalità di sottrarre seguaci alla fede cattolica, come nel caso dei comunisti. Non propugnano posizioni eretiche, non si prefiggono scismi, rispettano l’obbedienza alle gerarchie ecclesiastiche, non praticano una diversa e antitetica morale sessuale: dunque non rientrano nei casi fino ai giorni nostri oggetto degli anatemi e dei fulmini della Chiesa. I mafiosi sono ‘semplicemente’ assassini, cioè violano il sesto comandamento, ma la Chiesa nel corso della sua lunghissima storia ha avuto ‘normalmente’ a che fare con gli assassini e si è regolata senza ricorrere alla scomunica. Inoltre per più di un secolo non li ha mai neanche considerati assassini, ritenendo la ‘mafiosità’ un comportamento della sicilianità e di alcuni codici culturali tipicamente meridionali e non una forma delinquenziale. L’omicida è uno che toglie la vita ad un altro, e dunque viola un comandamento, come si possono violarne altri. Ma la scomunica non è uno strumento per i trasgressori dei 10 comandamenti. Non nel senso che trasgredirli non sia grave, o che l’omicidio non sia un peccato mortale (infatti non ti salvi se muori senza pentirtene), ma nel senso che esso è una delle più tipiche debolezze umane da Caino in poi: la Chiesa ha cercato di porvi freno, qualche volta lo ha ‘nobilitato’ se, ad esempio, finalizzato a sottrarre i luoghi santi dalle mani degli infedeli, più spesso ha provato a rendere con i suoi mezzi l’uomo meno lupo per altri uomini. Quindi l’assassinio non è mai stato un problema da affrontare con la scomunica, ma con i mezzi ordinari con cui nei secoli si è tentato di arginare la violenza dell’uomo sull’uomo. E poi l’omicidio è un ‘errore’ che rientra nel circuito colpa-pentimento-perdono sul quale si fonda l’essenza stessa della religione cattolica. Insomma il delitto di sangue non è considerato ‘eccezionale’ comportamento dell’uomo peccatore, non nel senso che non sia grave, ma solo nel senso che per affrontarlo non c’è bisogno di misure eccezionali. Certo il peccatore è considerato e valutato secondo l’entità della sua colpa, ma qualunque colpa abbia commesso è oggetto possibile del perdono divino tramite la Chiesa. Torniamo alle parole di Poletti: «Non è compito della Chiesa varare provvedimenti particolari». Cioè: per contrastare le mafie non c’è necessità di misure eccezionali. Qui il riferimento non è tanto alla giurisprudenza o alle azioni di contrasto ‘militare’ dello Stato, quanto allo stretto campo di competenza della Chiesa: contro le mafie la Chiesa non deve mettere in atto azioni ‘particolari’ come ad esempio la scomunica. Quindi Poletti considera la scomunica un’arma particolare, pensa che non sia ancora necessaria e con queste affermazioni riconosce nei fatti che la scomunica non c’è ancora verso i mafiosi, smentendo le sue stesse parole («già esiste»). D’altra parte se la scomunica fosse stata già applicabile ipso facto ad ogni assassino, perché si è consentito a un capo della banda della Magliana, Enrico De Pedis detto Renatino, autore di efferati omicidi, di essere seppellito tra papi e cardinali nella chiesa di Sant’Apolinare a Roma? È in questo clima altalenante di impegno e di cautela che va inscritta la storia della mancata scomunica alle mafie da parte del Vaticano, che ha riflettuto sicuramente le posizioni oscillanti all’interno delle Chiese meridionali e in particolare di quella siciliana. Imbarazzo che si è manifestato nella ricordata dichiarazione di Poletti e prosegue ogni volta si chiede a qualche esponente delle gerarchie ecclesiastiche il perché della decisione di non scomunicare le mafie. La risposta è sempre uguale: lo abbiamo già fatto. Ma anche chi risponde così sa di non dire la verità, come abbiamo dimostrato in questo capitolo. E allora, perché questo atteggiamento? Sicuramente ha influito sulle gerarchie vaticane e sulle prelature meridionali anche la paura, il timore di una reazione violenta dei mafiosi. Erano bastate alcune omelie, alcune prese di posizione più coraggiose della Chiesa per esporla a una prima ritorsione, con i delitti di due preti nel giro di pochi mesi. Anche gli attentati a due chiese di Roma, quella di San Giorgio al Velabro e di San Giovanni in Laterano, venivano lette come risposta alla posizione del Papa ad Agrigento. In un ambiente abituato alla cautela e alla convivenza con forme criminali, la paura di azioni più clamorose avrà pure pesato. Un secondo elemento di cui tenere conto sta proprio nelle affermazioni di Poletti: «le stesse autorità civili e giudiziarie sono perplesse quando debbono valutare i responsabili di atti criminosi». Cosa voleva dire l’allora segretario della Cei? Certo è difficile individuare un mafioso quando non è condannato per questo reato, dunque una scomunica generale verso di essi potrebbe imbarazzare un prete nell’applicarla: la comunione si deve dare o no ad uno che tutti sanno essere mafioso ma non ha avuto condanne? Si deve consentire che facciano da padrini di battesimo? Un gesuita siciliano così aveva risposto a un giornalista: «Perché chiedere al prete di sostituirsi al magistrato e al carabiniere? Il mafioso che si presenta in chiesa con il figlioccio tra le braccia, quante assoluzioni avrà già collezionato, per insufficienza di prove per non aver commesso i fatti imputatigli? E lei vorrebbe che un povero parroco si atteggiasse a super-giudice, scacciasse quell’uomo che la legge ha assolto?». Il cardinale Giordano, per la verità, aveva proposto la scomunica per quelli già condannati, superando intelligentemente il problema. Dunque non era questa la difficoltà. Essendo la mafia e le consorelle organizzazioni di massa, attorno a cui oltre agli aderenti orbita tutto un mondo di professionisti, di politici, di settori estesi delle classi popolari e dei colletti bianchi, la scomunica avrebbe potuto avere effetti non calcolabili nel rapporto della Chiesa con questi stessi strati sociali. Quando si scomunica un comunista, lo si individua facilmente perché egli non si nasconde; stessa cosa per un medico abortista o un divorziato. Nel caso di un mafioso, come comportarsi? Ci si può trovare nella condizione di privare dei sacramenti persone con le quali si vive a stretto contatto, o assidui frequentatori delle funzioni, cattolici ferventi. Si può, insomma, scomunicare una parte del proprio mondo? La Chiesa ha avuto enormi difficoltà a riconoscere il reato di associazione di tipo mafioso, perché esso non individua la colpa in un atto specifico ma nell’atteggiamento e nella forza derivante dal vincolo associativo, cioè rompe il rapporto individuale tra colpa e castigo, e rende potenziali mafiosi un numero esteso di persone non strettamente criminali. Insomma, se per le altre scomuniche comminate si trattava di persone o di mondi sociali e culturali già in qualche modo distaccatisi dalla Chiesa per ragioni politiche, scientifiche o altro, nel caso dell’eventuale scomunica alle mafie si andava a colpire un vasto mondo di credenti. Troppo per la Chiesa
In conclusione, alla domanda relativa al perché non c’è stata la scomunica, la risposta non è univoca. Forse l’elemento di maggior freno sta nella concezione cattolica della recuperabilità del peccatore: mai lasciare niente di intentato alla possibilità del recupero. Ci sono state persone e problematiche contro le quali la Chiesa ha eretto l’irriducibile inconciliabilità della dottrina cattolica, anche a costo di perdere definitivamente un’anima a Dio: i mafiosi e le mafie non fanno parte di questa categoria. In fondo, se si sentono a loro modo cattolici, vuol dire che non sono del tutto persi al messaggio cristiano. Questo in sintesi il ragionamento della Chiesa. La scomunica del Vaticano avrebbe chiuso tutte le porte, e qualcuna andava lasciata aperta. In un periodo decisivo della lotta alle mafie, all’inizio degli anni ottanta, e poi dopo l’uccisione di Falcone e Borsellino, quando lo Stato italiano sembrava nelle condizioni di venire a capo di una questione plurisecolare grazie anche al risveglio di una parte della società meridionale prima sorda e silenziosa, la Chiesa non ha voluto offrire e mettere a disposizione di questa battaglia di civiltà la sua arma più potente: la scomunica vaticana. Ha ancora una volta scelto di ribadire l’immodificabilità della sua struttura teologica e dottrinale di fronte a un problema centrale per la civiltà del Mezzogiorno. Perché il peccato di mafia interroga pesantemente la teologia morale cattolica, ne mostra tutta l’inadeguatezza di fronte ai problemi della convivenza civile, e ne mette in discussione alcuni dei suoi più sicuri e incontrovertibili postulati. Nella convinzione della ricerca della salvezza per tutti, alla fine ha salvato se stessa. La Confindustria in Sicilia ha deciso di espellere tutti gli imprenditori aderenti che in qualche modo hanno avuto rapporti con i mafiosi, anche sotto forma di pagamento del pizzo. Un fatto la cui portata si inscrive tra quegli atti che sono in grado di modificare la storia civile e sociale di un territorio, proprio perché viene da un mondo che ha sempre legittimato e collaborato con i mafiosi. La Chiesa non ha voluto finora fare altrettanto. Non di sola lotta alle mafie può vivere la Chiesa, né può uniformare la sua dottrina e identità solo su questa questione, è ovvio; ma ci sono momenti storici nei quali una comunità civile, di cui la Chiesa è parte, si pone obiettivi prioritari per la sua stessa sopravvivenza e li può raggiungere solo se le agenzie formative del senso comune e della mentalità assolvono pienamente alla loro funzione. La Chiesa non lo ha fatto ancora, e non è stata completamente all’altezza della sua funzione.
Letteratura e preti Concludiamo con questa domanda: perché in quasi tutta la letteratura meridionale non c’è una figura positiva di prete? Nel resto della letteratura italiana ci sono dei Fra’ Cristoforo accanto ai Don Abbondio, mentre nel sud solo Don Abbondio o anche preti mafiosi. Da Masuccio Salernitano al Basile, da Mastriani alla Serao, da Sciascia a Camilleri non c’è una figura di prete che possa eguagliare quelle presenti in alcuni autori centro-settentrionali, dal Manzoni al Fogazzaro (padre Giuseppe Flores), da Marino Moretti a Goffredo Parise. Anche in Camilleri l’uomo di Chiesa è il «parrino», ignorante, gaudente e mafioso, e in De Roberto, Pirandello e Tomasi di Lampedusa il ruolo della Chiesa nelle vicende storiche pre e post-unitarie è segnato dalla compromissione con le classi dirigenti gattopardesche. Nella letteratura francese possiamo pensare a Bernanos e alle figure spirituali del ‘Parroco di campagna’ e dell’Abate Donissan. È come se la letteratura rispecchiasse pienamente la diversa funzione che nelle rispettive società hanno svolto i preti e la chiesa: una religiosità ‘passiva’ nel sud fatta di fustigazioni, preghiere e rinunce, di esteriorità, di apparenze, rispetto ad una religiosità ‘attiva’ in cui la salvezza è dettata anche da ciò che si fa nel mondo e non solo in chiesa, nella propria cella o nella propria stanza. In questo quadro assume un ruolo centrale Leonardo Sciascia. Il tema dei preti è fondamentale nei suoi romanzi, al pari della mafia. La presenza di tanti religiosi e l’assenza di una religione civile sono le ossessioni di Sciascia. Due personaggi di prete prevalgono nella sue opere: il prete ignorante, spesso gaudente e privo di scrupoli, e quello colto, raffinato ma cinico, indifferente ai valori civici. Si può dire che in quasi nessun romanzo sia assente un prete o un uomo di chiesa. Perché tanti preti protagonisti nell’opera di un autore laico? Non ci sono in Italia scrittori cattolici che hanno reso così tanti preti corrotti protagonisti dei loro libri. E perché tanti preti modelli di falsificazione, di ignoranza, di turpitudine, di ambiguità? È il pregiudizio antireligioso che domina le sue ossessioni? È la religione modello di tutte le imposture, come una certa critica gli ha attribuito? Bella la frase di Sciascia a proposito del credere o non credere: «Si è credenti o atei sempre in maniera imperfetta». Certo, c’è anche qualche figura positiva di uomo di Chiesa, quale Monsignor Ficarra nel libro Dalle parti degli infedeli, ma per la maggior parte si tratta di cattivi preti che spesso ammazzano e vengono ammazzati (naturalmente nella finzione letteraria). Inquietante la figura di don Gaetano in Todo Modo che si lascia andare alla seguente affermazione: «Cos’è la Chiesa senza il male?». Ma se si prende per buono ciò che scrive uno dei suoi migliori interpreti, Gaspare Giudice, cioè la «tentazione cattolica» di Sciascia, allora il discorso cambia radicalmente: lo scrittore ha nostalgia e voglia di una Chiesa diversa, e la sua letteratura è come se gridasse: «Cosa sarebbe la Sicilia e l’Italia con una Chiesa non implicata con le classi dirigenti e con la mafia?». Egli segnala con la sua opera il ruolo centrale nella cultura e nella società siciliana della Chiesa («È da loro e tramite loro che traggono origine molti dei mali che ci affliggono») e al tempo stesso, nel descriverne le aberrazioni, avverte il bisogno di un’altra Chiesa. KAINOS 15.1.2013
I preti e i boss di ROBERTO SAVIANO. 22 marzo 2014
Le parole pronunciate dal Papa sono parole definitive. Tuonano forti non a San Pietro dove saranno risultate naturali, persino ovvie. Tuonano epocali a Locri, Casal di Principe, Natile di Careri, San Luca, Secondigliano, Gela.
E in quelle terre dove l’azione mafiosa si è sempre accompagnata ad atteggiamenti religiosi ostentati in pubblico. Chi non conosce i rapporti tra cosche e Chiesa potrà credere che sia evidente la contraddizione tra la parola di Cristo e il potere mafioso. Non è così. Per i capi delle organizzazioni criminali il loro comportamento è cristiano e cristiana è l’azione degli affiliati. In nome di Cristo e della Madonna si svolge la loro vita e la Santa Romana Chiesa è il riferimento dell’organizzazione.
Per quanto assurdo possa apparire il boss – come mi è capitato di scrivere già diverse volte – considera la propria azione paragonabile al calvario di Cristo, perché assume sulla propria coscienza il dolore e la colpa del peccato per il benessere degli uomini su cui comanda. Il “bene” è ottenuto quando le decisioni del boss sono a vantaggio di tutti gli affiliati del territorio su cui comanda. Il potere è espressione di un ordine provvidenziale: anche uccidere diventa un atto giusto e necessario, che Dio perdonerà, se la vittima metteva a rischio la tranquillità, la pace, la sicurezza della “famiglia”.
C’è tutta una ritualità distorta di provenienza religiosa che regola la cultura delle cosche. L’affiliazione alla ‘ndrangheta avviene attraverso la “santina”, l’effigie di un santo su carta, con una preghiera. San Michele Arcangelo è il santo che protegge le ‘ndrine: sulla sua figura si fa colare il sangue dell’affiliato nel rito dell’iniziazione. Padre Pio è il santo la cui icona è in ogni cella di camorrista, in ogni casa di camorrista, in ogni portafoglio di affiliato. Nicola, ex appartenente al clan Cesarano ha raccontato: “Mi sono salvato una volta, quando ero giovane, perché un proiettile è stato deviato. I medici mi hanno detto che è stata una costola a evitare che il colpo fosse mortale. Ma io non ci credo. Quello che mi ha sparato mi ha sparato al cuore, non è stata la costola, è stata la Madonna”. La Madonna, oggetto di preghiere: è a lei che ci si rivolge per sovrintendere gli omicidi. In quanto donna e madre di Cristo sopporta il dolore del sangue e perdona. Rosetta Cutolo veniva trovata in chiesa nelle ore delle mattanze ordinate da don Raffaele: pregava la Madonna di intercedere presso Cristo per far comprendere che la condanna a morte e la violenza era necessaria. A Pignataro Maggiore esiste “la madonna della camorra” che il defunto boss Raffaele Lubrano ucciso in un agguato nel 2002, fece restaurare a sue spese, nella sala Moscati attigua alla chiesa madre.
Anche Giovanni Paolo II aveva pronunciato – il 9 maggio del 1993 ad Agrigento – un attacco durissimo alla mafia: “convertitevi una volta verrà il giudizio di Dio”. Due mesi dopo i corleonesi misero una bomba a San Giovanni in Laterano. Ma Francesco I non parla solo a chi spara: ha abbracciato i parenti delle vittime della mafia, ha abbracciato don Luigi Ciotti, un sacerdote che non era mai stato accolto da un pontefice in Vaticano e con Libera è diventato l’emblema di una chiesa di strada, che si impegna contro il potere criminale. La chiesa di don Diana, che fu lasciato solo a combattere la sua battaglia. Oggi Francesco invita a stare a fianco dei don Diana. Le sue parole rompono l’ambiguità in cui vivono quelle parti di chiesa che da sempre fanno finta di non vedere, che sono accondiscendenti verso le mafie, e che si giustificano in nome di una “vicinanza alle anime perdute”.
Gli affiliati non temono l’inferno promesso dal Papa: lo conoscono in vita. Temono invece una chiesa che diventa prassi antimafiosa. Le parole di Francesco I potranno cambiare qualcosa davvero se la borghesia mafiosa sarà messa in crisi da questa presa di posizione, se l’opera pastorale della chiesa davvero inizierà a isolare il danaro criminale, il potere politico condizionato dai loro voti. Insomma se tutta la chiesa – e non solo pochi coraggiosi sacerdoti – sarà davvero parte attiva nella lotta ai capitali criminali. Dopo queste parole o sarà così o non sarà più Chiesa. LA REPUBBLICA
PAPA FRANCESCO E LA SCOMUNICA AI MAFIOSI UN GRIDO LIBERATORIO CONTRO OGNI AMBIGUITÀ DI CORRADO STAJANO
C’era dunque bisogno di un Papa arrivato di là dall’Oceano per scomunicare con solenne fermezza la mafia e i suoi uomini senza onore. È accaduto sabato scorso in Calabria, nella bella terra di Sibari, davanti a centinaia di migliaia di persone. «Coloro che nella loro vita seguono questa strada di male come i mafiosi, non sono in comunione con Dio: sono sco-mu-ni-cati». Così, scandendo le sillabe, papa Francesco ha spazzato via un’ambiguità secolare. E ancora: «La ‘ndrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune».È la prima volta dall’Unità d’Italia che i mafiosi vengono scomunicati: un tempo lungo, zeppo di tragedie sanguinose nel nostro Sud soffocato, a causa delle cosche, in un vivere angosciante. Non è stato facile arrivare alla scomunica, un percorso arduo, minato da ostacoli di ogni genere. La Chiesa, infatti, ha sempre tergiversato, frenata dalle sue corpose contraddizioni. Anche nel passato prossimo. Dopo l’assassinio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, nel 1982, nel testo di un intervento del papa Giovanni Paolo II figurava un passo, già anticipato ai giornali, molto duro su Cosa nostra che poi scomparve. Neppure una parola. Nel 1985, pareva che la Commissione episcopale avesse deciso per la scomunica, ma allora fu il cardinale Ugo Poletti a tagliar corto: «Non ci sarà nessuna scomunica della mafia da parte dei vescovi, per il semplice fatto che questa sanzione è già prevista dal codice di diritto canonico». Non sono mancati via via gli inviti al pentimento, che non fanno male a nessuno. Papa Giovanni Paolo II, nel 1993 ad Agrigento davanti al tempio della Concordia, spronò i mafiosi a convertirsi; vescovi e cardinali, spesso attenti a non pronunciare la parola mafia — dispiace a non pochi benefattori — si fecero anche loro missionari del pentimento. E tutto finì lì, nella delusione e nello sconcerto degli uomini di buona volontà.La ‘ndrangheta, impastata com’è di religiosità pagana, ha usato la Chiesa, una sua parte almeno, per i propri fini criminali e spesso gli uomini di quella Chiesa non sono stati impeccabili: basta pensare ai preti che hanno ospitato nelle loro parrocchie Luciano Liggio, Totò Riina e altri; ai collaborazionisti; ai falsi testimoni di giustizia; ai processati e condannati; ai consiglieri e consigliori inseriti a un buon livello nel sistema di collusione dei poteri criminali.Tutto, nella ‘ndrangheta, è simbolo. Se l’organizzazione fosse soltanto criminale sarebbe stata facilmente debellata, in più di un secolo, dalle forze di polizia. Ma ha sempre avuto agganci e alleanze coi poteri. Sbandiera la Madonna e usa l’esibizione religiosa per la sua legittimazione sociale. Il nuovo, poi, ha sempre bisogno del vecchio. La processione al Santuario di Polsi, la festa della Madonna della Montagna, ai primi di settembre di ogni anno, non serve di certo ai capi della ‘ndrangheta di oggi, laureati, addottorati, plurilingue, per sussurrarsi come un tempo, mascherati tra la folla dei pellegrini, le loro trame delinquenziali. Per i traffici dell’orrore preferiscono le stanze degli hotel a cinque stelle di tutto il mondo, ma hanno ugualmente bisogno di mostrarsi. Il loro potere è la loro faccia, il loro cognome, lo stesso di quarant’anni fa, come nelle monarchie ereditarie.Gli ‘ndranghetisti, unti di devozione, pregano e sparano. Nel 2007 nelle tasche di una delle vittime della strage di Duisburg, in Germania, è stata trovata un’immaginetta di San Michele Arcangelo. Le chiese fanno da fondale, i capi ‘ndranghetisti si inginocchiano piamente con la famiglia alla messa grande della domenica e sui sagrati, secondo la tradizione, si consumano le vendette, i delitti contro gli «infami» che devono essere visti da tutti i paesani. Le processioni, le feste patronali, i fuochi d’artificio sono appannaggio della ‘ndrangheta. Le statue delle Madonne vengono portate sulle spalle dagli «‘mbuttaturi» che gridano «viva Maria» e magari hanno appena ucciso o spacciato quintali di droga.Poi ci sono e ci sono stati i preti coraggiosi che, a rischio della vita, hanno sbattuto in faccia ai mafiosi i portoni delle loro chiese e hanno cercato di spiegare al popolo com’era e com’è falsa la devozione esibita dagli uomini delle cosche e come la ‘ndrangheta non porta ricchezza, ma degrado e miseria, non soltanto morale. Don Giuseppe Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio, a Palermo, assassinato da Cosa nostra; don Peppe Diana, parroco di Casal di Principe, assassinato dalla Camorra, sono dei martiri, ma, come scrisse Bertolt Brecht, «Sventurato il popolo che ha bisogno di eroi».La ‘ndrangheta, almeno da vent’anni, è diventata un’azienda leader del mercato criminale in Italia e in tutto il mondo, sopravanzando anche Cosa nostra. La Cassazione, il 6 giugno scorso, in una sentenza di grande rilievo sul primo troncone del processo milanese «Infinito» ha documentato, a differenza di quel che si pensava, l’unitarietà dell’organizzazione ‘ndranghetista e l’esistenza di un vertice di comando, anche se differente dalla Cupola di Cosa nostra.Papa Francesco ha ben capito che un Paese, e anche il mondo, non possono crescere, progredire, con questo cancro in casa. Quel che succede in Argentina, la tragedia della criminalità e della droga diffusa a tonnellate nel (e dal) Paese natale, gli hanno di certo fatto da stimolo e da guida. Non è stato prudente come i suoi predecessori o insensibile come non pochi prelati di curia. L’evento di Sibari non ha soltanto un sapore evangelico, ma anche un grande peso politico e civile. Un grido liberatorio, quello di papa Francesco. CORRIERE DELLA SERA 3.7.2014
Il ruolo della Chiesa nella diffusione della mafia
Anche la Chiesa è peccatrice. L’Istituzione ecclesiastica, come ogni organizzazione, è composta da uomini che possono sbagliare, contraddirsi o – perfino – andare contro ai precetti che dovrebbero seguire con rigore morale. Vi riportiamo alcuni episodi che raccontano la vicinanza di determinati membri dell’Istituzione “Chiesa” all’agire mafioso. E’ una parte, ed una parte minoritaria. Sappiamo quanti uomini di Chiesa hanno e continuano, anche rischiando la vita, a contrastare il crimine organizzato. Ma parlare di quelli che sbagliano non vuole essere il modo per condannarli tutti. Anzi..
La diffusione della mafia ha origini lontane ed è stata provocata dalla convergenza di una pluralità di fenomeni. Tra questi si può sicuramente annoverare l’atteggiamento connivente di un esigua minoranza della Chiesa meridionale. Secondo alcune testimonianze, raccolte nell’”Inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia”(1875-’76) (testo conclusivo della commissione parlamentare istituita nel 1875 dal governo Mughetti) tali frange già nel corso del XIX secolo avrebbero diffuso la cosiddetta Bolla di Componenda.
Questo documento consiste in un vero e proprio tariffario distribuito dagli istituti religiosi per consentire alle persone di avere facile accesso alla remissione dei peccati, in cambio di un prezzo prestabilito. Pratiche di questo tipo, sulla cui diffusione non c’è totale concordia tra gli storici, hanno comunque prodotto degli strappi gravissimi nella coscienza civile meridionale e sono stati fonte di grande ispirazione per il potere mafioso.
Ma non solo per questo si può dire che alcuni esponenti ecclesiastici abbiano rinunciato storicamente al proprio ruolo di guida etica e socialenei confronti del popolo meridionale: non si è mai assistito infatti all’estromissione o alla scomunica di mafiosi, ai quali invece, in cambio di larghe elargizioni in denaro, si è concesso di celebrare eventi in pompa magna, come matrimoni e funerali. Tale atteggiamento è derivato nel tempo dalla mancanza di nozione e reale consapevolezza del problema mafia, oltre che dalla volontà di non contrapporsi alle forze che si opponevano all’avanzata del partito comunista.
Ancora negli anni ’60 il cardinale di Palermo Ruffini retrocede la pericolosità del fenomeno a problema di ordine pubblico, ingigantito dai comunisti per indebolire la DC (ricordiamoci che siamo in un periodo in cui “mafia” è un concetto dai contorni non ancora ben definiti). Al di là di questi atteggiamenti di più o meno interessata sottovalutazione, ci sono poi sparuti esempi di consapevole contiguità e collaborazione.
Persino oggi, per quanto minoritariamente, alcuni esponenti ecclesiastici non si sottraggono dalla pratica dell’accompagnamento spirituale dei mafiosi; ne raccolgono le confidenze e arrivano a far loro da tramite per la gestione delle relazioni esterne. Utilizzano l’abito talare per infondere rassicurazione e fiducia, ma sono organici all’organizzazione, spesso come veri e propri esecutori materiali di delitti o silenti organizzatori di trame oscure connesse al potere. Emblematica in questo senso la figura letteraria di Padre Cricco, tratto da “Una storia semplice” di Sciascia, del quale abbiamo scelto di proporre l’immagine cinematografica tratta dall’omonimo film di Emidio Greco, insieme a una scena altrettanto evocativa de “I Soprano”.
Tra i casi più significativi dei rapporti di complicità tra Chiesa e mafia c’è quello di Fra Giacinto, al secolo Stefano Castronovo, frate francescano anche detto “Fra Lupara”. Negli anni ’70 è tra i consiglieri di Bontade e viene accusato di aver ospitato Luciano Liggio da latitante. Fra Lupara è ucciso nella propria chiesa nel 1980, dove tiene un armadietto dentro il quale vengono ritrovate una pistola con il caricatore pieno e decine di milioni in banconote.
E’ significativa anche la storia di Don Agostino Coppola, cugino del capo di Cosa Nostra americana Frank Coppola, detto “Frank tre dita”. Don Agostino è il prete dei corleonesi ed è colui che celebra le nozze di Riina con Ninetta Bagarella, a Cinisi. Legato anch’egli alla figura di Luciano Liggio, confessore di boss importanti, è anche amministratore dei beni dell’arcidiocesi di Monreale. Un sacerdote mafioso a tutti gli effetti, condannato con sentenza definitiva per sequestro di persona e rinviato a giudizio al quarto maxi processo, poco prima di morire.
Vi sono rapporti accertati anche tra membri della Chiesa e la ‘ndrangheta. In Calabria alcuni preti sono stati colti a spacciare cocaina e portare la pistola. Esponenti ecclesiastici hanno testimoniato ai processi definendo gli imputati dei galantuomini e altri hanno celebrato funerali di boss dicendo: “chi siamo noi per giudicare il bene e il male”? Questa retorica è specchio di una concezione della fede come rapporto privatistico tra individuo, sacerdote e Dio, ma che non ha nessuna corrispondenza nella vita sociale: tutto si risolve in un problema di coscienza, che si lava volta per volta con la confessione.
Questa impostazione ha indubbiamente fornito l‘humus necessario alle cosche per insinuarsi dentro le coscienze, consentendo alle mafie di affondare le proprie radici nelle profondità dei corpi sociali del meridione, da cui poi si sono diffuse nel resto della penisola. Pur non volendo negare le responsabilità storiche di certe frange, è però giusto ricordare gli sforzi e i sacrifici, che per alcuni sono stati della vita stessa, che la Chiesa ha messo in campo negli ultimi vent’anni contro la mafia. Sarà argomento del nostro prossimo articolo sul tema. 28/05/2014 ACMOS
LA SCOMUNICA DELLA CUPOLA
“Tutti noi uomini d’onore pensiamo di essere cattolici, Cosa Nostra si vuole farla risalire all’apostolo Pietro”. Così Leonardo Messina, un mafioso pentito, parlava durante un interrogatorio. In quell’occasione, il boss rivelò anche l’esistenza di una “Bibbia della mafia”, nascosta nelle campagne di Riesi, un piccolo comune in provincia di Caltanissetta. Ad una prima analisi, in effetti, sembra proprio che siano veramente poche le differenze tra un cattolico e un mafioso. Entrambi pregano. Hanno in tasca, o nel portafoglio, un santino: una Madonna Addolorata, un Cristo crocifisso, un Padre Pio, ecc. Anche i mafiosi sono religiosi. Tutti. Campani, siciliani, calabresi, boss. Per anni il confine tra credente e mafioso è stato invisibile.
La mafia, l’anti-Chiesa La malavita organizzata, da sempre denominata “anti-Stato”, oggi si potrebbe definire anche con l’appellativo di “anti-Chiesa”. Come i monaci osservano la regola benedettina dell’“ora et labora”, così anche la vita della mafia è scandita di riti, preghiere e funzioni religiose. Un esempio chiaro è la riunione dei capi della ‘Ndragheta, che il 2 settembre di ogni anno si riuniscono presso il Santuario della Madonna dei Polsi, situata a circa 860 metri d’altezza in una vallata dell’Aspromonte. Qui, a pochi passi dal torrente Bonamico, che costeggia il paese di San Luca, i boss prendono le decisioni più importanti e stringono alleanze. Qualche pentito rimasto anonimo ha raccontato che in questo luogo sono custodite le “12 Tavole della ‘Ndrangheta”. Una sorta di “codice etico” per certi aspetti molto simile ai “dieci comandamenti” donati da Dio a Mosè sul monte Sinai. Ma i riferimenti alla tradizione cristiana non si limitano al Vecchio Testamento. Nel 1951, mentre a Viterbo si celebrava il processo della strage di Portella della Ginestra, Gaspare Pisciotta, cugino traditore del bandito Salvatore Giuliano, in aula si difendeva con queste parole: “Siamo un corpo solo: banditi, polizia e mafia, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo”. Una vera e propria religione con tanto di ministri. Infatti, tra gli uomini d’onore di spicco della malavita siciliana figura anche padre Agostino Coppola, parroco di Carini. I media lo ricordano soprattutto come il prete che sposò in gran segreto Salvatore Riina (all’epoca latitante) e Antonina Bagarella. Anche le donne svolgono un ruolo importante. Infatti, i così detti “uomini d’onore” non si confessano direttamente. A riceve l’assoluzione sono le loro compagne. Grazie ad alcune intercettazioni della Polizia di Stato, è infatti emerso che sono le mogli a recarsi in chiesa per inginocchiarsi davanti al confessionale. Quando, raramente, sono gli stessi mafiosi che si accostano al Sacramento della Riconciliazione, ricorrono a una formula standard. Il dialogo suona, pressappoco, così: “Padre, mi assolva”. “Cosa hai fatto figliolo?”. “Niente, sono innocente come Gesù Cristo”.
Una Chiesa “divisa” I media italiani hanno sempre evidenziato come la Chiesa non sia stata “unita”, bensì divisa sulla questione mafia. Vescovi e parroci locali, stando a quanto riportano le cronache, nella maggior parte dei casi hanno taciuto il grande male che attanaglia il Mezzogiorno. In realtà, la Chiesa mai ha taciuto sulla mafia. A dimostrarlo non sono solo le scelte dettate dalla prudenza degli ecclesiastici che hanno svolto la loro missione pastorale in Sicilia, o in Calabria. Leonardo Messina, mafioso pentito, dichiarò: “La Chiesa ha capito prima dello Stato che doveva prendere le distanze da Cosa Nostra”. Quello dei mafiosi è un uso deviato della religione che, oggi come in passato, si manifesta in processioni, rituali e preghiere che assumono una dimensione pubblica con il solo scopo di riconoscere uno status di superiorità a chi, in realtà, viola la legge in nome di un falso dio.
Il peccato di mafia Le processioni sono atti di devozione che riguardano la sfera religiosa dell’uomo. Nel cattolicesimo, esse costituiscono un ulteriore elemento di appartenenza e identità a quel “depositum fidei” che la Chiesa custodisce. Una fede che da oltre duemila anni si rende visibile attraverso le liturgie. Esse scandiscono i ritmi della vita della Chiesa. E, per certi aspetti, anche quelli della mafia. Anche i malavitosi vanno a messa, e come tutti i buoni cristiani anche loro si confessano. Da alcune intercettazioni del prof. Guttadauro, aiuto primario in uno degli ospedali di Palermo, e capo mafia a Brancaccio, si viene a sapere che il medico la mattina si dedicava a ricevere i mafiosi, nel pomeriggio i politici di turno, e la sera istruiva il “delfino” che avrebbe dovuto sostituirlo, invitandolo a confessarsi, ma raccomandandogli di scegliere il sacerdote giusto. Gli racconta: “Sai cosa mi è successo? Un giorno mi sono andato a confessare e il sacerdote mi ha detto che esiste il peccato di mafia. Questa cosa non l’avevo mai sentita. Quindi, prima di andarti a confessare, devi trovare il soggetto giusto”.
Il senso religioso dei mafiosi La sociologa Alessandra Dino ha provato a spiegare le motivazioni per cui un mafioso prova un forte senso religioso. Secondo la studiosa, vi sono due livelli da prendere in considerazione: quello individuale e quello dell’organizzazione. Gaspare Mutolo, uno dei killer di Mondello, autore di oltre venti omicidi, ha dichiarato: “Noi mafiosi siamo religiosi perché siamo anche noi fatti di carne e di ossa. Lo sa cosa volevo fare da bambino? Il missionario, perché volevo aiutare la gente”. A livello organizzativo, invece, la religiosità fa si che le cosche assumano i tratti di una “comunità” nella quale identificarsi. Ad esempio, Bernardo Provenzano usava la Bibbia per comunicare. Il motivo è semplice: costituisce un punto di vista culturale a cui tutti possono attingere, e dà credibilità all’organizzazione.
Una religione strumentalizzata Pensiamo al caso della “Candelora” di Sant’Agata, nel 2005, a Catania. I membri del clan Santapaola, salirono sul catafalco della martire, al posto del prete, con l’obiettivo di deviare il percorso della processione per farla passare sotto la casa di Francesco Mangion, della cosca appena rilasciato, affinché la protettrice di Catania potesse dare il bentornato al malavitoso. Da ciò si evince che gli inchini, così come tutte le “liturgie” a cui prendono parte i mafiosi, non sono un elemento folkloristico, ma una forma di sfoggio del potere legittimato dalla divinità.
Un’efficace strategia di comunicazione Allo stesso tempo rappresenta una straordinaria strategia di comunicazione, efficace e diretta, che trasmette un solo messaggio: qui comandiamo noi. In realtà, la Chiesa non ha mai legittimato l’operato della mafia, ne ha mai stretto alcun tipo di patto. Alla base vi sono questioni storiche e sociali ben precise che trovano le loro radici all’indomani del secondo conflitto mondiale, quando tra i cittadini e gli esponenti del clero vi era una scarsa conoscenza, nonché una grande sottovalutazione, del fenomeno mafioso. Basti pensare all’operato di mons. Ruffini, cardinale di Palermo dal 1946 al 1967. Nel maggio del 1947, commentando la strage di Portella della Ginestra, affermò: “Come vescovo non posso certo approvare le violenze da qualunque parte provengano, ma è un fatto che la reazione all’estremismo di sinistra stia assumendo proporzioni impressionanti. Del resto, si poteva ritenere inevitabile la reticenza e la ribellione di fronte alle prepotenze, alle calunnie, ai sistemi sleali dei comunisti”. In altre parole: se la sono cercata. Bisognerà attendere gli anni ’80 e l’operato di don Pino Puglisi, oggi beato, per intravedere alcune crepe nel muro di omertà e silenzio innalzato da alcuni rappresentanti del clero siciliano. Il ruolo delle donne
Alcuni pentiti hanno raccontato che mentre erano impegnati nel realizzare l’opera voluta dai padrini, le loro mogli, o compagne, erano in chiesa, inginocchiate davanti ad un altare, o al simulacro della Vergine Maria. Pregavano affinché le anime di quelle persone che venivano uccise dai propri mariti fossero accolte in paradiso. La loro morte era necessaria perché andava contro il “piano divino”. E loro, i mafiosi, che si dicono credenti, come Cristo ha perdonato i peccatori, perdonano chiunque si metta contro il volere di Dio. Li uccidono, ma pregano per le anime dei morti ammazzati, e non per le loro perché i malavitosi, con quel gesto, compiono la volontà del Signore. Un ragionamento contorto e tutt’altro che cristiano, ma ben impostato e inculcato nelle menti dei giovani che si avvicinano al mondo della mafia.
La risposta della Chiesa locale Bisogna attendere l’alba degli anni ’80 per avere una prima denuncia pubblica del fenomeno mafioso da parte della Chiesa siciliana. A parlare è il cardinale Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di Palermo dal 1970 al 1996. Negli anni del suo ministero pastorale, in Sicilia si consumano quelli che saranno definiti, successivamente, i “delitti eccellenti”: Boris Giuliano, Cesare Terranova, Piersanti Mattarella, Emanuele Basile, Gaetano Costa, Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ma l’evento che fa da cassa di risonanza del sentimento di disprezzo e di orrore di tanti cittadini onesti, sono i solenni funerali di Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro, uccisi in un violento agguato il 3 settembre del 1982. Il giorno dopo, dal pulpito della chiesa di San Domenico, il cardinale fece impallidire i più importanti uomini politici siciliani e d’Italia, che assistevano nelle prime file alla messa funebre del prefetto Dalla Chiesa: “La mafia è un demone dell’odio, l’incarnazione stessa di Satana. Si sta sviluppando una catena di violenza e di vendette tanto più impressionanti perché, mentre così lente e incerte appaiono le mosse e le decisioni di chi deve provvedere alla sicurezza e al bene di tutti, quanto mai decise, invece, tempestive e scattanti sono le azioni di chi ha mente, volontà e braccio pronti a colpire. Sovviene e si può applicare una nota frase della letteratura latina: Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur; mentre a Roma ci si consulta, la città di Sagunto viene espugnata. Sagunto è Palermo. Povera la nostra Palermo! Come difenderla?”. Parole rimaste indelebili nelle coscienze non solo dei siciliani, ma degli italiani tutti. Queste parole, passano alla storia come l’“omelia di Sagunto”. Un intervento che, de facto, segna una grande svolta nella storia della lotta alla mafia e nei “rapporti”, se così si possono definire, della “piovra” con la Chiesa. Un lungo periodo che passa alla storia come “la Chiesa del silenzio”. Infatti, da quel momento, in Sicilia tanti giovai parroci, definiti “coraggiosi” dal Procuratore Antimafia, Pietro Grasso, “iniziarono a porsi domande sul loro ruolo in una terra di violenza, sangue e diritti negati, chiedendosi se dovevano limitarsi a curare le anime o invece impegnarsi in un’azione apostolica in difesa dei diritti dell’uomo. Sorsero, su impulso del cardinale, movimenti, missioni popolari fuori dalle parrocchie, istituti dedicati alla formazione evangelica dei credenti, dei giovani, degli emarginati”. Ma i veri trascinatori della lotta alla mafia sono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che nel 1986 riescono a far condannare i grandi capi di Cosa Nostra, tra cui Michele Greco, detto “il Papa”, come mandanti di numerose stragi. Tuttavia, Toto Riina e Bernardo Provenzano restano latitanti. I due giudici, su ordine di Riina, capo dei capi di Cosa nostra, vengono assassinati. Ma il coraggio e la tenacia dimostrata dai due magistrati, e i sempre maggiori sforzi degli inquirenti nel debellare questa piaga sociale, fanno nascere in molti strati della società una sensibilità diversa che tocca anche i vertici della Chiesa.
La scomunica E così, nel maggio del 1993, Giovanni Paolo II alza un forte grido contro gli uomini d’onore, e lo fa pronunciando anche la parola “mafia”. Il grido di conversione di Giovanni Paolo II viene ignorato dai mafiosi. E la Chiesa entra nel mirino di Cosa Nostra. La notte tra il 27 e il 28 luglio del 1993, due bombe al tritolo vengono fatte esplodere a Roma: una davanti la basilica di San Giovanni in Laterano, l’altra nella chiesa di San Giorgio al Velabro. Un attacco mirato alla Chiesa. E questo perché le frasi di Giovanni Paolo II tolgono ogni dubbio all’ambiguità tra religione e mafia. Per ciò cosa nostra colpisce Roma: San Giovanni in Laterano è la Cattedrale della “città eterna”, li viene custodita la cattedra del Papa. Alle bombe esplose nelle basiliche romane, segue un assassinio, quello di don Giuseppe Puglisi, parroco di Brancaccio. Anche Benedetto XVI ha condannato la mafia in occasione della sua visita pastorale a Palermo, il 3 ottobre del 2010. Le parole di Ratzinger si pongono sulla stessa scia di quelle di Giovanni Paolo II e, per certi aspetti, sembrano rievocarle. “La mafia è strada di morte, incompatibile con il Vangelo”, aveva dichiarato. Di recente, Papa Francesco ha messo del tutto fine al “rapporto” tra religione cattolica e mafia pronunciando in Calabria, terra martoriata dalla ‘Ndragheta, nel giugno del 2014, una scomunica latae sententiae nei confronti di tutti quelli che si professano mafiosi. “I mafiosi sono scomunicati, la ‘ndrangheta adora il male”, ha affermato Bergoglio. Nella concezione cristiana, chiunque commette peccato può pentirsi. Probabilmente questa prospettiva e l’idea che la mafia fosse solo un’organizzazione di assassini, ha rimandato l’uso dell’arma più potente che la Chiesa abbia mai avuto. Scomunicare persone che si ritengono, a modo loro cattoliche, avrebbe sbarrato ogni porta alla conversione.
C’è differenza tra mafiosi e cattolici: definirsi credenti non basta ad esserlo. È necessario vivere con le opere quell’incontro che il battezzato ha avuto con Cristo. Altresì, possiamo dire che la religione dei mafiosi non è quella cattolica: la mafia è un distorto complesso di falsi valori e dunque, prima ancora che “per il suo nefasto potenziale di delinquenza e anti-socialità, è incompatibile con il Vangelo”. Inoltre, la Chiesa ha capito fin da subito la pericolosità di tale organizzazione e, anche se a livello gerarchico vescovi e pontefici hanno denunciato la malvagità e l’incongruenza della criminalità organizzata solo a partire dalla seconda metà del XX secolo, a livello locale sono stati numerosi i sacerdoti, ma anche laici credenti, che si sono impegnati a lottare contro l’ombra nefasta della mafia. Allo stesso modo, non dobbiamo dimenticare che i media sono uno degli strumenti principali della lotta alla mafia: una corretta e approfondita informazione, infatti, garantirebbe l’isolamento della criminalità organizzata dalla società. Giovanni Falcone diceva: “La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine”. Quel giorno, la cupola, che da simbolo e faro della cristianità è stata snaturata nella sua quintessenza dalla mafia, continuerà ad essere un ponte tra l’uomo e Dio. Non sarà più accostata ad un organigramma che getta la sua ombra malefica grazie ad un potere occulto. Da quella cupola tornerà ad echeggiare un grido di speranza per ogni uomo, una speranza che la mafia non può, non ha potuto e non potrà mai rendere all’uomo: l’incontro con l’Infinito. IN TERRIS Fabio Beretta 17.6.2017.
‘Ndrangheta e massoneria “soci” per investire in Calabria 100 milioni dei Lloyd’s di Londra.
L’ex venerabile divenuto collaboratore di giustizia Cosimo Virgiglio racconta a Dda di Catanzaro e Ros anche gli affari dei Mancuso. Nel 2005 un’operazione di riciclaggio con «cardinali e vescovi» per opere ecclesiastiche. I soldi sporchi, mascherati da offerte, così uscivano puliti. E cita pure Letta e Previti (ASCOLTA L’AUDIO). di Pietro Comito 25 ottobre 2020 Un pezzo da novanta della massoneria e due della ‘ndrangheta, un ex ufficiale della Guardia di finanza e, niente meno, un emissario dei Lloyd’s di Londra. Anzi, erano proprio i Lloyd’s a voler investire «prima della chiusura dell’anno finanziario, cento milioni di euro nell’acquisto di villaggi turistici».
Per farlo, interessarono il maestro venerabile crotonese Sabatino Marrazzo. Il coinvolgimento dei boss Rocco Molè, da Gioia Tauro, e Giovanni Mancuso, una sorta di ministro delle finanze del clan di Limbadi, fu il passo successivo. E tutti insieme, c’era pure quell’ex finanziere – racconta Cosimo Virgiglio, ex colletto bianco con grembiulino sporco, al pool di Nicola Gratteri – «andammo a visionare diversi villaggi».
È il 24 luglio 2018, sede della Direzione nazionale antimafia. Virgiglio viene interrogato dal pm Antonio De Bernardo e dai carabinieri del Ros. Quella raccontata dal collaboratore di giustizia rosarnese, premettiamo, è una storia tutta da verificare sul piano investigativo, ma è certamente molto suggestiva e di rilevante interesse pubblico, acquisita agli atti delle maxinchieste condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.
Massomafia e alta finanza. Virgiglio ricorda delle riunioni massoniche in un noto ristorante catanzarese e colloca la vicenda relativa agli investimenti londinesi sulla Costa degli dei nel 2003. Quello era un periodo molto complicato, tanto per i Molè quanto per i Mancuso. A Gioia Tauro si frantumò l’alleanza coi Piromalli, esasperando quelle tensioni che l’1 febbraio 2008 condussero proprio all’omicidio di Rocco Molé. A Limbadi, invece, le frizioni tra le varie articolazioni del clan Mancuso, prima esplosero con il tentato omicidio di Ciccio Mancuso alias Tabacco e l’omicidio di Raffaele Fiamingo detto il Vichingo, poi furono spente con la maxioperazione Dinasty-Affari di famiglia: tutto, appunto, nel 2003. La malavita, però, avrebbe avuto piena intenzione di controllare quel fiume di denaro annunciato oltremanica. E la massoneria? Avrebbe sovrinteso gli affari dei Lloyd’s.
E questo è uno dei passaggi del verbale che contiene le dichiarazioni rese da Cosimo Virgiglio (in foto) al pm De Bernardo e al Ros: «Molte riunioni tra massoni per la discussione di grandi affari e candidature avvenivano al ristorante L’orso cattivo (dove abbiamo incontrato soggetti come Gianni Letta, con il quale si parlò dell’affare che coinvolgeva la Lloyd’s di Londra, Cesare Previti ed altri). Tuttavia previso che il ristorante L’orso cattivo era soltanto un luogo dove sapevamo di poter parlare indisturbati ed inascoltati di questioni delicate, ma non un vero e proprio tempio massonico».
Precisiamo che finora non c’è riscontro sulle dichiarazioni di Virgiglio e che tanto l’onorevole Gianni Letta quanto Cesare Previti non sono mai stati coinvolti in indagini della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Così come estranei ad ogni contestazione di reato sono i Lloyd’s e il ristorante L’orso cattivo. Ma andiamo avanti. Perché i racconti di Virgiglio – ripetiamo, tutti da riscontrare – sono davvero suggestivi. L’ex commercialista arringato ai Molè, arrestato nella maxioperazione Maestro della Dda di Reggio Calabria e poi passato tra le fila dei collaboratori di giustizia, faceva parte della Gran Loggia Garibaldini d’Italia di Vibo Valentia «da cui – sottolinea – dipendevano altre logge». Continua: «Io ero maestro venerabile di una di queste, quella Eroe dei due mondi di Reggio Calabria. Facevo comunque parte, già precedentemente, del Grande Oriente di San Marino di cui Ugolini era il massimo rappresentante». Ugolini, Giacomo Maria, ex ambasciatore sammarinese, massone potentissimo e controverso, scomparso nel 2006.
La massoneria e la Chiesa Ancora dal verbale reso da Cosimo Virgiglio, il 24 luglio 2018, a Dda di Catanzaro e Ros: «Mancuso (Giovanni, ndr) tramite la loggia di cui faceva parte Sensi, l’imprenditore romano, soggetto vicino ad Ugolini, e grazie all’intervento di questi, concluse anche una complessa operazione di riciclaggio». Precisiamo, anche in questo caso, che a Franco Sensi, scomparso nel 2008, che Ugolini, la giustizia non ha mai contestato nulla al riguardo. Ma torniamo nuovamente al racconto del collaboratore di giustizia.
Era il 2005 e «Ugolini fu convocato da Giovanni Mancuso e Mario Esposito (non indagato), degli Arena di Isola Capo Rizzuto, per il riciclaggio di danaro attraverso la realizzazione di opere ecclesiastiche, ad esempio un centro anziani». Il numero uno del Grande Oriente di San Marino – secondo quanto riferisce la gola profonda – «avrebbe dovuto fare da tramite per la consegna del denaro sotto forma di offerte ad istituti ecclesiastici, grazie all’intermediazione di alti prelati, quali cardinali e vescovi di Mileto, che avrebbero poi affidato la realizzazione di strutture a costruttori puliti, dietro cui però si celavano gli stessi mafiosi che avevano messo a disposizione il denaro di provenienza illecita, il quale attraverso le offerte non era più rintracciabile. So – conclude Virgiglio – che questa operazione è andata in porto con la costruzione di un centro anziani a Paravati». Proprio da quelle parti, il Grande Oriente di San Marino avrebbe giocato in casa. «Ugolini aveva un punto di riferimento in Calabria costituito da Mario Esposito della cosca Arena, ed era un personaggio molto importante e molto legato a Vibo Valentia, che teneva in grossa considerazione. Peraltro a Vibo c’è una loggia madre e dal punto di vista massonico, è un centro molto importante».LacNews24
MADONNE E SANTI E CROCIFISSI NELLA CAMERA DELLA MORTE
Periferia est di Palermo: via Messina Montagne. C’è un grande capannone, si vede dall’autostrada. Un magazzino circondato da erbacce, rovi e carcasse di veicoli. Un’insegna: “La commerciale”. In una nicchia mimetizzata dal rivestimento di finto abete che ricopre le pareti ci sono gli attrezzi: manette, corde, lacci, fili di ferro, guanti di lattice. Tutto l’occorrente per la tortura. Affisse al muro, senza un preciso ordine, tante immagini sacre: Santa Rosalia, Santa Rita, la Madonna, San Cristoforo, protettore degli automobilisti. È lo strangolatoio di Cosa Nostra Fin qui latitanti, armi ed esplosivi. Ma adesso arriva la parte più dura, la ricerca dei cadaveri. Certo, stiamo facendo un’operazione di polizia e non c’è spazio per altri pensieri, ma è davvero difficile rimanere insensibili di fronte a corpi decomposti o a resti umani seppelliti alla meno peggio. Morti ammazzati di cui non si è più saputo niente. Classici casi di lupara bianca. Romeo ci fa trovare un corpo sotterrato in un terreno sul litorale di Palermo: il cadavere di un ragazzo extracomunitario, legato mani e piedi e infilato in un sacco nero della spazzatura. Il giovane tunisino era responsabile solo di aver richiesto ai mafiosi il pagamento della sua attività lavorativa prestata come mozzo a bordo di un loro peschereccio, il Lupo di San Francesco, con cui periodicamente importavano qualche quintale di hashish dal Marocco. Vicino a Bolognetta, Romeo ci fa recuperare un secondo cadavere, quello di un certo Giovanni Ambrogio, e altri resti umani, residui di qualche frettoloso scioglimento nell’acido. Di alcuni di questi delitti ci aveva già parlato Pasquale Di Filippo, il collaboratore che ci ha portato sulle tracce di Bagarella. Era stato lui, prima ancora di Romeo, a spalancarci le porte della cosiddetta «camera della morte», uno dei luoghi più tetri e agghiaccianti che abbia mai visto in vita mia. Periferia est di Palermo: via Messina Montagne. C’è un grande capannone. Si vede dall’autostrada. Un magazzino circondato da erbacce, rovi e carcasse di veicoli. Un’insegna: La commerciale. Spazio aperto recintato da un muro e, sulla destra, dopo il pesante portone di ferro semiarrugginito, uno stanzino, un piccolo ufficio. Come la guardiola di un custode. In una nicchia mimetizzata dal rivestimento di finto abete che ricopre le pareti ci sono gli attrezzi: manette, corde, lacci, fili di ferro, guanti di lattice. Tutto l’occorrente per la tortura. Affisse al muro, senza un preciso ordine, tante immagini sacre: santa Rosalia, santa Rita, la Madonna, san Cristoforo, protettore degli automobilisti. È lo strangolatoio di Cosa nostra. Amen. Pasquale Di Filippo ci aveva parlato di questo luogo nel suo primo interrogatorio dopo la cattura di Bagarella. Il suo racconto, drammatico, parte dalla faida di Villabate, da questo strano gioco di guerra tra mafiosi e dalla paura che aveva Bagarella di essere oggetto di un complotto degli «scappati», i vecchi boss usciti sconfitti dalla guerra di mafia degli anni Ottanta.
LA FINE DI GAETANO BUSCEMI Perciò il boss di Corleone aveva emesso e fatto eseguire numerose sentenze di morte. I condannati di turno, in quella maledetta primavera del 1995, sono Gaetano Buscemi e Giovanni Spataro, soci in affari. Buscemi è un piccolo imprenditore edile di Villabate, nipote di tale Giuseppe Di Peri, che Bagarella aveva fatto uccidere insieme al figlio, poco più di un mese prima. Il 28 aprile scatta l’agguato. Spataro e Buscemi vengono attirati in un tranello. Mentre si recano a piedi a visitare un cantiere vedono arrivare una Fiat Croma con il lampeggiante e con a bordo uomini che indossano giubbetti con la scritta «polizia di Stato». Dalla macchina scendono, armi in pugno, i killer di Mangano e Bagarella. Prima che i due abbiano modo di comprendere cosa stia succedendo, Salvatore Grigoli e lo stesso Mangano fanno fuoco e uccidono Spataro. Gli altri prendono Buscemi e lo trascinano a forza nella Croma. Direzione: la camera della morte, dove pochi minuti dopo arriverà don Luchino in persona. Buscemi viene interrogato per oltre otto ore, schiaffeggiato di continuo e poi strangolato per mano dello stesso Bagarella. Pasquale Di Filippo e Pietro Romeo sono lì, sul posto, insieme a una mezza dozzina di gregari. Entrano ed escono da quella stanza. Quando decidono di collaborare ci raccontano nei dettagli, con estremo disagio, il drammatico «interrogatorio» di Buscemi, sicuramente uno dei più lunghi nella storia di Cosa nostra. Me lo sono immaginato diverse volte quell’interrogatorio: la luce fredda della lampada al neon, da ufficio di terz’ordine, Gaetano Buscemi bianco come un cencio, con il volto coperto di lividi, legato sulla vecchia sedia di legno impagliata, da quattro soldi. Di fronte a lui, i santini, beffardi, attaccati alla parete. Buscemi ha quarant’anni, è un mafioso di piccolo calibro e, obiettivamente, ha poco da raccontare. È solo capitato in un gioco di potere più grande di lui, un gioco tra Bagarella e i Graviano, da un lato, e Provenzano e Aglieri dall’altro. Nello stanzino lo interrogano per ore. Bagarella lo incalza. Vuole sapere tutto sulla famiglia Di Peri, anche quello che Buscemi non può dire perché non lo sa.
Gli hanno messo una corda al collo. Una corda sottile e ruvida, i cui capi penzolano dietro la sedia. È terrorizzato, ma è lucido. Tanto lucido da stipulare uno strano quanto macabro patto con i suoi assassini. Sa che la sua sorte è segnata e che non ha la minima possibilità di salvarsi la vita; mette sul piatto della bilancia l’unica richiesta che potrebbe forse essere accolta. Si dice disponibile a raccontare loro tutto quello che sa a patto che il suo cadavere non venga sciolto nell’acido: che almeno sua moglie e i suoi figli possano avere una tomba su cui piangere. Ancora oggi rabbrividisco a pensare alla forza morale dimostrata nell’occasione da quell’uomo, da quel condannato a morte.
Avuto l’assenso di don Luchino, Buscemi svela che suo zio, Giuseppe Di Peri, faceva esclusivo riferimento a Pietro Aglieri, legatissimo a sua volta a Provenzano, e che di recente aveva incontrato delle persone, forse proprio qualcuno degli «scappati», a Marsiglia. A queste rivelazioni Bagarella «sospende il verbale» e manda Calvaruso a cercare Giovanni Brusca per fargli sentire in diretta quelle informazioni che, secondo lui, costituiscono la prova del doppio gioco di Provenzano. Ma il boss di San Giuseppe Jato non si trova.
Si va avanti così fino a sera inoltrata, fin quando Bagarella capisce di non poter cavare più niente da quel povero cristo. E tira la corda per primo. Poi apre la porta e dice: «Cu ‘u voli salutari ora, lu po’ fari». Gli altri mafiosi entrano, a piccoli gruppi, e finiscono il lavoro. È notte fonda. Certamente qualcuno tra i presenti deve aver provato un senso di nausea e forse di pietà, senza darlo a vedere, ovviamente. Tutti insieme diventano arroganti: fanno branco.
Il corpo di Buscemi viene legato, caricato su un Fiorino Fiat e abbandonato in una via del centro di Villabate, con ancora la corda al collo. Bagarella e Mangano, da uomini d’onore, sono stati ai patti, hanno rispettato l’accordo con il condannato e hanno consegnato il suo cadavere alla famiglia.
Quando vado a fare il mio primo sopralluogo in quel capannone accuso un senso di vertigine, di smarrimento. Malgrado i due mesi trascorsi dall’ultimo omicidio eseguito, avverto in quello stanzino un indefinibile odore di morte. C’è ancora la sedia sgangherata dove è stato legato e strangolato Buscemi, ci sono le corde, le manette, i santini appesi al muro e le tracce di altre esecuzioni, di altri omicidi avvenuti là dentro.
Come quello di certo Vallecchia, noto come Gianni Giannuzzo, detto ‘U cantanti perché faceva l’interprete di canzoni napoletane. Bella voce e un repertorio classico, dicevano: ‘O sole mio, Malafemmena, Reginella, ‘O surdato ‘nnammurato… Si esibiva ai matrimoni e nelle feste di paese.
Al momento dell’esecuzione ha in tasca un telefonino che i killer, per non lasciare tracce, hanno bruciato proprio nell’atrio del magazzino. Così ci hanno raccontato i pentiti. Alla fine lo recupero proprio io quel telefono: trovo in un angolo dei pezzi anneriti, semicarbonizzati, di un e-tacs Motorola. In un frammento è visibile parte del numero di serie dell’apparecchio. E quelle cifre corrispondono al cellulare di Gianni ‘U cantanti! È la conferma che i pentiti dicono la verità e che quel magazzino gronda sangue.
Ne avevano ammazzati tanti, di uomini, lì dentro. Cose di mafia, in fondo, ma, soprattutto, cose da selvaggi. Come quando nel magazzino della Commerciale avevano condotto due cittadini marocchini, uno dei quali sospettato di aver attentato alla virtù della moglie di Pasquale Di Filippo. L’altro viene ucciso subito da Grigoli con un colpo di 7.65 munita di silenziatore. Un colpo solo, dritto in mezzo agli occhi. Il presunto spasimante, invece, viene «interrogato» e schiaffeggiato per un paio d’ore. Poi lo strangolano, lo evirano e gli infilano in bocca i genitali, assicurati con del nastro adesivo.
Nella notte i due corpi incaprettati vengono scaricati da un furgone lungo le vie di Brancaccio, affinché servano da monito per altri eventuali trasgressori del nono comandamento in relazione alle donne dei cosiddetti uomini d’onore. La grande caccia ai mafiosi dopo la cattura di Totò Riina. Uno dei magistrati è Alfonso Sabella. Le indagini son diventate poi un libro, “Cacciatore di mafiosi”. A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COSA VOSTRA
«MAFIA E MASSONERIA IN AFFARI COI SOLDI DEI LLOYD’S». VIRGIGLIO CITA PURE GIANNI LETTA E PREVITI
L’ex venerabile divenuto collaboratore di giustizia racconta a Dda di Catanzaro e Ros gli affari dei Mancuso. Nel 2005 un’operazione di riciclaggio con «cardinali e vescovi» per opere ecclesiastiche. I soldi sporchi, mascherati da offerte, così uscivano puliti Un pezzo da novanta della massoneria e due della ‘ndrangheta, un ex ufficiale della Guardia di finanza e, niente meno, un emissario dei Lloyd’s di Londra. Anzi, erano proprio i Lloyd’s a voler investire «prima della chiusura dell’anno finanziario, cento milioni di euro nell’acquisto di villaggi turistici». Per farlo, interessarono il maestro venerabile crotonese Sabatino Marrazzo. Il coinvolgimento dei boss Rocco Molè, da Gioia Tauro, e Giovanni Mancuso, una sorta di ministro delle finanze del clan di Limbadi, fu il passo successivo. E tutti insieme, c’era pure quell’ex finanziere – racconta Cosimo Virgiglio, ex colletto bianco con grembiulino sporco, al pool di Nicola Gratteri – «andammo a visionare diversi villaggi». [Continua]
È il 24 luglio 2018, sede della Direzione nazionale antimafia. Virgiglio viene interrogato dal pm Antonio De Bernardo e dai carabinieri del Ros. Quella raccontata dal collaboratore di giustizia rosarnese, premettiamo, è una storia tutta da verificare sul piano investigativo, ma è certamente molto suggestiva e di rilevante interesse pubblico, acquisita agli atti delle maxinchieste condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.
Virgiglio ricorda delle riunioni massoniche in un noto ristorante catanzarese e colloca la vicenda relativa agli investimenti londinesi sulla Costa degli dei nel 2003. Quello era un periodo molto complicato, tanto per i Molè quanto per i Mancuso. A Gioia Tauro si frantumò l’alleanza coi Piromalli, esasperando quelle tensioni che l’1 febbraio 2008 condussero proprio all’omicidio di Rocco Molé. A Limbadi, invece, le frizioni tra le varie articolazioni del clan Mancuso, prima esplosero con il tentato omicidio di Ciccio Mancuso alias Tabaccoe l’omicidio di Raffaele Fiamingo detto il Vichingo, poi furono spente con la maxioperazione Dinasty-Affari di famiglia: tutto, appunto, nel 2003. La malavita, però, avrebbe avuto piena intenzione di controllare quel fiume di denaro annunciato oltremanica. E la massoneria? Avrebbe sovrinteso gli affari dei Lloyd’s.
E questo è uno dei passaggi del verbale che contiene le dichiarazioni rese da Cosimo Virgiglio al pm De Bernardo e al Ros: «Molte riunioni tra massoni per la discussione di grandi affari e candidature avvenivano al ristorante L’orso cattivo (dove abbiamo incontrato soggetti come Gianni Letta, con il quale si parlò dell’affare che coinvolgeva la Lloyd’s di Londra, Cesare Previti ed altri). Tuttavia previso che il ristorante L’orso cattivo era soltanto un luogo dove sapevamo di poter parlare indisturbati ed inascoltati di questioni delicate, ma non un vero e proprio tempio massonico».
Precisiamo che finora non c’è riscontro sulle dichiarazioni di Virgiglio e che tanto l’onorevole Gianni Letta quanto Cesare Previti non sono mai stati coinvolti in indagini della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Così come estranei ad ogni contestazione di reato sono i Lloyd’s e il ristorante L’orso cattivo. Ma andiamo avanti. Perché i racconti di Virgiglio – ripetiamo, tutti da riscontrare – sono davvero suggestivi. L’ex commercialista arringato ai Molè, arrestato nella maxioperazione Maestro della Dda di Reggio Calabria e poi passato tra le fila dei collaboratori di giustizia, faceva parte della Gran Loggia Garibaldini d’Italia di Vibo Valentia «da cui – sottolinea – dipendevano altre logge». Continua: «Io ero maestro venerabile di una di queste, quella Eroe dei due mondi di Reggio Calabria. Facevo comunque parte, già precedentemente, del Grande Oriente di San Marino di cui Ugolini era il massimo rappresentante». Ugolini, Giacomo Maria, ex ambasciatore sammarinese, massone potentissimo e controverso, scomparso nel 2006.
LA MASSONERIA E LA CHIESA Ancora dal verbale reso da Cosimo Virgiglio, il 24 luglio 2018, a Dda di Catanzaro e Ros: «Mancuso (Giovanni, ndr) tramite la loggia di cui faceva parte Sensi, l’imprenditore romano, soggetto vicino ad Ugolini, e grazie all’intervento di questi, concluse anche una complessa operazione di riciclaggio». Precisiamo, anche in questo caso, che a Franco Sensi, scomparso nel 2008, che Ugolini, la giustizia non ha mai contestato nulla al riguardo. Ma torniamo nuovamente al racconto del collaboratore di giustizia. Era il 2005 e «Ugolini fu convocato da Giovanni Mancuso e Mario Esposito (non indagato), degli Arena di Isola Capo Rizzuto, per il riciclaggio di danaro attraverso la realizzazione di opere ecclesiastiche, ad esempio un centro anziani». Il numero uno del Grande Oriente di San Marino – secondo quanto riferisce la gola profonda – «avrebbe dovuto fare da tramite per la consegna del denaro sotto forma di offerte ad istituti ecclesiastici, grazie all’intermediazione di alti prelati, quali cardinali e vescovi di Mileto, che avrebbero poi affidato la realizzazione di strutture a costruttori puliti, dietro cui però si celavano gli stessi mafiosi che avevano messo a disposizione il denaro di provenienza illecita, il quale attraverso le offerte non era più rintracciabile. So – conclude Virgiglio – che questa operazione è andata in porto con la costruzione di un centro anziani a Paravati». Proprio da quelle parti, il Grande Oriente di San Marino avrebbe giocato in casa. «Ugolini aveva un punto di riferimento in Calabria costituito da Mario Esposito della cosca Arena, ed era un personaggio molto importante e molto legato a Vibo Valentia, che teneva in grossa considerazione. Peraltro a Vibo c’è una loggia madre e dal punto di vista massonico, è un centro molto importante». IL VIBONESE 25.10.2020
LA TASK FORCE DI BERGOGLIO PER “LIBERARE LA MADONNA DALLE PROCESSIONI.
Da qualche settimana è operativa una speciale task force in Vaticano formata da esponenti delle Forze dell’ordine, esperti anti-racket e anti-usura, procuratori in prima linea contro Cosa nostra, ‘ndrangheta, camorra e sacra corona unita. E con loro, uomini di Chiesa. La loro sfida è stata «benedetta» dal Papa: liberare la figura della Madonna da corteggiamenti e influssi mafiosi.
L’impegno è combattere la «spiritualità deviata» ravvisabile, per esempio, negli ignobili inchini delle effigi della Vergine davanti alle dimore dei capiclan. (Fonte La Stampa)
La processione della Madonna a Torre Annunziata ( Napoli ) oggetto della polemica nata tra il parroco Don Raffaele Russo e il giornale locale ‘Metropolis’ per presunti ‘inchini’ fatti fare alla statua a favore di abitazioni di esponenti di camorra criticati anche dal dirigente locale della Polizia di Stato, 24 ottobre 2019 ANSA/ GENTILE CONCESSIONE METROPOLIS
Fonte: Il Fatto Quotidiano del 19.09.2020 di Gianluca Roselli
Solo negli ultimi anni ci sono state decine di episodi. Parliamo delle processioni religiose fatte passare sotto la casa dei boss, con la statua della Madonna che va a rendere omaggio al mafioso di turno. O l’utilizzo dei simboli religiosi (Maria e l’Arcangelo Gabriele) durante i riti di affiliazione alla ‘ndrangheta. O il “padrino mafioso” nei battesimi o alle comunioni.
Ora il Vaticano ha deciso di intervenire per opporsi a tutto ciò con un’apposita task force, un dipartimento all’interno della Pontificia Accademia Mariana, l’istituzione della Santa Sede dedicata a promuovere la scienza mariologica (di Maria) in Italia e nel mondo. Ne faranno parte 37 persone coordinate da Fabio Iadeluca (sociologo e criminologo), tra cui prelati, docenti universitari, magistrati antimafia e forze dell’ordine. Tra i nomi, il fondatore di Libera don Luigi Ciotti, l’ex presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi, il prefetto Francesco Paolo Tronca, l’arcivescovo di Palmi Francesco Milito, quello di Campobasso, Giancarlo Bregantini.
“Liberare Maria dalle mafie e dal potere criminale” è il nome dell’iniziativa presentata ieri a Roma. Perché è proprio sulla figura della Madonna che Camorra, Cosa nostra, ‘ndrangheta spesso fanno leva per accrescere il loro consenso sociale.
“I mafiosi si pongono come persone religiose, devote, usano i simboli della cristianità per entrare in sintonia col popolo. Tutto ciò deve essere rigettato”, afferma Stefano Cecchin, presidente della Pontificia Accademia. Da qui l’idea del dipartimento con il compito di studiare e monitorare le interferenze criminali nella religione, che sfocerà in una relazione annuale e in un archivio digitale consultabile da tutti. Ma pure di creare sinergie tra Santa Sede e organi inquirenti.
Iniziativa fortemente voluta da papa Francesco, che ieri ha inviato un messaggio. “Bisogna escludere una religiosità fuorviante. Le manifestazioni mariane devono essere conformi al Vangelo”, le parole di Bergoglio. “Le processioni in onore dei boss purtroppo sono un fenomeno nel centro sud e non solo. Ma l’uso della spiritualità lo vediamo anche in Messico e in America Latina da parte dei narcos”, spiega Iadeluca.
Le processioni italiane a volte hanno visto la complicità di sacerdoti locali. “Le regole dei vescovati sono molto severe: c’è la scomunica. Ma nella maggior parte dei casi i sacerdoti non ne sanno nulla, perché non sono loro a decidere il tragitto di una processione, che magari viene deviata all’improvviso. Spesso i preti sono vittime inconsapevoli; aggiunge padre Cecchin. In particolare il Vaticano di recente ha messo in guardia i sacerdoti nelle zone “a rischio” chiedendo un attento esame di chi elargisce denaro, spesso di provenienza mafiosa
Webinar a più voci su rapporto Chiesa-mafia, Pm Manzini: “Consenso alla ‘ndrangheta nasce anche da sua vicinanza a riti religiosi”. “Parlare di politica oggi, significa occuparsi dei problemi della quotidianità, non possiamo fare finta che la mafia non esista, perciò è necessario affrontare anche questa tematica. Ancora più complesso è l’argomento che affronteremo oggi, si parlerà del rapporto tra mafia e Chiesa. – così l’onorevole Antonio Viscomi ha introdotto l’argomento di discussione del webinar “Chiesa e mafie. Quali strumenti di contrasto?” promosso dall’associazione di cultura politica “Luigi Sturzo”di cui è presidente. – La mafia non è più quella di una volta, con la coppola e la lupara, – ha affermato, – oggi si nasconde molto bene tra i meandri del potere: dobbiamo avere occhiali con lenti spesse per poter guardare bene e per decidere di non averci nulla a che fare. Con i mafiosi neanche un caffè insieme dobbiamo prendere.” Ad entrare nel vivo della discussione virtuale è stato l’avvocato penalista Sebastian Ciancio, che ha fatto da moderatore, ricordando prima di tutto il ruolo di Don Luigi Sturzo a cui è intitolata l’associazione e il suo impegno per la lotta alla mafia: “l’azione di Don Sturzo è stata molto lungimirante. Stiamo parlando degli inizi del ‘900, quando per contrastare la corruzione egli scelse la via della cultura”. Come ha spiegato bene Felice Caristo, studioso di tematiche costituzionali, la motivazione che ha spinto l’associazione a sollevare l’argomento oggetto di studio, è partita da una frase pronunciata dalla vedova di un boss di ‘Ndrangheta, emersa da un’intercettazione telefonica, durante la quale pregava la Madonna affinché aiutasse i figli a trovare i killer del marito per fare giustizia. “Soprattutto qui al sud – ha affermato Caristo,- dove il legame con la chiesa è più forte, è frequente che avvenga una commistione tra Chiesa e mafia. Accade, ad esempio, che i riti religiosi vengano utilizzati dalla ‘ndrangheta e stravolti. Avvengono delle vere e proprie distorsioni religiose: ad esempio, per alcune organizzazioni criminali, il rito di iniziazione per i nuovi affiliati si chiama Battesimo, proprio come il sacramento della Chiesa cattolica”. Per Antonino Mantineo, Professore ordinario di diritto ecclesiastico dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, “La pandemia sembrerebbe aver messo a tacere i fatti di mafia, ma in realtà non è cosi: sta agendo in silenzio, – ha aggiunto – sottotraccia. Magari proprio in questo momento di difficoltà per la società, sta cercando di rivolgersi a tutte le attività che si trovano in difficoltà, cercando di rastrellare tutte quelle che stanno chiudendo i battenti. Oppure si può parlare della mafia dai colletti bianchi, quella che cerca di creare business attraverso il denaro proveniente dai finanziamenti della Comunità Europea. – Ha poi ricordato con grande trasporto Don Pino Puglisi, esempio di quella chiesa di trincea di cui abbiamo bisogno, vittima di mafia – è stato ucciso perchè è rimasto isolato. – ha affermato – Aveva scelto Palermo, città difficile, per educare i ragazzi a vivere liberi e promuovere lo sviluppo del territorio. Un esempio da seguire ancora oggi per cambiare le cose.” Martineo ha spiegato che Don Puglisi era conscio del fatto che non potesse esserci pace senza giustizia sociale e che per vincere la mafia si dovessero creare, nella società le condizioni di sviluppo necessarie eliminando corruzione e inefficienza ed educando i ragazzi ai beni comuni, ad esempio al diritto alla salute, alla socialità. Parlando poi di diritto alla salute sarebbe stato impossibile non fare poi riferimento alle ultime vicende disastrose della sanità calabrese. Ma come si può dunque superare questo empasse partendo da questi presupposti? “favorendo lo sviluppo – ha affermato ancora il professore, – superando le difficoltà burocratiche che impediscono di gestire le risorse economiche, aiutando le imprese, nobilitandone la loro capacità e migliorandole,investendo inf formazione giovanile, orche con la cultura si formano i dirigenti del domani, facendo rete tra soggetti pubblici e privati per agire insieme: università, scuola, impresa, enti, associazioni, per sviluppare competenze e muoversi nell’ottica dell’innovazione”. Ma analizzando la storia, da Don Sturzo ad oggi, quanto è cambiata la situazione? A porsi questo quesito è stata Angela Robbe, Già Assessore Regionale al welfare e al lavoro. “Purtroppo è cambiato molto poco. – ha affermato – Per adottare strumenti di contrasto bisogna domandarsi cosa è diventata oggi la mafia. La mafia si rivolge alla società perchè ha bisogno di consenso, perciò c’è questo richiamo alla liturgia della chiesa. Riesce a rispondere laddove mancano stato ed istituzioni. Oggi utilizza gli strumenti di potere: corruzione e collusione sono gli strumenti con i quali rientra nella cosiddetta zona grigia delle imprese, delle amministrazioni pubbliche; la violenza, oramai è usata solo in extrema ratio. – E ha continuato – Bisogna agire isolando la mafia non concedendogli gli spazi, c’è bisogno di un recupero dell’etica, soprattutto in politica che è diventata oggi puro esercizio di potere. – poi a proposito della situazione sanità in Calabria – Quello che sta succedendo è l’apice di una situazione che era drammatica già da tempo. La Sanità era un nervo scoperto e per fortuna è venuto fuori, ora possiamo uscirne. Abbiamo bisogno che l’indignazione si trasformi ora in azione.” È toccato poi a Luigi Mariano Guzzo, docente di storia del Diritto Canonico dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, fare un excursus storico del rapporto della Chiesa calabrese difronte alla mafia. “Fino alla beatificazione di Don Pino Puglisi – ha spiegato – c’era la Chiesa del silenzio, da quel momento in poi è diventata la Chiesa che parla. Ed è proprio dalle chiese del sud che parte questa liberazione dalle mafie che sarà poi da guida per la Chiesa universale. Dal 1916 i vescovi calabresi hanno preso contezza del fenomeno mafioso facendo riferimento alla necessità di epurare la chiesa da certe usanze. – L’excursus continua fino ai giorni nostri, Guzzo ha ricordato che nel 2014, a Sibari, Papa Francesco ha scomunicato i mafiosi. L’ultimo intervento è stato quello del procuratore aggiunto di Cosenza Marisa Manzini, nominata esperta del dipartimento della Pontificia accademia mariana internazionale, organo della santa Sede. “Oggi la ‘Ndrangheta è evoluta, – ha spiegato la Manzini – ma trova sempre le radici nella sua terra d’origine. Nonostante faccia affari in Italia e all’estero, è qui in Calabria che continua a decidere quali saranno le proprie mosse. Il consenso che la popolazione dà alla ‘ndrangheta nasce anche dalla vicinanza che essa ha con i riti religiosi, considerando che in alcuni paesini isolati la cultura religiosa è l’unica forma di cultura, è facile che riesca a creare consenso attraverso la falsificazione dei riti. Ma cosa può fare lo stato collaborando con la Chiesa? – si è domandata la dottoressa, – Lo stato deve essere presente, la Chiesa deve essere riportata alla sua vera essenza, deve richiedere credibilità a chi si professa cristiano.- poi ha concluso citando l’Enciclica di Papa Francesco, Fratelli tutti: – “La solitudine, la paura e l’incertezza di tante persone che si sentono abbandonate dal sistema fanno sì che si vada creando un territorio fertile per le mafie” – questo è quello che dobbiamo evitare – ha affermato. Dora Coscarelli IL LAMENTINO 14.11.2020
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE. (istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87) XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOC. XXIII N. 38
Mafie e religioneLa Commissione Antimafia ha dedicato particolare attenzione alla promozione di una nuova cultura della legalità e della giustizia, senza le quali la lotta alle mafie rimane chiusa nel perimetro della repressione militare e giudiziaria e non produce quel cambiamento delle coscienze indispensabile a fare terra bruciata del metodo mafioso.
Su questo versante è stato affrontato anche il rapporto tra mafie e religione che in questa legislatura si è imposto con una rinnovata sensibilità alla luce della costante predicazione di Papa Francesco contro l’illegalità e la corruzione, culminata nella scomunica ai mafiosi pronunciata nel giugno del 2014 a Cassano allo Ionio.
Nel cuore del dominio ‘ndranghetista, il Pontefice ha tracciato una linea di assoluta incompatibilità tra l’essere cristiano e l’essere mafioso che schiude nuovi orizzonti di liberazione nei rapporti tra Chiesa Cattolica e mafie, una questione antica che ha accompagnato il radicamento nel nostro Mezzogiorno delle organizzazioni mafiose.
Dalla neutralità a una nuova consapevolezza
La storia ormai centenaria delle mafie meridionali non è la storia di semplici organizzazioni criminali ma dei rapporti che l’insieme della società ha stabilito con questi fenomeni criminali e viceversa. La Chiesa fa parte a pieno titolo di questi rapporti che sono stati ampiamente scandagliati da studiosi e teologi, interpellati dal paradosso di una religione non violenta usata dall’ideologia violenta e totalizzante dei mafiosi.
Cosa nostra, ‘ndrangheta, camorra e sacra corona unita, si sono appropriate dei riti e dei simboli della fede cristiana per creare un proprio universo di significati e di valori, riconoscibile e rassicurante.
Falcone sosteneva che entrare a far parte della mafia equivale a convertirsi a una religione e non c’è dubbio che per alcuni aspetti la Chiesa ha ispirato le regole, le gerarchie e il lessico sui quali si sono plasmate le organizzazioni criminali. In ampi territori del Sud d’Italia il legame con la religione è stato uno dei fattori decisivi nella costruzione del consenso e nella capacità delle mafie di presentarsi anche surrogato dei poteri pubblici e dello Stato.
Battesimi, cresime, matrimoni e funerali erano considerati una prova della religiosità dei mafiosi, insieme alle offerte di denaro in favore di confraternite, pellegrinaggi, feste patronali. Non si comprendeva o peggio si accettava la strumentalità con la quale queste occasioni pubbliche erano utilizzate per stringere alleanze e ostentare il controllo sul territorio.
Se per un mafioso la devozione era un elemento essenziale nell’autorappresentazione di sé – Michele Greco si faceva chiamare “papa” e nel covo di Provenzano sono stati trovati decine di santini, libri di preghiere, una bibbia e alle pareti solamente quadri raffiguranti scene sacre – per le chiese meridionali le mafie sono state a lungo vissute e tollerate come strutture d’ordine, alleate naturali nella comune estraneità-ostilità allo Stato unitario e poi, nel secondo dopoguerra, nella contrapposizione ideologica al comunismo e nella difesa di una comune civiltà cristiana.
I cedimenti, le omissioni e i silenzi di una parte del clero locale hanno avuto un ruolo legittimante dei poteri mafiosi che a lungo hanno fatto leva su questa neutralità per consolidare il loro dominio.
Come per la società italiana anche per la Chiesa Cattolica l’urgenza di eventi drammatici e sanguinosi costringe a guardare in faccia il male e a uscire dal silenzio.
La violenza sanguinaria degli anni Ottanta, le guerre di mafia a Palermo e quelle di camorra nel Napoletano, gli omicidi di Piersanti Mattarella, Pio la Torre, Carlo Alberto dalla Chiesa innescano le prime condanne pubbliche. Ai funerali del generale dalla Chiesa e di sua moglie Emanuela Setti Carraro, del 3 settembre 1982, il cardinale Salvatore Pappalardo denuncia l’indifferenza delle istituzioni e proietta la questione mafiosa oltre i confini della regione, con una celebre citazione di Tito Livio: “Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici! E questa volta non è Sagunto ma Palermo. Povera Palermo!”. Pochi giorni dopo, in un documento della conferenza episcopale siciliana di solidarietà alle posizioni del cardinale di Palermo, compare per la prima volta la parola mafia: “A seguito del doloroso acuirsi dell’attività criminosa che segna di sangue e di lutti la nostra regione, i vescovi, in forza della loro responsabilità di pastori, riaffermano la loro decisa condanna (…) sottolineando la gravità particolare di ricorrenti episodi di violenza che spesso hanno come matrice la mafia e la nefasta mentalità che la muove e la facilita”.
In Campania, nello stesso anno il nuovo vescovo di Acerra, Antonio Riboldi promuove una marcia anticamorra di migliaia di giovani a Ottaviano, nel centro del potere di Raffaele Cutolo.
In Calabria, già nel 1975 un documento della conferenza episcopale definisce la mafia “disonorante piaga della società”. Più tardi, il 2 settembre 1984, don Italo Calabrò, il don Milani del Sud, chiama la sua comunità a reagire al rapimento, a Lazzaro di Reggio Calabria, del piccolo Vincenzo Diano: “siamo qui per stabilire un costume di non violenta, ma ferma opposizione alla mafia in tutte le sue manifestazioni” e parla dei mafiosi come “gente che in mezzo a noi esprime il potere di Satana, il regno del male”.
Prese di posizione di chiese e sacerdoti meridionali che testimoniano una crescente consapevolezza del fenomeno mafioso che negli anni Novanta si arricchisce di nuovi decisivi passaggi.
Il documento della CEI “Educare alla legalità” del 10 aprile 1991, rappresenta una lucida denuncia della crisi democratica e del peso crescente delle dinamiche criminali nel mancato sviluppo della società. I vescovi italiani descrivono un quadro severo della criminalità organizzata “che spadroneggia in varie zone del paese fino a proporsi come uno Stato alternativo a quello di diritto” stigmatizzano “l’omertà, le collusioni e il disimpegno” e la ricerca “delle convenienze” l’esplosione della corruzione. Il documento traccia un cammino di recupero della legalità che deve tenere insieme “le responsabilità pubbliche e i comportamenti individuali”; richiama “la comunità cristiana a un impegno serio, non formale, al principio di legalità attraverso la crescita dell’etica della socialità e solidarietà” con una particolare attenzione alla coerenza nei comportamenti, pubblici e privati, e tra i mezzi e i fini e invita “i credenti a essere cittadini esemplari”.
Ad Agrigento, il 9 maggio del 1993, si consuma la cesura più radicale tra Chiesa e mafie. A un anno dalle stragi di Capaci e di via d’Amelio e dopo un commovente incontro privato con i genitori del giudice Rosario Livatino, Giovanni Paolo II abbandona il testo scritto dell’omelia per rivolgersi agli direttamente ai mafiosi con un grido di dolore pubblico che suona come un anatema: “Dio ha detto una volta, non uccidere. Nessun uomo, nessuna associazione umana, nessuna mafia può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Nel nome di Cristo, crocifisso e risorto, di Cristo che è vita, verità e vita, mi rivolgo ai responsabili: convertitevi, un giorno arriverà il giudizio di Dio”.
La reazione feroce di cosa nostra non si fa attendere. Prima, nella notte tra il 27 e il 28 luglio, gli attentati alle chiese romane di San Giorgio al Velabro e di San Giovanni in Laterano. Poi, il 15 settembre, nel giorno del suo compleanno, viene assassinato don Pino Puglisi, il prete che a Brancaccio liberava i ragazzi dal controllo dei mafiosi. Gaspare Spatuzza, il killer armato dai fratelli Graviano, è anche l’uomo che aveva imbottito di tritolo le auto esplose a Roma, uno degli autori delle stragi di Via Palestro a Milano e di Via dei Georgofili a Firenze.
Francesco Marino Mannoia, un collaboratore di giustizia, in quei mesi aveva spiegato ai magistrati: “Nel passato la Chiesa era considerata sacra e intoccabile. Ora invece cosa nostra sta attaccando anche la Chiesa perché si sta esprimendo contro la mafia. Gli uomini d’onore mandano messaggi chiari ai sacerdoti: non interferite”.
Il 19 marzo 1994, nel giorno del suo onomastico, veniva ucciso dalla camorra don Peppino Diana, parroco di Casal di Principe che in una lettera scritta nel Natale del 1991 insieme a altri sacerdoti, “Per amore del mio popolo non tacerò”, aveva denunciato il sistema criminale e i trafficidella camorra, richiamato la politica alla sua responsabilità ma chiedeva anche alla Chiesa di essere protetica “ai nostri pastori e confratelli chiediamo di parlare chiaro nelle omelie e in tutte quelle occasioni in cui si richiede una testimonianza coraggiosa”. Don Diana si era sentito meno solo dopo l’omelia agrigentina di Giovanni Paolo II e aveva moltiplicato il suo impegno anticamorra e ha pagato con la vita la sua coerenza cristiana.
Un anno dopo, il 25 marzo del 1995 nasce Libera, fortemente voluta da don Luigi Ciotti che riunisce in un cartello esplicitamente connotato dalla lotta alle mafie le associazioni antiracket e gruppi di volontariato civile e sindacati.
In poco tempo Libera è diventata l’anima dell’antimafia civile e culturale del nostro Paese che mobilita soprattutto i giovani e raccoglie sotto un’unica bandiera le voci e le esperienze di impegno sociale di tante parrocchie e centri di formazione del Sud.
Memoria delle vittime innocenti, educazione alla legalità nelle scuole, riuso sociale dei beni sottratti alle mafie, sono il terreno privilegiato sul quale si sviluppa un inedito percorso di partecipazione e condivisione che nei fatti rappresenta un’esplicita scelta di campo nella lotta contro l’illegalità e i poteri mafiosi.
Bibliografia
- Bolzoni, Parole d’onore, Rizzoli, Milano 2008.
- Cantone, Solo per giustizia, Mondadori, Milano 2008.
- Cavadi, Il Dio dei mafiosi, San Paolo, Cinisello Balzamo 2009.
- Cestaro, Studi e ricerche di storia sociale e religiosa, edizioni Osanna, Venosa 1996.
- De Blasio, Usi e costumi dei camorristi, Pierro editore, Napoli 1897.
- De Rosa, Un’altra vita. La verità di Raffaele Cutolo, Marco Tropea, Milano 2001.
- Dino, La mafia devota, Laterza, Roma-Bari 2008.
- Fasulo, Perché la Chiesa ha taciuto, in “Micromega”, 5 (1993).
- Franchetti, Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, Donzelli, Roma 1993.
- Frasca Polara, La terribile istoria dei frati di Mazzarino, Sellerio, Palermo 1989.
- Giannone, Istoria civile del regno di Napoli, 1723.
- Lupo, Storia della mafia, Donzelli, Roma 1993.
- C. Marino, L’opposizione mafiosa, Flaccovio, Palermo 1996.
- , I padrini, Newton Compton, Roma 2006.
- Pantaleone, Mafia e droga, Einaudi, Torino 1966.
- Renda, Storia della mafia, Sigma, Palermo 1997.
- Sales, I preti e i mafiosi, B.C. Dalai, Milano 2010.
- M. Salmann, Santi barocchi, Argo, Lecce 1996.
- Santino, Breve storia della Mafia e dell’Antimafia, Di Girolamo, Trapani 2008.
- Scarpinato, Il Dio dei mafiosi, in “Micromega”, 1 (1998).
- Stajano, Africo, Einaudi, Torino 1979.
- M. Stabile, La Chiesa nella società siciliana, Salvatore Sciascia, Caltanissetta 1992.
- Viviano, Michele Greco, Aliberti, Reggio Emilia 2008.
- 1 Le candelore, dette anche cerei, sono delle opere in legno di diversa dimensione e altezza allestite da varie categorie di mestieri che ne curano l’addobbo e la sfilata.
2 Nel covo del boss Lo Piccolo nel 2007 sono state trovate le «dieci regole» per l’appartenenza alla mafia: 1) «Non ci si può presentare da soli a un altro amico nostro, se non è un terzo a farlo»; 2) «Non si guardano mogli di amici nostri»; 3) «Non si fanno comparati (amicizia ndr) con gli sbirri»; 4) «Non si frequentano né taverne né circoli»; 5) «Si ha il dovere in qualsiasi momento di essere disponibile a Cosa nostra. Anche se c’è la moglie che sta per partorire»; 6) «Si rispettano in maniera categorica gli appuntamenti»; 7) «Si ci deve portare rispetto alla moglie»; 8) «Quando si è chiamati a sapere qualcosa si dovrà dire la verità»; 9) «Non ci si può appropriare di soldi che sono di altri e di altre famiglie»; 10) «Niente affiliazione per chi ha un parente stretto nelle varie forze dell’ordine, oppure chi ha tradimenti sentimentali in famiglia, o chi ha un comportamento pessimo e che non tiene ai valori morali».
- La religione contro il culto della mafia Intervista a Lucia Ceci di Elisa Gianni
- La Chiesa di fronte alle mafie tra devozione e secolarizzazione Alessandra Dino

Tesi La Chiesa di fronte alla mafia 1945-2000
COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA
30º – Beato don PINO PUGLISI, il prete che combatteva la mafia con il sorriso











